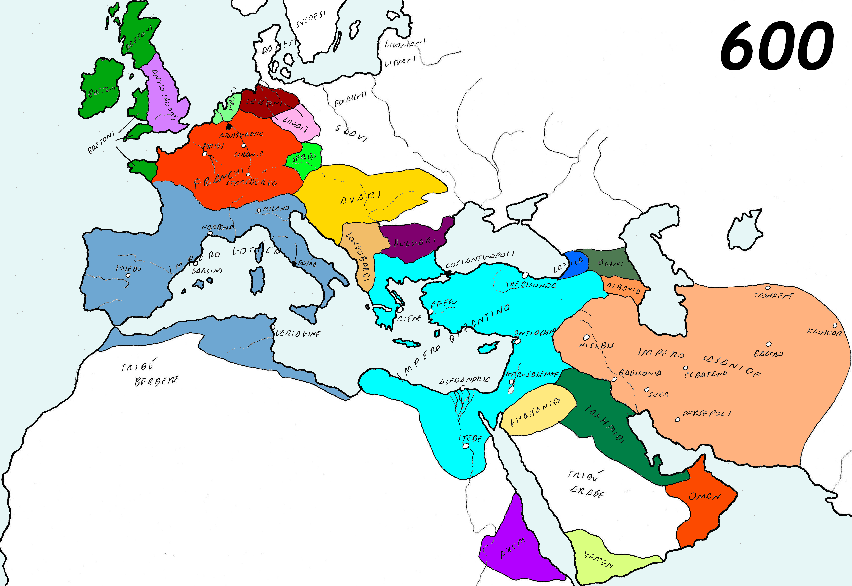
di Det0
POD: Il nobile ostrogota Teudi, dopo essere diventato re presso i visigoti alla morte di Amalarico, assume la reggenza anche del regno ostrogoto alla morte di Atalarico.
.
476: Odoacre, principe germanico, depone il giovane imperatore Romolo Augustolo; cade l’Impero Romano d’Occidente e comincia il Medioevo.
477: Il re dei Vandali Genserico muore, comincia il declino del regno vandalo. Nello stesso anno Odoacre toglie la Sicilia ai Vandali con le armi.
480: Giulio Nepote, imperatore romano in Dalmazia, riconosce ufficialmente il regno dei
Visigoti in Aquitania e concede al loro re Eurico tutte le terre al di sotto della Loira e ad ovest del Reno, compresa la Provenza.
Poi Odoacre, approfittando della morte di Nepote, conquista la Dalmazia.
481: Clodoveo diventa re dei Franchi, unificazione degli altri regni franchi in Gallia e Renania.
486: Durante la loro espansione verso occidente i franchi di Clodoveo sconfiggono Siagro nella battaglia di Soissons; facendo cadere l’ultimo baluardo romano in Occidente.
488: L’Imperatore Romano d’Oriente Zenone invia Teodorico re degli ostrogoti, che premevano alle frontiere settentrionali dell’impero, in Italia per sconfiggere Odoacre, così facendo eliminava la minaccia italiana di Odoacre e manteneva una certa tranquillità ai confini.
489: Dopo aver attraversato la Dalmazia, Teodorico e il suo popolo valicano le Alpi Giulie e giungono in Italia, dove si scontrano con Odoacre sul fiume Isonzo, dove quest’ultimo viene sconfitto e ripiega a Verona, dove è sconfitto nuovamente un mese dopo.
490: Odoacre fugge a Ravenna dove può organizzare un contrattacco, infatti in poco tempo si riappropria di Milano, Cremona e Pavia, dove pone la base agli attacchi dei goti. La situazione si sblocca con l’intervento dei Visigoti che liberano la città e fanno scappare di nuovo Odoacre a Ravenna, dove resiste a lungo grazie ai rifornimenti via mare.
492: Teodorico si munisce finalmente di una flotta e distrugge il porto di Ravenna, che in poco tempo capitola. Però grazie alla mediazione del vescovo di Ravenna Giovanni si scende a patti tra le parti per una divisione del territorio italiano.
493: Durante un banchetto per celebrare il trattato Teodorico assassina Odoacre con le sue mani e gli uomini di Odoacre vengono sterminati, facendo di Teodorico unico padrone dell’Italia.
Nascita del Regno degli Ostrogoti in Italia.
Nello stesso anno il matrimonio del re dei franchi Clodoveo con una principessa cristiana burgunde sancisce la conversione dei franchi al cristianesimo; così facendo i franchi si mettono in luce agli occhi del papa e di altri governatori cristiani, formando il nucleo di uno stato molto solido.
494: Il re franco Clodoveo sconfigge i Visigoti di Alarico II a Saintonge, cominciano le ostilità tra i due regni per il controllo della Gallia.
496: Il re franco Clodoveo sconfigge gli Alemanni e ne conquista le regioni.
500: Italia, viene emanato l’Editto di Teodorico, raccolta di leggi valida sul territorio ostrogoto.
Spagna, i visigoti controllano ormai ampia parte della penisola iberica (tranne l’attuale Galizia occupata dagli Suebi e le regioni dei popoli baschi) e della Gallia, con Aquitania, Settimania e Provenza.
506: I franchi Clodoveo alleati con i Burgundi attaccano i possedimenti visigoti in Gallia.
507: Battaglia di Vouille, Clodoveo e i franchi sconfiggono Alarico II e i visigoti in battaglia, il re visigoto muore e il suo regno viene privato di tutti i territori in Aquitania. Così la capitale del regno visigoto è spostata a Narbona.
I nobili visigoti eleggono il figliastro di Alarico II: Gesalico, in contrapposizione all’alleato ostrogota Teodorico che voleva far eleggere il figlio di Alarico
Amalarico.
508: Il re degli Ostrogoti, Teodorico, comincia campagne militari contro i franchi in Gallia per difendere i suoi alleati visigoti, ai quali riesce a salvare il possesso della Settimania, e estendere i domini ostrogoti, come in Provenza, tolta al controllo burgunde.
Nel frattempo i rapporti tra Teodorico e Gesalico si rompono e il piccolo Amalarico viene portato sotto la tutela del nonno e scortato a Barcino (l’attuale Barcellona), dove fu posto sotto la protezione di un nobile ostrogoto di nome
Teudi.
510: Ibbas, generale delle truppe ostrogote, entra a Barcino e vi fa eleggere re dei Visigoti il giovane Amalarico (di soli nove anni), nipote del suo re Teodorico, quest’ultimo se ne assume la reggenza, governando così il regno visigoto.
518: Giustino diventa Imperatore d’Oriente, nella sua politica attua una dura lotta contro l’arianesimo, entrando in conflitto con gli ariani ostrogoti di Teodorico.
522: Amalarico, ormai ventunenne, viene incoronato re dei visigoti, si intromette però il vecchio tutore Teudi che, nelle veci di consigliere continua ad esercitare il potere effettivo.
523: Teodorico organizza un attacco alla Burgundia ma i franchi arrivano prima e la sottomettono al loro regno.
524: L’imperatore Giustino mette a bando l’arianesimo in tutto l’impero; Teodorico, come ripicca, comincia un progetto di persecuzione dei cristiani e fa uccidere Boezio, suo consigliere d’origine romana.
526: Teodorico imprigiona papa Giovanni I e dei nobili romani in ritorno da Bisanzio, quando il pontefice muore viene eletto papa Felice IV, sotto la tutela del re ostrogoto. Poco dopo muore Teodorico il Grande, il suo corpo viene sepolto nel Mausoleo di Teodorico a Ravenna; i nipoti del re, Amalarico e Atalarico, uno re dei visigoti e l’altro degli ostrogoti, siglano un accordo per definire i confini dei due regni.
527: Dopo la morte del predecessore Giustino, Giustiniano viene eletto Imperatore d’Oriente.
528: Costantinopoli, comincia la composizione del Corpus Iuris Civilis.
530:Roma, alla morte di papa Felice IV è eletto pontefice Bonifacio II.
Costantinopoli, Giustiniano da il via al suo progetto di riconquista dei territori d’occidente, inviando il generale Belisario in Africa.
531: Il re visigoto Amalarico muore, il trono viene occupato dall’ex tutore Teudi.
534: Il Regno dei Vandali viene fatto cadere per opera di Belisario, Cartagine e tutta la zona dell’Africa del nord, le Baleari e la Corsica vanno sotto il controllo bizantino.
Intanto in Italia Atalarico muore e la madre Amalasunta, per mantenere il potere, pensa di sposare un nobile ostrogoto di nome Teodato.
Ma il re dei visigoti Teudi, appena saputo della morte del giovane sovrano ostrogoto, si dirige in Italia, assassina Amalasunta e Teodato e si fa proclamare re; così facendo unisce la corona visigota e ostrogota, dando vita ad un unico Regno Gotico.
535: Sale al soglio papale Agapito I, al quale il re goto Teudi chiede di fare ambasciata a Costantinopoli per fermare l’attacco di Belisario.
536: Il papa Agapito I giunge a Costantinopoli e parla con l’imperatore Giustiniano che, intenzionato a riconquistare l’occidente, rifiuta ogni sua offerta.
Però, mentre Belisario ha già conquistato la Sicilia un’altra ambasciata di Teudi giunge a Giustiniano e riferisce che il Regno Gotico è disposto ad arrendersi e ad andare sotto il dominio bizantino senza uno spargimento di sangue.
Giustiniano cede alle richieste e riporta Belisario in patria dopo aver riconquistato l’occidente senza problemi.
540: Giustiniano pubblica la Prammatica Sanzione, con la quale riconosce l’Italia e tutti i territori riconquistati sotto il dominio bizantino.
L’imperatore sasanide Cosroe I rompe la “pace eterna” siglata con i bizantini, invadendo la Siria e deportandone la popolazione in Persia.
541: I bizantini perdono il controllo della Lazica a favore dei persiani di Cosroe.
I franchi tentano di attaccare la spagna bizantina dai Pirenei ma un intervento del generale visigoto Atanagildo, mostratosi abile condottiero agli occhi dell’imperatore Giustiniano, li ferma a Saragozza e li scaccia dalla penisola iberica.
542: Una controffensiva bizantina attacca l’Armenia ma è sconfitta dai sasanidi.
Per rafforzare il potere militare nella regione, Giustiniano innalza la provincia spagnola dell’impero ad esarcato: l’Exarcatus Hispaniae, retto da Teudi e con capitale Barcino; lo stesso accade con i territori africani organizzati nell’Exarcatus Africae con capitale Cartagine.
545: Viene firmata una tregua di cinque anni tra gli imperi bizantino e sasanide.
Intanto Teudi sposta la capitale dell’Exarcatus Hispaniae dalla città di Barcino alla più centrale Toledo per motivi di difesa.
547: Col ritorno della Lazica sotto il controllo bizantino ricominciano le ostilità con i sasanidi, la guerra continua per anni ma è ristretta solo a quella zona.
548: Morte di Teudi, primo re riuscito ad unire le due corone gotiche, gli succede, come esarca di Spagna, il generale Atanagildo.
552: Battaglia di Asfeld, i Longobardi guidati dal re Audoino sconfiggono i Gepidi aggiudicandosi il predominio sulla Pannonia.
554: L’Italia è innalzata ad esarcato: l’Exarcatus Italiae con capitale Ravenna.
558: Il re Clotario I riunifica i territori franchi in Gallia.
560: La fascia costiera della Gallia controllata dai goto-bizantini viene tolta dall’Exarcatus Italiae e innalzata ad un esarcato autonomo: l’Exarcatus Narbonensis.
561-568: Il generale Atanagildo, su richiesta dell’imperatore Giustiniano, comincia una campagna militare contro il belligerante popolo dei baschi; dopo aver sottomesso la regione in pochi anni la consegna all’imperatore, poi, di sua spontanea volontà si munisce di un piccolo esercito e parte alla conquista del regno degli Svevi nel nord della Spagna accompagnato dal giovane fratello Leovigildo.
In pochi anni il regno svevo comincia a dare segni di difficoltà ma la battaglia si protrae a lungo e, quando nel 567 Atanagildo muore, il fratello Leovigildo diviene automaticamente esarca di Spagna.
562: Sasanidi e bizantini firmano un trattato di pace.
564: Una rivolta scoppiata in Armenia porta la popolazione locale, e presto anche quella della regione dell’Iberia, a ribellarsi al dominio sasanide.
565: Costantinopoli: morte dell’imperatore d’oriente Giustiniano, gli succede il nipote Giustino II; come prima impresa decide di approfittare della crisi sasanide in Armenia per non pagare i tributi annuali ai persiani per la difesa del Caucaso, poi accoglie la popolazione armena come alleata.
Pannonia: Alboino succede al padre Audoino come re dei Longobardi.
567: Morte di Atanagildo, re visigoto, durante la guerra contro gli Svevi, il fratello Leovigildo assume il potere di esarca.
568: Dalmazia: i Longobardi guidati da Alboino invadono la Dalmazia e l’Epiro, sottraendoli al dominio bizantino e dando inizio alla crisi dell’impero.
Spagna: Leovigildo termina la conquista dei territori svevi, poi, approfittando della crisi bizantina, attua il piano che tutti i governatori della spagna gotica avevano escogitato prima di lui: si muove verso Barcino e Cordova, dove risiedeva gran parte della nobiltà bizantina in Spagna, le assedia e decima la popolazione romana, poi si dirige a Toledo e si fa incoronare re di Spagna.
569: Leovigildo continua il suo piano di riconquista dei territori del Regno Gotico: all’inizio del 569 scaccia i bizantini dalle Baleari, dalla Sardegna e dalla Corsica; poi in primavera risale la costa francese ed entra in Italia, questa, appena devastata da un’epidemia di peste, viene invasa e sottomessa con facilità, grazie anche all’aiuto della resistenza gotica nella penisola, stanca del dominio bizantino.
570-572: Leovigildo si allea con le popolazioni berbere del nord africa e attacca l’Esarcato d’Africa, grazie all’aiuto dei suoi alleati conquista in poco tempo la parte occidentale della regione; mentre gli richiede un anno per far capitolare Cartagine.
573-575: In due anni Leovigildo si rimpossessa della Sicilia, ultimo baluardo bizantino in occidente; poi si dedica ai rapporti con Longobardi e Franchi, con i primi usa toni diplomatici e fissa i confini sulla penisola istriana, mentre con i secondi comincia una dura lotta per riappropriarsi dell’Aquitania.
Intanto Giustino II guida un assedio alla città persiana di Nisibis che, però, fallisce miseramente, da quel momento la guerra tra bizantini e sasanidi riprende occupando tutte le forze dell’impero ad oriente; nel 574 approfittano di questa situazione i Bulgari, che si stabiliscono sotto il Danubio.
578: Leovigildo sconfigge i franchi dopo la battaglia di Poitiers e la presa di Limoges, fissando il confine dei due regni sulla Loira.
Così, dopo dieci anni dalla sua rivolta, Leovigildo si dirige finalmente a Roma e si fa incoronare “re dei goti” da papa Benedetto I, il regno gotico torna indipendente.
580: Durante la stabilizzazione longobarda in Dalmazia i popoli dei Croati e dei Serbi migrano verso la Germania.
583: I longobardi si scontrano con la popolazione degli Avari, che aveva occupato la Pannonia e stava iniziando a mostrare la loro influenza in Europa.
586: Morte di Leovigildo, re dei goti, gli succede Recaredo, che come primo intervento sposta la capitale del regno da Roma a Barcellona, più facilmente difendibile dagli attacchi bizantini che cercavano di recuperare il controllo dell’Urbe.
In questa data comincia la Guerra Civile Gotica, gli ostrogoti in Italia si ribellano in quanto lo spostamento della capitale porta il baricentro del regno ad ovest.
587: Gli ostrogoti, guidati dal nobile Widin, dichiarano l’indipendenza del loro regno, rinchiudono il papa in prigione e attaccano la costa azzurra.
589: Gli ostrogoti assediano Marsiglia, che dopo otto mesi capitola, poi si dirigono verso i Pirenei.
591: Widin attraversa i Pirenei con il suo esercito e sconfigge i visigoti a Girona, alla notizia il re Recaredo fugge verso Toledo, lasciando, però, Barcellona in mano nemica.
594: Widin entra a Barcellona dopo una resistenza di soli pochi giorni, poi invia le sue truppe verso Toledo.
595: Dopo aver circondato completamente la città Widin comincia l’assedio di Toledo e, quando Recaredo cerca di scappare dalla porta secondaria delle mura viene catturato e ucciso dalla cavalleria ostrogota, alla morte del re la città si arrende e si consegna nelle mani di Widin.
596-597: Dopo aver placato le rivolte cittadine sulla costa catalana che volevano l’autonomia del regno visigoto Widin torna in Italia e fa eleggere un nuovo papa: Gregorio I.
598: Widin annuncia la conversione dei goti al cattolicesimo.
600, Notte di Natale: papa Gregorio Magno incorona Widin “Imperatore dei Romani”, rinasce l’Impero Romano d’Occidente.
.
La situazione mondiale nell'anno 600 d.C.
.
Se volete fornirmi suggerimenti o commenti, scrivetemi a questo indirizzo.
.
Ecco ora la nuova proposta di Pedro Felipe:
Durante le invasioni barbariche, invece dei popoli slavi, sono i Balti e i popoli finnici a migrare. Gli slavi rimangono confinati nella loro zona d'origine, tra le odierne Polonia e Ucraina, dove vengono schiacciati dal rullo compressore unno, o al massimo si rifugiano in qualche zona periferica, come la Crimea o proprio la zona baltica. Nel frattempo i Balti si stanziano nei balcani e i popoli finnici in Polonia e Germania orientale. La Russia, senza Slavi, viene conquistata dai popoli turchi. In seguito, con i Variaghi, la cultura norrena si radicherà più a fondo in Russia, dando vita ad uno strano mix tra turchi e Variaghi. Con le invasioni dei mongoli l'Orda d'Oro conquisterà tutta la Russia. Come cambia la storia dell'Europa con i Balti e i finnici al posto degli Slavi e con una Russia decisamente più orientata verso l' Asia?
E c'è anche una possibile alternativa: le migrazione dei Balti e dei Finni avviene dopo quella degli Slavi, intorno al VII secolo. I nuovi arrivati occupano i territori degli Slavi, che devono cercare un posto dove andare. Gli Slavi del nord si spostano in Germania; di conseguenza i popoli germanici, partendo dalla Francia, divenuta il loro centro, si spostano in Spagna, scacciando gli Arabi, e in Italia. Gli Slavi dei Balcani migrano a sud, invadendo la Grecia, e una parte di loro passerà in Anatolia, dando il colpo di grazia ai bizantini. Le conseguenze sarebbero importantissime: innanzitutto Italia, Francia, Spagna e Portogallo sarebbero completamente germanizzate (così come il Sudamerica successivamente). Inoltre la Jugoslavia nascerebbe in Grecia e in Anatolia e la Russia, abitata da Slavi così come nella nostra Timeline, avrebbe interessi "panslavici" nel Caucaso e nel Medio Oriente. Quali altre conseguenze?.
.
Cui risponde Bhrg'hros:
Secondo me c'è un punto critico nel postulato iniziale. L'espansione slava (che è stata, a Ovest del Oder e a Sud dei Carpazi, un'espansione sempre più linguistica e sempre meno antropica man mano che aumentava la distanza dai territorî protoslavi) è avvenuta allorché non c'era ancora distinzione linguistica tra Balti e Slavi (o, più precisamente, tale distinzione non superava quelle interne agli stessi Slavi e addirittura era inferiore a quelle tra i Balti Orientali e Occidentali). A maggior ragione tutto ciò, che è accaduto all'epoca della migrazione degli Avari, sarebbe stato vero in precedenza, prima della migrazione degli Unni; nella proposta c'è infatti un hysteron proteron: gli Slavi si sarebbero espansi prima degli Unni, contrariamente alla Storia reale. Già questo è un punto di divergenza, ma paradossalmente accentua la conseguenza che l'ucronia si risolve - per quanto riguarda la sostituzione dei Balti agli Slavi - in un esito identico alla Storia reale.
Seconda conseguenza: poiché non hanno avuto luogo migrazioni di massa, il vero punto di divergenza consiste appunto in questo - postularle. Qui c'è qualche complicazione in più, perché la Russia, dove non era già slava (e lo era in parte, poiché la Protoslavia non si limitava alle odierne Polonia e Ucraina), era comunque baltica orientale e a Nord-est finnica, per cui la migrazione di massa (ucronica in quanto tale e doppiamente ucronica in quanto sia baltica sia slava sia finnica) diventa ancora più ucronica in quanto lascerebbe dietro di sé così pochi stanziamenti da (mirabilmente) non influenzare i sopravvenuti. Questi ultimi, fra l'altro, sono esattamente quelli che la Storia ha documentato, per cui nel loro caso il tasso di ucronia diminuisce, in quanto si tratta solo di espandere un po' di più l'insediamento altaico (verso Nord-Ovest) e l'area di egemonia dell'Orda d'Oro (fino al Baltico, presumo).
Non ho invece capito perché i Finni si stanziano in Polonia e Germania Orientale: non c'erano rispettivamente Slavi e Germani (questi ultimi in quanto il loro territorio, proprio per ipotesi, non sarebbe stato slavizzato)? Se gli Slavi fossero stati (invero un po' troppo sbrigativamente: quarto punto di divergenza) altaicizzati dagli Unni, in Polonia ci sarebbero comunque stati questi ultimi (altrimenti non è chiaro come possano gli Unni nientemeno che eliminare gli Slavi ma non tangere i Finni).
Comunque sia, con ben quattro punti di divergenza non ci siamo sbloccati dalla Storia reale, perché il ruolo della Russia (e, se vogliamo, anche della Polonia) nell'espansione verso Est non è stato certo dovuto alla loro slavità, per cui anche sostituendole con Nazioni finniche e/o altaiche avremmo le stesse vicende geopolitiche, semplicemente col ciuvascio al posto del russo.
L'alternativa, apparentemente meno ucronica nei suoi iniziî, aumenta in realtà la divergenza dalla Storia nota. L'aspetto più macroscopico è che, a differenza che in quest'ultima, i migranti sorprendentemente sostituiscono gli indigeni (esattamente come sognato dall'agiografia nazionalistica otto-novecentesca). Come minimo ci si attende che ciò avvenga attraverso un cambio di religione (altrimenti i Germani avevano già sperimentato di non riuscire a vincere il confronto con la cultura etno-nazionale romana cattolica loro ostile, su questo piano - intendo politico, non religioso). In Grecia la slavizzazione aveva realmente avuto luogo, ciò che dimostra che occorre davvero qualcosa in più perché si mantenga vincente.
Immagino che "Medio Oriente" sia da intendere all'americana se riferito all'Anatolia (è solo dal punto di vista americano, infatti, che "Vicino Oriente" può essere una denominazione per l'Europa). Anche in questo caso, comunque, mi pare che non ci sarebbe alcuna deviazione dalla Storia che conosciamo, dove le mire geopolitiche su Grecia Continentale e Anatolia si sono basate sul pretesto bizantino e ortodosso anziché su quello panslavo, la quale differenza mi pare paragonabile a uno scenario in cui il Führer del Terzo Reich si chiamasse - per dire - Alarich Schicklgruber anziché Adolf Hitler.
.
E ora, un'altra geniale idea di dDuck: la Jugogernania!
Il POD è il seguente: i Goti si stabiliscono nei Balcani e inizia la gotizzazione dei territori a sud del Danubio. Poi arrivano i bulgari e gli avari e diffondono le lingue germaniche. Si avrà una Bulgaria germanica, ortodossa; una Gotia germanica e ortodossa (al posto della Serbia); una Lombardia germanica al posto della Croazia, ma cattolica. In seguito la Slovenia non nascerà mai come nazione. Il Goto-lombardo (serbo-croato) sarà una lingua germanica ma differente dal tedesco più o meno come l'inglese. La Slovenia sarà germanizzata completamente proprio di lingua tedesca. Ora arriviamo al secondo POD. La Russia non avrà interessi nei Balcani e spingerà maggiormente con il suo asiatismo aggressivo. Quindi l'appoggio ai Germani dei Balcani sarà accollato interamente dall'Austria asburgica e non dalla Russia. Come cambierà la storia?
.
Gli risponde Bhrghowidhon:
La prima ucronia è in realtà quello che sarebbe stato più probabile che succedesse. "Bulgaria" implica che i residui dell'Orda Unna si siano divisi come nella Storia vera, con una parte sul Basso Danubio; inoltre l'ucronia lascia intatto lo sviluppo della Romanìa, che a sua volta implica l'azione dei Bulgari (storici).
Quanto ai nomi, forse sarebbe meglio chiamare "Gepidi" anziché "Goti" i Germani di Serbia, per il parallelo (se vogliamo tenerne conto) che gli Slavi prebulgari sul Danubio si chiamavano probabilmente "Sloveni" - cioè col nome generale degli Slavi - e di conseguenza in questa ucronia si sarebbero chiamati "Goti" (come infatti si chiamavano per il tempo che sono rimasti in quell'area), mentre "Serbi" è il nome di una tribù più particolare (anche se diffusa in varî punti della Slavia) e quindi è abbastanza omologo a "Gepidi", denominazione dei Goti rimasti sul Basso Danubio. Avremmo perciò Gepidi al posto dei Serbi e Goti poi metonimizzati in Bulgari al posto dei... Bulgari.
Il passaggio di /a/ a /o/ in "Lombardi" è spiegabile solo in ambito cisalpino (per una paretimologia con i longobardi celtici - una classe di poeti), quindi al di fuori di quell'area sarebbero rimasti "Langobardi"; di conseguenza dovremmo aspettarci "gepido-longobardo" (piuttosto che "goto-lombardo") come omologo del serbocroato. Non sono tanto persuaso dell'inevitabilità della tedeschizzazione della Slovenia: potrebbe invece ben essere l'unica regione a continuare a chiamarsi "Gotia" e in luogo della Slavia Meridionale o Jugoslavia avremmo la Germania meridionale articolata in Gotia, Langobàrdia, Gepidìa e Bulgaria.
L'espansionismo asburgico sarebbe interamente all'insegna del pangermanesimo in senso proprio (cioè di Allgermanentum e non di Alldeutschtum); le postulabili Potenze Atlantiche appoggerebbero invece la costituzione di Stati 'nazionali' germanicomeridionali (appunto Gotia, Langobàrdia, Gepidìa e Bulgaria, eventualmente federati in funzione antiasburgica).
.
dDuck gli ribatte:
Non saprei se la Russia potrebbe cristianizzarsi in senso orientale. E se la Russia tentasse ugualmente di arrivare al Bosforo, è sempre ortodossia, che siano germanici, greci o latini. Poi i mari caldi sono proprio quelli e il Mediterraneo è l'obbiettivo, della Siberia è scontata l'annessione, ma non è quello l'obbiettivo prioritario.
Una Russia senza la Slavia meridionale non riesco a immaginarla come non riuscirei a capire quale ramo del cristianesimo possano abbracciare. Di sicuro si espandono in Siberia, e di sicuro tenteranno l'accesso al Baltico e al Mar Nero. Credo che la situazione del Balcani non sia molto diversa e che la decadenza ottomana sia la medesima.
Però un caso c'è già, sono le lingue scandinave e fiamminghe, la germanicità delle loro lingue non ne ha fatte facili prede dell'Impero tedesco prima e del nazismo dopo. Come le lingue non germaniche di ungheresi e bulgari non ha impedito loro di allearsi con i tedeschi nelle due guerre mondiali. Quindi mi immaginerei una "Jugogermania" o "Sudgermania" comunque che difende la sua indipendenza.
.
E Bhrghowidhon aggiunge:
L'alternativa alla Romanìa neolatina è, in prospettiva germanica, la Gepidia (che quindi vi si colloca meglio che in Serbia, invece piuttosto ostrogotica).
Naturalmente, l'Imperialismo di qualsiasi varietà di Russia sarebbe verso Sud e altrettanto naturalmente riempirebbe al contempo il vuoto di potere in Asia centro-settentrionale. La Slavia Meridionale è comunque secondaria rispetto al resto (Orientale e Occidentale) e l'interposizione di Romeni (naturalmente preesistenti, ma allora i Daci si possono considerare precursori degli Slavi, cui erano molto più vicini anche linguisticamente di quanto si immagini di solito) e Magiari ha aggravato il divario.
La decadenza ottomana potrebbe non essere del tutto scontata; l'alterazione degli equilibrî globali parte da quando la Gran Bretagna si è impadronita del deposito mondiale dell'oro, l'India, e termina quando cessa l'assedio europeo al deposito mondiale dell'argento, la Cina (dopodichè tutto tende a tornare come era sempre stato). Il distacco scandinavo dalla Germania inizia nel primo Ottocento, quello olandese ha radici nel Seicento ma in realtà diventa effettivo solo col Secondo Reich.
L'adesione ungaro-bulgara all'Asse è effetto dela Prima Guerra Mondiale, che a sua volta ha segnato la fine inesorabile della principale interpretazione sette-ottocentesca del Nazionalismo (oggi dimenticata), quella - già di otto secoli prima - delle tre Nazioni europee principali (la quarta era la greca): Latini, Germani e Slavi (osteggiata soprattutto dalla Gran Bretagna). Certamente, in ogni caso, le nazioni germaniche meridionali avrebbero finito per optare per una politica di 'difesa' dalla Germania, a meno che invece la Storia andasse diversamente e portasse in quelle Nazioni il primato culturale (anziché in Germania) tra Otto- e Novecento.
.
Passiamo alla questione postaci da Perchè No?:
Piccola domanda su un'idea inattesa. L'impero romano d'Oriente si è mantenuto in piedi per più di mille anni dopo il decesso dell’impero d’Occidente, conservando buona parte della cultura antica per poi trasmetterla all'Europa, senza parlare dello scudo rappresentato da Bisanzio contro l'onda araba del VII secolo e del peso di questa grande potenza sulle vicende italiane e europee. Cosa avviene se, pensando al caso peggiore, l'impero romano d'Oriente sparisce anche lui durante il V o VI secolo alla stessa maniera dell'impero fratello? Non sopravvive nessun impero romano durante il Medioevo. Carlomagno potrebbe tentare una doppia restaurazione, o vedremo la nascita di stati greco-barbarici con la possibilità di una restaurazione locale? Cosa avviene nella zona senza Bisanzio soprattutto nei confronti dei Persiani e poi degli Arabi e dei Turchi?
Una vasta ucronia, alla quale ne aggiungo un'altra: e se l'impero romano cadesse prima, diciamo direttamente alla fine del II o durante il III secolo, prima della cristianizzazione e prima che la romanizzazione sia universalmente diffusa nell'impero?
.
Gli risponde William Riker:
Bè, così su due piedi... l'Anatolia e i Balcani vengono islamizzati fin dall'Alto Medioevo, probabile conversione degli Avari all'Islam e - di conseguenza - anche della Rus di Kyev. Carlo Magno, sovrano cristiano per eccellenza, convince il suo amico Papa Adriano VII a bandire la Prima Crociata con tre secoli di anticipo sulla HL: Arabi di Spagna e Sassoni saranno lasciati in pace (anzi, Carlo si coprirà le spalle con trattati di pace con questi popoli), mentre i primi obiettivi delle campagne di Carlo saranno proprio gli Avari. Possibile la "liberazione" dei Balcani e la conquista di Costantinopoli. Alla morte di Ludovico, figlio di Carlo, il Sacro Romano Impero si rompe in tre: a Lotario Roma e l'Italia più il titolo imperiale, a Carlo il Calvo le nostre Francia e Germania, a Ludovico il Bizantino i Balcani e Costantinopoli. Ci sarà lo stesso lo Scisma d'Oriente? E la germanizzazione dei Balcani quali effetti avrà?
La caduta anticipata dell'Impero Romano provocherebbe invece il Volkwanderung anticipato dei Germani e la formazione anticipata di stati germanici, ma la penetrazione del Cristianesimo sarebbe più difficile, e forse ogni stato germanico adotterebbe una "versione" diversa del cristianesimo. I Sasanidi potrebbero arrivare al Mediterraneo e forse all'Egeo, se non all'Adriatico. La religione prevalente nel Mediterraneo potrebbe essere quella zoroastriana.
.
Ed ecco la pronta replica di quel diavolo d'un Bhrghowidhon:
Ottime ucronie, sono effettivamente momenti decisivi e non arriverei (pur da bizantino) a chiamarle "distopie: avrebbero prodotto una Storia abbastanza diversa, ma è da vedere se peggiore o no... Per la prima ucronia cambia notevolmente se il punto di divergenza si pone nel V. o nel VI. secolo; nel V. secolo e anche nel VI. fino al 568 si sarebbero formati Regni Romano-Germanici anche nella Penisola Balcanica, in particolare il Regno degli Ostrogoti, per cui forse in Italia e Cisalpina sarebbe rimasto quello degli Eruli, mentre dopo il 568 il Khanato degli Avari si sarebbe esteso fino a Bisanzio (se non si pone il punto di divergenza nel VII. secolo non è garantito che i Protobulgari si possano insediare sul Basso Danubio, di conseguenza la sopravvivenza della Latinità Balcanica è molto più aleatoria e al contrario si dànno gli estremi per una slavizzazione precoce della Tracia. Invariata sarebbe invece la conquista sāsānide di tutta la Prefettura dell'Oriente, con un anticipo di uno o due secoli della fine della Guerra dei Quattrocento Anni tra Roma e la Persia e perciò un molto probabile confinamento del''Islām nella Penisola Arabica; la Zoroastrianizzazione del Mediterraneo è quindi propria di tutta questa prima ucronia (il Mazdeismo o Mazdaismo svolgerebbe un ruolo simile a quello storico dell''Islām e in ogni caso per l'Europa Orientale, fino alla Rus' inclusa, resterebbe più probabile una Cristianizzazione, come anche per gli Avari; piuttosto, l'Arianesimo avrebbe maggiori possibilità di persistenza).
La seconda ucronia è di per sé presāsānide, lo scenario complessivo sarebbe caratterizzato dalle sicure presenze egemoniche dell'Imperium Galliārum (forse dalla Spagna alla Britannia), del Regno di Palmira, dell'Armenia e forse da un ruolo più di primo piano per i Parti; è possibile una restaurazione della Dacia indipendente (se non anche della Tracia), mentre come Regni Germanici emergerebbero quelli dei Goti e verosimilmente dei Bastarni, forse anche uno abbastanza solido dei Quadi e Marcomanni, mentre le altre tribù germaniche manterrebbero più a lungo la condizione di Comunità politiche distinte (senza fondersi in grandi Confederazioni tribali). In Africa è probabile un'espansione dei Getuli, forse fino al Mediterraneo, ma è evidente che la Nazione (neo)punica (almeno con la Sardegna e la Sicilia Occidentale) sarebbe una costante ineliminabile. È pressoché sicura la formazione di uno o più Regni in Grecia (anche Magna Graecia) e di certo resterebbe una continuazione italica dell'Impero Romano. A livello religioso, penserei a una ripresa in grande stile del Druidismo; il Cristianesimo sarebbe la Religione tipica dell'Anatolia e dell'Armenia, altrove nel Mediterraneo e nel Vicino Oriente sarebbe in concorrenza con l'Ebraismo, il Miθraismo e, a suo tempo (dopo questo periodo), il
Manicheismo.
.
Dario Carcano ha avuto un'altra idea geniale:
Maggioriano il Grande
Intorno al 450, l'imperatore d'Occidente Valentiniano III prese in considerazione la possibilità di dare in sposa la propria figlia minore Placidia al giovane Maggioriano, generale del seguito del potente magister militum Flavio Ezio che già si era distinto comandando la cavalleria a Vicus Helena contro i Franchi di re Clodione. L'imperatore non aveva figli maschi e sperava quindi che questo giovane comandante avrebbe messo fine alla successione di potenti generali che intendevano controllare l'imperatore (tra cui lo stesso Ezio); Maggioriano avrebbe avuto infatti la capacità di condurre di persona l'esercito romano, e risolvere contemporaneamente il problema della successione. Questo proposito cozzava col desiderio di Ezio di imparentarsi con la famiglia imperiale: il magister militum pose quindi fine della carriera militare di Maggioriano allontanandolo dal proprio seguito e costringendolo a ritirarsi nella sua proprietà in campagna.
E se Valentiniano vince le resistenze di Ezio e fa entrare Maggioriano nella famiglia imperiale? Sicuramente si indebolirebbe la posizione di Ezio, che potrebbe essere ucciso anticipatamente rispetto alla HL, forse poco tempo dopo la vittoria su Attila presso i Campi Catalaunici; se non addirittura prima, e in tal caso sarebbe Maggioriano a guidare i romani a Chalôn. Però Valentiniano avrebbe un successore capace, rafforzando la sua posizione abbastanza da non essere ucciso nel 455; Valentiniano III era il simbolo attorno al quale si coagulava la lealtà delle province romane, che dopo il suo assassinio si sfaldò in breve tempo, ma un suo regno più lungo vorrebbe dire, ovviamente, che tale lealtà durerebbe più a lungo. Inoltre, Maggioriano si troverebbe in una posizione di maggior forza rispetto a quando fu imperatore in HL, in quanto prenderebbe il posto di Ezio come magister militum e, forse, Valentiniano se lo assocerebbe come co-imperatore. Avrebbe un ampio margine di manovra per riformare l’impero e se dal suo matrimonio con Placidia riesce ad avere un erede, la successione sarebbe assicurata per un’altra generazione.
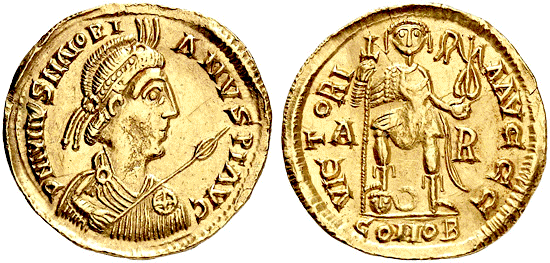
450
Valentiniano III vince le
resistenze di Ezio e riesce a combinare il matrimonio tra Maggioriano e
Placidia; la posizione del magister militum si indebolì notevolmente: la sua
intenzione era imparentarsi con la famiglia imperiale affinché potesse essere
lui, o suo figlio, a succedere a Valentiniano, ma ciò non fu più possibile con
un comandante capace come genero dell’Imperatore, e suo probabile erede. Ezio,
che aveva ormai perso la fiducia dell’imperatore, cadde in disgrazia e venne
ucciso discretamente quello stesso anno; Maggioriano prese il suo posto come
magister militum.
In oriente Marciano, appena asceso al trono, decise di sospendere i pagamenti ad
Attila, che pertanto iniziò a guardare a occidente dopo che la sorella di
Valentiniano, Giusta Grata Onoria, per sfuggire ad un matrimonio impostole dal
fratello aveva inviato un eunuco a recapitare una richiesta di aiuto al re degli
Unni, che fu da questi interpretata come una proposta di matrimonio e richiese
all'Imperatore d'Occidente, come dote per il matrimonio, metà dell'Impero
d'Occidente. All'ovvio rifiuto di Valentiniano III, Attila ebbe il pretesto per
invadere l'Impero d'Occidente.
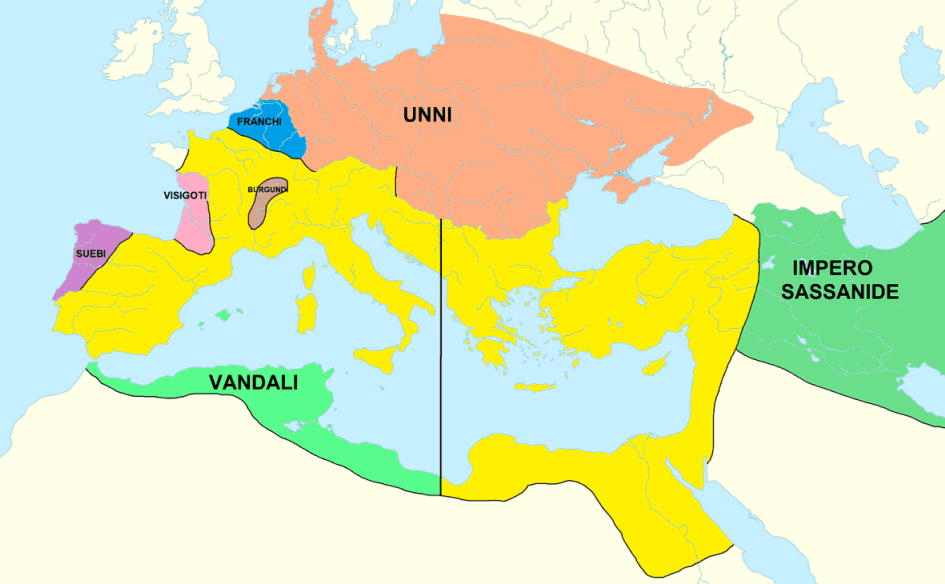
451
Attila invade la Gallia.
Informato dell'invasione, il magister militum Maggioriano si affrettò a
rafforzare il suo esercito: egli era al comando di poche e sparse truppe
ausiliarie – cioè mercenarie, e non aveva ai suoi ordini nessun soldato
regolare. Pertanto cercò subito di convincere il re dei Visigoti, Teodorico I,
ad unirsi a lui, senza peraltro ottenere troppo successo, in quanto quest'ultimo
sapeva che le truppe di Maggioriano erano veramente esigue, e riteneva che fosse
più saggio attendere nelle proprie terre l'eventuale arrivo di Attila.
Maggioriano allora chiese aiuto al magister militum locale, Avito, che riuscì a
convincere ad unirsi a Maggioriano non soltanto Teodorico, ma anche un buon
numero di altri barbari presenti in Gallia. Quest'esercito, composto quindi da
popolazioni diverse, si diresse alla volta di Aurelianum, assediata dagli Unni,
dove giunse il 14 giugno, dopo che il 7 aprile gli Unni avevano già saccheggiato
Divodurum.
Secondo l'autore della Vita sancti Aniani l'esercito di Maggioriano raggiunse
Aurelianum appena in tempo per salvarla dalla distruzione, quando già gli Unni
avevano aperto una breccia nelle mura ed avevano introdotto un primo contingente
all'interno della città. La comparsa all'orizzonte della nube di polvere
sollevata dalle truppe in avvicinamento convinse Attila della necessità di
interrompere la conquista della città e di iniziare una ritirata verso nord-est,
per evitare il rischio di passare da assediante ad assediato, e nella speranza
di trovare un terreno più favorevole allo scontro.
Teodorico e Maggioriano non si accontentarono di aver liberato Aurelianum, ma
procedettero all'inseguimento degli Unni in ritirata.
I due eserciti si scontrarono ai Campi Catalaunici il 20 giugno del 451.
Seguendo le usanze unne, Attila chiese ai suoi indovini di esaminare le
interiora di una vittima sacrificale durante la notte precedente alla battaglia.
Questi predissero che il disastro incombeva sugli Unni, ma che d'altro canto uno
dei capi dei loro nemici sarebbe caduto nella battaglia. Interpretando questo
vaticinio come un auspicio della morte di Giulio Valerio Maggioriano, Attila
decise di affrontare il rischio di una sconfitta pur di vedere morto il suo
nemico, e diede l'ordine di disporsi alla battaglia, ma decise di ritardarne
l'inizio fino al pomeriggio (nona ora) in modo che il tramonto imminente
limitasse i danni in caso di sconfitta.
Nella piana catalauna si levava una collina dai versanti piuttosto ripidi che
dominava il campo di battaglia ed era strategicamente importante da controllare,
per cui divenne il centro dei combattimenti. Mentre gli Unni tentavano di salire
dal lato destro della collina, i Romani cercavano di fare lo stesso dal lato
sinistro, senza che nessuno riuscisse però inizialmente ad occuparne la sommità.
Quando gli Unni riuscirono a guadagnare la sommità del rilievo, trovarono che i
Romani l'avevano occupata prima di loro, e ne furono respinti. I guerrieri unni
ripiegarono disordinatamente, portando lo scompiglio all'interno delle loro file
e causando il collasso dell'intero schieramento unno. Attila cercò di
riorganizzare le sue truppe per mantenere la posizione. Nel frattempo fu ucciso
Teodorico I, re dei Visigoti, mentre guidava i suoi uomini all'assalto dei
nemici in rotta. I Visigoti, proseguendo nella loro carica, arrivarono a
minacciare dappresso l'incolumità dello stesso Attila, costretto a cercare
rifugio nel suo campo, che aveva provveduto a fortificare disponendo
opportunamente i suoi carri. La carica dei Romano-Goti era ormai sul punto di
travolgere le difese del campo di Attila, quando sopravvenne il tramonto.
Torismundo, figlio del re Teodorico, rientrando nelle proprie linee, entrò per
sbaglio nell'accampamento di Attila, dove rimase ferito prima che i suoi uomini
potessero metterlo in salvo. Lo stesso Maggioriano perse il contatto con i suoi
uomini a causa dell'oscurità, e, temendo fossero stati sbaragliati, trascorse il
resto della notte con gli alleati Goti.
Il giorno seguente, non mostrando gli Unni alcuna intenzione di avventurarsi
fuori dal loro campo, i Romani ed i loro alleati cominciarono a tempestare di
frecce l'accampamento di Attila e vi posero l'assedio, contando sul fatto che
gli Unni potessero essere a corto di vettovagliamenti. Attila, assediato ed
anche a corto di frecce, cominciò a temere seriamente la disfatta, e fece
erigere al centro del suo campo una catasta costituita dalle selle dei cavalli
dei suoi guerrieri, da utilizzare come pira funeraria per se stesso, per non
cadere vivo nelle mani dei suoi nemici. Mentre Attila era intrappolato nel suo
campo, i Visigoti si posero alla ricerca del loro re Teodorico. Quando, dopo una
lunga ricerca, trovarono il corpo del re sotto una montagna di cadaveri, suo
figlio Torismundo si accinse ad assaltare il campo unno. Maggioriano non riuscì
a contenere la foga del principe visigoto, e i Romano-Goti diedero l’assalto
finale, che si concluse con l’annientamento degli Unni e il suicidio di Attila.
Senza di lui, il suo impero si sfaldò in pochissimo tempo.
Dopo la battaglia, Torismondo dovette frettolosamente tornare a Tolosa dove,
saputo della morte di Teodorico, suo fratello Teodorico (II) si era proclamato
re. Era l’inizio di una guerra civile che avrebbe impedito ai Visigoti di
approfittare di quel momento favorevole per aumentare il loro potere sulla
regione.
Quell’anno Placidia partorì il primo figlio di Maggioriano, chiamato
Valentiniano in onore del nonno materno.
452
Campagna di Maggioriano contro
i Vandali. Aveva deciso di attuarla in quello che gli sembrava il momento
migliore, con i Visigoti impegnati in una guerra civile e gli Unni distrutti.
Nell’accampamento degli Unni era stato catturato un grosso tesoro, che fu usato
per assoldare i mercenari da impiegare nella spedizione, comandata, oltre che da
Maggioriano, da due generali a lui vicini: il suebo-visigoto Ricimero e il gallo
Egidio.
Il primo scontro si ebbe al largo delle coste africane tra i vandali e la flotta
di Ricimero, e fu quest’ultima ad avere la meglio; la vittoria della flotta di
Ricimero permise all’esercito di terra di sbarcare a Hippo Diarrhytus, da dove i
Romani marciarono verso Cartagine. I Vandali di Genserico e Unnerico attesero
l’esercito romano presso Tunisi, dove il 13 settembre avvenne la battaglia. I
Vandali erano almeno tre volte più numerosi dei Romani, ma Maggioriano fece un
ottimo discorso d'incoraggiamento: “Perché non è con il numero dei soldati, né
con le dimensioni dell'esercito che si decide una guerra, ma con il valore
dell'anima”
Le due forze si incontrarono appena fuori la città e la cavalleria romana
immediatamente ruppe le linee Vandale attaccando e ritirandosi per tre volte.
Durante la terza carica Unnerico fu ucciso sotto gli occhi di Genserico che,
furibondo, fece suonare la carica; i guerrieri però, anche a causa delle pesanti
perdite già subite dai Vandali, credettero che il re avesse fatto suonare la
ritirata, dando inizio ad un ripiegamento che in breve tempo divenne una rotta
disordinata. Procopio di Cesarea riferisce che almeno i due terzi dell’armata
Vandala furono massacrati dai Romani durante la rotta verso Tunisi, dove i resti
dell’armata trovarono rifugio. Già il giorno dopo la battaglia Maggioriano inviò
Egidio, assieme ad una parte del suo esercito, a riconquistare Cartagine, mentre
Genserico era assediato dai Romani a Tunisi. Il 15 settembre Cartagine era stata
ripresa, mentre Genserico resistette a Tunisi fino a dicembre quando, resosi
conto che ormai la guerra era persa, si suicidò per non cadere prigioniero dei
Romani.
L’Africa era stata riconquistata, e Maggioriano ottenne da Valentiniano III la
nomina a co-Augusto dell’Impero Romano d’Occidente. Ricimero divenne il nuovo
magister militum.
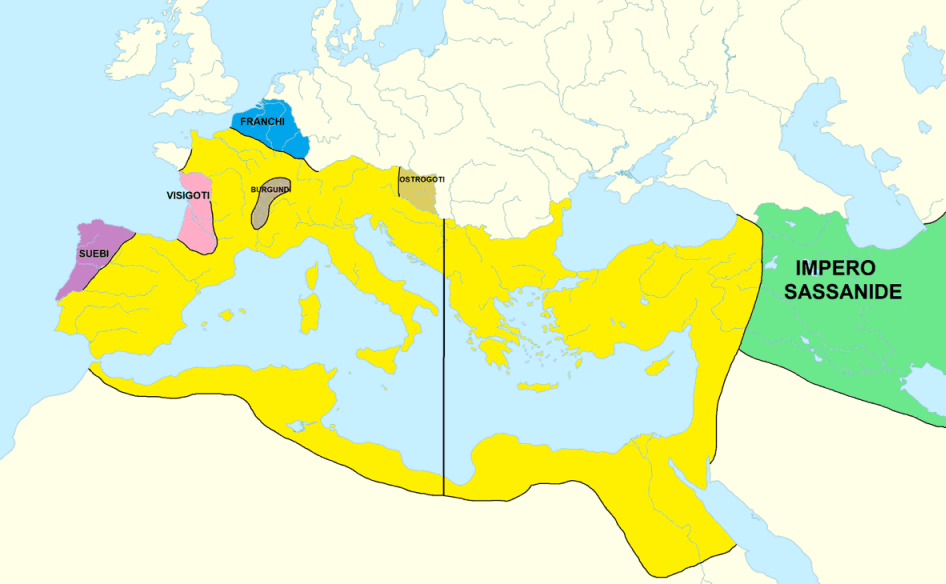
453-456
Questi anni furono spesi dal
co-Imperatore Maggioriano in una frenetica attività legislativa volta a
riformare l’Impero e far riprendere l’economia. In realtà, già i consiglieri di
Valentiniano III si erano impegnati nel varare riforme e provvedimenti volti a
risolvere la grave crisi in cui versava l’Impero che però, come la maggior parte
delle leggi dell’epoca, erano rimaste lettera morta. Maggioriano invece, a
differenza del suocero, si impegnò a far sì che le sue riforme fossero realmente
applicate attraverso frequenti viaggi nelle provincie per incontrare i
governatori locali.
Il co-Augusto volle anche contenerne gli della classe senatoriale, in quanto
molti senatori erano ormai abituati a coltivare il proprio potere locale a
scapito del potere centrale, giungendo persino a non pagare le tasse e a non
rimettere allo stato centrale quelle riscosse. Questo atteggiamento danneggiava
tutto l'apparato statale, poiché il peso delle tasse ricadeva sui possidenti
terrieri di rango inferiore, sui cittadini e sui funzionari locali, come i
decurioni, responsabili di rifondere tutte le tasse non esatte, portando ad un
fenomeno di abbandono della carica cui aveva già dovuto fare fronte l'imperatore
Giuliano (361–363). Del resto, dato l'elevato credito fiscale pregresso,
Maggioriano era cosciente del fatto che una politica di rigore nell'esazione
delle tasse non avrebbe avuto successo senza un condono che cancellasse gli
enormi debiti dell'aristocrazia con l'erario statale.
L'11 marzo 453 fu promulgata la Novella Maioriani, intitolata De indulgentiis
reliquorum («Remissione dei debiti pregressi»), una legge con la quale
Maggioriano rimise tutti i debiti fiscali maturati fino al 1º gennaio di quell'anno
da parte dei proprietari terrieri; la stessa legge toglieva il diritto di
esigere le tasse a tutti gli ufficiali pubblici, che avevano dimostrato di
tenere per sé la maggior parte delle tasse raccolte, riconsegnandolo ai soli
governatori. Anche la successiva Novella Maioriani IV, promulgata il 4 settembre
e intitolata De bonis caducis sive proscriptorum («Le proprietà abbandonate e
quelle appartenenti ai proscritti»), aveva lo scopo di riordinare il fisco
imperiale, proibendo abusi nella raccolta. L'8 maggio 453 fu promulgata la
Novella Maioriani II, De defensoribus civitatum («I difensori civici»), con la
quale il co-Imperatore intendeva rinvigorire la figura del defensor civitatis,
nata per rappresentare gli interessi dei cittadini vessati dall'amministrazione
pubblica, specie per quanto riguardava le questioni fiscali: la figura non era
caduta in disuso, ma aveva perso di efficacia in quanto tale carica era
ricoperta proprio da coloro che vessavano la popolazione. Il 6 novembre dello
stesso anno Maggioriano promulgò la Novella Maioriani VI, intitolata De
curialibus et de agnatione vel distractione praediorum et de ceteris negotiis
(«I decurioni e la ricezione in eredità e l'alienazione delle proprietà e altre
questioni»), con la quale perdonava le passate infrazioni ma impediva ai
decurioni di abbandonare il proprio rango sposando schiave o donne imparentate
con umili fattori e proibiva loro di alienare i propri terreni.
Come detto in precedenza, Maggioriano intraprese numerosi viaggi nell’Impero per
far sì che tali leggi fossero applicate. Fu proprio durante questi viaggi che si
rese conto dello stato di abbandono in cui versavano molti latifondi, spesso
lasciati incolti per pagare meno tasse. Il 4 ottobre 454 a Cartagine promulgò la
Novella Maioriani XII, De latifundis, con cui stabiliva fosse fatto un
censimento di tutte le terre coltivabili dell’Impero e che le terre incolte
fossero espropriate ai proprietari e divise tra i nullatenenti della provincia,
che sarebbero stati a loro volta censiti in apposite liste; le terre sarebbero
state date loro in usufrutto in cambio della decima parte del raccolto, e non
potevano essere né vendute né cedute.
Altro provvedimento che il co-imperatore prese in quegli anni fu la Novella
Maioriani V, De sanctimonialibus vel viduis et de successionibus earum («Sulle
donne che prendono i voti e le loro eredità»), in cui fissava l'età minima per
prendere i voti a 40 anni: con l'avvento del Cristianesimo, si era diffusa tra
le famiglie facoltose la pratica di far prendere i voti alle proprie figlie,
allo scopo di non disperdere il patrimonio famigliare. Maggioriano considerò
questa pratica dannosa per lo Stato: sia perché impediva a giovani donne romane
di procreare dei figli, utili all'Impero, sia in quanto riteneva che l'obbligo
di prendere il voto di castità avrebbe spinto queste ragazze verso unioni
illegali. Infatti Maggioriano riteneva che 40 anni fossero un’età alla quale le
pulsioni sessuali delle iniziate fossero ormai sopite. La stessa Novella
Maioriani V concedeva inoltre alle donne che erano state obbligate a prendere i
voti, ed erano state successivamente diseredate, di avere gli stessi diritti dei
propri fratelli e sorelle sull'eredità dei genitori.
Nel 453 nacque il secondogenito di Maggioriano, Teodosio.
457
Il 26 gennaio muore
l’Imperatore d’Oriente Marciano; il ramo della casata teodosiana discendente da
Arcadio si era già estinto con la morte dell’Augusta Elia Pulcheria quattro anni
prima. Valentiniano III rivendicò per sé anche il trono d’Oriente in quanto
marito della figlia di Teodosio II, Licinia Eudossia, e, con l’approvazione di
Maggioriano, inviò a Costantinopoli il magister militum Ricimero al comando di
un esercito a rivendicare i suoi diritti.
L’esercito di Ricimero affrontò fuori Costantinopoli le truppe di Leone il Trace,
insediato sul trono d’Oriente dal potente magister militum Aspare, che fu
sconfitto e inviato prigioniero a Ravenna dove Maggioriano gli risparmiò la
vita, pur trattenendolo a corte come prigioniero.
Il 12 maggio Valentiniano III e Maggioriano furono incoronati co-Augusti
d’Oriente, riunificando l’Impero.
458
Maggioriano estende
all’Oriente le riforme già applicate alla parte occidentale dell’Impero. L’11
luglio 458 venne promulgata la Novella Maioriani XIV, De aedificiis pubblicis
(«Sugli edifici pubblici»), primo provvedimento volto a tutelare gli edifici di
Roma; essa riservava all'imperatore o ai senatori la potestà di decidere se vi
fossero le condizioni estreme che giustificassero la demolizione di un edificio
antico; la pena per i magistrati che si arrogavano il diritto di concedere i
permessi era di 50 libbre d'oro, mentre i loro subordinati sarebbero stati
frustati e avrebbero avuto entrambe le mani amputate.
Grazie alla migliorata situazione delle casse statali dovuta al rientro
dell’Africa nei domini imperiali e alle riforme economiche di Maggioriano, fu
possibile da un lato concedere una diminuzione delle imposte, dall’altro
aumentare il numero di truppe regolari nell’esercito, riducendo il peso degli
ausiliari (come sopra, leggi “mercenari”) barbari.
459
Il re dei Visigoti Torrismondo
viola il patto di alleanza con Roma, cercando di annettersi Arleate e di
espandersi in Spagna; contemporaneamente, anche i Suebi avviano campagne
militari volte a ripetere le conquiste di re Rechila, iniziando l’assedio di
Emerita Augusta. Appena saputo della doppia invasione, Maggioriano e
Valentiniano III furono concordi nel decidere di estirpare una volta per tutte
quelle spine nel fianco dell’Impero: alla testa di un esercito di 30.000
soldati, in gran parte regolari, Maggioriano partì per affrontare l’ex alleato
Torrismondo. Il 12 giugno giunse ad Arleate, liberando la città dall’assedio,
poi, non contento, affrontò i Visigoti a Nemasus ottenendo una vittoria
schiacciante. Siccome nel frattempo anche i Burgundi avevano iniziato una
campagna di conquista conquistando Lugdunum, il magister militum Ricimero fu
inviato a Nord con 10.000 soldati per riconquistare la città gallica e
sconfiggere i Burgundi, mentre Maggioriano si addentrava nel territorio visigoto
col grosso dell’esercito. Lugdunum fu ripresa il 7 ottobre, mentre Tolosa,
capitale dei Visigoti, fu espugnata il 24 dello stesso mese: Torrismondo fu
ucciso mentre tentava di fuggire, mentre Maggioriano diede ordine di trucidare
tutti i Visigoti che abitavano la città; secondo Procopio di Cesarea, in un solo
giorno furono uccisi 50.000 visigoti, tra combattenti, donne, anziani e bambini.
Intanto Ricimero inflisse una sconfitta decisiva ai Burgundi presso Genava,
battaglia in cui fu ucciso Gundioco, re dei Burgundi.
Entrambi gli eserciti si fermarono a svernare dopo questi successi, Maggioriano
a Tolosa e Ricimero a Geneva.
Intanto anche gli Ostrogoti di Valamiro dalla Pannonia iniziarono a compiere
attacchi ai territori dell’Impero; contro di loro fu inviato Marcellino, comes
rei militaris dell’Illirico, che sconfisse Valamiro a Siscia, Sopianae e alla
fine inflisse agli Ostrogoti la sconfitta definitiva sul Pleso, dopo la quale
gli Ostrogoti furono costretti ad accettare una pace gravosa che prevedeva il
pagamento di un tributo in oro all’Impero.
460
Riprendono le campagne di
Maggioriano e Ricimero. L’Augusto si diresse verso Burdigala, ultima piazzaforte
dei Visigoti, mentre il magister militum affrontò un nuovo esercito burgundo
comandato da Chilperico sul lago Lemano; la battaglia del lago Lemano vide una
nuova vittoria Romana, che spianò la strada alla conquista di Aventicum.
Maggioriano espugnò Burdigala il 13 giugno di quell’anno, ponendo fine al regno
Visigoto; i Visigoti sopravvissuti alla battaglia furono ridotti in schiavitù,
stessa sorte toccò ai Burgundi dopo la conquista di Aventicum. Restavano i Suebi,
che espugnata Emerita Augusta avevano avviato l’assedio della strategica
Myrtilis Iulia. Saputo della sconfitta di Burgundi e Visigoti, Rechiaro cercò
disperatamente di avviare una trattativa di pace con Maggioriano, ma ormai il
tempo delle trattative era finito: l’Augusto aveva deciso che il destino di
Burgundi, Visigoti e Suebi sarebbe stato un esempio per tutti i sovrani
foederati all’Impero affinché non provassero a violare il patto di amicizia con
Roma.
Maggioriano e Ricimero si riunirono a Narbo per poi marciare fino a Toletum,
dove l’esercito si fermò a svernare.
461
In primavera i Romani
riconquistarono Emerita Augusta e liberarono Myrtilis Iulia dall’assedio dei
Suebi, per poi affrontare Rechiaro a Pax Iulia: Procopio di Cesarea scrive che
la battaglia terminò senza vincitori né vinti, in quanto, al sopraggiungere del
tramonto, non c’era ancora un chiaro vincitore. Rechiaro poté ripiegare fino a
Olisipo, dove il 23 agosto vi fu una nuova battaglia, questa volta una netta
vittoria dei Romani. I Suebi furono costretti a ritirarsi a nord del Durius dopo
la caduta di Scallabis il 9 ottobre. Poi, di nuovo, la guerra si fermò per
l’inverno.
462
Il 4 aprile si svolse la
battaglia di Bracara: l’esercito Romano affrontava nuovamente i Suebi di
Rechiaro. Lo scontro fu vinto dai Suebi, ma ad un prezzo talmente elevato in
termini di caduti che, di fatto, fu una ulteriore vittoria di Maggioriano che,
al contrario, nonostante la sconfitta riuscì a far ritirare ordinatamente le sue
truppe fino a Scallabis, dove l’Augusto attese l’arrivo dei rinforzi portati da
Egidio, giunti i quali, poté riprendere l’offensiva in territorio nemico e
prendersi la rivincita nella decisiva battaglia di Portus Cale il 21 giugno;
dopo quella vittoria, anche il regno Suebo cessò di esistere: i barbari
superstiti furono ridotti in schiavitù, come già fatto per Visigoti e Burgundi.
Dopo i successi contro dei Romani contro Visigoti, Suebi e Burgundi, il re dei
Franchi Childerico I, terrorizzato dalla prospettiva che il suo popolo potesse
fare la stessa fine, si precipitò a Ravenna per rinnovare agli Augusti
Valentiniano III e Maggioriano la sua alleanza. Dopo decenni l’Impero poteva
nuovamente trattare coi barbari da una posizione di forza: Maggioriano concesse
a Childerico I la sovranità sui territori della Gallia Belgica e della Germania
Inferiore occupati dai Franchi riconoscendogli il titolo di Rex Francorum,
tuttavia sarebbe stato subordinato agli Augusti Maggioriano e Valentiniano III,
con l’obbligo di pagare all’Impero tributi e fornire mercenari; altra condizione
posta a Childerico fu che lui e il suo popolo si convertissero al cristianesimo.
463
A 44 anni muore l’Augusto
Valentiniano III a causa di una malattia. Maggioriano, rimasto il solo padrone
dell’Impero, conferì il titolo di Augusto ai figli Valentiniano IV e Teodosio
III, rispettivamente di dodici e dieci anni.
Come proseguirla?
.
Chiudiamo per ora con la proposta di Marco Mocchetti:
L'Impero Romano d'Occidente non cade nel 476, ma la sua autorità sopravvive in Italia... l'invasione longobarda viene fronteggiata con un discreto successo (anche perché le elite italiche non la appoggiano) e si limita alla perdita dell'Italia nordorientale... La città di Roma diviene autonoma e viene gestita direttamente dal Papa, ma il resto d'Italia è sotto l'autorità imperiale, che nel corso del 6°/7° secolo si rafforza e stabilizza... Come si rapporta uno stato italico unito, erede della tradizione romana, con i nuovi popoli germanici, Franchi in primis? Mantenendo l'unità nazionale, l'Italia può divenire una potenza nel corso dell'età moderna, magari al posto della Spagna (che si unifica definitivamente solo nel 1492)? Carlo Magno fonda cmq un impero, da cui poi deriverà il SRI? Come si pone esso in rapporto con l'Impero Romano d'Occidente? Quali sono i rapporti tra Occidente e Oriente e tra Occidente e papato?

.
Per contribuire alla discussione, scriveteci a questo indirizzo.
