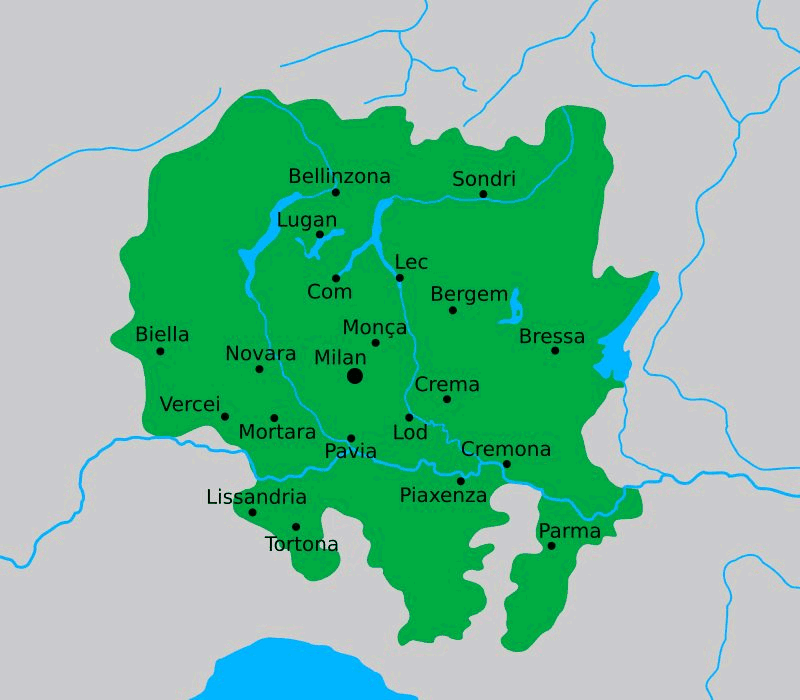Per primo
prende la parola a Generalissimus:
Papa Stefano IX aveva intenzione di incoronare Imperatore suo fratello Goffredo il Barbuto, nonché di aiutarlo a strappare il meridione ai Normanni, ma poco dopo la sua elezione venne colpito da una grave malattia dalla quale si riprese solo parzialmente e per poco tempo prima di morire.
Ma cosa accadrebbe se Stefano IX non si ammalasse, vivesse altri 30 anni, incoronasse suo fratello e cacciasse insieme a lui i Normanni dal sud Italia? E che farà la Reggente Agnese del Sacro Romano Impero?
.
Ed ecco come Federico
Sangalli ha deciso di sviluppare questa ucronia:
1. Lunga vita a Stefano IX!
Non pochi si stupirono, a Firenze, quando il Sommo Pontefice Stefano IX, al secolo Federico di Lorena, riuscì a rimettersi da una fulminea quando grave malattia che lo aveva colpito nella primavera del 1058 e molti gridarono al miracolo. Effettivamente si può senz'altro dire che fu un momento decisivo, giacché una eventuale morte di Papa Stefano IX appena otto mesi la sua elezioni al Soglio Pontificio come successore di Vittore II avrebbe senza dubbio cambiato radicalmente la Storia. Il Papa trentottenne ritornò ben presto a Roma e continuò i suoi sforzi di riforma ecclesiastica, sopratutto in favore del perentorio celibato dei religiosi, ma i suoi progetti erano decisamente più ambiziosi: il Sacro Romano Impero stava attraversando un momento di grande incertezza, giacché due anni prima era morto l'Imperatore Enrico III e il suo unico, omonimo figlio aveva soltanto otto anni. L'Impero era retto dalla debole ed inesperta Imperatrice Reggente Agnese che, disprezzata e non considerata dalla grande nobiltà tedesca, aveva perso con la morte di Vittore II il suo principale alleato ed era di giorno in giorno più debole. Stefano IX inoltre era stato uno dei primi papi eletti senza il consenso imperiale e non aveva intenzione di stare al servizio dell'Imperatrice, anzi iniziò ad incoraggiare i nobili contrari alla sua reggenza. Nel 1060 Agnese era ormai particolarmente presa di mira e la sua autorità valeva ben poco per cui decise di abbandonare la politica, ritirandosi in convento e lasciando il giovanissimo Enrico alle cure di un nuovo reggente da lei nominato, il Vescovo di Augusta Enrico. Tuttavia né i nobili né il Papa riconobbero tale mossa e lo stesso Enrico d'Augusta dovette rinunciare alla reggenza su ordine papale: il giovane Enrico venne rispedito nei suoi feudi (ormai ridotti a poca cosa visto che Agnese aveva dovuto cederne numerosi ai nobili tedeschi per tenerseli buoni) e la Notte di Natale del 1060 Papa Stefano IX poté coronare il suo sogno, ovvero suo fratello, il Duca di Lorena Goffredo il Barbuto, come Sacro Romano Imperatore col nome di Goffredo I. Il nuovo Imperatore, che era stato a lungo un oppositore di Enrico III, ottenne l'appoggio anche dei nobili tedeschi e come prima cosa decise di riparare ai torti e alle intromissioni subite durante il regno di Enrico III: si rimpossessò così pienamente dei suoi possedimenti come Duca di Alta e Bassa Lorena (Lotaringia) e Conte di Verdun, sottrattigli da Enrico III e assegnati a Federico di Lussemburgo. In questo modo Goffredo ebbe quello che mancò ad Agnese, ovvero una solida base di potere fondata su un territorio governato direttamente da lui. Egli inoltre si premurò di curare gli interessi imperiali e papali (cioè praticamente gli interessi di famiglia) in Italia: strinse una solida alleanza con il Papato, sposò suo figlio con Matilde di Canossa e si accordò con Barisone I di Torres, Giudice di Arborea, in Sardegna, per difenderlo dalle mire della Repubblica di Pisa. Nel 1064 compì la sua prima discesa in Italia a scopo militare: Barisone I, volendo intraprendere una politica di immigrazione monastica in Sardegna, aveva infatti chiesto ed ottenuto da Desiderio, Abate di Montecassino (che in HL divenne anche Papa Vittore III) l'invio di un gruppo di monaci per fondare monasteri sull'isola e questi ne aveva inviati dodici, con anche reliquie sacre, libri preziosi e altri oggetti sacri ma i monaci erano stati catturati durante il viaggio dai pisani che intendevano chiedere un riscatto ed ostacolare le relazioni tra i sardi e la penisola. Sia Barisone I sia Papa Stefano IX pregarono così l'Imperatore di vendicare l'affronto e questi, giudicandola una buona occasione per mostrare il suo potere in Italia, marciò su Pisa, costringendo la città toscana a restituire il maltolto e a liberare i prigionieri. A seguito di questo evento l'Impero pose de facto un protettorato sulla Sardegna e limitò notevolmente l'autonomia pisana che era pur sempre in territorio imperiale: solo la mediazione dei Canossa impedì l'annessione diretta ai feudi dell'Imperatore. Comunque tale discesa fu nulla in confronto alla Guerra di Liberazione Normanna del 1066. I Normanni infatti, guidati da Roberto il Guiscardo, si erano impossessati del Meridione e della Sicilia, scacciandone sia gli arabi sia i bizantini, e inizialmente si erano dimostrati amici del Papa ma ben presto avevano iniziato a dimostrargli ostilità per le sue rivendicazioni di vassallaggio sui sovrani meridionali. Nel 1066, prendendo a pretesto i violenti scontri tra alcune fazioni politiche romane, il Guiscardo invase il Lazio con l'obbiettivo neanche tanto nascosto di prendere prigioniero Stefano IX, che da tempo agognava a mettere le mani sul Meridione. Immediatamente suo fratello e Sacro Romano Imperatore Goffredo I discese in Italia per salvaguardare il Papato e il caro congiunto e si sprecarono i poemi che lo paragonarono a Carlo Magno che accorreva contro i Longobardi: davanti alle truppe imperiali, Roberto abbandonò il Lazio e ripiegò verso Sud ma dovette alla fine accettar battaglia nei pressi di Pontecorvo, a poca distanza da Monte Cassino. Lo scontro fu molto cruento e si concluse soltanto quando Roberto venne colpito a morte da una freccia mentre caricava per l'ennesima volta con la sua cavalleria le file imperiali, gettando nel caos il proprio esercito e permettendo a Goffredo di annientarne una larga parte. I pochi nobili superstiti, tra cui molti esponenti locali, in particolare siculi, ostili al dominio normanno, si affrettarono a giurare fedeltà al vincitore e questo pose fine al conflitto. I due fratelli, Goffredo I e Stefano IX, s'incontrarono e si abbracciarono poco dopo la battaglia presso l'Abbazia di Monte Cassino e lì stabilirono la spartizione dei territori normanni: il vassallaggio papale sul Meridione venne trasformato in dominio diretto, con lo Stato della Chiesa si annesse Napoli con gran parte della Campania e degli Abruzzi mentre i Ducati di Puglia e Calabria diventavano feudi papali, governati da nobili locali dietro nomina e fedeltà al Pontefice. Per parte sua Goffredo ottenne la Corona di Sicilia, gli venne confermato il protettorato sulla Sardegna e Pisa e il fratello gli conferì il titolo di Defensor Fidei. Tre anni dopo Goffredo I morì e Stefano IX non ebbe problema a confermare suo figlio (e dunque suo nipote) Goffredo II il Gobbo. Goffredo II era meno filopapale del padre e in particolare sosteneva la posizione imperiale nella Lotta per le Investiture ma sua moglie, l'Imperatrice Matilde di Canossa, fu sempre molto abile nel mediare. In effetti molti vedono in Matilde la vera mente dietro al trono e sicuramente si trattò di una delle donne più abili e potenti della sua epoca: ella si adoperò per allargare i domini dei Canossa su gran parte dell'Italia Centro-Settentrionale (comprese la totalità di Emilia, Lombardia, Romagna e Toscana) e, alla morte di Papa Stefano IX dopo ben 31 anni di pontificato, nel 1088, fu sempre lei a proporre ed ad appoggiare l'elezione di un suo lontano parente, il Vescovo di Ravenna Guiberto Giberti, che prese il nome di Clemente III. Suo marito l'Imperatore si dimostrò poco attento alle vicende italiche, almeno rispetto al padre, e preferì sfruttare la sua posizione di forza per rifarsi sugli storici nemici, in particolare i Conti di Fiandra e d'Olanda, a lungo avversari per il dominio della Lorena, a cui sottrasse diversi territori. Fu comunque nuovamente Matilde a gestire con la consueta abilità il principale problema dell'ultima parte del regno di Goffredo II, ovvero la successione: Goffredo e Matilde infatti non avevano avuto figli maschi ma soltanto due femmine, Beatrice e Ida, di cui la prima morta in tenera età. Goffredo II aveva scelto come proprio erede suo nipote, Goffredo di Buglione, figlio di sua sorella, la futura Beata Ida, Contessa di Boulogne (Buglione è l'italianizzazione di Boulogne), ma non si era preoccupato di far accettare e confermare questa scelta cosicché la successione era in realtà incerta, essendo finito il ramo maschile principale del Casato delle Ardenne e non essendoci un meccanismo certo per l'ascesa alla guida dell'Impero, a parte la consacrazione e l'incoronazione da parte del Papa. Matilde si adoperò innanzitutto per convincere i numerosi nobili tedeschi a supportare la sua candidatura, portando dalla sua sopratutto i filopapali, guidati da Rodolfo di Svevia e dai Guelfi di Baviera, che conoscevano il carattere pio e religioso del candidato, e ottenendo così il riconoscimento per Goffredo della carica di Vicario Imperiale in Italia, de facto un riconoscimento tale da paragonarsi ad una vera e propria designazione alla successione. Ella inoltre si affrettò, con l'aiuto di Clemente III, a far sposare la sua unica figlia Ida con il (di conseguenza suo) cugino Goffredo di Buglione, riconoscendolo e legittimandolo quindi come parte della famiglia e permettendogli di rivendicare quindi anche i possedimenti dei Canossa. Quando l'Imperatore Goffredo II il Gobbo morì nel 1094 Matilde era, fortunosamente, ancora viva e vegeta e gestì la transizione verso la nuova Dinastia dei Boulogne: Clemente III incoronò Goffredo Imperatore a Roma in brevissimo tempo e questa legittimità, unita alla forte guida e ai consigli di Matilde, permisero al neo incoronato Goffredo III di sconfiggere facilmente il tentativo di usurpazione di Enrico di Franconia (il nostro Enrico IV), figlio dell'ex Imperatore Enrico III. Nessuno infatti ricordava con gran favore il regno di suo padre né quello di sua madre, l'Imperatrice Agnese, e raccolse pertanto scarso consenso. L'Imperatore Goffredo III è famoso sopratutto per essere stato il principale sovrano europeo a rispondere all'Appello di Clermont (1095, Francia), pronunciato dal Cardinal Ottone de Chattilon (il nostro Urbano II) per conto di Papa Clemente III, con cui si esortavano i Re europei a d accorrere a difendere Gerusalemme e la Terra Santa dalle armate musulmane che le avevano invase. Nell'agosto del 1096 egli partì alla testa di un'armata di quasi 30 000 soldati e, attraversata a piedi l'Ungheria, i Balcani e l'Impero Bizantino, lanciò la riconquista della Terra Santa dall'invasore infedele. Dopo due anni di scontri e assedi Goffredo III era riuscito a conquistare Edessa, Antiochia e e gran parte della Siria e del Libano e ottenne infine, dopo quasi un anno di assedio, la capitolazione di Gerusalemme. Clemente III gli mandò una lettera piena di esclamazioni di giubilo e gli conferì anche a lui il titolo di Defensor Fidei e il soprannome di Cristianissimo. Tuttavia Goffredo III non volle assumere direttamente la corona di Gerusalemme, non ritenendosene degno, e pertanto si limitò a proclamarsi Advocatus Sancti Sepulchri, ovvero Protettore del Santo Sepolcro e quindi dei luoghi santi cristiani in Terra Santa, carica che gli venne prontamente riconosciuta dal Pontefice. Fu sostanzialmente l'ultimo grande atto politico per entrambi giacché sia Goffredo III sia Clemente III morirono a meno di due mesi di distanza nell'estate del 1100. Goffredo III, morto per primo, non aveva figli e pertanto il comando in Palestina venne assunto dai suoi fratelli, Eustachio e sopratutto Baldovino, il più giovane, mentre in Germania era l'Imperatrice Madre Matilde ad assumere la reggenza. Prima ancora di poter concordare con il Pontefice una nuova incoronazione, Clemente III morì e i Cardinali si riunirono a Roma: sebbene l'argomento imperiale venne largamente discusso, la principale preoccupazione dei prelati si rivelò un'altra, ovvero la diffusione della Rivolta Patarina. I Patarini erano un movimento popolare e religioso che chiedeva la fine della corruzione e della ricchezza del clero, il contrasto al concubinaggio e alla simonia e la rinuncia al potere temporale e, nonostante i ragguardevoli sforzi in tal senso da parte dei vari Vescovi ed Arcivescovi locali, esso si era diffuso a macchia d'olio nell'Italia Settentrionale, "conquistando" Milano e diventando maggioritaria in gran parte della Lombardia. I Cardinali, davanti anche al generale momento di commozione religiosa per la liberazione di Gerusalemme, elessero al Soglio Pontificio il futuro San Bruno da Segni, stimato Cardinale nato da padre astigiano e madre tedesca, dotto teologo e fine argomentatore, che apparve la scelta migliore per contrastare l'avanzata del Patarinismo. Il nuovo Pontefice prese il nome di Leone X in onore di Papa San Leone IX e come prima cosa annunciò la sua decisione di recarsi in pellegrinaggio nell'appena liberata Terra Santa. Poco prima di partire riuscì comunque lo stesso ad avere un colloquio con l'Imperatrice Reggente Matilde sulla successione imperiale. Giunto in Palestina nell'autunno del 1100, Leone X scoprì che Eustachio se ne era tornato in patria a gestire i suoi feudi e che al comando ora c'era l'altro fratello, Baldovino. Papa Leone si recò comunque prima al Santo Sepolcro e quindi s'intrattenne con Baldovino. Il Pontefice si mostrò favorevole ad incoronarlo successore del fratello ma sorse il problema della Terra Santa stessa: Baldovino infatti avrebbe voluto proclamarsene Re mentre il Patriarca di Gerusalemme, Dagoberto da Pisa, insisteva per un modello teocratico in cui la Palestina doveva essere possedimento diretto del Papato. Qui si mostrò appieno la grande saggezza di Leone X, che innanzitutto convinse Baldovino a recedere dai suoi propositi, perché nessun sovrano terreno e solo il Vicario di Cristo in Terra avrebbe potuto governare i Luoghi Sacri, mentre subito dopo redarguì Dagoberto, giungendo a invitarlo ironicamente a difendere da solo il confine del Giordano se ne era capace. La mediazione fu presto trovata: il Sacro Romano Imperatore era anche di diritto Protettore del Santo Sepolcro, amministrava la Terra Santa e poteva creare e avere vassalli in tutti i nuovi staterelli crociati nati nel Levante dopo la vittoria di Goffredo III ma doveva amministrata per conto del Papato, a cui tecnicamente quella terra apparteneva e che era rappresentato dal Patriarca di Gerusalemme. Trovato facilmente l'accordo, la Notte di Natale del 1100, esattamente tre secoli dopo l'incoronazione di Carlo Magno, Leone X incoronò Baldovino Sacro Romano Imperatore nella Basilica di Gerusalemme.
.
2. AAA Cercasi Imperatore
Il regno dell'Imperatore Baldovino I non fu entusiasmante: il nuovo sovrano passò buona parte del suo tempo a difendere i possedimenti del Levante dalle incursioni musulmane, tant'è che ritornò in Europa soltanto nel 1110, nominando Raimondo IV di Tolosa Governatore della Terra Santa in suo nome. Baldovino I non fu un cattivo sovrano ma i problemi erano tanti: nel 1115 morì l'Imperatrice Matilde di Canossa, che sarà proclamata Santa entro breve tempo da Leone X, e i possedimenti dei Canossa, compreso il Ducato di Tuscia, passarono alla sua unica figlia ed Imperatrice Vedova Ida di Canossa, alla cui morte essi sarebbero con ogni probabilità passati al Papato. La Sicilia e la Sardegna erano ormai dei corpi autonomi seppur sotto l'autorità nominale di Baldovino, che per tutto il suo regno non visitò mai nessuna delle due. Inoltre Baldovino non aveva eredi, cosa che metteva a rischio la successione in caso di morte. A seguito della morte di Matilde di Canossa Baldovino I prese la deprecabile decisione di sposare sua figlia Ida, nella speranza di tenere uniti i feudi canossiani all'eredità imperiale, cosa che provocò un brutto litigio con Papa Leone X (sposare la moglie vedova del fratello non era visto molto bene dal Santo), e infine nominò suo fratello maggiore Eustachio, Conte di Boulogne e Verdun e Duca di Lorena, come Vicario Imperiale e suo successore. Quando morì nel 1118 si accese subito lo scontro tra Eustachio, che era più forte ma era esitante a prendere il regno, e il suo avversario, Enrico il Giovane di Franconia (il nostro Enrico V), figlio di quel Enrico di Franconia che si era opposto a Goffredo III e nipote dell'Imperatore Enrico III e dell'Imperatrice Agnese, nonché ultimo discendente della Dinastia Salica. Eustachio si recò poi in Italia, ove poteva contare sul sostegno della sua due volte cognata Ida di Canossa e di Papa Leone X che lo incoronò Imperatore nel 1120. Lo stesso anno la disputa coinvolse anche il trono inglese, giacché, di ritorno dalla Francia, Guglielmo Adelin, unico figlio di Re Enrico I d'Inghilterra, morì nel naufragio della Nave Bianca insieme a gran parte della nobiltà inglese, lasciando la successione incerta tra la sua unica figlia, Matilde, che aveva sposato proprio Enrico il Giovane di Franconia, e il nipote del Re, per via femminile, Stefano di Blois, che aveva invece sposato Matilde di Boulogne, unica figlia del neoincoronato Imperatore Eustachio I. Nel 1125 morirono a pochi mesi di distanza sia Enrico il Giovane di Franconia sia l'Imperatore Eustachio, entrambi senza eredi, cosicché le tensioni in Inghilterra si attenuarono un poco e la palla passò al Papa che doveva, insieme ai nobili tedeschi, scegliere il nuovo Imperatore. Tuttavia Leone X era morto due anni prima e Roma era nel caos a causa degli scontri tra le potenti famiglie dei Pierleoni e dei Frangipane, entrambi con dei loro candidati al Soglio Pontificio: dopo oltre un anno di vacanza, era stato eletto come candidato di compromesso il Cardinal Sasso dei Conti di Segni, appartenente allo stesso paesino astigiano di Papa Leone X e che in suo onore prese il nome di Leone XI. Impegnato a schivare frecce e veleni nella stessa Roma e non particolarmente forte, Leone XI fu incapace di proporre e mediare una nuova nomina tra i vari nobili tedeschi che si facevano la guerra: questo periodo prese il nome di Gran Interregno e sarebbe perdurato per oltre un decennio. Nel 1135 infatti il Re d'Inghilterra Enrico I era morto, subito dopo aver designato come proprio erede la figlia Matilde e aver costretto i nobili inglesi a giurarle fedeltà ma il fatto che fosse una donna e l'aver sposato un odiatissimo Angiò portò in breve i nobili a rigettare il giuramento e ad acclamare Re Stefano di Blois: nei fatti il Regno precipitò nella guerra civile ma Stefano poté fregiarsi del titolo di Re d'Inghilterra, sostenuto da una larga parte della nobiltà anglo-normanna, e questo fu strategico l'anno seguente quando morì Papa Leone XI e si tenne un nuovo conclave. I Frangipane, schierati su posizioni filoimperiali e guidati dal Cardinale Aimerico de la Chatre, appoggiarono l'elezione del Cardinal Gregorio Papareschi col nome di Innocenzo II ma la Famiglia dei Pierleoni non riconobbe l'elezione e supporto un proprio membro, il Cardinal Pietro Pierleoni, col nome di Anacleto II. Questi, approfittando della mancanza del principale vantaggio degli avversari, ovvero della figura dell'Imperatore, arruolarono mercenari e nobili normanni da tempo desiderosi di vendetta e guidati da Ruggero d'Altavilla (il nostro Ruggero II di Sicilia) e occuparono Roma, costringendo Innocenzo II a rifugiarsi a Pisa. Con Roma occupata, i propri sostenitori demoralizzati dalla sconfitta, i normanni pro-Anacleto II al potere nel Sud e l'Impero allo sbando Innocenzo II sembrava destinato a sconfitta sicura ma fu proprio qui che intervenne la decisiva figura di San Bernardo di Chiaravalle. Egli era già molto conosciuto per le sue dotte quanto accalorate discussioni contro i Patarini, che ormai si erano diffusi nel Monferrato e nella Serenissima Repubblica di Venezia, nonché in gran parte dell'Emilia e della Romagna e in parte della Toscana stessa. San Bernardo si mise d'impegno e con un tour serrato e un'oratoria travolgente riuscì a compattare l'Europa dietro a Innocenzo II, facendolo riconoscere come il vero e legittimo Pontefice. Egli inoltre convinse i principi tedeschi che era necessario sostenere Innocenzo II perché ponesse fine all'Interregno e riuscì ad accordarsi la neutralità di almeno una parte dei Patarini, convincendoli che tra i due Anacleto II era decisamente il peggiore. Ma la mossa più importante del Santo fu l'incontro che ebbe con Stefano di Blois, pretendente al trono inglese, in Normandia, ove egli era appena sbarcato per sconfiggere la rivale Matilde: sfruttando il cattivo andamento della campagna dovuto al mancato supporto di molti baroni normanni (che in HL fu il motivo per cui pochi mesi più tardi egli deciderà di ritornarsene in Inghilterra sconfitto, permettendo a Matilde di prendere l'iniziativa e di portare la guerra sul suolo inglese), egli lo convinse a cercare il supporto del Papa, che avrebbe potuto legittimarlo come sovrano e gli promise anche la Corona Imperiale, in quanto genero del defunto Eustachio I, avendone sposato l'unica figlia Matilde, Contessa di Boulogne e Verdun e Duchessa di Lorena. Stefano allora piantò lì l'ncocludente guerra di posizione e assedi con Matilde e si diresse ad Est, prendendo prima effettivo possesso dei possedimenti della moglie in Lotaringia, con l'intenzione di rivendicare in tal modo la legittimità della propria successione rispetto al suocero, poi si diresse in Germania e ad Augusta ottenne il supporto della maggior parte dei nobili e del clero tedesco, convinti anche da Bernardo, infine passò il Brennero e nel 1138 s'incontrò con Papa Innocenzo II a Lucca. Il Pontefice era già stato largamente convinto dalle lettere di San Bernardo e dal sostegno della Chiesa inglese, guidata da Enrico, Arcivescovo di Winchester e fratello di Stefano, alle pretese del de Blois e pertanto si dimostrò fin da subito favorevole al pretendente. L'Incontro di Lucca fu decisivo per gli equilibri europei: il Papa riconobbe Stefano di Blois come legittimo Re d'Inghilterra e legittimo Sacro Romano Imperatore e in cambio Stefano riconobbe Innocenzo II come legittimo Pontefice e gli garantì l'assegnazione di tutti i feudi canossiani alla morte dell'ultima discendente della famiglia, Ida di Canossa. Subito dopo l'incontro Stefano marciò su Roma e sconfisse l'usurpatore Anacleto II e annientò facilmente le milizie mercenarie normanne degli Altavilla, quindi venne incoronato Imperatore in San Pietro nel 1139. Forte del nuovo
 sostegno, Stefano si diresse nuovamente alla volta dell'Inghilterra, occupando sulla strada diversi castelli normanni fedeli a Matilde, la quale nel frattempo aveva invaso l'Inghilterra con il sostegno di suo zio, Re Davide I di Scozia. Stefano riuscì a sbarcare in Inghilterra e intraprese una durissima campagna, particolarmente sanguinosa, con ripetuti cambi di fronte e diverse battaglie incerte. Dopo essere stato incoronato e riconosciuto Re nell'Abbazia di Canterbury, Stefano riuscì a sconfiggere e a distruggere l'esercito scozzese nella durissima Battaglia dello Stendardo: subito dopo offrì la pace a Re Davide, presentandosi come membro della famiglia (suo suocero, Eustachio I, aveva sposato una delle sorelle del Re) e ottenendo da questi il riconoscimento a Re d'Inghilterra. Abbandonata da tutti Matilde venne assediata a Oxford e il 17 dicembre 1141 ella tentò di fuggire dalla città, con soli quattro soldati, calandosi dai bastioni della città e cercando di attraversare a piedi il Tamigi ghiacciato con dei mantelli bianchi per mimetizzarsi ma il maggior numero di soldati a disposizione di Stefano aveva permesso al Re di sorvegliare anche quel lato della città, altrimenti trascurato, e la pretendente sconfitta venne catturata durante la fallita fuga. Con tale evento terminò de facto la Guerra Civile Inglese: il Sacro Romano Imperatore Stefano I, Defensor Fidei, venne riconosciuto Re d'Inghilterra dalla stessa Matilde, a cui Stefano concesse un diritto di successione in caso di estinzione della dinastia dei Blois d'Inghilterra per unificare il paese dopo la guerra. Stefano ora era sovrano di un Impero molto vasto e si apprestava a governarlo. Il contributo di San Bernardo di Chiaravalle non venne dimenticato: Innocenzo II lo nominò Cardinale e fu uno dei suoi più stretti collaboratori, in particolare nel contrastare la diffusione dei patarini. Alla morte di Innocenzo II nel 1143, i Cardinali ebbero pochi dubbi nell'eleggerlo come suo successore con il nome di Innocenzo III, in onore del suo predecessore e
collaboratore.
sostegno, Stefano si diresse nuovamente alla volta dell'Inghilterra, occupando sulla strada diversi castelli normanni fedeli a Matilde, la quale nel frattempo aveva invaso l'Inghilterra con il sostegno di suo zio, Re Davide I di Scozia. Stefano riuscì a sbarcare in Inghilterra e intraprese una durissima campagna, particolarmente sanguinosa, con ripetuti cambi di fronte e diverse battaglie incerte. Dopo essere stato incoronato e riconosciuto Re nell'Abbazia di Canterbury, Stefano riuscì a sconfiggere e a distruggere l'esercito scozzese nella durissima Battaglia dello Stendardo: subito dopo offrì la pace a Re Davide, presentandosi come membro della famiglia (suo suocero, Eustachio I, aveva sposato una delle sorelle del Re) e ottenendo da questi il riconoscimento a Re d'Inghilterra. Abbandonata da tutti Matilde venne assediata a Oxford e il 17 dicembre 1141 ella tentò di fuggire dalla città, con soli quattro soldati, calandosi dai bastioni della città e cercando di attraversare a piedi il Tamigi ghiacciato con dei mantelli bianchi per mimetizzarsi ma il maggior numero di soldati a disposizione di Stefano aveva permesso al Re di sorvegliare anche quel lato della città, altrimenti trascurato, e la pretendente sconfitta venne catturata durante la fallita fuga. Con tale evento terminò de facto la Guerra Civile Inglese: il Sacro Romano Imperatore Stefano I, Defensor Fidei, venne riconosciuto Re d'Inghilterra dalla stessa Matilde, a cui Stefano concesse un diritto di successione in caso di estinzione della dinastia dei Blois d'Inghilterra per unificare il paese dopo la guerra. Stefano ora era sovrano di un Impero molto vasto e si apprestava a governarlo. Il contributo di San Bernardo di Chiaravalle non venne dimenticato: Innocenzo II lo nominò Cardinale e fu uno dei suoi più stretti collaboratori, in particolare nel contrastare la diffusione dei patarini. Alla morte di Innocenzo II nel 1143, i Cardinali ebbero pochi dubbi nell'eleggerlo come suo successore con il nome di Innocenzo III, in onore del suo predecessore e
collaboratore.
.
3. Patarini ovunque!
Il Pontificato di Innocenzo III fu particolarmente importante per una pluralità di motivi, dovuti alla grande opera di questo Papa in campo diplomatico e teologico. Nel primo egli si trovò a dover gestire e a riorganizzare la vastità dei feudi pontifici, che quasi raddoppiarono con la morte di Ida di Canossa nel 1149. Secondo gli Accordi di Lucca l'Imperatore Stefano I concedette i feudi canossiani, riuniti all'interno del Ducato di Tuscia/Toscana, al Papato, permettendo a Roma di amministrare praticamente ogni città tra Milano e Reggio Calabria. In realtà lo status di questi feudi (che presero complessivamente il nome di "Eredità Canossiana") rimase un po' ambiguo perché le terre rimanevano parte del Sacro Romano Impero ma era amministrate dalla Chiesa, in quanto feudi pontifici: questa situazione favorì le città del Nord, sopratutto quelle lombarde, che da tempo desideravano maggior autonomia. Potendo contare sulle ambizioni di due stati, entrambi pronti a fare concessioni e promesse pur di attirarle maggiormente nella propria sfera d'influenza, esse iniziarono a fiorire rapidamente, ritagliandosi lentamente una propria autonomia e arricchendosi grazie al florido commercio che stava nascendo nella Pianura Padana finalmente in pace. Tale autonomia avrebbe infine trovato un definitivo riconoscimento nei decreti dell'Imperatore Amalrico I, datati 1162. Prima di allora governava ancora l'Imperatore Stefano I di Blois il cui regno in realtà fu abbastanza tranquillo: dopo il Primo Interregno nessuno aveva voglia di far scoppiare una nuova guerra civile e il carattere debole di Stefano e il suo dover spostarsi spesso da un suo dominio all'altro, dall'Inghilterra all'Italia, dalla Germania alla Sicilia, lasciando il potere nelle mani di nobili, reggenti e governatori locali senza voler effettivamente esercitare il pieno potere che la sua immensa carica gli garantiva contribuì a farlo ben volere sia dalla nobiltà sia dalle varie città e vescovadi del suo Impero. Suo figlio primogenito ed erede designato Eustachio si dimostrò invece un uomo volgare e violento e i suoi soprusi in Italia non fecero altro che convincere le città canossiane a ratificare gli Accordi di Lucca per porsi sotto la protezione del Papa ma fortunosamente Eustachio morì poco prima del padre e tutto l'Impero tirò un sospiro di sollievo. A differenza del figlio invece Stefano I non si arrogò mai più diritti di quanti non ne avesse e anzi esitò a far valere anche quelli che aveva per diritto né accampò grandi pretese nel concedere i feudi canossiani al Papato secondo gli Accordi di Lucca ma anzi fece da paciere e mediatore nella contesa tra Genova e Papato circa la Corsica (1151). L'isola era stata teatro di scontri e contese tra baroni locali finché, sul finire dell'11° Secolo, il Papato non l'aveva rivendicata sulla base di alcune concessioni di Carlo Magno (oggi appuratesi false) e nel 1077 l'isola si era volentieri data a Papa Stefano IX, il quale, scartando l'idea di affidarla ad un vescovo, come per esempio quello di Pisa, aveva incamerato il territorio direttamente nei domini pontifici. Tuttavia le ingerenze esterne della (relativamente) lontana Roma avevano finito per irritare una parte dei nobili corsi che si erano avvicinati alla Repubblica di Genova: la Superba aveva iniziato ad insediarsi sulla costa settentrionale dell'isola, spostandovi cittadini liguri come veri e propri coloni, e aveva contestato le pretese del Papato. L'Imperatore riconobbe i diritti del Papato sulla Corsica ma ottenne che essa fosse inclusa nell'Arcidiocesi di Genova a causa della presenza di molti liguri e genovesi nella popolazione isolana. Sia i Consoli genovesi sia Innocenzo III furono non troppo insoddisfatti dal risultato da mettersi a questionare con l'Imperatore e se ne tornarono a casa. Sua Santità aveva inoltre problemi più gravi, in particolare riguardo all'intensificarsi del Patarinismo, che ormai risultava maggioritario in Lombardia, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, Monferrato, Ticino e Liguria e stava disarticolando la gerarchia ecclesiastica, demolendo e rifiutando il potere dei Vescovi. Innocenzo III fu molto abile nel contrastare il fenomeno: egli concordava con molte delle rivendicazioni dei patarini, salvo sulla rinuncia al potere temporale, che considerava eretica, e si diede dunque da fare per promuoverle all'interno della Chiesa stessa. Emanò quindi severissime encicliche e editti draconiani contro il concubinaggio, il lusso, la simonia, la ricchezza dei religiosi e i loro abusi di potere, che alla fine erano i motivi principali di scandalo e di adesione al patarinismo. Giunse a strappare personalmente le berrette di un paio di cardinali poco ligi ai loro doveri ecclesiastici. Contemporaneamente tuttavia iniziò a colpire duramente qualunque deriva eretica del movimento, compresa quella sulla rinuncia del potere temporale. Questa politica finì per spaccare il movimento patarino tra i moderati, che vi avevano aderito perché desiderosi di un cambiamento nella Chiesa e che si riconciliarono presto con il Pontefice, e gli intransigenti, che invece pretendevano la fine completa di ogni potere ecclesiastico e che spesso erano anche portavoce di opinioni eretiche su argomenti teologici. A conti fatti i primi si dimostrarono la maggioranza e, una volta isolati i veri eretici e i violenti, il Papa poté facilmente metterli al bando con l'aiuto dell'Imperatore e neutralizzarli. Il Patarismo, inteso come movimento pauperistico, venne in un certo senso istituzionalizzato, cioè venne accettato (ovviamente non completamente e non da tutti, ma in linea di massima sì, a cominciare dallo stesso Papa) all'interno della Chiesa. In realtà alcune potenti famiglie e una parte consistente dell'alto clero si opposero attivamente e con veemenza alla riforma ecclesiastica e cercarono di sobillare violenze a Roma e di ostacolare anche le mosse del Pontefice, giungendo a contestarne, usando le stesse parole dei Patarini, il suo potere politico su Roma e supportando un ritorno ad istituzioni laiche. Comunque questo tentativo di contrasto ebbe esattamente l'effetto opposto e lo si vide alla morte di Innocenzo III nell'agosto del 1153: le potenti famiglie nobiliari pretesero ed ottennero di assistere al Conclave per l'elezione del suo successore e si accordarono con alcuni cardinali per appoggiare l'elezione del Cardinal Corrado della Suburra, uomo molto anziano e mite, che non avrebbe interferito nei loro affari. Diffusasi tuttavia la notizia che i potenti della città complottavano per usurpare il Papato e che sarebbero stati loro i responsabili della morte dell'amato Innocenzo III, i patarini romani e la gran parte del popolino della Città Eterna insorsero furibondi, distruggendo diverse ville nobiliari, incendiando alcuni edifici pubblici e giungendo ad assediare il Palazzo Apostolico ove era riunito il Conclave. Davanti alla notevole "opera di persuasione" degli insorti, i Cardinali elessero uno dei capipopolo patarini, un tal Arnaldo, che era stato eletto tempo addietro dai suoi concittadini patarini Vescovo di Brescia, poi confermato da Innocenzo III, e che pertanto era chiamato Arnaldo da Brescia, che prese il nome di Gregorio VII in onore del Padre della Chiesa e campione della moralità cristiana Papa San Gregorio I Magno. Tra i suoi primi atti, sfruttando la posizione di forza in cui si trovava, procedette ad espellere diversi aristocratici a lui ostili o eccessivamente ricchi e potenti, i cui simboli di lusso furono bruciati in pubblica piazza. Istituì tribunali per giudicare i religiosi macchiatisi di immoralità e agì con fermezza per purificare la Chiesa da ogni simoniaco. Non ebbe completamente successo ma ottenne comunque dei buoni risultati e il suo impegno lo rese molto popolare. I nobili espulsi e diversi esponenti dell'alto clero naturalmente non la pensavano così e, rifugiatisi a Lodi, tennero un simil-conclave che elesse un Anti-Papa, il Cardinal Ottaviano de Monticelli, esponente di una delle famiglie più potenti di Roma, con il nome di Vittore III. Egli riuscì a trovare un certo seguito in alcune città che avevano problemi con il Papato, come Lodi, Pisa o Genova, ma il suo sostegno popolare fu abbastanza marginale. L'Imperatore avrebbe potuto tranquillamente reprimere questo tentativo scismatico senza neppure alzarsi dal letto ma proprio l'anno dopo, nel 1154, Stefano I si sdraiò nel suo e ci rimase: suo figlio secondogenito Guglielmo gli successe come Guglielmo III d'Inghilterra e I come Sacro Romano Imperatore. Debole e poco ambizioso, Guglielmo I non ebbe il polso per tenere in ordine l'Impero che iniziò a precipitare nel disordine. Mentre i nobili e le città prendevano ad autogovernarsi, ricominciando le guerre tra loro, e in Inghilterra i sostenitori del figlio di Matilde la Pretendente, Enrico, riguadagnavano forza, Papa Gregorio VII continuava indefesso la sua opera riformatrice, concedendo nel 1156 il Renovatio Senatus, il suo editto più importante, con cui istituiva formalmente un Senato laico con un certo peso amministrativo: esso aveva competenza solo su Roma ma ne avrebbe gestito l'autonomia cittadina al di fuori della gerarchia ecclesiastica e sarebbe stato il principale interlocutore della monarchia elettiva pontificia nella città. Avrebbe inoltre eletto una serie di magistrati cittadini, che, ispirandosi all'Antica Roma, si sarebbero chiamati Consoli, Tribuni, Pretori, Questori ed Edili (anche se quello preferito dal Pontefice bresciano era ovviamente il Censore, ovvero il magistrato incaricato di valutare con estrema severità la moralità dei suoi concittadini e di punirli di conseguenza). La mossa era dettata da tatto politico oltre che dalle convinzioni del Pontefice che, da buon ex patarino, era favorevole alla rinuncia di almeno una parte del potere temporale ecclesiastico (e difatti concedette privilegi simili a molte città sotto autorità pontificia, sopratutto nel Nord, secondo quanto detto all'inizio di questo stesso articolo): anche se godeva di un vasto supporto popolare, Gregorio VII sapeva bene che senza perlomeno la neutralità della nobiltà non sarebbe riuscito a controllare Roma, a far diminuire le furiose violenze o a mantenere efficiente l'amministrazione pubblica. In tal senso la mossa non ebbe effetti immediati tant'è che alla morte dell'Antipapa Vittore III nel 1164, il suo sostenitore Guido da Crema, uno dei principali avversari di Gregorio VII, venne eletto suo successore come Pasquale II. Ma quando questi morì quattro anni più tardi il suo successore Callisto II, al secolo il monaco Giovanni di Struma, non ebbe altra scelta che porre fine allo scisma sottomettendosi al legittimo Pontefice. Questo fu possibile grazie anche al rinsaldarsi del potere imperiale dopo la morte di Guglielmo I di Boulogne nel 1159, senza figli od eredi diretti oltre a sua sorella Maria, che però era monaca e, quando venne tirata fuori dal convento a forza per sposarsi con un nobile desideroso di accampare diritti sul trono imperiale, i due vennero prontamente scomunicati da Gregorio VII e persero ogni diritto. Secondo quanto stabilito da Stefano I dopo la sua vittoria di Oxford, il figlio di Matilde la Pretendente, Enrico, divenne Re d'Inghilterra come Enrico II mentre per quanto riguardava l'Impero la palla passava nuovamente ai nobili tedeschi e al Papa. Gregorio VII agì con prontezza e decisione, determinato ad evitare un nuovo interregno, e appoggiò la candidatura di Baldovino III, Duca di Alta e Bassa Lorena e lontano discendente degli Imperatori Baldovino I ed Eustachio I (era nipote di un loro cugino), appartenente dunque ad un ramo cadetto detto dei Buglione-d'Angiò. Baldovino III era un giovane 29enne di bell'aspetto e i nobili tedeschi si accordarono con Gregorio VII per sostenerlo: sembrava abbastanza inesperto per poter pensare di mantenere intatto il proprio potere ed influenza. Si sbagliavano: Baldovino, non appena incoronato come Baldovino II nella primavera del 1160, si rivelò impulsivo ed irruento, dotato di poco tatto diplomatico e anzi aggressivo e maldestro. Intollerante alle critiche e sospettoso, vanitoso e fanfarone, in poco tempo riuscì ad alienarsi le simpatie di gran parte dei nobili e delle città semi-autonome dell'Italia Settentrionale che iniziarono ad approntare una lega per contrastarlo, con il sostegno anche di Gregorio VII. Intuendo la cosa, Baldovino II decise immediatamente di partire per l'Italia e di radere al suolo tutte le città che non gli avrebbero giurato fedeltà ma il suo scarso acume politico e la sua avventatezza lo privarono di molti alleati e ne ostacolarono la marcia. Giunto alle porte di Milano con un esercito di poco superiore ai 20 000 soldati, egli si apprestava a radere al suolo la città, come suggeritogli da uno dei pochi nobili rimastigli fedeli, Federico III, Duca di Svevia, appartenente alla Dinastia degli Hoheustaufen, detto il Barbarossa, ma improvvisamente, mentre l'assedio perdurava, Baldovino II morì nel febbraio del 1162, qualcuno insinua avvelenato. Nuovamente Gregorio VII diede prova di astuzia offrendo il proprio sostegno al fratello minore di Baldovino II, Amalrico, in cambio di pace e concessioni. Circondato dalle armate della lega, Amalrico cedette volentieri in cambio dell'incoronazione imperiale. Subito dopo egli riunì una dieta imperiale a Piacenza (Dieta di Piacenza o Dieta di Roncaglia) con cui, alla presenza di tutti i più importanti nobili e feudatari tedeschi, del Papa e dei legati di tutti i possedimenti imperiali in Italia e con l'aiuto dei dotti dell'Università di Bologna, promulgò la Costitutio de Regalibus e la Constituio Pacis con cui regolò definitivamente i contenziosi con gli avversari del fratello e stabilì in forma scritta i diritti degli Imperatori: il sovrano aveva il potere di nominare e/o elevare duchi, conti, marchesi e altri nobili a lui sottoposti, di imporre lavori di carattere ed utilità pubblica e di derimere questioni riguardanti i beni fondiari e dispute territoriali. Inoltre proibì le guerre private tra i vari soggetti dell'Impero. Dall'tro canto l'editto stabiliva che, dietro autorizzazione dell'Imperatore e in cambio di un tributo annuale, della fedeltà al legittimo sovrano (di cui si riconosceva il governo sopra le città stesse) e del sostegno militare, le città avrebbero potuto eleggere dei propri magistrati cittadini autonomi, riscuotere le tasse e coniare moneta. Poco dopo la sua ascesa al trono imperiale, come ulteriore concessione, accettò anche l'annullamento del sua matrimonio con Agnese di Courtenay, preteso da Gregorio VII in quanto consanguinei (avevano un trisnonno in comune). Fu l'ultimo atto importante di Papa Gregorio VII che morì da lì a poco nel 1163. Il successivo Conclave vide la riuscita di un compromesso tra chi voleva portare avanti la ferrea politica purificatrice di riforma religiosa di Gregorio VII e chi invece era per un ammorbidimento, anche perché l'eccessiva intransigenza rischiava di alienare anche le simpatie della gente comune: venne eletto al Soglio Pontificio il Cardinale senese Rolando Bandinelli, uno stretto collaboratore di Gregorio VII e grande avversario di Baldovino II (tant'è che, portandogli l'ambasceria del Papa sotto le mura di Milano assediata, gli avrebbe detto "Da chi dunque il Principe ottiene l'Impero? Da chi se non dal Papa?"), che prese il nome di Alessandro II. Il nuovo Pontefice era un amico delle forze autonomiste delle cittadine padane e, un po' per far comunque sentire che era sempre lui l'Imperatore, un po' per colmare il vuoto lasciato da Gregorio VII, un po' come dimostrazione di forza, Amalrico I decise di scendere in Italia. Un buon pretesto fu la guerra che era scoppiata in Sardegna tra il Giudicato di Arborea da un lato e quelli di Torres e Calari dall'altro. Amalrico rivendicò l'antica alleanza stipulata a suo tempo da Goffredo I il Barbuto e, ottenuto il sostegno della flotta genovese in cambio di privilegi commerciali, sopratutto nella stessa Sardegna, sbarcò ad Olbia nell'estate del 1164. Con il suo appoggiò Barisone I d'Arborea riuscì a sconfiggere facilmente i suoi avversari e, con il consenso dell'Imperatore e del Papa, venne incoronato nella Cattedrale di Santa Maria Assunta ad Oristano, tutt'oggi la più grande dell'isola, come Re di Sardegna col nome di Barisone I, realizzando così il suo sogno, seppur in rapporto di sostanziale vassallaggio nei confronti dell'Impero. Tornando vittorioso, Amalrico sostò a Roma, ove ebbe un amichevole incontro con Papa Alessandro II, e poi percorse l'Italia Settentrionale nel tentativo di recuperare un po' della popolarità persa dal fratello predecessore. L'obbiettivo fu facilmente assicurato: dopo la fine del conflitto con Baldovino II, le concessioni commerciali e politiche avevano incoraggiato commerci ed economia e molte città stavano vivendo un momento di grande espansione, sopratutto Genova. Amalrico I era visto come un sovrano misurato e giusto che aveva portato ricchezza e concesso libertà e venne accolto trionfalmente in quasi tutte le città che visitò. Al culmine della visita venne addirittura battezzata in suo onore una città di recente fondazione alla confluenza tra il Tanaro e il Bormida, in Piemonte, era stata presa in considerazione l'idea di battezzarla in onore di Alessandro II, così da farla diventare Alessandria, ma l'Imperatore era al momento decisamente più popolare e la sua visita cascava a fagiolo: il 3 maggio 1167, alla presenza del sovrano in persona, che pose di sua mano la prima pietra, venne così fondata la città di Amalrica. Amalrico era un sovrano saggio e assennato, amante della letteratura e delle arti, generoso, sempre pronto a perdonare, discreto e molto sapiente e curioso e il suo si prospettò come un regno stabile e felice ma nubi dense si addensavano sull'Oriente: nel 1169 infatti era morto il Gran Visir del Sultanato Fatimide d'Egitto, Shirkuh, e gli era succeduto suo nipote 32enne, il giovane ed ambizioso Salah al-Din, meglio conosciuto in Occidente con la storpiatura di Saladino...
Nel giro di un anno le armate del nuovo leader musulmano avevano bruciato Gaza e raso al suolo la fortezza di Eilat, che, arroccata su un'isola in mezzo all'omonimo golfo, aveva fama di imprendibile. Saputa la notizia, Amalrico si affrettò a risposarsi con Maria Comnena, figlia dell'Imperatore bizantino Manuele, per ottenere la sua alleanza (e già che c'era anche la città di Edessa, ceduta come dote) e nell'aprile del 1171, con tanto di bolla pontificia autorizzante la Crociata, l'Imperatore salpò da Genova per il Vicino
Oriente...
.
4. Caos all'inglese
La Seconda Crociata fu decisamente più deludente della Prima: l'Imperatore Amalrico passò quattro anni a combattere Saladino ai confini torridi e sabbiosi della Palestina, senza per questo riuscire a riportare una vittoria decisiva sull'avversario, finché non morì nell'accampamento crociato di Dorileo ai primi di luglio del 1174. Suo figlio
Baldovino aveva solo tredici anni, e divenne Imperatore come Baldovino III sotto la Reggenza di sua madre, Agnese di Courtenay, che l'anno successivo si adoperò per firmare una tregua con il condottiero musulmano. L'Impero era nelle mani di un bambino, piccolo e, come si scoprì presto, sfortunatamente malato di lebbra, e non era nella posizione migliore per ingaggiare conflitti seri a grande distanza. Se tuttavia la situazione nel Sacro Romano Impero in questi primi Anni Settanta del XII Secolo potrebbe sembrare precaria, impallidirebbe e non poco a confronto con quella del Regno d'Inghilterra nello stesso periodo. Re Enrico II, asceso nel 1159 alla morte di Guglielmo III di Blois, si era dimostrato un sovrano abile e riformatore ma purtroppo assolutamente intollerante a qualunque attore sociale o politico anche solo in grado di contestarne l'autorità o provare a limitare la stessa. La cosa era aggravata dalla contrapposizione tra i vecchi sostenitori dei de Blois e i partigiani dei Plantageneti e fu rapidamente catalizzata dallo scontro con il clero, che aveva supportato fortemente il regno di Stefano I e Guglielmo III. Ciliegina finale sulla torta, giusto per peggiorare la situazione, a capo della Chiesa inglese vi era Enrico di Blois, fratello di Stefano I, che, da Vescovo di Winchester, aveva scalato le gerarchie ecclesiastiche grazie all'influenza del fratello fino a diventare Arcivescovo di Canterbury ed era il capo dei de Blois, nonché, per alcuni dei suoi partigiani più irriducibili, il legittimo pretendente al trono d'Inghilterra. Tutto ciò era intollerabile per Enrico II e sfociò in una serie di scontri e violenze di strada che acutizzarono la tensione e costrinsero infine Enrico di Blois alla fuga in Francia mentre il Re promulgava le Costituzioni di Claredon, con cui limitava fortemente i diritti del clero e lo portava sotto il controllo diretto della Corona a cui ora spettava la nomina dei Vescovi e degli Arcivescovi. Papa Alessandro II rispose spedendo una lettera al sovrano composta da circa un migliaio di frasi composte da un soggetto, un verbo e "scomunica immediata" e alla fine il Re dovette cedere alle pressioni del Pontefice e permise all'esule di ritornare in Inghilterra, ove tuttavia la situazione peggiorò. I sostenitori delle due fazioni si scontravano regolarmente mentre l'Arcivescovo lanciava dal suo pulpito veementi orazioni contro il "tiranno di Claredon" e i suoi tentativi di sopprimere l'autonomia ecclesiastica. Vanificati i tentativi di mediazione del Lord Cancelliere, l'Arcivescovo di York Thomas Becket, nel 1170 la misura era ormai colma e, dopo l'ennesimo, violento scontro verbale tra i due, il Re esplose: tra insulti e maledizioni ordinò sprezzante ai suoi uomini di "levarmi di torno questo maledetto prete turbolento in modo definitivo!". Fu ubbidito: la mattina del 29 dicembre quattro cavalieri fedeli al Re irruppero nella Cattedrale di Canterbury durante la Santa Messa e passarono a fil di spada l'Arcivescovo tra le urla d'orrore dei fedeli. Il Re si compiacque apertamente per la sorte del suo principale avversario e si preparò ad imporre un candidato a lui fedele come nuovo capo della Chiesa Cattolica in Inghilterra ma se pensava di aver risolto tutto con la morte si sbagliava di grosso: fin dai tempi di Papa Gregorio VII preti e predicatori di nuova estrazione patarina di erano sparsi fin nel Regno d'Inghilterra e da tempo arringavano il popolo contro gli abusi del Re ma l'assassinio di Enrico innescò una serie di violente proteste che in breve si diffusero a tutto il paese. Enrico II era fiducioso di poterle facilmente reprimere ma si era dimenticato di non essere meno invulnerabile del defunto Arcivescovo di Canterbury e ormai aveva catalizzato troppo odio per poterne uscire indenne: il 9 aprile 1171, mentre si apprestava ad entrare proprio nella stessa chiesa in cui Enrico di Blois aveva esalato il suo ultimo respiro sotto le coltellate dei suoi sicari per nominare un nuovo Arcivescovo, un esaltato patarino riuscì ad avvicinarglisi e lo pugnalò tre volte prima di essere abbattuto dalle armi degli uomini del suo seguito. Re Enrico II morì così sul sagrato mentre i suoi nobili cercavano i toglierli la veste regale e il sangue del suo assassino si mischiava ancora caldo al suo. L'assassinio del monarca fece precipitare il regno nel caos: i patarini insorsero in tutta Londra e s'impossessarono del Palazzo Reale, prendendo in ostaggio l'erede al trono Enrico il Giovane. Solo la mediazione del Lord Cancelliere Thomas Becket di York riuscì ad evitare un bagno di sangue. I Baroni intimoriti e sotto minaccia accettarono di formare un Consiglio di Reggenza, presieduto dal Lord Cancelliere Becket, che assistesse il neoincoronato Enrico III ma in pratica il potere era nelle mani di un triumvirato composto da Becket, il suo amico e segretario nonché Vescovo di Winchester Giovanni di Salisbury e dal fratellastro di Enrico III e figlio illegittimo di Enrico II, Goffredo, Vescovo di Lincoln. Enrico III aveva soltanto sedici anni quando ascese al trono e fu rapidamente chiaro che era Re in tutto tranne che nei fatti. Questa debolezza incoraggiò i suoi fratelli Riccardo, Goffredo e Giovanni, rispettivamente Duchi di Aquitania e Guascogna, Bretagna e Normandia, a cercare maggiore spazio politico, dando inizio ad una vera e propria ribellione nel 1174. La situazione entrò in breve tempo in stallo giacché i ribelli avevano il saldo controllo dei territori oltremanica mentre l'Inghilterra era in mano ai nobili fedeli ad Enrico III e questa impasse permise al Consiglio di Reggenza di mediare un accordo che riportasse la nazione al precario status quo. Tuttavia, giovane testa calda dal carattere ribelle, Enrico III iniziò a mostrarsi sempre più insofferente verso il controllo del triumvirato ecclesiastico e nel 1181 decise di svincolarsi da esso ricominciando la guerra con i suoi fratelli. Per marcare la sua decisione, saccheggiò chiese e monasteri lungo la strada per pagare i suoi soldati e quindi sbarcò in Normandia per iniziare la guerra. Guerra che fu incredibilmente breve giacché Re Enrico III morì a soli 28 anni di dissenteria nel giugno 1183. I predicatori non tardarono ad affermare che era incorso nella punizione divina come suo padre per i suoi atti sacrileghi e una parte consistente della Chiesa e del movimento popolare cattolico-patarino iniziò a supportare la candidatura del triunviro Goffredo di Lincoln, che era il figlio primogenito, seppur illegittimo, del defunto Enrico II, presentando anche un presunto "Testamento di Enrico II" (poi rivelatosi falso) in cui si affermava la preferenza del Re per Goffredo ( il che era anche vero) e lo si dichiarava legittimo (e qui invece c'era la parte falsa). Naturalmente il terzo fratello, il Duca di Aquitania Riccardo, si rifiutò di accettare tale pretesa e ricominciò la ribellione. Con una parte consistente della nobiltà inglese pronta ad appoggiarlo per porre fine all'egemonia ecclesiastica a corte Goffredo decise di venire a patti: Riccardo I diventava il legittimo Re d'Inghilterra e in cambio ratificava il "Testamento", de facto legittimando Goffredo a succedergli in caso di sua morte senza eredi. Comunque Riccardo I rimase in Inghilterra solo lo stretto tempo necessario per essere incoronato Re e poi se ne tornò in Normandia: troppi partigiani di Goffredo albergavano a Londra ed in Inghilterra e la fine dei suoi due predecessori gli consigliava la saggia prudenza di risiedere in un territorio a lui fedele. Con questa decisione il Regno restava ancora nelle mani di Goffredo come Reggente e nuovo Lord Cancelliere dopo la partenza per Roma di Thomas Becket. Papa Alessandro II era rimasto infatti deliziato dall'abilità di Becket di gestire la difficile situazione inglese e aveva voluto nominarlo Cardinale. L'inglese fece appena in tempo perché nel 1181 Alessandro II morì e nel successivo Conclave l'oratoria e la saggezza di Becket furono decisive per compattare il fronte filo-imperiale dietro la figura del Patriarca di Gerusalemme Guglielmo da Tiro, uomo sapiente e precettore dell'Imperatore Baldovino III, sconfiggendo la fazione più "nazionalista", capeggiata dal Cardinale lucchese Ubaldo Alluncingoli (in HL Papa Lucio III). Il nuovo Pontefice prese il nome di Stefano X e fu fin dal principio uno dei più grandi collaboratori dell'Imperatore, aiutandolo e consigliandolo nel governare mentre la sua salute declinava sempre di più. Comprendendo l'impellente necessità di rafforzare l'Impero, Stefano X e Baldovino III non videro altra possibilità se non un matrimonio politico e, non potendo l'Imperatore sposarsi a causa della lebbra (che ormai era degenerata a tal punto da obbligarlo ad indossare una maschera d'argento per evitare la vista della sua faccia deturpata) e non avendo quindi figli o figlie da maritare, l'unica possibilità era la sorella del monarca, Sibilla. Per il marito la scelta fu semplice ed era una sola: Enrico di Hohenstaufen, erede del Duca di Svevia Federico III, uno dei più potenti tra i nobili tedeschi e il principale leader politico in alternativa all'Imperatore stesso. Il matrimonio avvenne appena in tempo: nel 1185 Baldovino III il Lebbroso morì mentre si apprestava ad un estenuante viaggio in Terra Santa per rintuzzare la minaccia di Saladino ed Enrico venne scelto come Sacro Romano Imperatore dall'assemblea dei principi tedeschi e confermato dal Papa come Enrico IV. Subito dopo morì anche Stefano X e Thomas Becket venne eletto Papa a 68 anni come Innocenzo IV. Il nuovo Pontefice era decisamente meno entusiasta di Enrico IV rispetto al predecessore, annusandone la puzza di Ghibellinismo da cento miglia, ma dovette suo malgrado mettere da parte i suoi dubbi quando dovette chiedergli una Terza Crociata. In Terra Santa infatti era accaduto che, alla morte del governatore Raimondo III di Tripoli senza eredi, due nobili gerosolimitani, Guido di Lusignano e Rinaldo di Chatillon, aveva de facto usurpato il feudo e avevano iniziato ad attaccare le carovane di pellegrini e mercanti musulmani di passaggio, rompendo così la tregua concordata da Baldovino III nel 1175. Saladino aveva risposto invadendo la Palestina e l'esercito crociato guidato dai due era stato completamente distrutto nella disastrosa Battaglia di Hattin (1187), dovuta ad una serie di pessimi errori strategici e in cui entrambi avevano perso vergognosamente la vita, che aveva permesso a Saladino di riprendere Gerusalemme. La Terza Crociata vide l'immediata adesione di Riccardo I d'Inghilterra, che sui campi mediorientali si guadagnerà il soprannome di Cuor di Leone per il suo coraggio, e dell'Imperatore Enrico IV con il padre, il Barbarossa. Con la piena benedizione di Innocenzo IV, l'esercito crociato si mise in marcia nella primavera del 1189, diretto alla sfida finale con la nemesi dell'intera
Europa...
.
5. Restitutio Integritatis Imperii. ovvero la riunificazione dell'Impero
La Terza Crociata riuscì a battere la seconda nel non invidiabile record di inconcludenza e mancanza di risultati: dopo aver passato la maggior parte del primo anno a litigare coi Bizantini per il diritto di passaggio e a disputarsi il possesso della città di Edessa, quando nell'estate del 1190 i Crociati si rimisero in marcia verso Gerusalemme il Duca di Svevia Federico III Barbarossa, padre dell'Imperatore Enrico IV, morì annegando a causa della pesante armatura mentre guadava il Fiume Saleph, nell'Anatolia Meridionale. Il figlio Enrico si perse rapidamente d'animo e, quando suo fratello Federico morì assediando San Giovanni d'Acri ai primi del 1191, abbandonò la Crociata e se ne ritornò in patria, lasciando il comando a Riccardo Cuor di Leone che, nonostante i coraggiosi sforzi che ne lo avrebbero reso una figura leggendaria nella poesia epica cavalleresca medievale, non riuscì a riconquistare Gerusalemme. Dall'tra parte a Enrico IV interessava relativamente poco di queste guerre lontane, mirando a ben altro: egli aspirava infatti a creare un potente impero con la sua famiglia a capo, accorpando ai feudi svevi (e a quelli lorenesi portatigli in dote dalla moglie Sibilla di Lorena) l'Ereditá Canossiana e la Sicilia per creare una potente base territoriale su cui fondare il proprio dominio. Per guadagnarsi la fedeltà dei nobili tedeschi gli avrebbe offerto l'ereditarietà dei loro domini e avrebbe altresì trasformato i Vescovi in Principi con la possibilità di scegliersi i propri successori, creando così una nuova nobiltà da lui dipendente e a lui fedele. Tutto ciò aveva un grande e principale ostacolo, che si chiamava Papa: il Pontefice infatti non solo non avrebbe mai accettato che i Vescovi venissero trasformati in nobili terreni al di fuori della Chiesa stessa e sottoposti ad un'autorità laica ( oltre al fatto che l'idea di far scegliere i successori a loro stessi e non alla Chiesa era fuori discussione), ma era anche fortemente allergico al pensiero di restituire il controllo dei vecchi feudi canossiani all'Impero. Enrico IV lo sapeva benissimo per cui decise di approfittare dell'esercito (ormai ex) crociato al suo comando per sistemare i suoi conti in Italia. Di ritorno dalla Terra Santa, egli decise sulla strada di fermarsi a visitare la Sicilia, Regno di cui tecnicamente era solo Re Consorte. Accolto con tutti gli onori (era dai tempi di Baldovino I, nel 1111, anche lui di ritorno dalla Palestina, che un'Imperatore/Re di Sicilia non visitava il regno) egli s'insediò a Palermo nell'estate del 1192. In breve tempo pretese di essere riconosciuto come sovrano legittimo ed assoluto, annullando molte delle autonomie che l'isola aveva ottenuto grazie all'assenza prolungata dei suoi sovrani ed esigendo giuramenti di fedeltà alla sua persona da parte di tutta la nobiltà siciliana. L'anno seguente la morte del Cancelliere del Regno Matteo d'Aiello, de facto Reggente per lungo tempo data l'assenza del Monarca, aggravò la situazione giacché Enrico pretese di nominarne uno a lui fedele, scegliendolo tra i nobili tedeschi del suo seguito. I siciliani non gradirono affatto il nuovo corso centralista imposto da quelli avvertiti come usurpatori stranieri (nessuno a corte sapeva una parola di siciliano) e si mostrarono restii a concedere ad Enrico più poteri di quanti gli spettassero nel suo ruolo cerimoniale di Re Consorte. In breve la nobiltà, capitanata dal Conte Riccardo d'Acerra, discendente di una delle più antiche famiglie dell'Isola, e il clero, guidato dal figlio di Matteo, Niccolò d'Aiello, Arcivescovo di Salerno, iniziarono a rumoreggiare e chiesero aiuto al Papa. L'anziano Innocenzo IV era noto per le sue doti oratorie e per il suo uso in difesa delle posizioni ecclesiastiche ma inizialmente optò per la prudenza: inviò pertanto una lettera all'Imperatore, facendogli presente il disappunto suo e dei siciliani al suo governo. La risposta non fu delle migliori: Enrico IV si fece solennemente incoronare a Palermo come se fosse il legittimo sovrano e si mosse fin da subito contro i suoi avversari. Accusato di far parte di una congiura contro il sovrano, Niccolò venne arrestato e brutalmente torturato fino alla morte mentre Riccardo riuscì a fuggire e ad animare la resistenza contro lo Svevo. Poco male: Enrico IV fece rapidamente imprigionare e uccidere migliaia di sospetti anti-svevi ed autonomisti, con l'intenzione di ridurre la Sicilia a niente di più che un feudo. La morte dell'Arcivescovo Aiello spinse Innocenzo IV a rompere gli indugi e scomunicò l'Imperatore ma questi, lungi dall'essere intimorito, sbarcò in Italia e reclamò i feudi canossiani per sé. Il Papa dovette fuggire a Perugia e morì da lì a poco. Nel Conclave umbro del 1196 i Cardinali elessero all'unanimità il trentacinquenne Cardinal Lotario dei Conti di Segni, il più giovane Cardinale del Collegio Cardinalizio, che prese il nome di Leone XII (in HL Innocenzo III). Egli era difatti conosciuto come uno dei più accesi oppositori delle pretese imperiali e la sua giovane età sembrava garanzia di un pontificato duraturo ed energico. Comunque per il momento poté fare ben poco per evitare che Enrico IV, approfittando della morte del suo predecessore, occupasse Roma e buona parte dei feudi pontifici nel Meridione. Enrico considerò l'idea di mettere in sacco Perugia ed imprigionare il Pontefice ma, ritenendo che la cosa gli avrebbe arrecato più danno (d'immagine) che profitto, lasciata una guarnigione nella Città Eterna, si dedicò ad un compito più vantaggioso: la sottomissione delle città dell'Italia Settentrionale. Egli marciò infatti attraverso la Toscana, ove ottenne il sostegno di Pisa e Firenze, e penetrò in Lombardia ove si fermò a Pavia, che era pur sempre la capitale del Regno d'Italia imperiale. Come in Sicilia, egli dichiarò decaduto qualunque diritto del Papa sulla regione e revocò gran parte delle autonomie concesse da Amalrico I. Anche qui i lombardi si dimostrarono poco contenti alla novità e Milano in particolare dovette essere brutalmente occupata dalle soldataglie imperiali. La revoca delle autonomie tuttavia causò un'ondata di ribellioni anti-imperiali in tutta la Penisola: a Roma fu lo stesso Senato, dichiarato decaduto e soppresso, a chiamare alla rivolta, a costringere alla fuga la guarnigione imperiale e a riaccogliere il Papa a braccia aperte. Leone XII si mobilitò subito contro l'Imperatore e in breve riportò dalla sua gran parte dell'Italia Meridionale. In particolare la Sicilia cacciò il governatore imperiale ed elesse Riccardo d'Acerra come suo Re, atto prontamente ratificato dal Pontefice romano. Enrico IV non era disposto a tollerare oltre questa insubordinazione e decise di dare una punizione esemplare. Con l'aiuto di una flotta genovese e di qualche legno pisano egli sbarcò quindi a sorpresa in Sicilia, prendendo Palermo con relativa facilità. A questo punto marciò verso l'interno, saccheggiando e bruciando le città che incontrava sul suo cammino e costringendo Riccardo a ritirarsi nella fortezza di Caltabellotta. Enrico IV pose quindi sotto assedio la cittadella e, dopo oltre un anno di durissimo assedio, ne ebbe ragione: la città venne bruciata insieme a tutti i suoi abitanti e le fortificazioni distrutte. A Riccardo d'Acerra toccò la sorte peggiore: venne mutilato e torturato e quindi appeso a testa in giù in pubblica piazza a Palermo e lì vi rimase per tre giorni e tre notti in dolorosa agonia finché un giullare di corte, impietosito, non gli assestò il colpo di grazia. In realtà la punizione non fece altro che rendere l'Imperatore ancora più odioso agli occhi dei siciliani e nel resto dell'Italia la situazione non migliorò di certo, anzi: il Papa aveva ormai ripreso il controllo del Centro-Sud mentre nel Nord era sorta un'alleanza di città autonome, chiamata Lega Lombarda, che aveva liberato Milano e osteggiava apertamente il dominio di Enrico IV. Poco dopo, nel giugno del 1200, avvenne forse l'evento decisivo per la contesa: la flotta amalfitano-papalina guidata dall'Ammiraglio Margarito, un ex pirata bizantino, sorprese alle fonda la flotta genovese a Milazzo e la incendiò nottetempo. Tagliato fuori, Enrico era padrone della Sicilia ma aveva perso il controllo del resto della penisola e con esso la via per tornare a casa, da cui peraltro gli giungeva notizia che Enrico il Leone, Duca di Baviera e capo dell'opposizione nobiliare tedesca al suo governo, era nuovamente in rivolta. Enrico IV capì che era necessaria un po' di diplomazia, prese carta e penna e scrisse a Leone XII, proponendogli una tregua in occasione dell'Indulgenza dei Cent'Anni indetta dallo stesso Pontefice come celebrazione dell'entrata nel XIII Secolo (ad oggi il più antico Giubileo mai indetto). Il Papa comprese che una trattativa era il modo migliore per permettere ad entrambi di salvare la faccia (l'Imperatore per non uscirne completamente sconfitto, il Pontefice per evitare che questi potesse tornare alla chetichella in Germania e approntare un nuovo esercito) e stabilì le seguenti condizioni: in Sicilia Enrico sarebbe rimasto Re Consorte e sarebbe tornato in Germania, lasciando il regno nelle mani di sua moglie, la legittima Regina, Sibilla di Lorena, che avrebbe anche avuto in cura il loro figlioletto Federico Baldovino; nel resto d'Italia veniva ristabilito lo status quo, compresi i feudi pontifici e gli statuti amalriciani; Enrico IV era riconosciuto legittimo Imperatore e Re di Germania, permettendogli di sedare la rivolta bavarese; infine egli s'impegnava a portare a compimento la Crociata promessa e a liberare la Terra Santa dall'occupante musulmano). L'accordo non andò a genio al sovrano tedesco ma non era troppo rovinoso (gli riconosceva comunque la Sicilia e la Corona Imperiale, compresa la sua autorità sui feudi canossiani, e non gli imponeva nulla di troppo umiliante, tipo andare in pellegrinaggio a Roma col capo cosparso di cenere) e pertanto venne a patti ed accettò. Nel 1201 poté quindi far ritorno in Germania e sconfiggere Enrico il Leone, riprendendosi il trono imperiale. Sennonché la sua presenza agitava un po' tutti: le città del Nord Italia che ne temevano una nuova calata, i nobili tedeschi che rischiavano nuove purghe, gli ecclesiastici intimoriti dal poter essere presi in mezzo da un nuovo scontro con il Papa. Una sua partenza, per la Crociata concordata per esempio, sembrò a tutti una buona idea e dall'tra parte non passava settimana senza che Leone XII non ricordasse al sovrano i suoi doveri nei confronti della Cristianità. Alla fine del 1203 Enrico si decise infine a partire e raggiunse con un esercito allestito alla bell'e meglio Venezia per imbarcarsi: la disfatta di Milazzo rendeva infatti Genova indisponibile per il trasporto ma la Serenissima (da tempo in recessione da quando Genova l'aveva superata nel monopolio del commercio con gli Stati Crociati del Levante) fu intrattabile nel richiedere cifre esose per i suoi servizi. Quando l'Imperatore, appena uscito da un lungo conflitto e da una campagna di arruolamento di mercenari, si scoprì in rosso i veneziani furono lesti a proporre il trasporto scontato in cambio dell'aiuto dei suoi soldati contro i nemici della città lagunare. Enrico IV non andava tanto per il sottile e, trovato l'accordo, sottomise facilmente Zara agli interessi veneziani. Il Papa non era affatto contento che i soldati cristiani si dedicassero ad ammazzare altri cristiani come volgari mercenari e inviò un'ambasceria con lettere pungenti che ingiungevano all'Imperatore di fare quello che doveva fare e nient'altro. Ma gli ambasciatori trovarono solo moli vuoti a Zara giacché la flotta veneziana era già salpata con destinazione Costantinopoli, recentemente interessata da un golpe di palazzo. I pretendenti deposti avevano offerto cifre da capogiro ai veneziani ed agli imperiali perché questi li aiutassero contro i loro avversari e naturalmente il comandante della Serenissima, il Doge Enrico Dandolo, aveva subito fiutato l'affare. Giunta davanti alla capitale bizantina ai primi dell'aprile del 1204, la flotta crociata pose sotto assedio la città e ne ebbe ragione in un tempo relativamente breve, riportando sul trono i propri clienti. I quali tuttavia nel tentativo di alzare le tasse per pagare quanto promesso e di favorire apertamente i soldati e i mercanti europei a scapito di quelli locali si inimicarono rapidamente la popolazione che li rovesciò, favorendo la successione di un nobile della famiglia Ducas, Alessio V, che immediatamente rigettò le promesse fatte ai crociati dal suo sfortunato e defunto predecessore. I Crociati allora irruppero in città e la devastarono, uccidendo Alessio V e conquistando in questo modo il cuore dell'Impero Bizantino. Enrico IV vide la possibilità di coronare il suo grande sogno di riunificazione imperiale e proclamò pertanto suo fratello, Filippo di Svevia, Imperatore Romano d'Oriente e legittimo sovrano bizantino, facendolo incoronare in Santa Sofia. Egli poteva infatti vantare dei diritti grazie al suo matrimonio con Irene Angela, figlia dell'Imperatore Isacco II e sorella di Alessio IV, i due sovrani deposti che si erano rivolti ai veneziani a Zara per riprendersi il trono. Diversi nobili bizantini riuscirono a fuggire, dando vita a diversi staterelli di lingua greca tra Nicea e Trebisonda, ma non costituivano un pericolo immediato sebbene essi dessero rifugio a tutti gli oppositori del nuovo sovrano, in particolare i religiosi ortodossi, in fuga da quando Enrico IV aveva dichiarato riunificate la Chiesa Ortodossa con quella Cattolica. A tal proposito Papa Leone XII si era dimostrato "felice" del "successo" nel "convincere" gli ortodossi a tornare all'ovile ma ne aveva criticato aspramente i metodi violenti contro altri confratelli cristiani per raggiungerla ed intimò ad Enrico di proseguire senza indugi verso la meta della sua missione, Gerusalemme. Ma il sovrano tedesco era accecato dalla possibilità di gloria e stufo delle paternali del Pontefice e i suoi soldati si sentivano sazi dei saccheggi compiuti fin'ora e poco desideravano continuare una guerra quando ne avevano già vinto una più facile che gli aveva riempito le tasche e i bicchieri. Enrico IV dunque si apprestò a tornare in Italia a sistemare una volta per tutte le sue questioni con il Papa ma sulla strada incontrò un nuovo nemico, i Bulgari, che, approfittando del collasso di Bisanzio, stavano premendo in Tracia. Enrico era abbastanza esaltato da accettare battaglia contro quelli che pensava essere un esercito di barbari ma se avesse studiato la Storia avrebbe saputo che i campi di Adrianopoli portavano poca fortuna agli Imperatori e il 14 aprile 1205 venne sbaragliato dall'esercito bulgaro e cadde in battaglia insieme a gran parte dei suoi cavalieri (la Crema dell'Occidente come li definirono i cronisti dell'epoca), lasciando il neorifondato trono d'Oriente e d'Occidente a suo figlio, l'undicenne Federico
I...
.
6.
Defensor Mundi
A seguito della disastrosa disfatta di Adrianopoli e della morte nella stessa del Sacro Romano Imperatore Enrico IV, il suo unico erede era suo figlio, Federico Baldovino di Hohenstaufen, che però era ancora minorenne. Fu quindi suo zio, l'Imperatore bizantino Filippo III (si tiene la numerazione contando anche gli Imperatori romani, dunque anche Filippo l'Arabo e suo figlio Filippo II), a reclamare il trono imperiale d'Occidente in quanto parente maggiorenne più prossimo di Enrico IV e Duca di Svevia. Papa Leone XII tuttavia si oppose sperando di sottrarre la Corona ai fastidiosi Svevi. Si ebbero così due rivendicazioni: da una parte i nobili tedeschi ghibellini elessero Filippo III Re di Germania mentre dall'altra quelli guelfi facevano lo stesso con Ottone IV di Brunswick, che ottenne anche la Corona imperiale da Leone XII. In questa baraonda il piccolo Federico Baldovino venne spedito in Sicilia con la madre Sibilla di Lorena, che morì lo stesso anno lasciandolo legittimo Re di Sicilia. Nel frattempo Filippo III era giunto in Germania con un massiccio esercito bizantino-ghibellino e sconfiggeva Ottone IV nella battaglia di Wassenberg (1206), prendendolo addirittura prigioniero e costringendolo ad abdicare da tutte le sue rivendicazioni. Per evitare una nuova calata in Italia Leone XII lo riconobbe quindi come legittimo sovrano. Filippo decise per ora di non ricominciare le annose contese con il Papa e accettò il rametto d'olivo della riconciliazione: in fondo ora doveva governare un Impero immenso, impero che mancava di unità, leggi comuni e sistemi armonizzati tra loro (giusto per capire per diventare Sacro Romano Imperatore serviva l'elezione da parte dei nobili tedeschi e, tecnicamente, l'incoronazione papale mentre la Corona bizantina era ereditaria, particolarità che rendeva ancora possibile un possibile sdoppiamento dell'Impero, che avrebbe generato molti problemi e sarebbe stata definitivamente risolta solo molto tempo dopo). Nel 1208, a seguito di un tentativo indipendentista bizantino, Filippo fece ritorno a Costantinopoli e, sulla strada, fu capace di guadagnarci anche qualcosa: con la scusa infatti di difendere i possedimenti veneziani sulla costa dalmata egli infatti assunse il controllo della regione, sottraendola al Regno di Croazia ed Ungheria. La mossa era motivata dalla necessità di un collegamento diretto tra i possedimenti italo-germanici e quelli greco-levantini. Appena due anni dopo Filippo dovette accorrere a Nord, per difendere i principati della Germania Settentrionale dalle mire di Re Valdemaro di Danimarca: il conflitto non vide grandi avvenimenti se non una serie di pur impegnative scaramucce nella gelida campagna dello Jutland. Già che si trovava nel Baltico Filippo decise di impegnarsi maggiormente nella regione, recentemente sconvolta dalle Crociate del Nord, lanciate per convertire i riottosi popoli pagani del Nord Europa. L'Imperatore era preoccupato per gli sforzi che la Chiesa stava investendo nell'area: correva voce infatti che Papa a Leone XII intendesse dichiarare i territori baltici "feudo della Chiesa" e avesse consigliato ai polacchi di farsi difendere da ordini cavallereschi religiosi, come i Cavalieri Teutonici o i Portaspada. Egli dunque riaffermò subito con forza il predominio imperiale nel Baltico, creando il Principato di Livonia, vassallo e parte del Sacro Romano Impero. Per contentare il Pontefice lo affidò ai Portaspada, che in fondo avevano sostenuto lo sforzo maggiore nella conquista dell'area. Successivamente, grazie alla vittoria di Tallin del 1217 contro i pagani, la Livonia giungerà ad includere anche Estonia, Senigallia e Curlandia. Più a Sud invece inviò una spedizione militare in sostegno dei polacchi guidato da Corrado I, Duca di Masovia, che fu così in grado di sottomettere le ribelli popolazioni pagane della Prussia (o meglio, in polacco, Prusia). Sistemati i conti a Settentrione, ecco riaprisi i conflitti a Sud: Andrea II, Re d'Ungheria, non era rimasto esattamente entusiasta dell'intromissione imperiale in Dalmazia e, approfittando di una pausa tra un'incursione cumana e l'altra, aveva messo in sacco Zara. Nel marzo del 1213 l'esercito imperiale, rafforzato da rincalzi bizantini, affrontò e vinse con relativa facilità i soldati ungheresi a Karlovac, in Croazia. Nel giro di un anno i nobili scontenti del malgoverno di Andrea, delle sue sconfitte e dei privilegi che accordava ai tedeschi di corte, al seguito di sua moglie, ordirono una congiura che portò il sovrano e consorte ad un incontro ravvicinato con alcuni pugnali e all'ascesa al trono del piccolo Bela IV, di appena quattro anni (congiura che ci fu anche in HL e che portò all'assassinio della moglie ma che alla fine fallì). La precaria reggenza ora al potere a Buda venne rapidamente a patti con Filippo, acconsentendo a cedergli buona parte del Banato di Slavonia, che corrispondeva grossomodo all'antico Regno di Croazia. Gli ungheresi dovettero anche rinunciare alla sovranità sulla Serbia che ottenne così la piena indipendenza. I serbi, grati, acconsentirono quindi volentieri ad un accordo con l'Imperatore, con cui essi cedevano al sovrano svevo le loro regioni costiere (intorno alla base veneziana di Cattaro, in Montenegro) in cambio della Corona Regale che tanto agognavano e che gli venne concessa dal Papa per intercessione dell'Imperatore. Per la prima volta dai tempi dell'Imperatore Teodosio ora si poteva andare da Aquisgrana ad Antiochia rimanendo sempre all'interno dello stesso stato! Il successo era, effettivamente, notevole ed ebbe il suo peso nel Conclave che seguì la morte di Leone XII nel 1216: in realtà i Cardinali era abbastanza soddisfatti della tregua con l'autorità imperiale e avevano ben altre preoccupazioni, come recuperare Gerusalemme dalle mani degli infedeli, contrastare la minacciosa eresia albigense nella Francia Meridionale e mettere ordine tra gli ordini monastici necessari a contrastare paganesimo ed eresie. Venne infine eletto come candidato di compromesso il Cardinal Pietro Collevacino, beneventano, che era stato Legato Apostolico in Provenza e aveva coordinato gli sforzi per contrastare gli albigensi, che prese il nome di Onorio II in onore dell'ultimo pontefice campano, Onorio I. Il nuovo Papa ebbe come principale collaboratore il potente Cardinale Ugolino da Ostia il quale impresse una svolta energica al pontificato: istituì l'Ordine Francescano, combatté duramente gli albigensi e aiutò i Portaspada a consolidarsi nel governo della Livonia. Dopo averne approvato l'Ordine omonimo, Onorio II decise, anche per mostrare nuovamente l'influenza della Chiesa in Oriente dopo l'intervento imperiale nel Baltico, di accogliere senza indugio la richiesta di San Domenico di Guzman di essere inviato tra i Cumani per cristianizzarli. Questo era uno dei più grandi sogni del Santo spagnolo che aveva già imparato a menadito lingua e costumi di quel lontano popolo, che viveva tra le steppe riunito in una Confederazione di Tribù che si estendeva dal Kazakistan alla Moldavia, ma che, senza l'intervento papale, difficilmente avrebbe potuto realizzare, visti gli oberanti impegni derivatigli dal suo nuovo Ordine monastico. Con al seguito diversi frati predicatori e qualche cavaliere teutonico, San Domanico passerà il resto della sua vita tra i popoli delle steppe, diventando prima il primo Arcivescovo e poi il Patrono di quelle lontane regioni chiamate Cumania, fino alla sua morte nel 1221. Intanto però un assassinio aveva sconvolto l'Europa: tornato finalmente in Germania dopo anni passati a viaggiare in giro per l'Impero per consolidarlo, l'Imperatore Filippo venne ucciso da Otto von Wittelsbach, nipote del suo vecchio avversario Ottone IV di Brunswick, ufficialmente per ragioni personali. Suo nipote Federico Baldovino, già Re di Sicilia, 24 anni, ascese quindi al trono imperiale come Federico
I. Il nuovo sovrano era più simile al padre, Enrico IV, che non allo zio ed era un convinto assertore della superiorità dell'Impero sul Papato, cosa che raffreddò notevolmente le relazioni con Roma. Ad ogni modo il giovane neo-coronato aveva bisogno di tempo per consolidare il suo governo e Onorio II non era il tipo da svegliare il can che dorme per cui, almeno all'inizio, i rapporti proseguirono abbastanza civilmente. A contribuire fu anche il peggioramento della situazione nella Francia Meridionale, ove, a seguito della morte del leader crociato Simone di Montfort, i crociati stessi erano stati sconfitti pesantemente dai catari guidati Raimondo VII, Conte di Tolosa. Federico
I aveva ereditato dal padre la passione militaresca e le ambizioni territoriali ed espansioniste per cui si offrì di occuparsi della questione, che in fondo ricadeva all'interno dei confini del Regno imperiale di Arles. Con l'appoggio del giovane Raimondo Berengario, Conte di Provenza, l'Imperatore marciò quindi alla volta del Rodano e piegò i rivoltosi: Lione e Avignone vennero restaurate come territori imperiali mentre Marsiglia veniva data alla Provenza. Mentre la pace veniva firmata, nell'autunno del 1220, giunse la notizia della morte di Onorio II: Ugolino da Ostia venne quindi eletto Papa come Gregorio VIII e già il nome lasciava intuire in che direzione fosse cambiato il vento. Il nuovo Pontefice aveva in simpatia le rivendicazioni imperiali quanto quelle musulmane e non si preoccupava certo di nasconderlo ma ancora lo scontro fu rimandato: Federico
I spese gli anni successivi a riportare ordine e controllo nei suoi territori occidentali, reprimendo le sporadiche ribellioni catare e riaffermando antichi vassallaggi. Amante delle lingue romanze, egli inoltre istituì una vera e propria scuola poetica provenzale a corte e fondò la prestigiosa Università di Avignone, oggi ritenute tra i maggiori motivi di sopravvivenza della cultura occitana. Quando finalmente l'Imperatore ritornò in Italia nel 1225, con il mezzo sogno di riprendersi i feudi canossiani, trovò Gregorio VIII pronto ad aspettarlo e ben preparato a schivare il colpo: come poteva infatti un sovrano cristiano pretendere obbedienza quando non assolveva ai suoi doveri in difesa della sua Fede e dei suoi confratelli? E come osava questo sovrano preferire futili rivendicazioni terrene alla liberazione della Terra Santa? Si potevano dire tante cose di Papa Gregorio e una di queste è che aveva una faccia di bronzo pazzesca, ma non lo si può certamente accusare di mancanza di eloquenza, cosicché, con la Dieta di San Germano, Federico dovette giurare di portare a termine la Crociata in Palestina laddove i suoi predecessori avevano fallito, pena la scomunica. Per evitare dilazioni e rinvii il giuramento aveva pure una data di scadenza, ovvero il 1227. Agli inizi di quell'anno Federico
I si mise dunque alla testa dell'esercito imperiale e, partito da Venezia, giunse in settembre a Costantinopoli, ove fu bloccato da una pestilenza. Finalmente nell'estate del 1228 gli imperiali si rimisero in marcia verso Sud ma, dopo una serie di vittorie secondarie, Federico preferì cercare un accordo che lo disimpegnasse dal Levante e lo riportasse in fretta verso la sue ambizioni italiche. Egli fece così la pace con il Sultano ayyubide al-Malik al-Kamil, che gli cedette la Terra Santa e Gerusalemme a patto di non costruirvi nuove fortificazioni e di permettere il passaggio dei pellegrini musulmani. Sulla via del ritorno Federico
I nominò suo figlio Enrico, avuto dall'ormai defunta prima moglie Costanza d'Aragona, Cesare d'Oriente e lo lasciò a governare Costantinopoli e i territori orientali. Quest'atto segnò il culmine del processo di riorganizzazione amministrativa iniziato da suo zio Filippo di Svevia, in quanto d'ora in poi il titolo di Cesare d'Oriente sarà sempre assegnato all'erede al trono imperiale e diverrà così la seconda carica più importante dell'Impero, mentre quella di Vicario Imperiale in Italia verrà via via slegata dalla dinastia regnante per essere data di volta in volta a importanti feudatari o vassalli locali fedeli alla Corona. Inoltre la ripartizione, con un Imperatore che regnava su tutti i territori dell'Impero, ma che risiedeva spesso in Germania, l'erede al trono che governava i territori orientali e teneva a bada le irrequietezze greche risiedendo alle Blaquerne e il Vicario Imperiale che aveva responsabilità sui territori italici da Pavia, cioè in pratica l'esistenza di una scala gerarchica che garantisse un Imperatore "germanico", un Cesare "greco"be un Vicario "italico", garantiva una sorta di federalizzazione del potere imperiale che accontentava le varie anime del grande stato. Ad ogni modo, quando Federico
I ritornò in Europa si ritrovò immensamente popolare: dopo più di mezzo secolo era infatti riuscito nell'incredibile impresa di riprendere i Luoghi Santi senza colpo ferire! La popolarità ne compattò il potere e le ambizioni e innervosì molto il Papa che si preparò allo scontro. Che puntualmente avvenne nell'estate del 1230: il pretesto fu minimo (una città dei feudi pontifici rifiutò di pagare un tributo all'erario imperiale) ma quello che seguì non lo fu. Federico
I varcò le Alpi con il suo esercito e avanzò verso Sud, seppur ostacolato dalla resistenza delle città lombarde lanciategli contro da Gregorio VIII. Una dopo l'altra queste dovettero però capitolare e Federico era ormai sul punto di guadare l'Arno e puntare direttamente su Roma sennonché, ai primi del 1233, suo figlio, il Cesare Enrico, sposò le ambizioni nazionaliste della nobiltà bizantina e si proclamò Imperatore. Federico
I dovette firmare una tregua con il Papa e lasciare l'Italia alla volta dei Balcani, non senza aver lasciato fior fiore di podestà e signorie ghibelline in molte città. Enrico si fece stupidamente sconfiggere in capo a due anni sotto le mura di Tessalonica e fu deposto ed imprigionato e sarebbe di morto di lebbra in prigione dieci anni più tardi. Nuovo Cesare fu quindi incoronato l'altro figlio di Federico, Corrado, sette anni, avuto dalla sua seconda ed amatissima moglie Bianca Lancia. Approfittando della tregua, nel 1234, con la Bolla Pietati Proximum, il Papato riconobbe la nascita dello Stato dell'Ordine Teutonico di Burzenland, in Transilvania, (Siebenbürgen in tedesco), un territorio che era stato ceduto all'Ordine da Andrea II d'Ungheria nel 1211 per contrastare le incursioni cumane (in HL Andrea II se lo riprese nel 1225); lo stesso anno anche l'Impero fece la stessa cosa. Federico inoltre decise di mettere brevemente ordine anche ad Occidente ove Raimondo VII, Conte di Tolosa, si era schierato coi ghibellini per via dei brutti rapporti con il Papato da quando era stato sostenitore degli albigensi mentre Raimondo Berengario, Conte di Provenza, si era per reazione alleato al campo guelfo, in un vero e proprio rovesciamento di alleanze. Per questo Federico, rintuzzati di provenzali, strinse un'alleanza con Raimondo VII, elevandolo al rango di Marchese e concordando il matrimonio della sua unica figlia, Giovanna, 15 anni, con il Cesare d'Oriente Corrado. Sistemati i conti Federico
I ritornò in Italia e il 27 novembre 1237 ottenne una sfolgorante vittoria contro le milizie della Lega Lombarda a Cortenuova, vicino a Bergamo. A seguito di questa vittoria Federico
I rimase de facto il padrone d'Italia, costringendo alla resa Milano, Brescia e le altre città ribelli e obbligando il Papa a più miti consigli. La Pace di Bologna sancì il ritiro di tutte le scomuniche contro l'Imperatore (che per l'occasione si fece reincoronare in San Pietro la Vigilia di Natale dello stesso anno) e l'annullamento del Trattato di Lucca: i Feudi Canossiani ritornavano direttamente all'Imperatore che ne assegnò una parte al Regno di Lombardia (principalmente i territori a Nord del Po) e riorganizzò il resto (grossomodo Toscana, Emilia e Romagna) nel rinato Ducato di Tuscia. La Corsica invece venne infeudata a Genova come ricompensa per i suoi servigi. Un'altro gran colpo fu il matrimonio concordato l'anno dopo tra il figlio più giovane di Federico, Enzo, e l'ultima discendente dei Re di Sardegna che fece del giovane rampollo svevo il legittimo sovrano dell'Isola. Sembrava che finalmente la pace fosse stata assicurata all'Impero e invece iniziarono ad arrivare ambascerie sempre più allarmate dall'Oriente: profughi Cumani cristiani si riversavano nei Balcani terrorizzati, delirando su un'Orda di mostri sanguinari che stava avanzando da Est, mercanti veneziani e genovesi riferivano di un minaccioso invasore che si profilava dalla Persia all'Ucraina, villaggi e città intere smettevano improvvisamente di dare notizie e altre erano trovate semplicemente deserte ma con macabre file interminabili di teste impalate disposte tutt'intorno in un lago di sangue. L'orrore ebbe presto un nome: Mongoli. L'imponente Orda invase l'Europa come un fiume in piena ai primi del '40 e calpestò e bruciò tutto ciò che trovo sulla sua strada: caddero così i Cumani, i Peceneghi, i Russi.... Gli ungheresi tentarono di opporre resistenza e furono spazzati via: Re Bela IV fuggì nell'Adriatico sotto protezione veneziana e chiese aiuto all'Imperatore in cambio della sua sottomissione. Federico
I si mobilitò subito e ottenne l'appoggio, riluttante, del Papa e di Re Luigi IX di Francia contro la minaccia comune. Nel mentre i Teutoni erano costretti a rifugiarsi tra le vette più inaccessibili e scoscese dei Carpazi mentre i Polacchi, per loro sfortuna abitanti in una regione pianeggiante perfetta per la cavalleria mongola, vennero travolti in una disastrosa battaglia. Così il 5 agosto 1242 l'Orda Mongola, forte di 120.000 guerrieri mongoli addestratissimi e fedeli fino alla morte al loro condottiero Batu Khan, nipote di Gengis Khan, si scontrò nella Battaglia del Fiume Nidda, poco a ovest di Francoforte sul Meno, con l'armata condotta dall'Imperatore Federico
I di Hohenstaufen, forte di 100.000 uomini. In essa alle truppe germaniche si erano aggiunte quelle delle città dell'Italia settentrionale, guidate da Ezzelino III da Romano, le forze del Regno di Sicilia e delle regioni orientali guidate dal Cesare Corrado e quelle del Regno di Sardegna al comando di Re Enzo, entrambi figli di Federico
I, un contingente francese inviato da Re Luigi IX, uno inglese spedito da Re Arturo II d'Inghilterra, le truppe polacche di Corrado di Masovia, Duca di Polonia, e quelle boeme del Venceslao I, Duca di Boemia, oltre alle schiere dei Cavalieri templari, dei Cavalieri Portaspada, dei Cavalieri Ospedalieri e dei Cavalieri Teutonici. Papa Gregorio VIII era morto l'anno prima e i Cardinali avevano eletto Papa il Cardinal Raniero Capocci da Viterbo, uomo molto colto che aveva comandato personalmente le milizie pontificie contro Federico
I nella recente guerra e stretto amico e collaboratore di Gregorio VIII, col nome di Gregorio IX. Il nuovo Pontefice, pur condividendo l'opinione del suo predecessore sull'Imperatore, si era precipitato in Germania alla testa delle truppe guelfe e ora arringava e benediceva con piglio militaresco le spaventate e raccogliticce soldataglie che avrebbero dovuto opporsi all'Apocalisse in persona. Accantonata la propaganda guelfa che vedeva in lui nientemeno che l'Anti-Cristo, ora Federico
I era additato e presentato come l'ultima speranza, l'ultima difesa per la Cristianità, come l'ultimo Difensore del Mondo...
La battaglia incombe. É in gioco il destino dell'Europa: come andrà a finire?
.
7.
La Battaglia per l'Europa
La battaglia che decise le sorti dell'Europa prese il nome di Battaglia del Fiume Nidda a causa dell'estensione del campo di battaglia dovuto all'enormità delle forze in gioco ma forse più propriamente avrebbe dovuto chiamarsi Battaglia di Friedberg perché il grosso dei combattimenti si svolse presso questa piccola cittadina di poche migliaia di abitanti, una decina di chilometri a Nord di Francoforte. La geografia giocò un ruolo decisivo in questo scontro: mentre l'Orda Mongola penetrava e razziava in Europa, la presenza a Nord del Mar Baltico e a Sud dei Monti Carpazi costrinse le armate del Gran Khan ad attraversare la sfortunata Polonia fino a giungere nella Germania Settentrionale e quindi piegare verso Sud-Ovest attraverso il Bassopiano Germanico per puntare sul Reno e su Francoforte, principale città del Sacro Romano Impero, il che voleva dire, per i difensori, che il nemico sarebbe giunto da Nord-Est. Entrando nella valle del Nidda da Grünberg, i mongoli avrebbero dovuto costeggiare il paludoso fiume tedesco e guadare il suo affluente, il Wetter, presso
 Freidberg per poi attraversarlo direttamente all'altezza di Francoforte, nei pressi di Vilbell. Friedberg, a poca distanza dalla confluenza dei due fiumi rappresentava dunque una strozzatura strategica in cui costringere
l'aggressore (a fianco, la valle del fiume Nidda). Non solo, ma la cittadina, seppur piccola, era dotata di una fortezza che dominava la vallata circostante e avrebbe permesso di ammassare le provviste, che sarebbero giunte numerose dalla grande fiera annuale della città, seconda solo a quella di Francoforte stessa. Per tutti questi motivi l'Imperatore Federico I scelse questo luogo come campo di battaglia e vi pose nelle vicinanze il proprio accampamento, giusto sull'altra sponda del Wetter rispetto alla direttrice d'arrivo dei nemici. Fattore che si rivelerà ancor più decisivo, fino agli anni '70 del Novecento, quando furono bonificate, le sponde del fiume Nidda e la vallata circostante erano soggette a ripetute inondazioni e risultavano quindi paludose e acquitrinose, un terreno altamente sfavorevole alla cavalleria mongola, principale e sostanzialmente unica arma della grande armata mongola. La sera del 4 agosto 1242 un trafelato cavaliere con una freccia in una spalla giunse ansimante al campo: Grünberg era stata raggiunta dai mongoli e ora i roghi delle sue case e le urla degli abitanti che non erano riusciti a fuggire in tempo si riverberavano nella notte. Dopo aver bruciato Berlino, Magdeburgo, Lipsia, Dresda, Hannover, Kassel e Gottinga i Mongoli non avevano trovato altro che piccoli villaggi durante la marcia verso Francoforte ed erano dunque affamati di saccheggio. Avrebbero guadato il Wetter e sarebbero giunti a Friedberg il mattino seguente, si convenne nell'accampamento europeo. I monti di Vogelsberg, a Est, e Taunnus, a Ovest, impedivano ai cavalieri dell'Oriente di intraprendere altre strade. Venne passata parola, i cittadini di Friedberg furono fatti fuggire verso Francoforte nottetempo e le armi furono lucidate. Il mattino seguente, ancora prima che l'alba sorgesse su una notte insonne, l'Imperatore Federico I fece uscire il suo variegato esercito dall'accampamento e gli fece attraversare il Wetter, disponendosi poi con le spalle al fiume. Una mossa tatticamente sbagliata, poiché impediva la fuga in caso di ritirata, aveva in realtà un grande valore simbolico che fu sottolineato dallo stesso sovrano: qui si sarebbe decisa la sorte del Mondo Occidentale e non vi erano alternative che la vittoria e la libertà o una morte onorevole in battaglia. Non si sarebbe potuti essere codardi o traditori neppure volendolo ormai. Tagliando la ritirata al suo stesso esercito, Federico I sottolineò l'inevitabilità del loro compito, che venne accolto da una silenziosa consapevolezza. L'esercito imperiale venne così schierato: a Nord, sul fianco sinistro, vicino alla cittadina di Neuheim, stavano i contingenti inviati da altre nazioni, in particolare i cavalieri francesi ed ungheresi, guidati dal fratello del Re di Francia, Carlo d'Angiò, e dal Re d'Ungheria Bela IV, la fanteria polacca del giovane Duca di Prusy Casimiro I, figlio del defunto Corrado I, Alto Duca di Polonia e Duca di Masovia e Prusy, e fratello di Boleslaw I, Duca di Masovia, i soldati provenzali del Conte Raimondo Berengario e gli arcieri inglesi inviati da Re Arturo II sotto il comando di suo cugino, Enrico di Winchester, Duca di Normandia, figlio di suo zio, Giovanni il Serpente. In aggiunta a questi Federico I vi destinò i soldati comandati personalmente da Papa Gregorio IX, che fu designato comandante del fianco sinistro, contante circa trentamila soldati. Essendo così variegato era il fianco che aveva maggiori possibilità di cedere e così Federico I lo mise a Nord, in modo tale da assicurare una posizione più defilata rispetto all'avanzata della cavalleria avversaria e lasciandogli intendere di non avere altra scelta se non combattere con tutte le loro forze, visto che erano la parte dell'esercito più lontana rispetto alle mura di Francoforte. Sul fianco destro Federico I mise i soldati del Marchese di Tolosa Raimondo VII, le truppe del Duca di Boemia Venceslao I e soprattutto i soldati delle città e dei territori italici guidati da Ezzelino III da Romano, che era anche il comandante in capo del fianco destro, annoverante circa ventimila uomini, visto che doveva difendere soprattutto la paludosa sponda settentrionale del Nidda, poco appetibile da parte dei seguaci del Khan e facilmente difendibile. Al centro infine si trovava l'imperatore in persona alla testa delle truppe germaniche, delle armate bizantine, guidate dal Cesare Corrado (che in virtù della sua giovane età, appena quattordici anni, aveva lasciato il comando effettivo nelle mani di Goffredo di Hohenlohe, Gran Maestro dell'Ordine Teutonico e dunque sovrano del Burzenland), dei reparti crociati e di quelli degli Ordini Teutonico, dei Portaspada, Templare e degli Ospitalieri, per un totale di cinquantamila uomini. Alle prime luci del mattino una grande nuvola di polvere venne avvistata innalzarsi in direzione di Grünberg mentre un leggero rombo crescente faceva increspare le pozzanghere e tremare la terra. Nessuno aveva bisogno di spiegazioni: qualcosa come centomila cavalli stavano arrivando al galoppo verso di loro. Federico I indossò la sua armatura dorata e salì sul suo cavallo bianco, disponendosi al centro del suo schieramento, ben visibile per animare i suoi uomini. Papa Gregorio IX passò davanti a tutte le file, mentre il tremore aumentava, impartendo a tutti l'ultima benedizione e ricordando che il giorno dopo sarebbe stata la Festa della Trasfigurazione di Gesù e dunque era il caso di fare almeno bella figura. Finalmente, verso le dieci del mattino, l'orda mongola apparve e caricò subito lo schieramento cristiano, urlando versi orribili e agitando le loro armi per spaventare gli avversari. Qualcuno trema, qualcuno vacilla, ma il fiume Wetter sbarre sempre la strada: non resta che rimanere e combattere. I cavalieri mongoli sono a trecento metri, duecento, centocinquanta, cento... "Ora!" urla l'Imperatore quando ormai i mongoli non distano che una trentina di metri dalla prima linea. La prima fila si abbassa e la seconda, composta da arcieri inglesi e balestrieri svizzeri lascia partire una micidiale raffica di dardi contro le file nemiche. A questa distanza, con i nemici così vicini, nessun tiro è a vuoto. La prima ondata di cavalieri cade falciata e disarcionata e viene travolta dalla seconda che a sua volta incespica ed inciampa, ma non si ferma. Non può, ormai lo slancio li spinge in avanti con troppa forza per fermarsi. Le prima file cozzano le une contro le altre, scontro immane di scudi, lance spezzate, spade, metallo contro metallo che già si sporca di sangue. La mischia è immensa, si combatte ferocemente da entrambe le parti. La grande massa di mongoli cerca di sfondare al centro, quella è la parte importante, perché, una volta crollata, le ali saranno isolate e si daranno alla fuga. Poi improvvisamente i mongoli ripiegano, dandosela a gambe. I soldati scalpitano, vorrebbero inseguire quei vigliacchi, ma Federico I li ferma, ha sentito i racconti dei cumani, dei russi, dei polacchi e degli ungheresi, sa delle trappole dei guerrieri venuti dal Lontano Oriente... Ma non così i cavalieri francesi che si lanciano in avanti per inseguire i fuggitivi. Quando, nel giro di pochi minuti, i mongoli fanno dietro front e attaccano a sorpresa gli incauti soldati del Re di Francia, Papa Gregorio IX, che sta osservando tutto da sopra un grande carro su cui ha fatto erigere una grande croce bianca perché protegga i soldati cristiani e che stava già bofonchiando maledizioni contro quei dannati francesi, salta su come un grillo urlando "Giammai un cristiano non soccorra un altro cristiano! Forza, fratelli, impugniamo le armi e accorriamo in loro difesa, perché non si dica che quest'oggi abbiamo mancato ai nostri doveri verso Nostro Signore: le campane, suonate le campane...vedrete che l'aiuto arriverà! E ora alla pugna, alla pugna!". Il fianco sinistro si precipitò così tutto insieme contro i cavallerizzi mongoli che già si preparavano a farsi un sol boccone dei francesi e che vennero invece presi di sorpresa da questo contrattacco. In breve la piana poco a nord di Friedberg si trasformò in una mischia furibonda e confusa, con altri mongoli che affluivano contro i soldati europei mentre questi li combattevano con foga senza arretrare di un passo. In mezzo il Carroccio rappresentava il baluardo e il fulcro della difesa cristiana nonché l'unico punto di riferimento visibile e non pochi commentatori dell'epoca giurano di aver visto Gregorio IX sopra di esso, con la sua svolazzante veste bianca, intento a suonare vivacemente la campana con una mano mentre con l'altra e con un piede ricacciava i mongoli giù dal carro urlando cose come "Giù da questo sacrissimo carro, mannaggia a voi! Non osate insozzarlo con le vostre dannate manacce pagane! E li mortacci tuoi...pussa via, e tu prendi questo, brutto muso!". Vedendo il centro mongolo spostarsi per prendere alle spalle la sua ala sinistra Federico I decise che era il momento di battersi come leoni: sguainò nuovamente la spada e si gettò in avanti urlando "Soldati dell'Impero, diamo loro una mano!", alche il Cesare Corrado gridò "Tutti con l'Imperatore!" e si gettò a sua volta alla carica seguito da tutto il centro. Mentre le trombe suonavano alla riscossa, la carica imperiale colse di sorpresa i cavalieri mongoli che si ritrovarono presi tra due fuochi. Fu una strage: mezzi accerchiati, senza aspettarsi una resistenza così tenace, con i cavalli stanchi per la lunga marcia e azzoppati dalle paludi e ostacolati dal fango, i mongoli non riuscirono a riprendere l'iniziativa e l'esercito cadde nel caos. Una fetta consistente, vista la malaparata e data le scarse possibilità di bottino, cercò di sganciarsi e di darsela a gambe ma fu intercettata dall'ala destra di Ezzelino III che ne massacrò una gran quantità. Entro sera la temibile armata mongola era dispersa ed in rotta e i soldati cristiani festeggiavano sul campo vittorioso con tanto fervore che si dice che per molti giorni il fiume Nidda e le paludi adiacenti erano composte da più birra che acqua! In realtà oggi gli storici hanno appurato che quella affrontata a Friedberg non fu altro che un'avanguardia di un corpo d'invasione principale contro il quale le pur valorose forze europee non avrebbero avuto probabilmente scampo. Ma-e qui quando lo seppe Gregorio IX e tutti i Papi successivi non fecero altro che additarlo come un evidente miracolo- a diecimila chilometri di distanza era morto il Gran Khan Ögödei e la legge mongola imponeva a tutti i comandanti militari di rientrare in patria per eleggere un nuovo Khan. Così i mongoli si ritirarono mentre all'opposto gli europei erano in festa e trasformavano il Carroccio pontificio in uno dei più grandi simboli di collaborazione ed orgoglio europeo. Ma i grandi festeggiamenti furono funestati anche da un triste evento: l'Imperatore Federico I era stato colpito da una freccia mongola durante la sua ultima e vittoriosa carica ma, nonostante la ferita, aveva continuato a lottare fino alla fuga definitiva dei mongoli. Nei giorni successivi si era ulteriormente speso per inseguire a distanza i mongoli e assicurarsi che non tornassero indietro e per visitare e portare la buona novella nelle terre recentemente devastante dalla marea mongola, che, proprio come l’evento naturale, stava ora defluendo. La scarsa attenzione prestata alla ferita e lo sforzo fisico contribuirono a causare una grave infezione, a causa della quale, quando tornò due settimane dopo a
Francoforte, dove nel frattempo non avevano ancora smesso di festeggiare, era già in preda ad una grave febbre. I soccorsi furono inutili e probabilmente anche l'aria insalubre di quelle stesse paludi che gli avevano assicurato la vittoria contribuì a debilitarlo sempre di più, fino alla morte sopraggiunta il 26 agosto 1242. La morte di quello che era ormai considerato da tutti come il Salvatore d'Europa generò una grande commozione in tutto il Continente e non ci fu città che non dedicò messe al suo nome. Il suo funerale avvenne alla presenza di tutti i sovrani continentali, che non avevano ancora smobilitato, e lo stesso Gregorio IX, prima suo inflessibile avversario, tenne una celebre orazione funebre in cui non lesinò parole di lode e di rimpianto per il defunto. L'incredibile atmosfera di affetto che aveva avvolto questo sovrano, prima così controverso, nel momento in cui aveva assunto le redini del Mondo conosciuto per salvarlo fu accresciuta ancora di più dalla sua morte. Per pochi mesi egli era stato l'incontrastato leader di tutti i popoli europei e cristiani e questo lo innalzò a simbolo dell'unità della Cristianità e di
un intero continente. E fu anche e sopratutto per questo che, osservando il feretro mentre veniva calato nella fossa, il suo segretario e biografo Thomas von Mazzon commentò triste "Con lui muore
l'Europa..."
Freidberg per poi attraversarlo direttamente all'altezza di Francoforte, nei pressi di Vilbell. Friedberg, a poca distanza dalla confluenza dei due fiumi rappresentava dunque una strozzatura strategica in cui costringere
l'aggressore (a fianco, la valle del fiume Nidda). Non solo, ma la cittadina, seppur piccola, era dotata di una fortezza che dominava la vallata circostante e avrebbe permesso di ammassare le provviste, che sarebbero giunte numerose dalla grande fiera annuale della città, seconda solo a quella di Francoforte stessa. Per tutti questi motivi l'Imperatore Federico I scelse questo luogo come campo di battaglia e vi pose nelle vicinanze il proprio accampamento, giusto sull'altra sponda del Wetter rispetto alla direttrice d'arrivo dei nemici. Fattore che si rivelerà ancor più decisivo, fino agli anni '70 del Novecento, quando furono bonificate, le sponde del fiume Nidda e la vallata circostante erano soggette a ripetute inondazioni e risultavano quindi paludose e acquitrinose, un terreno altamente sfavorevole alla cavalleria mongola, principale e sostanzialmente unica arma della grande armata mongola. La sera del 4 agosto 1242 un trafelato cavaliere con una freccia in una spalla giunse ansimante al campo: Grünberg era stata raggiunta dai mongoli e ora i roghi delle sue case e le urla degli abitanti che non erano riusciti a fuggire in tempo si riverberavano nella notte. Dopo aver bruciato Berlino, Magdeburgo, Lipsia, Dresda, Hannover, Kassel e Gottinga i Mongoli non avevano trovato altro che piccoli villaggi durante la marcia verso Francoforte ed erano dunque affamati di saccheggio. Avrebbero guadato il Wetter e sarebbero giunti a Friedberg il mattino seguente, si convenne nell'accampamento europeo. I monti di Vogelsberg, a Est, e Taunnus, a Ovest, impedivano ai cavalieri dell'Oriente di intraprendere altre strade. Venne passata parola, i cittadini di Friedberg furono fatti fuggire verso Francoforte nottetempo e le armi furono lucidate. Il mattino seguente, ancora prima che l'alba sorgesse su una notte insonne, l'Imperatore Federico I fece uscire il suo variegato esercito dall'accampamento e gli fece attraversare il Wetter, disponendosi poi con le spalle al fiume. Una mossa tatticamente sbagliata, poiché impediva la fuga in caso di ritirata, aveva in realtà un grande valore simbolico che fu sottolineato dallo stesso sovrano: qui si sarebbe decisa la sorte del Mondo Occidentale e non vi erano alternative che la vittoria e la libertà o una morte onorevole in battaglia. Non si sarebbe potuti essere codardi o traditori neppure volendolo ormai. Tagliando la ritirata al suo stesso esercito, Federico I sottolineò l'inevitabilità del loro compito, che venne accolto da una silenziosa consapevolezza. L'esercito imperiale venne così schierato: a Nord, sul fianco sinistro, vicino alla cittadina di Neuheim, stavano i contingenti inviati da altre nazioni, in particolare i cavalieri francesi ed ungheresi, guidati dal fratello del Re di Francia, Carlo d'Angiò, e dal Re d'Ungheria Bela IV, la fanteria polacca del giovane Duca di Prusy Casimiro I, figlio del defunto Corrado I, Alto Duca di Polonia e Duca di Masovia e Prusy, e fratello di Boleslaw I, Duca di Masovia, i soldati provenzali del Conte Raimondo Berengario e gli arcieri inglesi inviati da Re Arturo II sotto il comando di suo cugino, Enrico di Winchester, Duca di Normandia, figlio di suo zio, Giovanni il Serpente. In aggiunta a questi Federico I vi destinò i soldati comandati personalmente da Papa Gregorio IX, che fu designato comandante del fianco sinistro, contante circa trentamila soldati. Essendo così variegato era il fianco che aveva maggiori possibilità di cedere e così Federico I lo mise a Nord, in modo tale da assicurare una posizione più defilata rispetto all'avanzata della cavalleria avversaria e lasciandogli intendere di non avere altra scelta se non combattere con tutte le loro forze, visto che erano la parte dell'esercito più lontana rispetto alle mura di Francoforte. Sul fianco destro Federico I mise i soldati del Marchese di Tolosa Raimondo VII, le truppe del Duca di Boemia Venceslao I e soprattutto i soldati delle città e dei territori italici guidati da Ezzelino III da Romano, che era anche il comandante in capo del fianco destro, annoverante circa ventimila uomini, visto che doveva difendere soprattutto la paludosa sponda settentrionale del Nidda, poco appetibile da parte dei seguaci del Khan e facilmente difendibile. Al centro infine si trovava l'imperatore in persona alla testa delle truppe germaniche, delle armate bizantine, guidate dal Cesare Corrado (che in virtù della sua giovane età, appena quattordici anni, aveva lasciato il comando effettivo nelle mani di Goffredo di Hohenlohe, Gran Maestro dell'Ordine Teutonico e dunque sovrano del Burzenland), dei reparti crociati e di quelli degli Ordini Teutonico, dei Portaspada, Templare e degli Ospitalieri, per un totale di cinquantamila uomini. Alle prime luci del mattino una grande nuvola di polvere venne avvistata innalzarsi in direzione di Grünberg mentre un leggero rombo crescente faceva increspare le pozzanghere e tremare la terra. Nessuno aveva bisogno di spiegazioni: qualcosa come centomila cavalli stavano arrivando al galoppo verso di loro. Federico I indossò la sua armatura dorata e salì sul suo cavallo bianco, disponendosi al centro del suo schieramento, ben visibile per animare i suoi uomini. Papa Gregorio IX passò davanti a tutte le file, mentre il tremore aumentava, impartendo a tutti l'ultima benedizione e ricordando che il giorno dopo sarebbe stata la Festa della Trasfigurazione di Gesù e dunque era il caso di fare almeno bella figura. Finalmente, verso le dieci del mattino, l'orda mongola apparve e caricò subito lo schieramento cristiano, urlando versi orribili e agitando le loro armi per spaventare gli avversari. Qualcuno trema, qualcuno vacilla, ma il fiume Wetter sbarre sempre la strada: non resta che rimanere e combattere. I cavalieri mongoli sono a trecento metri, duecento, centocinquanta, cento... "Ora!" urla l'Imperatore quando ormai i mongoli non distano che una trentina di metri dalla prima linea. La prima fila si abbassa e la seconda, composta da arcieri inglesi e balestrieri svizzeri lascia partire una micidiale raffica di dardi contro le file nemiche. A questa distanza, con i nemici così vicini, nessun tiro è a vuoto. La prima ondata di cavalieri cade falciata e disarcionata e viene travolta dalla seconda che a sua volta incespica ed inciampa, ma non si ferma. Non può, ormai lo slancio li spinge in avanti con troppa forza per fermarsi. Le prima file cozzano le une contro le altre, scontro immane di scudi, lance spezzate, spade, metallo contro metallo che già si sporca di sangue. La mischia è immensa, si combatte ferocemente da entrambe le parti. La grande massa di mongoli cerca di sfondare al centro, quella è la parte importante, perché, una volta crollata, le ali saranno isolate e si daranno alla fuga. Poi improvvisamente i mongoli ripiegano, dandosela a gambe. I soldati scalpitano, vorrebbero inseguire quei vigliacchi, ma Federico I li ferma, ha sentito i racconti dei cumani, dei russi, dei polacchi e degli ungheresi, sa delle trappole dei guerrieri venuti dal Lontano Oriente... Ma non così i cavalieri francesi che si lanciano in avanti per inseguire i fuggitivi. Quando, nel giro di pochi minuti, i mongoli fanno dietro front e attaccano a sorpresa gli incauti soldati del Re di Francia, Papa Gregorio IX, che sta osservando tutto da sopra un grande carro su cui ha fatto erigere una grande croce bianca perché protegga i soldati cristiani e che stava già bofonchiando maledizioni contro quei dannati francesi, salta su come un grillo urlando "Giammai un cristiano non soccorra un altro cristiano! Forza, fratelli, impugniamo le armi e accorriamo in loro difesa, perché non si dica che quest'oggi abbiamo mancato ai nostri doveri verso Nostro Signore: le campane, suonate le campane...vedrete che l'aiuto arriverà! E ora alla pugna, alla pugna!". Il fianco sinistro si precipitò così tutto insieme contro i cavallerizzi mongoli che già si preparavano a farsi un sol boccone dei francesi e che vennero invece presi di sorpresa da questo contrattacco. In breve la piana poco a nord di Friedberg si trasformò in una mischia furibonda e confusa, con altri mongoli che affluivano contro i soldati europei mentre questi li combattevano con foga senza arretrare di un passo. In mezzo il Carroccio rappresentava il baluardo e il fulcro della difesa cristiana nonché l'unico punto di riferimento visibile e non pochi commentatori dell'epoca giurano di aver visto Gregorio IX sopra di esso, con la sua svolazzante veste bianca, intento a suonare vivacemente la campana con una mano mentre con l'altra e con un piede ricacciava i mongoli giù dal carro urlando cose come "Giù da questo sacrissimo carro, mannaggia a voi! Non osate insozzarlo con le vostre dannate manacce pagane! E li mortacci tuoi...pussa via, e tu prendi questo, brutto muso!". Vedendo il centro mongolo spostarsi per prendere alle spalle la sua ala sinistra Federico I decise che era il momento di battersi come leoni: sguainò nuovamente la spada e si gettò in avanti urlando "Soldati dell'Impero, diamo loro una mano!", alche il Cesare Corrado gridò "Tutti con l'Imperatore!" e si gettò a sua volta alla carica seguito da tutto il centro. Mentre le trombe suonavano alla riscossa, la carica imperiale colse di sorpresa i cavalieri mongoli che si ritrovarono presi tra due fuochi. Fu una strage: mezzi accerchiati, senza aspettarsi una resistenza così tenace, con i cavalli stanchi per la lunga marcia e azzoppati dalle paludi e ostacolati dal fango, i mongoli non riuscirono a riprendere l'iniziativa e l'esercito cadde nel caos. Una fetta consistente, vista la malaparata e data le scarse possibilità di bottino, cercò di sganciarsi e di darsela a gambe ma fu intercettata dall'ala destra di Ezzelino III che ne massacrò una gran quantità. Entro sera la temibile armata mongola era dispersa ed in rotta e i soldati cristiani festeggiavano sul campo vittorioso con tanto fervore che si dice che per molti giorni il fiume Nidda e le paludi adiacenti erano composte da più birra che acqua! In realtà oggi gli storici hanno appurato che quella affrontata a Friedberg non fu altro che un'avanguardia di un corpo d'invasione principale contro il quale le pur valorose forze europee non avrebbero avuto probabilmente scampo. Ma-e qui quando lo seppe Gregorio IX e tutti i Papi successivi non fecero altro che additarlo come un evidente miracolo- a diecimila chilometri di distanza era morto il Gran Khan Ögödei e la legge mongola imponeva a tutti i comandanti militari di rientrare in patria per eleggere un nuovo Khan. Così i mongoli si ritirarono mentre all'opposto gli europei erano in festa e trasformavano il Carroccio pontificio in uno dei più grandi simboli di collaborazione ed orgoglio europeo. Ma i grandi festeggiamenti furono funestati anche da un triste evento: l'Imperatore Federico I era stato colpito da una freccia mongola durante la sua ultima e vittoriosa carica ma, nonostante la ferita, aveva continuato a lottare fino alla fuga definitiva dei mongoli. Nei giorni successivi si era ulteriormente speso per inseguire a distanza i mongoli e assicurarsi che non tornassero indietro e per visitare e portare la buona novella nelle terre recentemente devastante dalla marea mongola, che, proprio come l’evento naturale, stava ora defluendo. La scarsa attenzione prestata alla ferita e lo sforzo fisico contribuirono a causare una grave infezione, a causa della quale, quando tornò due settimane dopo a
Francoforte, dove nel frattempo non avevano ancora smesso di festeggiare, era già in preda ad una grave febbre. I soccorsi furono inutili e probabilmente anche l'aria insalubre di quelle stesse paludi che gli avevano assicurato la vittoria contribuì a debilitarlo sempre di più, fino alla morte sopraggiunta il 26 agosto 1242. La morte di quello che era ormai considerato da tutti come il Salvatore d'Europa generò una grande commozione in tutto il Continente e non ci fu città che non dedicò messe al suo nome. Il suo funerale avvenne alla presenza di tutti i sovrani continentali, che non avevano ancora smobilitato, e lo stesso Gregorio IX, prima suo inflessibile avversario, tenne una celebre orazione funebre in cui non lesinò parole di lode e di rimpianto per il defunto. L'incredibile atmosfera di affetto che aveva avvolto questo sovrano, prima così controverso, nel momento in cui aveva assunto le redini del Mondo conosciuto per salvarlo fu accresciuta ancora di più dalla sua morte. Per pochi mesi egli era stato l'incontrastato leader di tutti i popoli europei e cristiani e questo lo innalzò a simbolo dell'unità della Cristianità e di
un intero continente. E fu anche e sopratutto per questo che, osservando il feretro mentre veniva calato nella fossa, il suo segretario e biografo Thomas von Mazzon commentò triste "Con lui muore
l'Europa..."
.
8. Ne ferisce più il Papa che la Spada
Corrado IV d'Occidente (Sacro
Romano Impero) e I d'Oriente (Impero Bizantino) era diventato Imperatore a soli
14 anni e senza altri membri adulti della famiglia che lo potessero assistere,
come era stato con Filippo III per Federico I. Pertanto fu imbastito un
Consiglio di Reggenza comprendente il Cardinale Hugh de Saint-Chier, Legato
Pontificio in Germania, il Gran Maestro dell'Ordine Teutonico e Sovrano del
Burzenland Goffredo di Hohenlohe, l'Arcivescovo di Magonza Sigfrido III von
Epstein, il Langravio di Turingia Enrico Raspe, che lo presiedeva, e il Duca di
Boemia Venceslao I. Non avendo al momento eredi, suo fratello Manfredi, dieci
anni, fu nominato Cesare d'Oriente e inviato a Costantinopoli. I tre anni che
seguirono la vittoria del Fiume Nidda furono caratterizzati da questo improvviso
vacuum del e nel potere imperiale, in netto contrasto con la sovrapposizione che
si era invece avuta sotto suo padre Federico I. La necessità ricostruire le aree
devastate dai mongoli e lo sforzo economico e sociale in essa profuso
contribuirono indebolire il potere imperiale, il che lasciò mano libera agli
altri membri del Consiglio. Enrico Raspe iniziò a governare come se fosse lui
l'Imperatore, accarezzando neanche tanto nascostamente l'idea di sostituirsi a
quello legittimo e costruendo una base di potere nella sua natia Turingia,
mentre i Duchi di Boemia acquisivano e accumulavano potere e ricchezze fino a
diventare tra i più importanti nobili dell'Impero. Goffredo di Hohenlohe invece
gestì a proprio vantaggio il processo di ricostruzione delle zone devastate
dalla furia mongola: in particolare incanalò i migliaia di profughi tedeschi che
avevano abbandonato quelle terre prima e dopo l'invasione e li accolse a braccia
aperte in Transilvania, ove già sussisteva una nutrita minoranza tedesca e dove
l'Ordine Teutonico mirava a rafforzare il proprio potere aumentando la compone
etnica germanica per contrastare il predominio slavo e magiaro. Tra le
conseguenze di questa politica si ebbero la progressiva germanizzazione del
Burzenland (lo stato teutonico in Transilvania) e il fallimento dell'analogo
piano portato avanti da Giovanni I il Teologo, Signore del Meckleburgo, che
stava cercando di sostituire la maggioranza slava abitante la costa baltica
germanica con abitanti tedeschi, cosa che risultò impossibile non solo per la
mancanza di "materia prima", dirottata nei Balcani, ma anche a causa
dell'afflusso di innumerevoli profughi polacchi ed slavi che si era spostati ad
Occidente per sfuggire all'avanzata mongola. Nonostante ciò molte città furono
ricostruite in breve tempo, sebbene alcune delle più giovani e piccole (come la
neonata Berlino, fondata appena cinque anni prima del passaggio dei mongoli)
fossero andate definitivamente perdute. Ad approfittare della debolezza
imperiale fu anche e sopratutto il Papato: il Pontefice Gregorio IX, sfruttando
il fatto di essere, dopo la morte di Federico I, il principale eroe della lotta
contro i Mongoli sopravvissuto e la relativa popolarità, riuscì a dilazionare a
lungo la nomina di un nuovo Vicario Imperiale in Italia e ottenne una lunga
serie di concessioni dal minorenne Corrado che permisero al Pontefice di
riassumere il controllo o comunque molta influenza sui territori della sempre
contesa Eredità Canossiana. Se Corrado non crebbe come una marionetta in mano ai
suoi consiglieri e cortigiani fu sopratutto per merito del suo tutore Pier delle
Vigne, già Cancelliere sotto Federico I. Fu così che, raggiunta la maggiore età
nel 1245 ed incoronato ufficialmente Imperatore, Corrado IV e I si mosse subito
nella direzione opposta in cui speravano i reggenti: egli sciolse infatti il
Consiglio, tolse ad Enrico Raspe la carica di Canceliere che affidò invece al
delle Vigne e, giusto per essere chiari fin da subito, nominò il vecchio
generale Ezzelino III da Romano, ultra-ghibellino, come nuovo Vicario Imperiale
in Italia con l'esplicito ordine di rimettere ordine nella giurisdizione
imperiale. Le reazioni naturalmente non si fecero attendere: Papa Gregorio IX
convocò un Concilio a Lione e scomunicò Corrado, dichiarandolo deposto, e
appoggiò invece la rivolta del Raspe, che, dopo tanti anni passati come il Re de
facto, ora che aveva perso la carica voleva esserlo anche de iure e si era
ribellato. Dopo un iniziale successo tuttavia, Raspe morì senza figli e diede
inizio alla Guerra di Successione della Turingia, in cui si contrapponevano
Sofia di Bramante, nipote di Enrico Raspe, suo cugino Enrico III di Meissen e
l'Arcivescovo di Magonza Sigfrido III von Epstein, già membro del Consiglio di
Reggenza di Corrado, in quanto prima della dinastia dei Raspe la Turingia era
stato un possedimento dell'Arcivescovado e ora questi lo rivolevano indietro.
Approfittando delle divisioni tra i guelfi (il Papa sosteneva Sigfrido e i
nobili Sofia), Corrado intervenne e sconfisse i due pretendenti, investendo poi
l'alleato Enrico III di Meissen dei Langraviati di Turingia e Assia. Mentre
l'Imperatore era tuttavia impegnato tra le foreste turinghe, i nobili e i
vescovi renani e lorenesi, che da tempo si sentivano trascurati dai nuovi
Imperatori non lorenesi, offrirono la corona imperiale a Guglielmo II d'Olanda
che accettò e venne immediatamente supportato dal Papa. Tuttavia gli stessi
nobili olandesi si pronunciarono per rimanere fedeli all'Imperatore e Guglielmo
II venne in un primo momento sconfitto, mentre in Italia Ezzelino contribuiva a
mantenere l'ordine con piglio sanguinario e militaresco. Vista la male parata,
Papa Gregorio IX, usando la sua vecchia prerogativa di "protettore della
Sicilia", chiese aiuto a Carlo d'Angiò, fratello del Re di Francia, che aveva
già incontrato sui campi del Fiume Nidda e con cui era recentemente ritornato a
parlare per via di un suo possibile matrimonio con Beatrice di Provenza sul
quale il Pontefice era stato interpellato, offrendogli la Corona di Sicilia in
cambio del suo aiuto. Carlo, che da tempo aspirava ad una corona (l'eventuale
matrimonio con Beatrice sarebbe dovuto servire a quello), radunò un esercito e
giunse in Italia, guerreggiando con Ezzelino III e costringendo Corrado IV a
calare oltralpe con nuovi rinforzi . Guglielmo II, ottenuto l'appoggio del Duca
di Brunswick grazie ad un matrimonio combinato con sua figlia, cercò quindi di
impossessarsi della Germania in sua assenza ma fu fortemente ostacolato dalle
forze ghibelline di Enrico III di Meissen e dei ribelli fiamminghi e lorenesi,
incoraggiati dal'Arcivescovo di Colonia Corrado di Hochstaden e guidati da Guido
di Dampierre. In tutto questo caos alla fine di maggio del 1250 morì Papa
Gregorio IX: i Cardinali, capeggiati da Riccardo Annibaldi e Giangaetano Orsini,
elessero infine il francese Hugh de Saint-Cher, un po' per le sue doti
diplomatiche come legato Pontificio in Germania e membro del Consiglio di
Reggenza, un po' perché come francese avrebbe strizzato l'occhio al supporto
francese attraverso Carlo d'Angiò, che prese il nome di Alessandro III. Corrado
IV ne approfittò per scendere nuovamente in Italia e respingere le forze guelfe,
ottenendo l'ubbidienza delle città settentrionali con alcune modiche concessioni
fiscali. Una tregua tra il giovane Imperatore e il nuovo Pontefice venne
concordata ma non resse a lungo, a causa degli intrighi dei vescovi tedeschi e
della brutale repressione portata avanti da Ezzelino III e nel 1252 la guerra
ricominciò. Con Guglielmo II impantanato nei suoi problemi su al Nord, Corrado
IV decise nuovamente di concentrarsi sull'Italia: conquistate senza troppe
grosse difficoltà Milano e Cremona nell'estate del 1253, l'Imperatore radunò un
grosso esercito nei pressi di Forlì per continuare l'avanzata su Roma l'anno
seguente. Sennonché Corrado s'ammalò di malaria (contratta probabilmente durante
la guerra in zone fluviali paludose come quelle del vicino Po) e morì a soli 26
anni il 27 maggio 1254. Fatto curioso, durante il suo funerale un eccessiva
concentrazione di candele e ceri presso il feretro causarono un violento
incendio che distrusse il catafalco e danneggiò gravemente il duomo di Bologna,
evento che i guelfi attribuirono al contrappasso divino dovuto ai crimini del
sovrano scomunicato. La morte di Corrado IV paradossalmente ingarbugliò ancora
di più la situazione invece di contribuire a districarla: in Germania Guglielmo
II d'Olanda reclamò la corona imperiale per se, con il sostegno di alcuni nobili
(ma non quelli olandesi) e del Papa (ma non del clero tedesco); i ghibellini
sostennero invece la candidatura di Corradino, unico figlio di Corrado IV e di
sua moglie, Giovanna di Tolosa, che però aveva solo due anni e di cui in molti
rivendicavano la reggenza e l'affidamento; il fratello di Corrado IV e zio di
Corradino, Manfredi, Cesare d'Oriente, che fino ad ora non aveva mosso un dito
per aiutare il caro congiunto nelle sue lotte dinastiche e si era cullato
nell'idea di essere il nuovo sovrano bizantino, reclamò allora, in quanto
parente più anziano, il trono imperiale sull'esempio di quanto aveva fatto
Filippo III con Federico I; ciliegina sulla torta, l'Arcivescovo di Colonia
Corrado di Hochstaden e un gruppo di altri nobili ostili a Guglielmo II tennero
una pseudo-dieta (in realtà tutte erano pseudo-diete visto che non erano mai
complete di tutti i nobili tedeschi ma solamente di quelli che parteggiavano per
il candidato che l'aveva convocata) che offrì la corona imperiale ad Ottocaro II,
Duca di Boemia, senza contare le candidature auto-avanzate da parte di Riccardo
di Cornovaglia, fratello del Re d'Inghilterra Enrico IV, e di Alfonso X, Re di
Castiglia. Come al solito, grande caos imperava sotto il cielo e la disfida si
sarebbe dovuta decidere con le armi. Innanzitutto Papa Alessandro III inviò una
perentoria lettera all'Arcivescovo di Colonia Corrado di Hochstaden,
ingiungendogli di cessare immediatamente il proprio sostegno ad Ottocaro II, per
evitare di dividere il fronte guelfo in troppi candidati e per non indebolire la
candidatura di Guglielmo II, il quale peraltro, sconfitto su quasi tutti i
fronti, morì ignominiosamente nel gennaio del 1256, quando, mentre combatteva
una rivolta tra i Frisoni, la superficie ghiacciata di un fiume che stava
attraversando cedete, uccidendolo. Dopo questo fatto e con l'aiuto del fido
Enrico III di Meissen, Manfredi riuscì facilmente ad entrare in Germania con il
suo esercito bizantino e a farsi riconoscere come Imperatore della Dieta
tedesca, dichiarando poi ufficialmente Corradino come proprio erede. Anche il
Pontefice acconsentì ad una tregua e lo incoronò, in cambio del riconoscimento
dell'occupazione della Sicilia. La pace non poteva durare e la guerra ricominciò
ben presto nella primavera del 1257: con l'aiuto di Ezzelino III, Manfredi I
penetrò facilmente in Italia e sconfisse le forze guelfe nei pressi di Mantova,
giungendo quindi ad occupare Roma, ove ottenne la fedeltà del Console
Brancaleone degli Andalò, mentre il Papa si rifugiava a Viterbo. Manfredi quindi
tentò una spedizione per riconquistare la Sicilia, occupata dalle forze guelfe
guidate da Carlo d'Angiò, ma la campagna si rivelò difficile e faticosa, a causa
della resistenza guelfa ben impiantata nell'entroterra siciliano e all'appoggio
internazionale a Carlo d'Angiò (oltre alla Francia, lo sostenevano infatti anche
Inghilterra e Norvegia, convinte da Alessandro III). Mentre il sovrano era
duramente impegnato in Sicilia, il Papa ne approfittò per rialzare la testa e
mobilitare le forze guelfe nella penisola, che furono coagulate in una vera e
propria crociata contro Ezzelino III e Manfredi I. Lo stesso Ezzelino III, ormai
da tempo signore delle terre venente e soprannominato l'Orco di Padova per la
gentilezza da lui dimostrata nei confronti della città dopo un tumulto guelfo,
venne attirato in trappola ed accerchiato mentre marciava alla volta della
ribelle Milano: egli cadde così nella disastrosa Battaglia di Cassano d'Adda il
16 settembre 1259. La notizia del disastro spinse Manfredi I ad un precipitoso
ritorno in patria e, radunate le proprie milizie, riuscì ancora a cogliere una
netta vittoria nella Battaglia di Montaperti un anno dopo, il 4 settembre 1260,
in Toscana. Tuttavia Carlo d'Angiò colse immediatamente l'occasione per
mobilitare il suo esercito e sbarcare nei feudi pontifici in Italia Meridionale,
per poi risalire la penisola. La battaglia decisiva fra i due fu più volte
rimandata, poiché Manfredi dovette tener testa anche ai guelfi tedeschi e a
quelli lombardi capitananti da Azzo VII d'Este, Signore di Ferrara, mentre Carlo
combatteva i ghibellini toscani e romani. Neppure la morte di Alessandro III nel
1263 e l'elezione del suo gran e dotto collaboratore Alberto Magno di Bollstad
col nome di Leone XIII riuscirono a rasserenare gli animi e a evitare lo
scontro, nonostante la più conciliante e diplomatica posizione del nuovo
Pontefice. Finalmente il 26 febbraio 1266 i due eserciti si scontrarono nei
pressi di Prato: in ultima analisi l'idea di indossare armature che non
proteggevano i fianchi e le diserzioni tra gli alleati italiani dopo la morte di
Ezzelino e un decennio di lunghe guerre inconclusive si rivelarono fattori
decisivi per la sconfitta del fronte ghibellino. L'Imperatore Manfredi I cadde
eroicamente in battaglia, combattendo fino all'ultimo, mentre i suoi soldati
sbandavano e lavoravano di calcagni per sottrarsi all'accerchiamento guelfo. La
morte di Manfredi I lasciava la Corona Imperiale al piccolo Corradino, 14 anni,
cresciuto finora lontano dall'agone politico, in Germania, sotto la cura della
madre Giovanna, Imperatrice Madre e Marchesa di Tolosa dal 1249, che divenne
Corrado V e II. Visto il pessimo risultato dell'ultima volta, si convenne a non
istituire alcun Consiglio di Reggenza ma si procedette invece all'immediata
incoronazione del sovrano, che avrebbe governato assistito dalla madre. Giovane
ed inesperto, Corrado V venne facilmente convito da alcuni cortigiani a tentare
di farsi un nome e una fama che eliminassero l'idea di un piccolo moccioso
seduto sul trono imperiale, conducendo un'avventata spedizione punitiva in
Italia. Dopo aver facilmente preso Verona, Pavia e Pisa, le forze ghibelline
erano riuscite ad entrare nuovamente a Roma, sempre grazie all'aiuto del Console
della città, Enrico di Castiglia. Corrado V si era allora esaltato e aveva
cercato di affrontare direttamente Carlo d'Angiò, venendo disastrosamente
sconfitto nella Battaglia di Tagliacozzo il 23 agosto 1268 e preso prigioniero
dalle milizie guelfe. Durante la battaglia Carlo fece indossare la propria
armatura ad un altro cavaliere cosicché, quando questi cadde in battaglia, le
forze ghibelline ruppero le righe per lanciarsi all'inseguimento di quello che
ormai ritenevano un esercito sconfitto e decapitato e furono invece travolti
dalla cavalleria tenuta sapientemente di riserva e guidata dallo stesso Carlo.
Sembra che il comandante francese fosse addirittura propenso a condannare a
morte e a far decapitare il giovanissimo sovrano ma l'intervento del Pontefice
stesso, per bocca del giovane Cardinale e primo collaboratore di Leone XIII,
Tommaso D'Aquino, facenti leva sulla carità cristiana e sulla giovane età dello
sconfitto, nonché sul suo importante rango, salvarono la vita a Corrado V, il
quale dovette comunque sottoscrivere una pace umiliante, in cui riconosceva il
dominio guelfo sui territori canossiani, sulla Sicilia e sulla Corsica e
accettava di nominare nuovo Vicario Imperiale in Italia il guelfo Azzo VII.
Mentre tornava via Brennero in Germania Corrado V e II si sentiva umiliato e
deriso, additato come un piccolo, stupido rampollo viziato che osava paragonarsi
al grande nonno, e sembra che neppure le parole di conforto del grande amico
Federico I di Baden-Baden potessero consolarlo. Ma si sa, la vita è lunga e
piena di sorprese, diamogli ancora qualche anno per crescere...
Federico
Sangalli
.
E questo è
il commento in proposito di *Bhrg'howidhHô(n-):
La mia domanda nasceva dal confronto fra testo e cartina. Un primo dubbio era dovuto alla duplice interpretazione possibile del lungo periodo «la penisola italiana è divisa tra lo Stato della Chiesa, che si estende sostanzialmente su Lazio, Umbria, Marche, Abruzzi (quindi anche il Molise) e Campania, oltre a possedere Puglia e Calabria (con la Lucania spartita tra i due) sotto forma di feudi pontifici, in pratica su tutto il Centro-Sud, il Regno di Sicilia, i Giudicati sardi (di Arborea, cioè di Oristano, di Calare, cioè di Cagliari, di
Lugudoro, cioè di Porto Torres, e di Gallura, cioè di Olbia) e il Ducato di
Tuscia, che si estende su Toscana, Emilia, Romagna e Lombardia e appartiene alla Duchessa Ida di Canossa, anziana e senza figli», che può significare sia “la Penisola Italiana [e aggiungerei la Cisalpina, che non è né Penisola Italiana né italiana, nonché le Isole Maggiori] è divisa fra lo Stato della Chiesa, il Regno di Sicilia [che non è Penisola], i Giudicati Sardi [che non sono Penisola] e il Ducato di Tuscia” sia, come avevo inteso, “la Penisola Italiana (più Cisalpina e Isole Maggiori) è divisa fra da un lato lo Stato della Chiesa, che si estende su Lazio, Umbria, Marche, Abruzzi (quindi anche il Molise) e Campania, oltre a possedere Puglia e Calabria (con la Lucania spartita fra le due [che però non è vero, se si guarda la cartina, corretta]) sotto forma di Feudi Pontifici, in pratica su tutto il Centro-Sud, il Regno di Sicilia, i Giudicati Sardi
(tuto questo dipendente da «lo Stato della Chiesa, che si estende su...») e dall’altro il Ducato di
Tuscia». Interpretavo così proprio per l’espressione «Penisola»: la Penisola propriamente detta (all’epoca non ci sarebbe stato alcun senso di chiamare «Penisola» anche la Cisalpina e le Isole Maggiori, visto che non facevano parte di un’unica compagine politica centrata sulla Penisola) è effettivamente divisa fra Stato della Chiesa e Ducato di
Tuscia, il che spiega l’espressione «Penisola» e al contempo la menzione della Cisalpina (in quanto interessata dal Ducato o Marchesato di
Tuscia) e delle Isole Maggiori (in quanto, in tale interpretazione, soggette allo Stato della Chiesa) e siccome però appunto dalla cartina le Isole Maggiori non risultano affatto appartenenti allo Stato della Chiesa mi era sorto il dubbio.
Avrei dato ragione alla cartina (e avrei fatto bene, ho poi capito, no?) e avrei considerato «Penisola» un anacronismo politico (come poi «Emilia» e soprattutto «Ticino»: fa lo stesso effetto che parlare del “territorio di Littoria” o “di Mussolinia” riferendosi al Medioevo, non è sbagliato – basta sottintendere «di quella che nel XX secolo è stata edificata e chiamata così» – ma certo rimane un po’ straniante), se non fosse che un simile dubbio mi sorgeva per la Lombardia e qui mi avvedo che la questione è ben maggiore.
Chiarito che allora per la sola questione della Media e Alta Valtellina la cartina va interpretata come sovraestendente i confini della
Tuscia, il resto che avevo scritto era una lode per aver scelto in cartina il confine fra Neustria e Austria longobarde (che privilegiavo rispetto al testo, il quale attirbuiva invece tutta la Lombardia alla
Tuscia) e invece dalla risposta ricavo che prevale anche in questo caso il testo sulla cartina, ma allora mi permetto di dissentire, nel presupposto che questa ucronia (autodefinitasi «articolo») non sia un romanzo (di proprietà esclusiva del’Autore), ma una discussione storica. I motivi sono che: 1) siccome la risposta contiene l’affermazione «conoscendo la differenza tra l'attuale Lombardia e la Lombardia per così dire "storica", ho inteso come Lombardia appunto la Lombardia dell'epoca» e tutti sappiamo che la Lombardia cosiddetta “storica” era il Bacino del Po (lo si vede anche dalla cartina per la parte di Regno di Lombardia che non è stata inclusa nell’ucronico Marchesato di Toscana; basta andare a vedere la cartina vera che è servita di base), allora fra cartina e testo («ella si adoperò per allargare i domini dei Canossa su gran parte dell'Italia Centro-Settentrionale (comprese la totalità di Emilia, Lombardia, Romagna e Toscana)») prevale la cartina (dove la maggior parte della Lombardia “storica” non è compresa nei Dominî dei Canossa) e non il testo (questa è una considerazione di pura Filologia Fridericiana o
Sangallesca, se si può dir così) e tuttavia nella Terza Puntata leggo «l'Imperatore Stefano I concedette i feudi
canossiani, riuniti all'interno del Ducato di Tuscia/Toscana, al Papato, permettendo a Roma di amministrare praticamente ogni città tra Milano e Reggio Calabria», il che significa che Milano (che in cartina è nel Regno di Lombardia) apparterrebbe invece ai Beni
Canossiani, quindi c’è una contraddizione fra risposta e Terza Puntata; 2) immagino che la nuova risposta sarà che la Terza Puntata prevale su qualsiasi precedente affermazione in contrasto, ma a questo punto devo riprendere la Prima Puntata in realzione agli eventi ucronici degli Anni Ottanta e Novanta dell’Undicesimo Secolo. Premessa storica: nel 1093 Milano si ALLEA con Matilde di Canossa contro Enrico IV per sottrarsi alla dipendenza dall’Impero di quest’ultimo circa gli affari governativi e l’Arcivescovo Anselmo III da Rho si riconcilia con la Curia Romana sotto Papa Urbano II. In questa ucronia, Matilde è Imperatrice, quindi ci si attenderebbe, a stare pedissequamente dietro alla Storia vera, che Milano si schierasse contro di lei e suo marito Goffredo II nella Lotta per le Investiture (alleandosi casomai con Enrico di
Franconia, storicamente Enrico IV); ammettiamo però, per logica interna all’ucronia, che l’opera mediatrice di Matilde sia tale da conservare Milano nel campo imperiale (contrariamente alla Storia) ossia nel proprio (conformemente alla Storia): a questo punto Milano e la Lombardia (perlomeno l’Arcivescovato) diventano come la
Lotaringia, una base territoriale dell’Imperatore: perché mai dovrebbero poi passare al Papa? Sono o Allodî di Famiglia (e allora seguono la Legge
Salica) oppure Kaiserliche Reichsländer (e allora vanno al successivo Imperatore), ma di certo non faranno il gioco di servire due padroni, per il semplicissimo motivo che o uno dei due padroni non percepisce tributi (e allora l’Imperatore che ne facesse dono o Investitura al Papa sarebbe un idiota totale; queste donazioni si facevano quando non si disponeva di questi Beni e si mirava alla Corona, non quando si aveva la Corona e i Beni erano già dell’Imperatore) oppure entrambi i padroni li percepiscono (e allora gli idioti sono i Milanesi, che invece di diventare autonomi – come nella Storia vera – si sottomettono non a uno, ma a due Padroni!). Quindi: o Milano – come da cartina – fa parte del Regno di Lombardia (ed è quindi relativamente autonoma, come nella Storia reale) oppure – come da testo – fa parte dei Beni
Canossiani, ma allora, come tutti questi ultimi, è base territoriale dell’Imperatore, in quanto Allodio o in quanto Kaiserliches
Reichsland; non c’è una terza possibilità.
Questo mi porta al punto più delicato. In tutta l’ucronia si ripete che non c’è «un meccanismo certo per l'ascesa alla guida dell'Impero, a parte la consacrazione e l'incoronazione da parte del Papa»: è vero, ma le due affermazioni messe insieme omettono due particolari essenziali: a) non c’era un meccanismo certo perché le procedure erano due, l’Ereditarietà (attraverso l’elezione del figlio del Sovrano durante la vita di questi) oppure l’Elezione (affermatasi dopo i Carolingi fino agli Ottoni e di nuovo dopo i Salii fino agli
Svevi, infine dopo gli Svevi). Il Sovrano era il Re dei Franchi Orientali e il Papa non aveva la benché minima voce in capitolo. Poteva trattarsi di uno scomunicato o di un non Cristiano, l’Elezione o la Successione sarebbero state valide lo stesso; b) il Papa aveva solo il Potere di incoronare il Sacro Romano Imperatore, non di scegliere (o porre il voto su) il Re dei Romani. Si noti che anche l’Arcivescovo di Milano – indipendentemente dal Papa – aveva una facoltà, quella di incoronare il Re dei Longobardi (al poso dell’Elezione da parte dei Grandi, che era rimasta in vigore fino a Ottone III e poi notoriamente con Arduino d’Ivrea). L’Incoronazione di Goffredo il Barbuto da parte di Stefano IX sarebbe stata appunto tale, ma la condizione imprescindibile era la sua Elezione da parte dei Principi (tutti) dell’Impero, fra i quali chi sceglieva i Candidati erano i Laudātōrēs, le massime Cariche in Franconia (i tre Arcivescovi Renani e il Conte Palatino), che poi avrebbero costituito il nucleo del Collegio degli Elettori. Trasformare questa situazione nel meccanismo illustrato in quest’ucronia va perfino oltre i più ambiziosi progetti di Gregorio
VII, Alessandro III o Innocenzo III: pensavo che in questa Lista ci fosse un solo Sostenitore della Monarchia Pontificia Universale, ma vedo che la Matrice Neoguelfa porta in questo campo anche Esponenti della Sinistra Repubblicana...
Da qui discendono le esagerazioni ‘costantiniane’ degli Imperatori in questa ucronia: Goffredo I che cede al Papato (non a suo fratello come Feudo personale; al Papato come Stato!) tutte le conquiste nel Meridione della Penisola e si accontenta della Sicilia; Goffredo III (storicamente sostenitore di Enrico
IV!!) che cede al Papa Gerusalemme (qui non è Goffredo di Buglione – tant’è che reprime il tentativo di Enrico di Franconia – ma l’Imperatore...); Stefano I (nemmeno Principe Tedesco) che cede al Papa – proprio allo Stato della Chiesa, nemmeno, per dire, come Feudo Ecclesiastico al modo dei Vescovi-Conti in Germania (mi chiedo cosa ne pensasse l’Arcivescovo di Milano, Oberto I da
Pirovano) – l’Eredità Canossiana e la Corsica (mi chiedo cosa importasse allora a Genova di averla solo in spīrituālī nella propria Arcidiocesi, tale dal 1133) e concede a Matilde il Diritto di Successione in Inghilterra (sapevo che sarebbe andata a finire così; eppure non è che perché qualche volta ho fatto commenti ucronici in direzione di un Impero Mondiale non posso criticare una scelta geopolitica così assurda: i Patti di Mutua Successione si fanno appunto con una Dinastia altrettanto potente e soprattutto non si divide l’Eredità!)...
Per riassumere: propongo di aumentare la plausibilità storica di questa bellissima e interessantissima ucronia introducendo almeno un vero Patto di Mutua Successione Dinastica e il minimo ridimensionamento indispensabile dello Strapotere Pontificio (il Punto di Divergenza è una... convergenza fra UN Papa – massimo due – e l’Impero, magari anche una collaborazione prolungata – che sarebbe stata vantaggiosa per entrambi – ma non la sottomissione dell’Impero al Papato) attraverso il mantenimento dei Beni Canossiani all’Imperatore (come Allodio o come Kaiserliches
Reichsland) e il trattamento di Milano come principale Città Imperiale (la più importante, anche rispetto alla
Lotaringia) oppure, più modestamente e realisticamente, come Capitale di fatto del Regno di Lombardia (amministrata dall’Arcivescovo).
Quisquilie linguistiche: «fortunosamente» significa “per caso, accidentalmente, in qualche maniera”, non “fortunatamente” (nelle due ricorrenze non riesco a capire se debba intendere proprio «fortunosamente» o invece “fortunatamente”); gli Editti non sono Encicliche (per cui non impongono il proprio generale grammaticale all’incipit usato come titolo), quindi prendono il genere grammaticale del proprio titolo, in questo caso femminile
(Renouātiō Senātūs).
.
C'è ora la
proposta di Generalissimus:
Nel 1084 arrivò a Roma Roberto il Guiscardo, chiamato da Papa Gregorio VII perché lo salvasse dall'Imperatore Enrico IV di Franconia.
Assolse il suo compito, ma la salvezza personale fu l'unica cosa che il Pontefice guadagnò dall'arrivo dei Normanni.
Dopo aver sonoramente battuto le truppe Imperiali, la soldatesca del Guiscardo si mise a saccheggiare la città, la cui popolazione inferocita costrinse Gregorio VII ad andare in esilio a Salerno, dove rimase fino alla morte perché Roberto si schierò contro la restituzione dei suoi pieni poteri.
Tra l'altro il re normanno andò via da Roma lasciandola completamente sguarnita e alla mercé dell'Antipapa Clemente III e delle milizie imperiali che lo proteggevano.
Ma cosa accadrebbe se Roberto il Guiscardo approfittasse della situazione per impadronirsi dei territori dello Stato Pontificio e relegasse il Papa e i suoi successori in una sorta di "cattività salernitana"?
.
Anche a lui
risponde il solito *Bhrg'howidhHô(n-):
Andiamo sùbito al sodo? Chiaramente sempre a parità di tutto il resto, altrimenti non saprei come si possa
‘prevedere’...
Il Ducato di Perugia, la Pentapoli e l’Esarcato restano Feudi Ecclesiastici, ma entro l’Impero, come quelli dei Vescovi-Conti.
Quando avviene l’Ūnĭō Rēgnī ĕt Ĭmpĕrĭī con Enrico VI, il Papa diventa legato a doppio filo all’Imperatore (ed evidentemente non può sviluppare alcuna allergia a essere circondato da Dominî Imperiali).
Spoleto rimane Ducato Imperiale. Gli Angioini (né della Seconda né della Terza Dinastia) non si insediano nel Regno di Sicilia (che potrebbe passare agli Aragonesi e staccarsi dall’Impero); in Ungheria però sì.
Temo che almeno alcuni Papi (specialmente durante la “Cattività Avignonese”, che forse non avrebbe luogo) cambierebbero; può darsi che l’Imperatore Carlo IV riesca ugualmente (con o senza Urbano V) a impedire il matrimonio fra Alberto III d’Asburgo ed Elisabetta d’Angiò-Ungheria nel 1365, però Maria d’Ungheria avrebbe sposato Sigismondo di Lussemburgo, portandogli in Dote la Corona di Polonia (non d’Ungheria), mentre la sorella Edvige (Jadwiga), senza intromissioni della Nobiltà del Regno, potrebbe sposare l’amato Guglielmo I d’Asburgo (figlio di Leopoldo III e di Verde Visconti figlia di Bernabò), con tutto ciò che ne conseguiva nell’ucronia su Milano nella Guerra dei Cent’Anni (dello scorso novembre). Da qui in poi uso (con opportuni adattamenti e in combinazione adeguata alla circostanza) quasi soltanto brani già impiegati in varie altre ucronie:
- Ladislao Jagiełło ha comunque i suoi successivi matrimonî e le relativa discendenza, gli Jagielloni sono Granduchi di Lituania, ma Vassalli dell’Ordine Teutonico (v. sotto), che nel 1525 lo diventa della Polonia (v. più sotto);
- alla morte di Edvige d’Angiò (1399), l’Ungheria passa iūrĕ ŭxōrĭs a Guglielmo d’Asburgo (come storicamente la Polonia a Ladislao Jagiełło) e da questi, nel 1406, al fratello Ernesto (marito di Cimburca di Masovia) donde a suo figlio Federico III (IV) Imperatore (quindi né Jagiellonidi d’Ungheria né
Hunyadi);
- Sigismondo non darebbe il Brandenburgo in pegno a Federico di Hohenzollern o comunque farebbe di tutto per riscattarlo (data la ben maggiore importanza della Marca per un Re di Polonia rispetto a un Re d’Ungheria), probabilmente riuscendoci almeno dopo essere diventato Re dei Romani;
- il Gran Maestro dell’Ordine Teutonico Ulrich von Jungingen vincerebbe nell’omologo ucronico della Battaglia di Grunwald/Tannenberg (qui invece presumibilmente presso Vilnius) intorno al 1410 la Lituania-Russia dei Gediminidi, che nel 1399 avrebbe vinto proprio con l’aiuto teutonico sulle sponde della Vorskla separatamente le truppe dell’Orda d’Oro e quelle timūridi di Yādigār
/Edigej;
- a Sigismondo di Lussemburgo succede Alberto V d’Asburgo = Alberto II Imperatore e Re di Polonia (non d’Ungheria), che, alla scadenza della tregua quinquennale fra Venezia e Impero (il 4. giugno 1438), in quanto Imperatore e anche Re d’Ungheria attacca Venezia in alleanza con Filippo Maria Visconti, il quale si spartisce con l’Imperatore i Dominî Veneziani: dall’Adda a Verona la parte spettante a Milano, la Dalmazia all’Ungheria, il resto all’Impero e in gran parte (Pordenone, Treviso, Belluno, Padova) direttamente all’Austria Asburgica, Venezia (con Creta e gli altri possedimenti dell’epoca nello Ionio e nell’Egeo) Città Libera dipendente direttamente dall’Imperatore. Insieme ai proventi delle persecuzioni antisemite, Alberto il Magnanimo ha così a disposizione una quantità enorme di denaro, che investe con grande profitto nella Guerra di Successione di Toggenburg; in compenso, non si reca in Ungheria e non contrae la malattia che storicamente ne ha causato la morte a Neszmély il 27.ottobre 1439. D’altra parte, è inevitabile che – come nella Storia vera Ladislao III Jagiellone – finisca per osare troppo contro i Turchi e muoia precocemente in battaglia, succeduto o direttamente – nell’Impero – o attraverso il figlio Ladislao (in tal caso non Postumo, ma che comunque muore il 23. novembre 1457) da Federico III (nella cui Eredità confluisce per intero la Linea Leopoldina degli Asburgo);
- nel corso del XV secolo, viene attuata la Reformation Kaiser Sigmunds (con buona pace di Eugenio IV, se è Papa) e il reincameramento nell’Impero di Lombardia, Delfinato e Provenza, nonché il recupero della maggior parte dei Cantoni Svizzeri da parte
asburgica;
- dopo Ladislao III Jagiellone (che morirebbe probabilmente nella Battaglia di Konitz / Chojnice del 18. settembre 1454, comunque celibe) e Luigi II (qui Ludovico I e che forse, senza aver messo in atto la prudenza che storicamente è stata di Sigismondo il Vecchio e soprattutto senza le virtù tattiche dell’atamano Jan Tarnowski, morirebbe nella Battaglia di Obertyn del 22. agosto 1531 contro il Voivoda Petru Rareş di Moldavia), gli Jagiellonidi di Lituania sarebbero gli stessi che nella Storia reale;
- nel 1525 i Territorî Baltici (e Russo-Lituani) dell’Ordine Teutonico (contemporaneamente Vassallo della Polonia) diventano Feudi nell’Impero (perché Carlo V è già Re di Polonia e quindi non ha ragioni diplomatiche per rinunciarvi);
- nel 1526 gli Asburgo (Carlo V e Ferdinando I) sono sconfitti dagli Ottomani, ma nei territorî non conquistati dalla Sublime Porta mantengono senza contestazioni il proprio dominio;
- nel 1575 Massimiliano II d’Asburgo (che qui unisce i ruoli degli Imperatori, dei Re di Polonia e di Ivan IV il “Terribile”) subentra agli Jagiellonidi (continuatori dei Gediminidi) di Lituania-Russia (con Kazan’ e
Astrachan’);
- nel 1598 la Transilvania, che è sempre rimasta asburgica, ritorna (definitivamente) al Sacro Romano Impero (Rodolfo II);
- nel 1599 Sigismondo Vasa rimane Re (Cattolico) di Svezia, dato che disporrebbe direttamente delle Forze Armate e non ci sarebbe contrasto fra Svezia e
Polonia-Lituania;
- l’ormai bisecolare sottomissione di Venezia all’Impero annulla (data la completa disponibilità del transito delle Armate Asburgiche dalla Lombardia Orientale e dal Veneto) la Guerra di Successione Mantovana, onde rimangono sotto la sovranità austro-ispanica, storicamente fissata col Trattato di Milano del gennaio 1622, la Valtellina e la Valchiavenna, la Bassa Engadina, la Val Monastero, Davos, Schanfigg, Belfort e la Partenza, circondate da tre lati contro l’invasione francese del 1635, di conseguenza Mazzarino non diventerebbe Successore di
Richelieu;
- con la Svezia ai Vasa Cattolici e la Polonia agli Asburgo al più tardi già dal 1437, la Guerra dei Trent’Anni non conoscerebbe la Fase Svedese (gli Svedesi intervengono a fianco dei Cattolici), per cui dopo il 1644 l’Alleanza Interdinastica fra Asburgo e Vasa continuerebbe e alla morte (16. dicembre 1672) di Giovanni II Casimiro (qui ugualmente II) i primi erediterebbero i Regni dei secondi.
- nel 1648 non avviene il distacco dall’Impero di Svizzera (più ridotta rispetto alla Storia nota), Olanda, Metz, Toul, Verdun e Alsazia né continua la Guerra Franco-Spagnola fino al 1659;
- non hanno luogo né l’invasione della Svezia in Polonia (1655-1660) né tantomeno la Guerra Russo-Polacca conclusa storicamente con la Tregua di Andrusovo (1667);
- la “Seconda Guerra dei Trent’Anni” si scompone nella Guerra di Devoluzione (1667-1668), Guerra Franco-Olandese (1672-1678) – in questo caso Franco-Spagnola per la diversa Pace di Münster (15. maggio 1648) – e Guerra della Lega di Augusta 1688-1697) identiche a quelle storiche, senza invece la Guerra delle Riunioni (1683-1684) a causa del diverso Trattato di Münster del 24. ottobre 1648;
- a questo punto, essendo Svezia e Russia dominî asburgici, non ha luogo la Terza o Grande Guerra Nordica (1700-1721) e le forze di entrambe le Potenze rendono gli Asburgo d’Austria manifestamente più forti di Luigi XIV, per cui nel 1700 il Testamento di Carlo II di Spagna sarebbe di sicuro a favore dell’Arciduca Carlo, senza Guerra di Successione Spagnola né Spartizioni (nonostante l’impotente ostilità franco-britannica);
- vengono reincamerati dall’Imperatore i Feudi di Parma (20.
gennaio 1731) – mai più ceduta – e Toscana (9. luglio 1737) nonché, in questa ucronia, Mantova e Guastalla il 15. agosto 1746 per Estinzione (anziché solo Mantova per Fellonia nel 1708);
- nel 1733 non scoppia alcuna Guerra di Successione Polacca e quindi gli Asburgo vincono la Settima Guerra Austro-Turca (nonché Quinta Guerra Russo-Turca), 1736-1739;
- nel 1740 viene eletto Re dei Romani Francesco Stefano di Lorena (troppo superiore di forze grazie a Maria Teresa, Regina di Spagna, Boemia, Ungheria, Polonia e Imperatrice di Russia);
- nel 1756 avviene un opposto Rovesciamento delle Alleanze (qui un semplice cambio di schieramento), con l’abbandono della Francia da parte del Regno Unito a favore di una restaurata collaborazione con gli Asburgo, quindi Guerra dei Sette Anni con sconfitta francese e spartizione di tutte le Colonie fra Regno Unito e
Spagna-Impero;
- nel 1768 la Corsica viene ceduta in pegno all’Austria;
- nel 1772-1795 non hanno luogo le Spartizioni della Polonia-Lituania (già interamente asburgiche dal 1437 e 1575 rispettivamente);
- nel 1777, essendo la Prussia asburgica dal 1437 (per cui la Sassonia è circondata su tre lati da Maria Teresa), non scoppia la Guerra di Successione Bavarese (comunque senza scambio fra Baviera e Paesi Bassi, per la maggiore importanza strategica di questi ultimi rispetto alla Storia vera);
- nel 1779 l’intervento ispano-imperiale e olandese a fianco del Regno Unito contro la Francia e i Rivoluzionarî Americani si conclude con la sconfitta di questi ultimi (1783);
- nel 1787-1792 la vittoria (storica) della Russia nella Settima Guerra Russo-Turca coincide con la vittoria (ucronica) dell’Austria (nella stessa guerra in quanto Ottava Guerra Austro-Turca);
- nel 1792-1800 la vittoria della Coalizione Antirivoluzionaria sulle Forze Repubblicane (prive, fra l’altro, di Napoleone e Masséna) porta alla spartizione della Francia (ancora nei confini del XIV secolo) fra l’Impero e un pur dubbioso Regno Unito (che comunque opta per la spartizione per evitare lo scenario peggiore, tutte le coste atlantiche europee in mano asburgica) secondo i confini feudali del 1189 (ma con le Contee di Fiandra e Ponthieu all’Inghilterra);
- il Congresso di Vienna è anticipato al 1800-1801 e vi viene operata una Restaurazione completa, ma con le modifiche legalmente introdotte nel frattempo (fra l’altro, il Regno di Lombardia resta parte del Regno di Spagna, mentre la Città Imperiale di Venezia resta, come Trieste, parte della Monarchia Austriaca; le due sono unite come Monarchia Austro-Ispanica, non c’è un Regno Lombardo-Veneto separato dal resto), quindi i Savoia vengono reintegrati in Savoia e a Nizza, ma non in Piemonte, che qui non è mai perduto dagli Austriaci nel 1800;
- per quanto riguarda Genova, che fosse mantenuta la Dignità di Regno è stato realmente chiesto al Congresso di Vienna (con esito negativo perché avrebbe diminuito la Dignità del Re di Sardegna, che in Piemonte era solo Principe...) e la preferenza per un Arciduca era dello stesso Governo Repubblicano (degli Asburgo si era mantenuto un ricordo di affari vantaggiosi dai tempi di Carlo V e il Partito Spagnolo è sempre stato forte, anche se nella Storia vera dal 1700 si è trasformato in Borbonico); in quanto Secondogenitura, il Regno di Genova e Liguria sarebbe stato assegnato sotto Tutela al dodicenne Arciduca Francesco Carlo, secondogenito maschio dell’Imperatore Francesco II;
- nel 1814 il Regno Unito occupa il Senegal;
- nel 1821-1825 non si arriva alle Indipendenze Americane dall’Impero Coloniale Spagnolo;
- nel 1822 non si ha l’Indipendenza dell’Impero del Brasile dal Portogallo;
- nella Contea di Provenza, di cui la Contea di Nizza rappresenta le Terre Nuove (appunto di Provenza) dalla Dedizione di Saint-Pons del 28. settembre 1388 ai Savoia, non vige la Legge Salica (come per la Provenza dimostra la Successione di Giovanna d’Angiò al nonno Roberto d’Angiò nel 1343), dunque il 10. gennaio 1824 le eredita Maria Beatrice di Savoia, mentre Carlo Felice diventa Duca di Savoia. Poiché Maria Beatrice è moglie di Francesco IV d’Asburgo-Este, i suoi Dominî passano, il 15. settembre 1840, al figlio ventunenne Francesco Ferdinando Geminiano V d’Asburgo-Este, legittimo Conte di Nizza (gli Accordi del 19. novembre 1391 stabilivano che i Conti di Savoia non potessero alienare la Città ad altro Principe, ma questo non è un caso del genere) e, alla morte del padre (21. gennaio 1846), Erede del Ducato di Modena-Reggio (che il 14. ottobre 1803 suo nonno, l’Arciduca Ferdinando Carlo d’Asburgo-Lorena, figlio di Francesco Stefano di Lorena = Francesco I e Maria Teresa, aveva ereditato dal suocero Duca Ercole III d’Este) nonché del Principato di Massa, per cui il 29.novembre 1847 la Fusione Perfetta (storicamente dei Dominî Sabaudi) avviene fra la Contea di Nizza e i Dominî Estensi. Come nella Storia Reale, il 20. novembre 1875 Francesco V d’Austria-Este designa come proprio Erede il cugino Arciduca Francesco Ferdinando (Imperatore dal 21. novembre 1916) – a condizione che adotti il cognome d’Austria-Este – mentre lascia alla nipote Maria Teresa d’Austria-Este (2. luglio 1849 – 3. febbraio 1919) la rivendicazione dei Diritti sull’Eredità Stuarda;
- nel 1825 l’Oregon è spartito fra Regno Unito e Spagna-Russia;
- nel 1830 ha luogo l’occupazione gallispano-imperiale di Algeri;
- nel 1839-1841 è decisivo l’appoggio britannico all’Egitto contro l’Impero Ottomano sotto protettorato austro-russo;
- il 2. dicembre 1848 all’abdicazione dell’Imperatore Ferdinando IV = I d’Austria, il Re di Genova e Liguria Francesco Carlo – non importa se eletto o no Re dei Romani – abdica a sua volta da Imperatore d’Austria (conservando però a Genova la dignità Imperial-Regia) a favore del figlio Francesco Giuseppe (per diciott’anni Arciduca – in questa ucronia – a Genova);
- nel 1853-1856 l’eventuale e assai più squilibrata Guerra di Crimea termina con l’annessione dei Principati Danubiani ai Dominî Austro-Russi;
- nel 1858-1884 il Regno Unito occupa l’Indocina;
- nel 1862 può darsi che non venga deposto Ottone I di Wittelsbach;
- nel 1877-1878 si stacca dall’Impero Ottomano la Bulgaria di Santo Stefano (Protettorato Asburgico);
- nel 1878 l’Austria occupa la Bosnia-Hercegovina e il Sangiaccato di Novi Pazar;
- nel 1881 inizia il Protettorato gallispano-imperiale sulla Tunisia;
- nel 1885 il Congo viene spartito fra Impero e Regno Unito;
- nel 1885-1898 viene spartita la Nigrizia (Sūdān, compresa l’Africa Occidentale ed Equatoriale) fra Impero e Regno Unito;
- nel 1905 si conclude senza né vincitori né vinti la Guerra (Austro)Russo-Giapponese;
- nel 1908 la Bosnia-Hercegovina e il Sangiaccato di Novi Pazar vengono annessi all’Austria;
- nel 1912 inizia il Protettorato gallispano-imperiale sul Marocco; l’Austria annette la Libia e il Dodecan(n)eso;
- dal 1913 il nazionalista Adolf Hitler vive a Monaco di Baviera come artista, Ioseb Besarionis je J̌uḡašvili a Kurejka come internato;
- nel 1914 non avviene l’Attentato di Sarajevo (la Serbia è austriaca da due secoli);
- nel 1916 la Danimarca-Norvegia entra nell’Unione Mitteleuropea con l’Impero e la
Spagna - Austria - Ungheria - Polonia - Lituania - Russia - Svezia, mentre Albania (indipendente dal 1913), Bulgaria e Grecia – tutte con Dinastie tedesche – formano una Confederazione dell’Europa Sud-Orientale (Südosteuropäischer Bund) con l’Austria;
- l’assenza della Grande Guerra e delle Rivoluzioni del 1917 dovrebbe permettere alla Russia (qui asburgica) la conservazione delle Zone d’Influenza nell’Impero Cinese (Xīnjiāng e Mongolia Esterna) e in Persia Settentrionale. È quasi fatale che, senza una guerra, si arrivi a una spartizione di fatto dell’Impero Ottomano residuo (ossia solo in Asia) come per le Concessioni in Cina, in linea di massima Regione degli Stretti e Anatolia agli Asburgo e il resto (Levante; Mesopotamia; coste occidentali e orientali della Penisola Arabica) all’Impero Britannico; Faccio notare che, come nell’ucronia sulla Repubblica di Venezia e Ungheria, ho lasciato invariato tutto il possibile (Conquiste Ottomane, fallimento dell’Unione fra Inghilterra e Spagna nel 1558, secessione del Portogallo nel 1640 ecc.). Non c’è un unico Impero Mondiale, ma quattro Potenze – Impero, Regno Unito, Portogallo, Giappone – che nel 1913 si sono spartite la Cina. Con l’esaurimento della Spartizione della Cina (e della Persia, dove rimane l’Istituzione Monarchica, trasformata in senso più esplicitamente imperiale), tutte le Potenze hanno raggiunto il limite della propria capacità di espansione.
Se facciamo una media fra l’età del padre (l’Arciduca Carlo Ludovico, 1833-1896) e del nonno paterno (l’Arciduca Francesco Carlo, 1802-1878) di Francesco Ferdinando, questi (che era del 18. dicembre 1863) potrebbe vivere fin verso il 1932/1933 (in questa ucronia, il delicato equilibrio dinastico di tanti Regni e Imperi in Unione Personale induce a maggior ragione Francesco Giuseppe all’inflessibilità nei suoi confronti in relazione al Matrimonio Morganatico e quindi all’esclusione dei figli dalla Successione); la morte per sifilide dell’Arciduca Ottone a quarant’anni non permette previsioni sulla sopravvivenza di Carlo I e VII senza polmonite a Madera, per cui la stessa media (nel suo caso dal nonno e bisnonno paterni) farebbe stimare una sua permanenza sul Trono fino al 1956/1957, allorché gli succederebbe un quarantaquattrenne Ottone I e V.
Se non ci sono state altre guerre mondiali dopo la Seconda è notoriamente per l’Equilibrio del Terrore prodotto dalla Mutua Distruzione Assicurata: per evitare una guerra mondiale purchessia sarebbe quindi magari necessario far resistere il precedente Equilibrio (quello della cosiddetta Belle Époque, pur con tutto il suo Militarismo ecc.) fino alla scoperta dell’impiego militare dell’Energia Nucleare (forse anticipabile di qualche tempo in assenza di Persecuzioni Antisemite in Europa?).
Nel periodo fra il 1917 e la scoperta dell’impiego militare dell’energia nucleare (al più tardi, come ci impone la Storia, nel 1945), sarebbe dunque stato Imperatore in Austria / Mitteleuropa Francesco Ferdinando (quasi cinquantatreenne all’ascesa al Trono, 21.novembre 1916, fino a circa settant’anni nel 1933) seguìto da Carlo I/VII (a partire da circa 45/46 anni di età). Mi sembra abbastanza probabile che una sorta di Belle Époque potesse continuare fino a una Grande Crisi come quella del 1929; siccome, invece, le cause della Crisi del 1929 non sono affatto rimosse in questa ucronia, è perlomeno pensabile che la situazione rischi di precipitare proprio da allora, in particolare verso il 1933, con un Imperatore di 45 anni o poco più in Austria / Mitteleuropa (in quell’anno, Hitler aveva 44 anni, Mussolini 50, Stalin 55).
Ci chiediamo quindi se fra il 1914 e la scoperta dell’impiego militare dell’energia nucleare (al più tardi, come ci impone la Storia, nel 1945) potesse scoppiare una Guerra Mondiale. Se non scoppia, si configura per la seconda metà del XX secolo un Mondo dalla struttura politica abbastanza diversa da quella che conosciamo. Ciò che salta all’occhio è la persistenza delle Monarchie, come mi pare che sia dimostrato dai Paesi che non hanno perso né la Prima né la Seconda Guerra Mondiale (e che erano Monarchie nel 1914), a eccezione della Grecia (la Jugoslavia rappresenta innegabilmente un caso a parte, essendo nata dopo la Prima e oggi non più esistente) Negli Anni Sessanta sarebbero fuori dall’Unione Mitteleuropea il Regno Unito (forse ancora con l’Irlanda?) e il Portogallo. Non si vedono gli estremi per un processo di Decolonizzazione né per un’eventuale Crisi del Petrolio negli Anni Settanta (che comunque non coinvolgerebbe le due maggiori Superpotenze, dato che i rispettivi Imperi Coloniali comprenderebbero la maggior parte dei Paesi Produttori).
A livello di Equilibrî di Potere Mondiali, però, ciò che risulta fondamentale è che senza le Guerre Mondiali non si applicano, in questa ucronia, né la Geopolitica di Mackinder o di Spykman né quella delle Panregioni di Haushofer: non c’è una vera e propria Eurafrica, perché questa Panregione risulta divisa in due fra Eurafrica Mitteleuropea (la potremmo chiamare “Mitteleurafrika”) e Anello Esterno (Greater Britain), mentre sia la Panrussia sia l’America Latina sono strettamente unite al Mitteleuropa e la Sfera di Co-Prosperità Asiatica è minoritaria in Cina e assente in Indocina e Indonesia (entrambe spartite fra Impero Britannico e
Mitteleuropa).
A questo punto mi sottopongo a un’autocritica: com’è possibile un tale accumulo di territorî?
La premessa è la constatazione che, in Europa, le Potenze alla periferia del Subcontinente si sono espanse molto più di tutte quelle centrali messe insieme: vale notoriamente per gli Stati Coloniali della Facciata Atlantica (Portogallo, Spagna, Francia, Olanda, Inghilterra), per la Russia (estensione della Moscovia, il più nordorientale dei Principati Russi) e per il solo convenzionalmente periferico Impero Ottomano (in realtà centrale come posizione fra Europa e Vicino Oriente, ma pur sempre marginale rispetto al sistema regionale europeo) a spese dei Mamelucchi (potenzialmente quindi in Africa; in Asia sùbito bloccato dalla Persia Ṣafāwide), in quest’ultimo caso senza alcuna forma di Colonialismo, ma in tutti sempre con un divario tecnologico-militare di partenza a favore dell’Aggressore/Vincitore. Che poi la Gran Bretagna (anche con la collaborazione della Francia) e successivamente le Potenze Anglosassoni siano riuscite ad annullare – e dove possibile a guadagnare per sé – gli Imperi Coloniali di Portogallo, Spagna, della stessa Francia (con la Guerra dei Sette Anni)e in buona misura anche dell’Olanda, neutralizzando o circoscrivendo i tardivi tentativi di Danimarca e Svezia, e poi a spartirsi l’Eredità Ottomana (all’inizio fra Regno Unito e Francia, talvolta proteggendo con la collaborazione austriaca lo stesso Impero Ottomano contro una uguale e contraria espansione russa, oggi invece soprattutto fra Stati Uniti e Regno Unito) rientra in una competizione geopolitica più vasta rispetto al sistema puramente europeo, nella quale il ruolo delle Potenze del centro del Subcontinente era prossimo alla zero.
Mentre l’Unione del Sacro Romano Impero con la Spagna è stata una – pur provvisoria – realtà storica nel XVI secolo e sul punto di rinnovarsi all’inizio del XVIII e quella fra Asburgo d’Austria e Polonia-Lituania lo è stata nel 1575-1576, quella fra Lituania e Moscovia (nel 1610-1612 imminente come Unione Personale fra Polonia-Lituania e Russia) è del tutto ucronica se collocata nel XV secolo. A differenza che nell’ucronia su Milano nella Guerra dei Cent’Anni, in questa un importantissimo Nodo di Divergenza Secondario (= conseguenza dell’unico Punto di Divergenza, ma che a sua volta produce effetti molto più dirompenti) è che Guglielmo I d’Asburgo arrivi a sposare l’amata Edvige d’Angiò diventando Re d’Ungheria (non di Polonia); allo stesso modo, però, ne consegue che Ladislao Jagiełło non diventerebbe Re Consorte di Polonia nel 1386 e quindi il cugino Vytautas potrebbe, con l’aiuto dell’Ordine Teutonico, ottenere il predominio sulla Lituania e approfittare dell’attaco di Tuqtamış a Mosca per sottomettere quest’ultima insieme (pacificamente) a Novgorod, per poi guadagnare il tempo prezioso onde non far confluire (ma, al contrario, appunto vincere separatamente) nel 1399 sulle sponde della Vorskla le truppe dell’Orda d’Oro con quelle timūridi di Yādigār / Edigej. A questo punto la Lituania sarebbe egemone su tutta la Rus’ e anche su parte dei Tatari ed è chiaro che entro dieci anni si volgerebbe contro l’Ordine Teutonico, ma l’omologo della Battaglia di Grunwald o Tannenberg (come detto, probabilmente più spostato verso Vilnius) vedrebbe le Divisioni Polacche (intere, senza nemmeno la diversione di una ai confini dell’Ungheria dell’erede di Guglielmo, Alberto V d’Asburgo, che sarebbe alleata e non nemica), sotto il comando di Sigismondo, schierate con l’Ordine Teutonico contro Lituani, Russi e Tatari ed è lecito pensare che costituirebbe l’elemento decisivo per un esito opposto a quello – già fino all’ultimo incerto – storicamente avvenuto il 15. luglio: l’Impero Lituano – esteso a tutta la Rus’ e a parte dei Tatari – passerebbe direttamente all’Ordine Teutonico.
Per quanto riguarda dunque l’Europa Orientale fra fine del XIV e inizio del XVI secolo, in questa ucronia il Nodo Secondario di Divergenza e le sue principali conseguenze sono:
1) il diverso matrimonio di Edvige d’Angiò (1386), con gli Asburgo
in Ungheria, Sigismondo in Polonia e i Gediminidi ‘confinati’in Lituania, donde però
2) unificano gli Slavi Orientali e
3) vincono alla Vorskla (1399),
4) perdendo tuttavia l’omologo della Battaglia di Tannenberg o Grunwald (1410);
5) le quattro Corone riunite da Alberto II (1438), che
6) non si ritira davanti agli Ottomani né quindi muore prematuramente nel 1439, bensì
7) attua una sorta di Reformatio Sigismundi con cui
8) l’Ordine dei Cavalieri diventa a tutti gli effetti Vassallo dell’Impero.
Riguardo invece al quinto
capitolo... Colpo di scena! In effetti Federico II aveva, fra i proprî Titoli,
anche quelli di «Sultano, Basileus, Imperatore Latino», ma in questo caso lo è veramente! È per il fatto che ad Adrianopoli muore anche
Filippo di Svevia?
A proposito di «penetrò in Lombardia ove si fermò a Pavia, che
era pur sempre la capitale del Regno d'Italia imperiale. Come in Sicilia, egli dichiarò decaduto qualunque diritto del Papa sulla
regione e revocò gran parte delle autonomie concesse da Amalrico I. Anche qui i lombardi si dimostrarono poco contenti alla novità e
Milano in particolare dovette essere brutalmente occupata dalle soldataglie imperiali» e «nel Nord era sorta un'alleanza di città
autonome, chiamata Lega Lombarda, che aveva liberato Milano e osteggiava apertamente il dominio di Enrico IV»:
in precedenza avevo letto «su Milano propongo un cavillo: intendiamo quanto ho detto come "da Milano (ESCLUSA) a Reggio
Calabria", in tal modo salviamo il testo (vi è un'imprecisione, non un errore), la cartina (giustamente senza Milano) e l'Ucronia (Milano non
fa parte dei Domini Canossiani)», mentre «le autonomie concesse da Amalrico I» erano: «Secondo gli Accordi di Lucca l'Imperatore Stefano I concedette i
feudi canossiani, riuniti all'interno del Ducato di Tuscia/Toscana, al Papato, permettendo a Roma di amministrare praticamente ogni città tra
Milano e Reggio Calabria. In realtà lo status di questi feudi (che presero complessivamente il nome di "Eredità Canossiana") rimase un
po' ambiguo perché le terre rimanevano parte del Sacro Romano Impero ma era amministrate dalla Chiesa, in quanto feudi pontifici: questa
situazione favorì le città del Nord, sopratutto quelle lombarde, che da tempo desideravano maggior autonomia. Potendo contare sulle
ambizioni di due stati, entrambi pronti a fare concessioni e promesse pur di attirarle maggiormente nella propria sfera d'influenza, esse
iniziarono a fiorire rapidamente, ritagliandosi lentamente una propria autonomia e arricchendosi grazie al florido commercio che stava
nascendo nella Pianura Padana finalmente in pace. Tale autonomia avrebbe infine trovato un definitivo riconoscimento nei decreti
dell'Imperatore Amalrico I, datati 1162.»
Milano fa dunque parte del residuo Regno di Lombardia (coincidente
con la Neustria Longobarda) insieme alla Capitale del Regno d’Italia, Pavia; entrambe sono quindi già sotto completo controllo di Enrico
IV, perfino più di Palermo nel momento di massima forza dell’Imperatore (sono nella stessa condizione di – cito – «Strasburgo o […] Magonza o
[…] Aquisgrana»). L’estremità nordoccidentale dei Beni Canossiani era
l’Insula Fulcherii; la città più importante in zona era Pizzighettone, adattissima al ruolo di rappresentante delle ucroniche autonomie
amalrichesche (in quanto favorite da condizioni di duplice appartenenza) perché essa stessa divisa dall’Adda fra due diverse
Diocesi (Lodi e Cremona), fra l’altro quindi marginale rispetto alla rete di dominazioni comitali o vescovili (l’ideale per il ceto
mercantile in ascesa). Proporrei quindi di sostituire semplicemente «Pizzighettone» alle due occorrenze di «Milano» nel testo, che
risulterebbe così: «Anche qui i lombardi si dimostrarono poco contenti alla novità e
Pizzighettone in particolare dovette essere brutalmente occupata dalle soldataglie imperiali»; «nel Nord era sorta un'alleanza di città autonome, chiamata Lega
Lombarda, che aveva liberato Pizzighettone e osteggiava apertamente il dominio di Enrico IV».
.
Anche
Generalissimus vuole proporre un PoD:
E se nel 976 Ottone II non
scorporasse la Marca Orientale dal Ducato di Baviera, donandola a Leopoldo I di
Babenberg? Praticamente stiamo supponendo l'assenza dell'Austria dalla storia.
Come influirà questo avvenimento sulla storia d'Europa?
.
Lord
Wilmore
suggerisce:
E se gli Asburgo diventassero
re delle nostre Italia e Svizzera?
.
Ed ecco il
parere del grande *Bhrg'howidhHô(n-):
Per l’ascesa iniziale è
appunto necessario che gli Asburgo prevalgano sui Confederati alla fine del
XIII. secolo (magari con una sorte meno tragica per Alberto I.?); per arrivare
all’obiettivo di Milord è altrettanto
indispensabile che Rodolfo IV. ottenga da Carlo IV. l’investitura del Regno di
Lombardia (dunque sovraordinata ai Visconti, senza modifiche da parte di
Venceslao) e che poi nel 1384-1386 l’Arcicasa (che sarebbe ugualmente tale,
anche senza Austria) conservi Treviso, Feltre, Belluno, Pordenone e Padova.
Con questa base per gli
Asburgo e il Patto di Mutua Successione fra loro e i Lussemburgo, Sigismondo può
sconfiggere Venezia, il che comincia ad alterare considerevolmente la Storia.
Senza alcuna Crisi Dinastica Viscontea (al cui posto si avrebbe anzi
l’incontestabile incameramento definitivo dei loro dominî da parte del Regno),
Genova rimarrebbe con Milano e a questo punto tutte le Guerre d’Italia
cambierebbero prospettiva. La Mutua Successione con gli Jagielloni d’Ungheria
(anche ammesso che dopo Mattia Corvino l’Austria tornasse comunque alla Baviera)
avverrebbe tanto quanto l’Unione fra Spagna e Impero, come nella Storia reale;
non ci sarebbero però – perché non avrebbero alcun senso – né la Restaurazione
Sabauda dopo San Quintino (dunque neanche il Trattato di Lione del 1601 e
probabilmente neppure la promessa del Ducato di Milano per il primo figlio nato
dal matrimonio di Caterina Micaela d’Austria con Carlo Emanuele I. “Testa di
Fuoco”, tantomeno la riserva dei diritti al Trono di Spagna in linea femminile a
preferenza dei rami laterali in caso di mancanza di eredi maschi degli Austrias)
né la reinvestitura del Württemberg a Federico di Mömpelgard nel 1599.
Tutto ciò cambia la Guerra di
Successione Mantovana, forse addirittura la biografia del Mazzarino e con ogni
verosimiglianza il destino dell’Alsazia dopo il 1648; in ogni caso, le
conseguenze sono dirompenti nelle Guerre di Successione Spagnola (la Baviera –
più strategica che in qualsiasi altra ucronia – non verrà restaurata), Polacca
(con un Teatro Lombardo completamente diverso e senza possibilità di rinuncia
alla Lorena) e Austriaca (verosimilmente senza Carlo VII.), mentre quella
Bavarese potrebbe addirittura non scoppiare. Soprattutto, però, nel 1731 la
Corsica risulterà reincorporata nell’Impero oltre che nei Territorî Prammatici e
ciò comporterà che Napoglione Buonaparte sarà un Generale asburgico (che
pressoché di certo vincerebbe a Marengo contro un esausto Masséna), col
risultato che la Prima Coalizione sconfiggerebbe la Francia Rivoluzionaria, di
cui a Francesco II./I. andrebbero come minimo Provenza, Delfinato e Franca
Contea come parti del Kaisertum, mentre le Legazioni Pontificie tornerebbero
definitivamente al Reich.
Ho lasciato volutamente
inalterate, per scrupolo di Minimalismo, le altre conseguenze (storiche) della
Guerra di Successione Polacca e delle Guerre Austro-Turche. A questo punto,
comunque, l’Impero è rimasto (così come l’esito delle prime tre Spartizioni
della Polonia) e non c’è alcuno spazio per la Prussia di Bismarck, che non potrà
far altro che aderire alla Riforma del Reich fra gli Anni Cinquanta e Settanta
(la quale non si chiamerebbe “grande-austriaca”, quanto piuttosto
“grande-asburgica”, verosimilmente senza Compromesso del 1867).
Alla guerra con la Serbia si
arriverebbe probabilmente lo stesso; ma la concatenazione delle dichiarazioni di
guerra sarebbe diversa: da parte degli Imperi Centrali (Kaisertum e Reich) alla
Serbia, di conseguenza da parte della Russia agli Imperi Centrali; la Francia
non sarebbe costretta e, anche se entrasse in guerra, il Regno Unito avrebbe
tutte le ragioni (compresa l’inesistenza del Belgio, rimasto Paesi Bassi
Asburgici) per non seguirla. Se ci atteniamo al massimo possibile alla Storia
reale, alla fine del 1918 – senza Intervento Statunitense – sarebbe piuttosto la
Francia a capitolare (nel caso che appunto avesse dichiarato guerra agli Imperi
Centrali).
L’Unione Mitteleuropea
diventa una realtà, dalla Scandinavia all’Egitto e al Mittelafrika; resta
tuttavia il rischio di una Seconda Guerra, se non Mondiale almeno
Mitteleuropeo-Sovietica (non è inevitabile, ma possibile sì), che però
divamperebbe a partire dalla Linea di Brest-Litovsk per gli Imperi Centrali e
dunque con probabile esito in una “Saracinesca” (Iron Curtain nell’espressione
di Churchill) sul confine uralico fra Russia Europea e Asiatica (l’Asia Centrale
sarebbe già ottomana dal 1918).
Offrirebbe ugualmente il
Generalísimo la Corona di Spagna a Francesco Giuseppe II./Ottone V. nel 1961?
N.B. Non sostengo affatto che
questo sia lo sviluppo più probabile del Punto di Divergenza per cui la Marca
Orientale rimane alla Baviera; sono partito solo dalla richiesta del Comandante
(Svizzera e non dico Italia, ma solo Lombardia; alla fine la Sardegna rimane
probabilmente dei Wittelsbach, la Sicilia dei Savoia e Napoli dei Borboni, lo
Stato Pontificio rientra in gran parte nell’Impero, ma non il Ducato Romano).
.
Diamo ora la
parola a Renato Balduzzi:
La Lega Lombarda nacque come
alleanza provvisoria tra i vari comuni padani per fronteggiare il comune nemico
germanico. Una volta vinta la guerra, ritornarono a farsi la guerra tra di loro.
Ma se riescono a strutturarsi in una federazione possono dare origine ad una
Svizzera ante-litteram in terra lombarda già nel XII secolo. In età moderna
avremo una nazione lombarda che va dall'Appennino alle Alpi, fedelissima al Papa
nella lotta agli eretici e agli infedeli, e per questo possibile alleata di
Carlo V nella lotta al protestantesimo. A differenza della nostra Svizzera, la
Confederazione Lombarda sarà uno stato etnicamente e linguisticamente piuttosto
omogeneo. La lingua parlata non sarà il toscano, ma presumibilmente il Lombardo
(koiné lombardo-veneta), che non avrà ragione di estinguersi a favore del
toscano come nella nostra timeline. Oggi la Lombardia è uno stato federale molto
curioso: i suoi comuni costituenti possono essere ancora retti da qualche
signore, ad esempio i Della Torre a Milano, che coesiste con le repubbliche
storiche quali Venezia e la repubblica di San Marino...
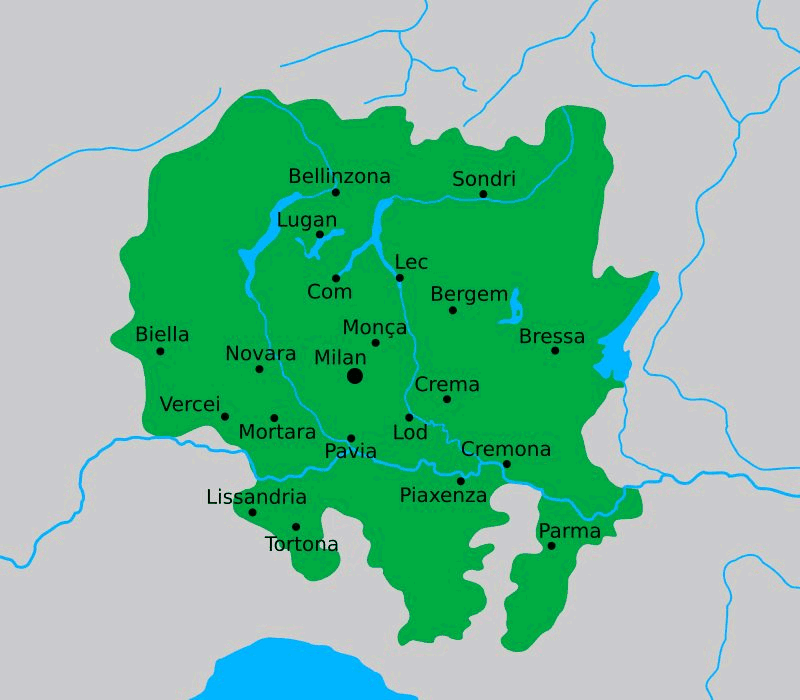
.
Chiudiamo per
ora con quest'idea di Tommaso Mazzoni:
Anno Domini 850. Lotario I, invece di
creare la Lotaringia per sé, decide di ordinare l'impero in modo che si possa
avere espansione ed equilibrio interno; per farlo, stabilisce un
Ordinatio Imperii, che diventa la
legge fondamentale dell'Impero con la quale si impongono una serie di immutabili
leggi fondamentali:
prima di tutto, vengono nominati tre Grandi Regni costituenti l'Impero (il
numero è esplicitamente nominato come l'attuale, e quindi non fissato) Essi sono
l'Italia (che include la Provenza), la Francia e la Germania (che si dividono la
mancata Lotaringia).
l'Imperatore è, a rotazione uno dei Grandi Re; (Ordine Iniziale, Italia,
Germania, Francia)
I feudatari dei Grandi Regni eleggono fra loro i Grandi Re;
Nessuno può essere Grande Re di più di un Grande Regno, e tutti i grandi Regni
sono eguali fra loro.
Nessun nobile dei Grandi Regni, nemmeno il Grande Re, può assommare in sé più di
un feudo (Contea, Ducato, Signoria, Marca o altro), nello stesso Grande Regno,
per più di una generazione, e i feudi non possono essere accorpati.
Chiunque muova guerra ad un'altro feudatario senza consenso dell'Imperatore è un
fellone.
L'Imperatore è fellone se appoggia illecite rivolte di vassalli contro i propri
signori.
L'Imperatore deve riassegnare un feudo lasciato vacante (per estinzione della
linea diretta legittima maschile o per fellonia) a persona diversa da se stesso
entro un anno, privilegiando le linee femminili legittime e quelle maschili
illegittime, quando presenti, e non colpevoli di eventuale fellonia.
La legge di successione è per successione primogenita in linea preferibilmente
maschile (Semisalica).
In caso di divisione di un singolo Feudo fra più eredi (secondo la libera
volontà del Feudatario), il primogenito maschio ha diritto alla signoria sugli
altri eredi;
In caso di eredità composta di più feudi al primogenito spetta il più grande,
ricco e popoloso, gli altri sono divisibili in parti uguali fra i maschi
legittimi, fra le femmine legittime, fra i maschi illegittimi, e fra le femmine
illegittime (in quest'ordine) secondo la volontà del testatore.
L'Impero è indivisibile e indissolubile, se un suddito dell'Impero diventa Re di
un territorio al di fuori dell'impero, quel territorio è incorporato
automaticamente nell'impero).
Viene costituito come grande Regno ogni territorio governato da un Re che abbia
altri sovrani come propri vassalli.
Sono sovrani, all'interno dell'Impero, Conti, Duchi, Principi, Marchesi e Re;
ciascuno può essere eletto Grande Re del proprio Grande Regno d'appartenenza.
Il Papa è Duca di Roma, e dipende dal Gran Re d'Italia per le questioni
temporali.
Questo l'elenco degli imperatori da allora fino ad oggi:
Lotario I (Italia) (840-855)
Ludovico II (Germania) (855-876)
Carlo II (Francia) (876-877)
Carlomanno (Italia) (877-880)
Carlo III (Germania) (880-887)
Oddone I (Francia) (887-898)
Berengario I (Italia) (898-924)
Enrico I (Germania) (924-936)
Ludovico III (Francia) (936-954)
Berengario II (Italia) (954-966)
Ottone I (Germania) (966-973)
Lotario II (Francia) (973-984)
E qui cominciano i miei
dubbi, perché, fino a qui, i vari Grandi Re sono stati, piu o meno, elettivi
anche nella nostra timeline, ora però, abbiamo l'Italia, su cui, nella LTO, nel
984 regna Ottone II, che qui però non può esserci, visto che, al massimo, si è
fatto eleggere Re in Germania dopo la morte del padre. Quindi, bisogna calarsi
nell'Italia (intesa in senso Carolingio, per ora, e includendo la Provenza ,fra
qualche anno, infeudandosi al Papa, gli Altavilla porteranno in dote al Gran
Regno d'Italia anche il resto della Penisola ) Quindi la domanda è: chi potrebbe
essere realisticamente il Re d'Italia nel 984, alle condizioni da me poste?
.
Gli replica
*Bhrg'howidhHô(n-):
Punterei su questo: se tale è
l'Ordinamento, il 25. dicembre 983 Adelaide (vedova di Ottone il Grande)
concorda con Enrico II che la Corona di Germania vada a lui e riserva al nipote
Ottone III quella d'Italia e la successione all'Impero. Nei dettagli: Ottone I
ha fatto eleggere il figlio Ottone II (chiamiamolo così, anche se non diventa
Imperatore) Re d'Italia (già storicamente è stato Coreggente). Alla morte del
padre, Ottone II eredita in Germania la Sassonia (gli ucronici Ordinamenti di
Lotario – «Nessun nobile dei Grandi Regni, nemmeno il Grande Re, può assommare
in sé più di un feudo [Contea, Ducato, Signoria, Marca o altro], nello stesso
Grande Regno, per piu di una generazione» – glielo permettono), mentre Re di
Germania diventa suo cugino Enrico il Litigioso (non ci sono alternative per la
famiglia; perciò sarà anche meno litigioso) come Enrico II di Germania. Alla
morte di Ottone II (qui Ottone I d'Italia), suo figlio Ottone III (qui II
d'Italia) diventa Imperatore (Ottone II); alla sua morte, gli subentra il cugino
Enrico II (III di Germania e II come Imperatore).
.
Tommaso
torna alla carica:
Si, mi convince; Anche se è un bambino, niente lo impedisce.
Lotario I (Italia) (840-855)
Ludovico II (Germania) (855-876)
Carlo II (Francia) (876-877)
Carlomanno (Italia) (877-880)
Carlo III (Germania) (880-887)
Oddone I (Francia) (887-898)
Berengario I (Italia) (898-924)
Enrico I (Germania) (924-936)
Ludovico III (Francia) (936-954)
Berengario II (Italia) (954-966)
Ottone I (Germania) (966-973)
Lotario II (Francia) (973-984)
Ottone II (Italia) (984-1002)
Enrico II (Germania) (1002-1024)
Roberto I (Francia) (1024-1031)
Arduino I (Italia) (1031-1050)
Enrico III (Germania) (1050-1056)
Enrico IV (Francia) (1056-1060)
E qui ci si riblocca, dato che Arduino II d'Ivrea non aveva figli; Bonifacio III di Canossa potrebbe essere riuscito a farsi eleggere nel 1050 Re d'Italia, ma muore nel 1052, e per quanto la legge, di per se, non escluda le donne dall'elezione, nel 1055 (quando muore Federico, possibile erede di Bonifacio) Matilde è ancora troppo giovane. Il gioco fatto da Ottone un secolo prima non è ripetibile per mancanza di parenti prossimi da parte di Enrico III.
.
*Bhrg'howidhHô(n-)
però è di diverso avviso:
Il Successore di Ottone III (qui II) sarebbe stato il cognato Azzo di
Lotaringia (955-1034), Imperatore dal 1031. Arduino d’Ivrea sarebbe stato deposto dall’Imperatore Enrico II entro il 1013 e Marchese
d’Ivrea sarebbe diventato, due anni dopo, Olderico Manfredi, come nella Storia vera.
Nel 1034 (all’ascesa di Corrado il Salico, II del suo nome in
Germania, a Imperatore, fino al 1039), Arduino II d’Ivrea aveva una base territoriale troppo esigua per superare la concorrenza di Ottone
II di Svevia, figlio di Azzo e Re d’Italia fino al 1047, cui succede il cugino Enrico I di Svevia, brevemente Imperatore nel 1060-1061.
All’estinzione degli Azzoni (con Ermanno I d’Italia, 1061-1085),
l’Imperatore Enrico V (per noi IV) è all’apice del potere e impone come Re d’Italia il proprio ultimogenito Enrico (per noi V), essendo
all’epoca destinato alla successione in Germania Corrado (che però gli premuore nel 1101). Ai Salii subentrano direttamente, in Italia, gli
Hohenstaufen con Corrado di Svevia (per noi III, 1025-1152) e quindi poi Federico Barbarossa (1152-1190), mentre in Germania permangono i
Guelfi con Enrico il Superbo (1137-1139), Enrico il Leone (1139-1195), Ottone di Brunswick (1195-1215) ecc.; al Barbarossa succedono Enrico
(1190-1197), Federico il Grande (con tutela degli zii Corrado ălĭās Federico VI di Svevia – che il 28. aprile 1188 sposa Berenguela o
Berengaria di Castiglia, Erede di Alfonso VIII dunque Re Consorte di Spagna dal 1217, senza annullamento del Matrimonio anche perché
Corrado/Federico non è figlio dell’Imperatore, ma ‘solo’ fratello del Re d’Italia, quindi meno pericoloso, per cui non è a Durlach il 15.
agosto 1196 e comunque è molto più difficile che venga ucciso in quella circostanza – ed eventualmente Filippo di Svevia), Corrado II
(1250-1254), Corradino (1254-1313, se si calcola un po’ più di 60 anni come media fra i 65 anni di longevità del trisnonno – pur non deceduto
di morte naturale – e i 56 del nonno paterno, purché non muoia di malaria come il padre a 26 anni).
Se in Germania non dobbiamo postulare la ribellione degli Elettori
all’Ereditarietà nell’ultimo decennio del XIII secolo, prosegue la Dinastia di Brunswick-Lüneburg, che porterà all’Impero la Gran
Bretagna con l’Irlanda e, nel 1740, la Russia. Se in Italia gli Svevi si estinguono comunque, ritengo scontato che diventi Re Giovanni di
Boemia e con lui i Lussemburgo, ai quali succederanno gli Asburgo. Darei per immutata la Successione Capetingia in Francia, attraverso le
varie Case. Quindi:
Ottone II (Italia) (984-1002)
Enrico II il Santo (Germania) (1002-1024)
Roberto I (Francia) (1024-1031)
Azzo I (Italia) (1031-1034)
Corrado I (Germania) (1034-1047)
Enrico III (Francia) (1047-1060)
Enrico IV (Italia) (1060-1061)
Enrico V (Germania) (1061-1106)
Filippo I (Francia) (1106-1108)
Enrico VI (Italia) (1108-1125)
Lotario III di Supplimburgo (Germania) (1125 – 4. dicembre 1137
Ludovico IV il Giovane (Francia) (1137-1180; Luigi VI il Grosso di Francia, anch’egli Re dal 1125, era morto il 1. agosto 1137)
Federico I Barbarossa (Italia) (1180-1190)
Enrico VII il Leone (Germania) (1190-1195)
Filippo II Augusto (Francia) (1195-1223)
Federico II il Grande (Italia) (1223-1250)
Ottone III di Brunswick-Lüneburg (Germania) (1250-1252)
Ludovico V il Santo (Francia) (1252-1270)
Corrado II di Svevia (Italia) (1270-1313)
Ottone IV il Severo (Germania) (1313-1330)
A questo punto, se nonostante la Legge Semisalica si impone la
Successione di Filippo III il Fortunato (Francia) (1330-1350):
Carlo IV Venceslao di Lussemburgo (Italia) (1350-1378)
Venceslao di Sassonia-Wittenberg (Germania) (1378-1388)
Carlo V di Valois il Folle (Francia) (1388-1422)
Sigismondo di Lussemburgo (Italia) (1422-1437), che apporta l’Ungheria
Ottone V di Lüneburg lo Zoppo (Germania) (1437-1446)
Carlo VI di Valois il Vittorioso (Francia) (1446-1461)
Federico III d’Asburgo (Italia) (1461-1493)
Enrico VIII di Lüneburg (Germania) (1493-1532)
Francesco I di Valois-Angoulême (Francia) (1532-1547)
Carlo VII d’Asburgo (Italia) (1547-1556 o 1558), che apporta la Spagna
Francesco II Ottone di Lüneburg (Germania) (1556 o 1558 – 23. aprile 1559)
Enrico IX di Valois-Angoulême (Francia) (23. aprile – 10. luglio 1559)
Filippo IV d’Asburgo-Spagna (Italia) (1559 – 13. settembre 1598), che apporta il Portogallo (mentre Massimiliano II d’Italia, 1564-1576,
apporta la Polonia-Lituania)
Ernesto I di Lüneburg (Germania) (1598-1611)
Ludovico VI di Borbone (Francia) (1611-1643)
Filippo V d’Asburgo-Spagna (Italia) (1643 – 17. settembre 1665)
Giorgio I Guglielmo (Germania) (1665 – 28. agosto 1705)
Ludovico VII di Borbone (Francia) (1705-1715)
Carlo VIII d’Asburgo-Austria (Italia) (1715-1740)
Giorgio II Augusto di Hannover (Germania) (1740-1760), Re di Gran Bretagna e Irlanda
Ludovico VIII di Borbone (Francia) (1760-1774)
Giuseppe I d’Asburgo-Lorena (Italia) (1774-1790)
Giorgio III Guglielmo Federico di Hannover (Germania) (1790-1820)
Ludovico IX di Borbone (Francia) (1820-1824), se è diventato Re
Francesco III d’Asburgo-Lorena (Italia) (1824-1835)
Guglielmo I di Hannover (Germania) (1835-1837)
Ludovico X di Borbone (Francia) (1837-1844)
Ferdinando d’Asburgo-Lorena (Italia) (1844-1875)
Giorgio IV Federico di Hannover (Germania) (1875-1878)
Enrico X di Borbone (Francia) (1878-1883)
Francesco Giuseppe I d’Asburgo-Lorena (Italia) (1883-1916)
Ernesto II Augusto di Hannover (Germania) (1916-1923)
Alfonso I di Borbone (Francia) (1923-1941)
Carlo IX d’Asburgo-Lorena (Italia) (1941-1957?)
Ernesto III Augusto di Hannover (Germania) (1957-1987)
Giovanni Carlo di Borbone (Francia) (1987-); se abdica il 9. giugno 2014, allora gli succede
Carlo X d’Asburgo-Lorena (Italia) (2014-)
.
Per farci
sapere che ne pensate, scriveteci a questo indirizzo.

Torna
indietro
 sostegno, Stefano si diresse nuovamente alla volta dell'Inghilterra, occupando sulla strada diversi castelli normanni fedeli a Matilde, la quale nel frattempo aveva invaso l'Inghilterra con il sostegno di suo zio, Re Davide I di Scozia. Stefano riuscì a sbarcare in Inghilterra e intraprese una durissima campagna, particolarmente sanguinosa, con ripetuti cambi di fronte e diverse battaglie incerte. Dopo essere stato incoronato e riconosciuto Re nell'Abbazia di Canterbury, Stefano riuscì a sconfiggere e a distruggere l'esercito scozzese nella durissima Battaglia dello Stendardo: subito dopo offrì la pace a Re Davide, presentandosi come membro della famiglia (suo suocero, Eustachio I, aveva sposato una delle sorelle del Re) e ottenendo da questi il riconoscimento a Re d'Inghilterra. Abbandonata da tutti Matilde venne assediata a Oxford e il 17 dicembre 1141 ella tentò di fuggire dalla città, con soli quattro soldati, calandosi dai bastioni della città e cercando di attraversare a piedi il Tamigi ghiacciato con dei mantelli bianchi per mimetizzarsi ma il maggior numero di soldati a disposizione di Stefano aveva permesso al Re di sorvegliare anche quel lato della città, altrimenti trascurato, e la pretendente sconfitta venne catturata durante la fallita fuga. Con tale evento terminò de facto la Guerra Civile Inglese: il Sacro Romano Imperatore Stefano I, Defensor Fidei, venne riconosciuto Re d'Inghilterra dalla stessa Matilde, a cui Stefano concesse un diritto di successione in caso di estinzione della dinastia dei Blois d'Inghilterra per unificare il paese dopo la guerra. Stefano ora era sovrano di un Impero molto vasto e si apprestava a governarlo. Il contributo di San Bernardo di Chiaravalle non venne dimenticato: Innocenzo II lo nominò Cardinale e fu uno dei suoi più stretti collaboratori, in particolare nel contrastare la diffusione dei patarini. Alla morte di Innocenzo II nel 1143, i Cardinali ebbero pochi dubbi nell'eleggerlo come suo successore con il nome di Innocenzo III, in onore del suo predecessore e
collaboratore.
sostegno, Stefano si diresse nuovamente alla volta dell'Inghilterra, occupando sulla strada diversi castelli normanni fedeli a Matilde, la quale nel frattempo aveva invaso l'Inghilterra con il sostegno di suo zio, Re Davide I di Scozia. Stefano riuscì a sbarcare in Inghilterra e intraprese una durissima campagna, particolarmente sanguinosa, con ripetuti cambi di fronte e diverse battaglie incerte. Dopo essere stato incoronato e riconosciuto Re nell'Abbazia di Canterbury, Stefano riuscì a sconfiggere e a distruggere l'esercito scozzese nella durissima Battaglia dello Stendardo: subito dopo offrì la pace a Re Davide, presentandosi come membro della famiglia (suo suocero, Eustachio I, aveva sposato una delle sorelle del Re) e ottenendo da questi il riconoscimento a Re d'Inghilterra. Abbandonata da tutti Matilde venne assediata a Oxford e il 17 dicembre 1141 ella tentò di fuggire dalla città, con soli quattro soldati, calandosi dai bastioni della città e cercando di attraversare a piedi il Tamigi ghiacciato con dei mantelli bianchi per mimetizzarsi ma il maggior numero di soldati a disposizione di Stefano aveva permesso al Re di sorvegliare anche quel lato della città, altrimenti trascurato, e la pretendente sconfitta venne catturata durante la fallita fuga. Con tale evento terminò de facto la Guerra Civile Inglese: il Sacro Romano Imperatore Stefano I, Defensor Fidei, venne riconosciuto Re d'Inghilterra dalla stessa Matilde, a cui Stefano concesse un diritto di successione in caso di estinzione della dinastia dei Blois d'Inghilterra per unificare il paese dopo la guerra. Stefano ora era sovrano di un Impero molto vasto e si apprestava a governarlo. Il contributo di San Bernardo di Chiaravalle non venne dimenticato: Innocenzo II lo nominò Cardinale e fu uno dei suoi più stretti collaboratori, in particolare nel contrastare la diffusione dei patarini. Alla morte di Innocenzo II nel 1143, i Cardinali ebbero pochi dubbi nell'eleggerlo come suo successore con il nome di Innocenzo III, in onore del suo predecessore e
collaboratore. Freidberg per poi attraversarlo direttamente all'altezza di Francoforte, nei pressi di Vilbell. Friedberg, a poca distanza dalla confluenza dei due fiumi rappresentava dunque una strozzatura strategica in cui costringere
l'aggressore (a fianco, la valle del fiume Nidda). Non solo, ma la cittadina, seppur piccola, era dotata di una fortezza che dominava la vallata circostante e avrebbe permesso di ammassare le provviste, che sarebbero giunte numerose dalla grande fiera annuale della città, seconda solo a quella di Francoforte stessa. Per tutti questi motivi l'Imperatore Federico I scelse questo luogo come campo di battaglia e vi pose nelle vicinanze il proprio accampamento, giusto sull'altra sponda del Wetter rispetto alla direttrice d'arrivo dei nemici. Fattore che si rivelerà ancor più decisivo, fino agli anni '70 del Novecento, quando furono bonificate, le sponde del fiume Nidda e la vallata circostante erano soggette a ripetute inondazioni e risultavano quindi paludose e acquitrinose, un terreno altamente sfavorevole alla cavalleria mongola, principale e sostanzialmente unica arma della grande armata mongola. La sera del 4 agosto 1242 un trafelato cavaliere con una freccia in una spalla giunse ansimante al campo: Grünberg era stata raggiunta dai mongoli e ora i roghi delle sue case e le urla degli abitanti che non erano riusciti a fuggire in tempo si riverberavano nella notte. Dopo aver bruciato Berlino, Magdeburgo, Lipsia, Dresda, Hannover, Kassel e Gottinga i Mongoli non avevano trovato altro che piccoli villaggi durante la marcia verso Francoforte ed erano dunque affamati di saccheggio. Avrebbero guadato il Wetter e sarebbero giunti a Friedberg il mattino seguente, si convenne nell'accampamento europeo. I monti di Vogelsberg, a Est, e Taunnus, a Ovest, impedivano ai cavalieri dell'Oriente di intraprendere altre strade. Venne passata parola, i cittadini di Friedberg furono fatti fuggire verso Francoforte nottetempo e le armi furono lucidate. Il mattino seguente, ancora prima che l'alba sorgesse su una notte insonne, l'Imperatore Federico I fece uscire il suo variegato esercito dall'accampamento e gli fece attraversare il Wetter, disponendosi poi con le spalle al fiume. Una mossa tatticamente sbagliata, poiché impediva la fuga in caso di ritirata, aveva in realtà un grande valore simbolico che fu sottolineato dallo stesso sovrano: qui si sarebbe decisa la sorte del Mondo Occidentale e non vi erano alternative che la vittoria e la libertà o una morte onorevole in battaglia. Non si sarebbe potuti essere codardi o traditori neppure volendolo ormai. Tagliando la ritirata al suo stesso esercito, Federico I sottolineò l'inevitabilità del loro compito, che venne accolto da una silenziosa consapevolezza. L'esercito imperiale venne così schierato: a Nord, sul fianco sinistro, vicino alla cittadina di Neuheim, stavano i contingenti inviati da altre nazioni, in particolare i cavalieri francesi ed ungheresi, guidati dal fratello del Re di Francia, Carlo d'Angiò, e dal Re d'Ungheria Bela IV, la fanteria polacca del giovane Duca di Prusy Casimiro I, figlio del defunto Corrado I, Alto Duca di Polonia e Duca di Masovia e Prusy, e fratello di Boleslaw I, Duca di Masovia, i soldati provenzali del Conte Raimondo Berengario e gli arcieri inglesi inviati da Re Arturo II sotto il comando di suo cugino, Enrico di Winchester, Duca di Normandia, figlio di suo zio, Giovanni il Serpente. In aggiunta a questi Federico I vi destinò i soldati comandati personalmente da Papa Gregorio IX, che fu designato comandante del fianco sinistro, contante circa trentamila soldati. Essendo così variegato era il fianco che aveva maggiori possibilità di cedere e così Federico I lo mise a Nord, in modo tale da assicurare una posizione più defilata rispetto all'avanzata della cavalleria avversaria e lasciandogli intendere di non avere altra scelta se non combattere con tutte le loro forze, visto che erano la parte dell'esercito più lontana rispetto alle mura di Francoforte. Sul fianco destro Federico I mise i soldati del Marchese di Tolosa Raimondo VII, le truppe del Duca di Boemia Venceslao I e soprattutto i soldati delle città e dei territori italici guidati da Ezzelino III da Romano, che era anche il comandante in capo del fianco destro, annoverante circa ventimila uomini, visto che doveva difendere soprattutto la paludosa sponda settentrionale del Nidda, poco appetibile da parte dei seguaci del Khan e facilmente difendibile. Al centro infine si trovava l'imperatore in persona alla testa delle truppe germaniche, delle armate bizantine, guidate dal Cesare Corrado (che in virtù della sua giovane età, appena quattordici anni, aveva lasciato il comando effettivo nelle mani di Goffredo di Hohenlohe, Gran Maestro dell'Ordine Teutonico e dunque sovrano del Burzenland), dei reparti crociati e di quelli degli Ordini Teutonico, dei Portaspada, Templare e degli Ospitalieri, per un totale di cinquantamila uomini. Alle prime luci del mattino una grande nuvola di polvere venne avvistata innalzarsi in direzione di Grünberg mentre un leggero rombo crescente faceva increspare le pozzanghere e tremare la terra. Nessuno aveva bisogno di spiegazioni: qualcosa come centomila cavalli stavano arrivando al galoppo verso di loro. Federico I indossò la sua armatura dorata e salì sul suo cavallo bianco, disponendosi al centro del suo schieramento, ben visibile per animare i suoi uomini. Papa Gregorio IX passò davanti a tutte le file, mentre il tremore aumentava, impartendo a tutti l'ultima benedizione e ricordando che il giorno dopo sarebbe stata la Festa della Trasfigurazione di Gesù e dunque era il caso di fare almeno bella figura. Finalmente, verso le dieci del mattino, l'orda mongola apparve e caricò subito lo schieramento cristiano, urlando versi orribili e agitando le loro armi per spaventare gli avversari. Qualcuno trema, qualcuno vacilla, ma il fiume Wetter sbarre sempre la strada: non resta che rimanere e combattere. I cavalieri mongoli sono a trecento metri, duecento, centocinquanta, cento... "Ora!" urla l'Imperatore quando ormai i mongoli non distano che una trentina di metri dalla prima linea. La prima fila si abbassa e la seconda, composta da arcieri inglesi e balestrieri svizzeri lascia partire una micidiale raffica di dardi contro le file nemiche. A questa distanza, con i nemici così vicini, nessun tiro è a vuoto. La prima ondata di cavalieri cade falciata e disarcionata e viene travolta dalla seconda che a sua volta incespica ed inciampa, ma non si ferma. Non può, ormai lo slancio li spinge in avanti con troppa forza per fermarsi. Le prima file cozzano le une contro le altre, scontro immane di scudi, lance spezzate, spade, metallo contro metallo che già si sporca di sangue. La mischia è immensa, si combatte ferocemente da entrambe le parti. La grande massa di mongoli cerca di sfondare al centro, quella è la parte importante, perché, una volta crollata, le ali saranno isolate e si daranno alla fuga. Poi improvvisamente i mongoli ripiegano, dandosela a gambe. I soldati scalpitano, vorrebbero inseguire quei vigliacchi, ma Federico I li ferma, ha sentito i racconti dei cumani, dei russi, dei polacchi e degli ungheresi, sa delle trappole dei guerrieri venuti dal Lontano Oriente... Ma non così i cavalieri francesi che si lanciano in avanti per inseguire i fuggitivi. Quando, nel giro di pochi minuti, i mongoli fanno dietro front e attaccano a sorpresa gli incauti soldati del Re di Francia, Papa Gregorio IX, che sta osservando tutto da sopra un grande carro su cui ha fatto erigere una grande croce bianca perché protegga i soldati cristiani e che stava già bofonchiando maledizioni contro quei dannati francesi, salta su come un grillo urlando "Giammai un cristiano non soccorra un altro cristiano! Forza, fratelli, impugniamo le armi e accorriamo in loro difesa, perché non si dica che quest'oggi abbiamo mancato ai nostri doveri verso Nostro Signore: le campane, suonate le campane...vedrete che l'aiuto arriverà! E ora alla pugna, alla pugna!". Il fianco sinistro si precipitò così tutto insieme contro i cavallerizzi mongoli che già si preparavano a farsi un sol boccone dei francesi e che vennero invece presi di sorpresa da questo contrattacco. In breve la piana poco a nord di Friedberg si trasformò in una mischia furibonda e confusa, con altri mongoli che affluivano contro i soldati europei mentre questi li combattevano con foga senza arretrare di un passo. In mezzo il Carroccio rappresentava il baluardo e il fulcro della difesa cristiana nonché l'unico punto di riferimento visibile e non pochi commentatori dell'epoca giurano di aver visto Gregorio IX sopra di esso, con la sua svolazzante veste bianca, intento a suonare vivacemente la campana con una mano mentre con l'altra e con un piede ricacciava i mongoli giù dal carro urlando cose come "Giù da questo sacrissimo carro, mannaggia a voi! Non osate insozzarlo con le vostre dannate manacce pagane! E li mortacci tuoi...pussa via, e tu prendi questo, brutto muso!". Vedendo il centro mongolo spostarsi per prendere alle spalle la sua ala sinistra Federico I decise che era il momento di battersi come leoni: sguainò nuovamente la spada e si gettò in avanti urlando "Soldati dell'Impero, diamo loro una mano!", alche il Cesare Corrado gridò "Tutti con l'Imperatore!" e si gettò a sua volta alla carica seguito da tutto il centro. Mentre le trombe suonavano alla riscossa, la carica imperiale colse di sorpresa i cavalieri mongoli che si ritrovarono presi tra due fuochi. Fu una strage: mezzi accerchiati, senza aspettarsi una resistenza così tenace, con i cavalli stanchi per la lunga marcia e azzoppati dalle paludi e ostacolati dal fango, i mongoli non riuscirono a riprendere l'iniziativa e l'esercito cadde nel caos. Una fetta consistente, vista la malaparata e data le scarse possibilità di bottino, cercò di sganciarsi e di darsela a gambe ma fu intercettata dall'ala destra di Ezzelino III che ne massacrò una gran quantità. Entro sera la temibile armata mongola era dispersa ed in rotta e i soldati cristiani festeggiavano sul campo vittorioso con tanto fervore che si dice che per molti giorni il fiume Nidda e le paludi adiacenti erano composte da più birra che acqua! In realtà oggi gli storici hanno appurato che quella affrontata a Friedberg non fu altro che un'avanguardia di un corpo d'invasione principale contro il quale le pur valorose forze europee non avrebbero avuto probabilmente scampo. Ma-e qui quando lo seppe Gregorio IX e tutti i Papi successivi non fecero altro che additarlo come un evidente miracolo- a diecimila chilometri di distanza era morto il Gran Khan Ögödei e la legge mongola imponeva a tutti i comandanti militari di rientrare in patria per eleggere un nuovo Khan. Così i mongoli si ritirarono mentre all'opposto gli europei erano in festa e trasformavano il Carroccio pontificio in uno dei più grandi simboli di collaborazione ed orgoglio europeo. Ma i grandi festeggiamenti furono funestati anche da un triste evento: l'Imperatore Federico I era stato colpito da una freccia mongola durante la sua ultima e vittoriosa carica ma, nonostante la ferita, aveva continuato a lottare fino alla fuga definitiva dei mongoli. Nei giorni successivi si era ulteriormente speso per inseguire a distanza i mongoli e assicurarsi che non tornassero indietro e per visitare e portare la buona novella nelle terre recentemente devastante dalla marea mongola, che, proprio come l’evento naturale, stava ora defluendo. La scarsa attenzione prestata alla ferita e lo sforzo fisico contribuirono a causare una grave infezione, a causa della quale, quando tornò due settimane dopo a
Francoforte, dove nel frattempo non avevano ancora smesso di festeggiare, era già in preda ad una grave febbre. I soccorsi furono inutili e probabilmente anche l'aria insalubre di quelle stesse paludi che gli avevano assicurato la vittoria contribuì a debilitarlo sempre di più, fino alla morte sopraggiunta il 26 agosto 1242. La morte di quello che era ormai considerato da tutti come il Salvatore d'Europa generò una grande commozione in tutto il Continente e non ci fu città che non dedicò messe al suo nome. Il suo funerale avvenne alla presenza di tutti i sovrani continentali, che non avevano ancora smobilitato, e lo stesso Gregorio IX, prima suo inflessibile avversario, tenne una celebre orazione funebre in cui non lesinò parole di lode e di rimpianto per il defunto. L'incredibile atmosfera di affetto che aveva avvolto questo sovrano, prima così controverso, nel momento in cui aveva assunto le redini del Mondo conosciuto per salvarlo fu accresciuta ancora di più dalla sua morte. Per pochi mesi egli era stato l'incontrastato leader di tutti i popoli europei e cristiani e questo lo innalzò a simbolo dell'unità della Cristianità e di
un intero continente. E fu anche e sopratutto per questo che, osservando il feretro mentre veniva calato nella fossa, il suo segretario e biografo Thomas von Mazzon commentò triste "Con lui muore
l'Europa..."
Freidberg per poi attraversarlo direttamente all'altezza di Francoforte, nei pressi di Vilbell. Friedberg, a poca distanza dalla confluenza dei due fiumi rappresentava dunque una strozzatura strategica in cui costringere
l'aggressore (a fianco, la valle del fiume Nidda). Non solo, ma la cittadina, seppur piccola, era dotata di una fortezza che dominava la vallata circostante e avrebbe permesso di ammassare le provviste, che sarebbero giunte numerose dalla grande fiera annuale della città, seconda solo a quella di Francoforte stessa. Per tutti questi motivi l'Imperatore Federico I scelse questo luogo come campo di battaglia e vi pose nelle vicinanze il proprio accampamento, giusto sull'altra sponda del Wetter rispetto alla direttrice d'arrivo dei nemici. Fattore che si rivelerà ancor più decisivo, fino agli anni '70 del Novecento, quando furono bonificate, le sponde del fiume Nidda e la vallata circostante erano soggette a ripetute inondazioni e risultavano quindi paludose e acquitrinose, un terreno altamente sfavorevole alla cavalleria mongola, principale e sostanzialmente unica arma della grande armata mongola. La sera del 4 agosto 1242 un trafelato cavaliere con una freccia in una spalla giunse ansimante al campo: Grünberg era stata raggiunta dai mongoli e ora i roghi delle sue case e le urla degli abitanti che non erano riusciti a fuggire in tempo si riverberavano nella notte. Dopo aver bruciato Berlino, Magdeburgo, Lipsia, Dresda, Hannover, Kassel e Gottinga i Mongoli non avevano trovato altro che piccoli villaggi durante la marcia verso Francoforte ed erano dunque affamati di saccheggio. Avrebbero guadato il Wetter e sarebbero giunti a Friedberg il mattino seguente, si convenne nell'accampamento europeo. I monti di Vogelsberg, a Est, e Taunnus, a Ovest, impedivano ai cavalieri dell'Oriente di intraprendere altre strade. Venne passata parola, i cittadini di Friedberg furono fatti fuggire verso Francoforte nottetempo e le armi furono lucidate. Il mattino seguente, ancora prima che l'alba sorgesse su una notte insonne, l'Imperatore Federico I fece uscire il suo variegato esercito dall'accampamento e gli fece attraversare il Wetter, disponendosi poi con le spalle al fiume. Una mossa tatticamente sbagliata, poiché impediva la fuga in caso di ritirata, aveva in realtà un grande valore simbolico che fu sottolineato dallo stesso sovrano: qui si sarebbe decisa la sorte del Mondo Occidentale e non vi erano alternative che la vittoria e la libertà o una morte onorevole in battaglia. Non si sarebbe potuti essere codardi o traditori neppure volendolo ormai. Tagliando la ritirata al suo stesso esercito, Federico I sottolineò l'inevitabilità del loro compito, che venne accolto da una silenziosa consapevolezza. L'esercito imperiale venne così schierato: a Nord, sul fianco sinistro, vicino alla cittadina di Neuheim, stavano i contingenti inviati da altre nazioni, in particolare i cavalieri francesi ed ungheresi, guidati dal fratello del Re di Francia, Carlo d'Angiò, e dal Re d'Ungheria Bela IV, la fanteria polacca del giovane Duca di Prusy Casimiro I, figlio del defunto Corrado I, Alto Duca di Polonia e Duca di Masovia e Prusy, e fratello di Boleslaw I, Duca di Masovia, i soldati provenzali del Conte Raimondo Berengario e gli arcieri inglesi inviati da Re Arturo II sotto il comando di suo cugino, Enrico di Winchester, Duca di Normandia, figlio di suo zio, Giovanni il Serpente. In aggiunta a questi Federico I vi destinò i soldati comandati personalmente da Papa Gregorio IX, che fu designato comandante del fianco sinistro, contante circa trentamila soldati. Essendo così variegato era il fianco che aveva maggiori possibilità di cedere e così Federico I lo mise a Nord, in modo tale da assicurare una posizione più defilata rispetto all'avanzata della cavalleria avversaria e lasciandogli intendere di non avere altra scelta se non combattere con tutte le loro forze, visto che erano la parte dell'esercito più lontana rispetto alle mura di Francoforte. Sul fianco destro Federico I mise i soldati del Marchese di Tolosa Raimondo VII, le truppe del Duca di Boemia Venceslao I e soprattutto i soldati delle città e dei territori italici guidati da Ezzelino III da Romano, che era anche il comandante in capo del fianco destro, annoverante circa ventimila uomini, visto che doveva difendere soprattutto la paludosa sponda settentrionale del Nidda, poco appetibile da parte dei seguaci del Khan e facilmente difendibile. Al centro infine si trovava l'imperatore in persona alla testa delle truppe germaniche, delle armate bizantine, guidate dal Cesare Corrado (che in virtù della sua giovane età, appena quattordici anni, aveva lasciato il comando effettivo nelle mani di Goffredo di Hohenlohe, Gran Maestro dell'Ordine Teutonico e dunque sovrano del Burzenland), dei reparti crociati e di quelli degli Ordini Teutonico, dei Portaspada, Templare e degli Ospitalieri, per un totale di cinquantamila uomini. Alle prime luci del mattino una grande nuvola di polvere venne avvistata innalzarsi in direzione di Grünberg mentre un leggero rombo crescente faceva increspare le pozzanghere e tremare la terra. Nessuno aveva bisogno di spiegazioni: qualcosa come centomila cavalli stavano arrivando al galoppo verso di loro. Federico I indossò la sua armatura dorata e salì sul suo cavallo bianco, disponendosi al centro del suo schieramento, ben visibile per animare i suoi uomini. Papa Gregorio IX passò davanti a tutte le file, mentre il tremore aumentava, impartendo a tutti l'ultima benedizione e ricordando che il giorno dopo sarebbe stata la Festa della Trasfigurazione di Gesù e dunque era il caso di fare almeno bella figura. Finalmente, verso le dieci del mattino, l'orda mongola apparve e caricò subito lo schieramento cristiano, urlando versi orribili e agitando le loro armi per spaventare gli avversari. Qualcuno trema, qualcuno vacilla, ma il fiume Wetter sbarre sempre la strada: non resta che rimanere e combattere. I cavalieri mongoli sono a trecento metri, duecento, centocinquanta, cento... "Ora!" urla l'Imperatore quando ormai i mongoli non distano che una trentina di metri dalla prima linea. La prima fila si abbassa e la seconda, composta da arcieri inglesi e balestrieri svizzeri lascia partire una micidiale raffica di dardi contro le file nemiche. A questa distanza, con i nemici così vicini, nessun tiro è a vuoto. La prima ondata di cavalieri cade falciata e disarcionata e viene travolta dalla seconda che a sua volta incespica ed inciampa, ma non si ferma. Non può, ormai lo slancio li spinge in avanti con troppa forza per fermarsi. Le prima file cozzano le une contro le altre, scontro immane di scudi, lance spezzate, spade, metallo contro metallo che già si sporca di sangue. La mischia è immensa, si combatte ferocemente da entrambe le parti. La grande massa di mongoli cerca di sfondare al centro, quella è la parte importante, perché, una volta crollata, le ali saranno isolate e si daranno alla fuga. Poi improvvisamente i mongoli ripiegano, dandosela a gambe. I soldati scalpitano, vorrebbero inseguire quei vigliacchi, ma Federico I li ferma, ha sentito i racconti dei cumani, dei russi, dei polacchi e degli ungheresi, sa delle trappole dei guerrieri venuti dal Lontano Oriente... Ma non così i cavalieri francesi che si lanciano in avanti per inseguire i fuggitivi. Quando, nel giro di pochi minuti, i mongoli fanno dietro front e attaccano a sorpresa gli incauti soldati del Re di Francia, Papa Gregorio IX, che sta osservando tutto da sopra un grande carro su cui ha fatto erigere una grande croce bianca perché protegga i soldati cristiani e che stava già bofonchiando maledizioni contro quei dannati francesi, salta su come un grillo urlando "Giammai un cristiano non soccorra un altro cristiano! Forza, fratelli, impugniamo le armi e accorriamo in loro difesa, perché non si dica che quest'oggi abbiamo mancato ai nostri doveri verso Nostro Signore: le campane, suonate le campane...vedrete che l'aiuto arriverà! E ora alla pugna, alla pugna!". Il fianco sinistro si precipitò così tutto insieme contro i cavallerizzi mongoli che già si preparavano a farsi un sol boccone dei francesi e che vennero invece presi di sorpresa da questo contrattacco. In breve la piana poco a nord di Friedberg si trasformò in una mischia furibonda e confusa, con altri mongoli che affluivano contro i soldati europei mentre questi li combattevano con foga senza arretrare di un passo. In mezzo il Carroccio rappresentava il baluardo e il fulcro della difesa cristiana nonché l'unico punto di riferimento visibile e non pochi commentatori dell'epoca giurano di aver visto Gregorio IX sopra di esso, con la sua svolazzante veste bianca, intento a suonare vivacemente la campana con una mano mentre con l'altra e con un piede ricacciava i mongoli giù dal carro urlando cose come "Giù da questo sacrissimo carro, mannaggia a voi! Non osate insozzarlo con le vostre dannate manacce pagane! E li mortacci tuoi...pussa via, e tu prendi questo, brutto muso!". Vedendo il centro mongolo spostarsi per prendere alle spalle la sua ala sinistra Federico I decise che era il momento di battersi come leoni: sguainò nuovamente la spada e si gettò in avanti urlando "Soldati dell'Impero, diamo loro una mano!", alche il Cesare Corrado gridò "Tutti con l'Imperatore!" e si gettò a sua volta alla carica seguito da tutto il centro. Mentre le trombe suonavano alla riscossa, la carica imperiale colse di sorpresa i cavalieri mongoli che si ritrovarono presi tra due fuochi. Fu una strage: mezzi accerchiati, senza aspettarsi una resistenza così tenace, con i cavalli stanchi per la lunga marcia e azzoppati dalle paludi e ostacolati dal fango, i mongoli non riuscirono a riprendere l'iniziativa e l'esercito cadde nel caos. Una fetta consistente, vista la malaparata e data le scarse possibilità di bottino, cercò di sganciarsi e di darsela a gambe ma fu intercettata dall'ala destra di Ezzelino III che ne massacrò una gran quantità. Entro sera la temibile armata mongola era dispersa ed in rotta e i soldati cristiani festeggiavano sul campo vittorioso con tanto fervore che si dice che per molti giorni il fiume Nidda e le paludi adiacenti erano composte da più birra che acqua! In realtà oggi gli storici hanno appurato che quella affrontata a Friedberg non fu altro che un'avanguardia di un corpo d'invasione principale contro il quale le pur valorose forze europee non avrebbero avuto probabilmente scampo. Ma-e qui quando lo seppe Gregorio IX e tutti i Papi successivi non fecero altro che additarlo come un evidente miracolo- a diecimila chilometri di distanza era morto il Gran Khan Ögödei e la legge mongola imponeva a tutti i comandanti militari di rientrare in patria per eleggere un nuovo Khan. Così i mongoli si ritirarono mentre all'opposto gli europei erano in festa e trasformavano il Carroccio pontificio in uno dei più grandi simboli di collaborazione ed orgoglio europeo. Ma i grandi festeggiamenti furono funestati anche da un triste evento: l'Imperatore Federico I era stato colpito da una freccia mongola durante la sua ultima e vittoriosa carica ma, nonostante la ferita, aveva continuato a lottare fino alla fuga definitiva dei mongoli. Nei giorni successivi si era ulteriormente speso per inseguire a distanza i mongoli e assicurarsi che non tornassero indietro e per visitare e portare la buona novella nelle terre recentemente devastante dalla marea mongola, che, proprio come l’evento naturale, stava ora defluendo. La scarsa attenzione prestata alla ferita e lo sforzo fisico contribuirono a causare una grave infezione, a causa della quale, quando tornò due settimane dopo a
Francoforte, dove nel frattempo non avevano ancora smesso di festeggiare, era già in preda ad una grave febbre. I soccorsi furono inutili e probabilmente anche l'aria insalubre di quelle stesse paludi che gli avevano assicurato la vittoria contribuì a debilitarlo sempre di più, fino alla morte sopraggiunta il 26 agosto 1242. La morte di quello che era ormai considerato da tutti come il Salvatore d'Europa generò una grande commozione in tutto il Continente e non ci fu città che non dedicò messe al suo nome. Il suo funerale avvenne alla presenza di tutti i sovrani continentali, che non avevano ancora smobilitato, e lo stesso Gregorio IX, prima suo inflessibile avversario, tenne una celebre orazione funebre in cui non lesinò parole di lode e di rimpianto per il defunto. L'incredibile atmosfera di affetto che aveva avvolto questo sovrano, prima così controverso, nel momento in cui aveva assunto le redini del Mondo conosciuto per salvarlo fu accresciuta ancora di più dalla sua morte. Per pochi mesi egli era stato l'incontrastato leader di tutti i popoli europei e cristiani e questo lo innalzò a simbolo dell'unità della Cristianità e di
un intero continente. E fu anche e sopratutto per questo che, osservando il feretro mentre veniva calato nella fossa, il suo segretario e biografo Thomas von Mazzon commentò triste "Con lui muore
l'Europa..."