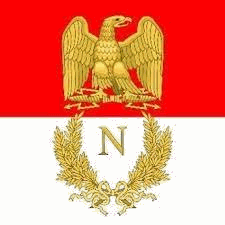
La storia del Listenburgo
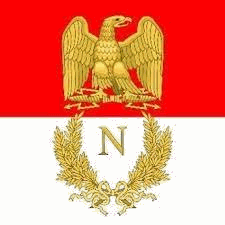
.
Tutto è cominciato con la boutade di Perchè No?:
Tutto è iniziato come una barzelletta. Su Twitter, un Francese si è divertito a creare una carta con un paese immaginario e chiedere agli Americani di identificarlo. In appena qualche giorno è diventato un trend con una folla di persone che hanno creato un paese dal nulla (cosa noi facciamo in maniera abituale...). Questo paese è ormai chiamato il Listenbourg, ha la sua moneta, la sua storia, la sua bandiera e inno, le sue regioni, fa parte dell'UE e della NATO. Ha anche un suo governo autoproclamato. Il paese è stato creato nel X secolo; si parla il francese (nell'immaginaria regione di Caséière), il tedesco (in Kusterde, Mitteland e Flusserde) e lo spagnolo (nell'Adriàs). L'ucronia sta diventando di moda su Twitter!!
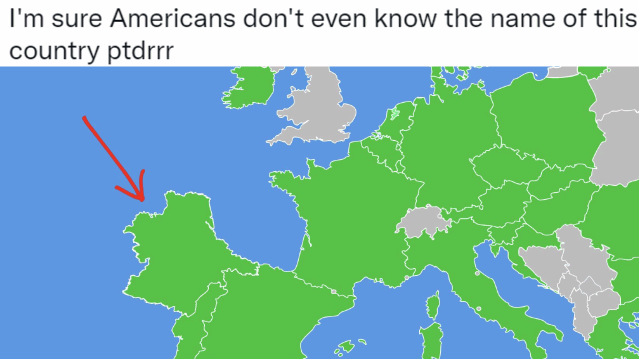
Per quelli che non
avevano gia indovinato, questo Listenburgo è solo la Francia rovesciata e più
piccola!
Le cose prendono delle proporzioni inaspettate con certe città francesi che
stabiliscono dei gemellaggi (?) con le città del Listenburgo e la squadra
francese di calcio ha dichiarato aver scelto il paese per prepararsi al mondiale
(e il paese sta per essere invitato ai Giochi Olimpici di Parigi).
.
William Riker però fa notare:
Il problema è: geologicamente, come si è formato il Listenburgo? Le scarpate continentali europee corrispondono molto bene a quelle nordamericane, eccezion fatta per alcune anomalie (la Scozia è un pezzo di Acadia rimasto dalla parte sbagliata quando si chiuse l'oceano Giapeto e poi si riaprì l'oceano Atlantico); con quel clone della Francia di mezzo, la tettonica delle placche se ne va a mignotte. Per salvare capra e placche, sospetto che "manchi" un pezzo di Nuova Inghilterra dall'altra parte dell'oceano. O meglio, per chi sa qualcosa di TdP, il microcontinente di Avalonia (una specie di Giappone atlantico) non si è schiacciato tutto contro la Laurenzia formando gli Appalachi e la Nuova Inghilterra, ma un pezzo è rimasto appiccicato al Vecchio Mondo. Urca urca! Vuoi vedere che, in questo universo, Boston è in Europa? E in tal caso, senza il MIT, dove studieranno Buzz Aldrin, Kofi Annan e un giovane Mario Draghi?
Inoltre, ti sei accorto che la spiritualità medioevale cambia completamente, senza Santiago de Compostela? Senza Santiago Matamoros, chi guiderà la Reconquista? E ancora prima, gli Arabi non avevano conquistato il Listenburgo? Da lì potevano minacciare persino le Isole Britanniche! Secondo me è un'ucronia che può cambiare tutta la storia europea!
.
Bhrihskwobhloukstroy annuisce:
Inquadramento tettonico
assolutamente imprescindibile!
Se, nella nostra Realtà, la parte di Avalonia che oggi è in Europa
(continentale) è a Nord della Baia della Somme, tenuto conto della parte di
Avalonia oggi sommersa (che ucronicamente sarebbe altrettanto sommersa) il
Listenburgo potrebbe anche essere costituito (più o meno) dalla metà orientale
di Terranova (prima di arrivare a privare della Nuova Inghilterra le Americhe)?
Altrimenti il Mare del Nord sarebbe abbastanza sollevato da non essere mai
sommerso e allora altro che Boston: avremmo un Impero Atlantideo esteso su tutto
il territorio indoeuropeo...
Direi che lo scherzo nasce dalla combinazione fra il profilo del Golfo Artabro e
quello rovesciato della Penisola del Cotentin (e con Lille combaciante con
Malpica de Bergantios). In questo caso, la Galizia non ne risulterebbe alterata
(se può servire).
.
Perchè No? aggiunge:
Personalmente pensavo che l'origine del Listenburgo sarebbe da cercare dopo la conquista musulmana della penisola iberica come regno-rifugio per una dinastia visigotica. Le province più settentrionali infatti parlano una lingua "germanica" (ma possiamo procedere secondo nostri gusti, dopotutto è una invenzione recente). Nei secoli seguenti Francia e regni iberici (poi Spagna) avrebbero lottato per il controllo della penisola, e ciò spiega le province francofone e ispanofone. Probabilmente il Listenburgo non ha partecipato alla Reconquista, ma non so il perché.
.
Diamo allora la parola ad Alessio Mammarella:, che ha provato a scrivere per noi la storia di questa ipotetica nazione:
Fino al V secolo
Il territorio dell'attuale
Listenburgo risulta popolato, in epoca storica, da tribù di celtiberi. Le prime
cittadine fondate da questi ultimi risultano più o meno coeve con delle piccole
colonie greche e cartaginesi (Stratord è riconducibile a una colonia greca,
Meylan a una cartaginese, abbandonata comunque in età molto precoce). A causa
della relativa distanza rispetto alla costa mediterranea della Spagna, le
regioni dell'odierno Listenburgo non furono coinvolte dalle guerre tra romani e
cartaginesi e la prima incursione romana del quale ci sono prove certe avvenne
solo dopo la caduta di Numanzia. Nel corso del secolo successivo i romani
continuarono la loro conquista, anche se a causa delle numerose guerre
combattute in quegli anni essi riservarono sempre attenzioni limitate a quel
territorio così periferico.
La colonizzazione sistematica iniziò, più che per brama di conquista, per
inseguire comandanti romani ribelli, come Sertorio e Sesto Pompeo. Risulta però
che la conquista fu completata solo al tempo dell'Imperatore Domiziano, quando
fu annesso un regno locale già cliente dei romani, ubicato nell'odierno Kusterde.
Durante l'epoca imperiale, l'Adriàs era parte dell'Hispania Lusitania, il
Caséière dell'Hispania Tarraconensis, mentre il resto del paese faceva parte
della provincia dell'Hispania Nova, con capitale Colonia Flavia (l'odierna
Alsbourg).
Il regno dei Suebi
All'inizio del V secolo, le varie
province della Spagna romana furono raggiunte e occupate da gruppi di invasori
appartenenti a varie popolazioni. I Suebi si concentrarono nell'area
dell'odierno Mitteland e lì fondarono un regno. Il regno dei Suebi si estese ben
presto in tutte le direzioni fino a comprendere, nella sua massima estensione,
anche l'intera Lusitania. I secoli successivi furono contraddistinti da continue
guerre con il vicino regno visigoto, Nessuno dei due regni riuscì a soverchiare
l'altro, visto che avevano un'estensione e una popolazione pressappoco
equivalente. Nel Kusterde cominciò ad avere ad un certo punto molto successo il
priscillianesimo, una variante cristiana ritenuta eretica dai cattolici. I
sovrani suebi decisero però di essere tolleranti, tanto che la dottrina si
diffuse a tutto il paese, e molti sovrani abbracciarono la nuova dottrina, anche
se in un clima di tolleranza verso i cattolici. Questa particolare situazione
religiosa tornò utile ai suebi al tempo dell'invasione araba. I nuovi arrivati,
infatti, consideravano la dottrina dei priscilliani per alcuni versi
apprezzabile, e quindi decisero di non invadere e non combattere il regno dei
suebi come avevano fatto con quello dei visigoti. Il regno visse quindi i tre
secoli successivi all'invasione araba in modo molto più pacifico rispetto ai tre
secoli precedenti.
Il frazionamento e le
lotte religiose
Le fortune per il regno dei suebi
cominciarono a declinare all'inizio dell'XI secolo per una serie di congiunture
politiche: il Califfato di Cordova, con il quale c'erano stati ottimi rapporti,
subì un collasso, frazionandosi in numerosi stati minori; i regni cattolici,
spinti da Roma, cominciarono allora a lottare maggiormente contro il regno che
tollerava l'eresia priscilliana. Loro alleato, il regno di Francia, che inviò
molti cavalieri. Le spedizioni cattoliche condussero alla conquista del Caséière,
dove si insediò Raimondo di Borgogna e fondò la nuova città di Saint Marie.
Quando il re dei suebi Fromaro III sconfisse il castigliano castigliano Alfonso,
morendo però in battaglia (1173), il ribelle cattolico Ermenerico costituì un
piccolo dominio indipendente nel Flusserde, regione che per la prima volta nella
storia del paese assurse a una certa importanza. Nel suo territorio iniziò la
restaurazione cattolica, con modi molto energici. Alcuni anni dopo l'ambizioso
cavaliere affrontò anche un pericoloso viaggio in mare, durante la cattiva
stagione, per raggiungere l'Imperatore Federico Barbarossa, proclamarsi suo
suddito e ottenerne l'appoggio. Impressionato dal suo coraggio l'Imperatore lo
riconobbe come suo vassallo e comandò a uno dei suoi migliori cavalieri,
Sibrando, di seguirlo e di aiutarlo nella lotta contro gli eretici. Sibrando,
che aveva già combattuto in Terrasanta, prese il suo compito molto sul serio e
finì per fondare quello che diventerà noto come Ordine Teutonico.
Verso il Listenburgo
moderno
Nei secoli che seguirono, il
Flusserde vide una continua e massiccia immigrazione di tedeschi, principalmente
cavalieri ma anche mercanti e artigiani al loro seguito. Ermenerico, nonostante
il buon rapporto stabilito con l'Imperatore Federico Barbarossa, non era
riuscito a farsi riconoscere un titolo ducale o comunque un altro titolo formale
per governare i suoi domini e quindi ben presto i cavalieri tedeschi presero
direttamente il controllo del Flusserde, grazie anche al riconoscimento della
Santa Sede. Il resto del paese era diviso in quattro piccoli regni distinti. Il
regno occidentale, nella regione del Kusterde, subì prima di ogni altro la
pressione tedesca e infatti fu il primo tra i resti del vecchio regno dei Suebi
a essere conquistato. Molto più resistente il regno orientale, nell'odierno
Mitteland, protetto dalle montagne e dalle foreste. Proprio nel mezzo della
foresta, nel 1410, i locali ottennero una vittoria clamorosa contro i cavalieri
teutonici ritardando di quasi un secolo la conquista del loro territorio. Il
Caséière invece era governato, sin dai tempi di Raimondo di Borgogna, da
dinastie francesi che si succedevano l'una all'altra. In ogni caso, entro
l'inizio del XVI secolo tutto il territorio del Listanburgo era stato
completamente cattolicizzato. Solo il regno dell'Adriàs resisteva ancora, come
ultima roccaforte del priscillianesimo e di una politica di piena ospitalità
verso ebrei e musulmani che invece altrove erano trattati con grande durezza.
Il Ducato del
Listenburgo
Alla fine XV secolo l'Ordine
Teutonico completò la conquista del Mitteland, dopo averne quasi sterminato la
popolazione. Paradossalmente, proprio un Grande Maestro dei cavalieri teutonici,
erede della lunga lotta per restaurare il cristianesimo contro l'eresia
priscilliana, decise di aderire alla Riforma protestante e di secolarizzare
territorio, fondando il Ducato del Listenburgo. Si trattava di Alberto del
Brandeburgo, che divenne Duca del Listenburgo come Alberto I. Dopo di lui regnò
suo figlio Alberto II (Alberto Federico) che ebbe però come erede una femmina,
la principessa Anna. L'annuncio del matrimonio della principessa con Federico IV
del Palatinato, uno dei principali avversari tedeschi della dinastia imperiale,
provocò l'intervento armato della Spagna che provò a invadere il ducato. La
"crociata contro i lustemburghesi" fu la prima fase della Guerra dei Trent'anni.
In Lustenburgo tale conflitto viene chiamato "guerra d'indipendenza
lustenburghese". A Federico successero il figlio, con lo stesso nome, e poi il
nipote Carlo, che spostò definitivamente la sede della famiglia e della corte,
avendo perso a causa della guerra i domini di famiglia in Germania. Alla morte
di Carlo II scoppiò la Guerra di Successione Listenburghese poiché la sorella ed
erede di Carlo, Elisabetta Carlotta, aveva sposato il fratello di Luigi XIV di
Francia e si prospettava quindi lo spostamento stabile del Listenburgo in orbita
francese, che le altre potenze europee volevano evitare.
La Guerra di
Successione Listenburghese
L'avvento sul trono listemburghese
di Elisabetta Carlotta e di suo marito Filippo di Borbone-Orleans fu contrastato
soprattutto da Carlo II d'Inghilterra, che aveva sposato una cugina di
Elisabetta Carlotta e che era comunque imparentato con la famiglia ducale
(tramite Elisabetta Stuart, sposa del Duca Federico II). Carlo dal punto di
vista giuridico non aveva ragione, ma cercò di ottenere l'appoggio dell'Austria
e della Spagna dichiarando che, se fosse diventato Duca del Listenburgo, vi
avrebbe restaurato il cattolicesimo. Questa dichiarazione se da una parte gli
fruttò l'appoggio politico e finanziario che cercava dall'altro spaventò i suoi
stessi sudditi, e pochi mesi dopo l'inizio del conflitto l'Inghilterra si
ribellò al suo sovrano, scegliendosi un nuovo Re protestante, Guglielmo d'Orange.
Per quanto Guglielmo fosse personalmente ostile al sovrano francese Luigi XIV,
con la messa da parte di Carlo II d'Inghilterra veniva a cadere qualsiasi
opposizione alla nuova coppia ducale del Listenburgo. Guglielmo decise quindi di
abbandonare il conflitto. L'Austria e la Spagna, invece, cercarono di continuare
la lotta appoggiando le ambizioni del marito di un'altra cugina di Elisabetta
Carlotta, che aveva sposato Alfonso VI del Portogallo. Il sovrano lusitano
tuttavia non aveva fama di essere particolarmente scaltro o energico, e ben
presto finì per essere abbandonato dai suoi alleati.
Le Guerre di
Successione Spagnola e Francese
Pochi anni dopo scoppiò una nuova
guerra per la successione al sovrano spagnolo Carlo II. Dopo un estenuante
conflitto, che coinvolse l'intero continente, anche il trono spagnolo passò a
una dinastia borbonica. Ciò comportò, dopo secoli di conflitto ininterrotto, uno
stato di pace tra Listenburgo e Spagna. Pochi anni dopo la firma della pace,
tuttavia, morì il giovanissimo Luigi XV, ultimo erede legittimo del grande "Re
Sole". Secondo la riforma voluta proprio dal Luigi XIV la corona sarebbe dovuta
passare a Luigi Augusto, il primo tra i suoi figli illegittimi. Costui tuttavia,
per contrastare le voci malevole che lo avrebbero visto coinvolto nella morte
del giovanissimo re, decise di rinunciare al trono a favore di suo figlio,
appena maggiorenne, che salì quindi al trono come Luigi XVI. Ciò tuttavia non fu
abbastanza per impedire l'attacco in armi della Spagna, i cui sovrano, Filippo
V, era nipote legittimo di Luigi XIV, Le altre potenze europee furono a lungo
indecise su chi appoggiare: il trattato di Utrecht era stato scritto
appositamente per impedire a Filippo di diventare anche Re di Francia, ma la
Francia, più forte militarmente, era per loro il vero nemico e per attaccarlo
sarebbe bastato delegittimare il nuovo sovrano. Il Listenburgo fu tra i paesi
che alla fine restarono completamente neutrali. Luigi XVI, alla fine, riuscì a
farsi riconoscere come legittimo Re di Francia, anche se poi i suoi tentativi di
alleanza matrimoniale furono sistematicamente osteggiati. Finì per sposare Maria
Leszczynska, figlia di un nobile polacco.
Titolo regio, riforme
e la questione dell'Adriàs
Nel corso del XVIII secolo, il
Listenburgo attuò una politica estera piuttosto accorta, che consentì di
ottenere vari obiettivi. Filippo III, partecipando alla Guerra di Successione
Polacca, ottenne il Caséière, mentre partecipando alla Guerra di Successione
Austriaca si vide finalmente riconoscere il titolo regio. Il suo successore
Filippo IV fu invece un sovrano pacifico e illuminato, uno tra più lodati dagli
intellettuali della sua epoca.
L'unico territorio del Listenburgo che restava separato dal resto del paese era
l'Adriàs. Conquistato inizialmente dal Portogallo, l'Adriàs si caratterizzò
sempre per una resistenza vigorosa, che costò anche la vita al re Sebastiano. Al
tempo della dominazione spagnola la resistenza si affievolì via via. Ormai era
passato molto tempo dalla scomparsa del priscillianesimo e dei nuclei di ebrei e
mori che vivevano in abbondanza in quella regione. Filippo V, uomo di di grandi
ideali e di idee controverse, si interessò molto a quella regione e cominciò a
intrigare per sottrarla in qualche modo alla Spagna, nonostante tra i due paesi
di fosse una politica di amicizia e collaborazione. Allo scoppio della
Rivoluzione Francese egli cominciò a parlare apertamente dell'Adriàs come di una
terra irredenta e finanziò degli avventurieri che tentarono di sollevare la
regione contro il governo spagnolo.
L'era napoleonica e
il cambio di dinastia
Lo spregiudicato Filippo V sfruttò
la Rivoluzione Francese per attaccare militarmente la Spagna ottenendo
finalmente l'Adriàs, ma poco dopo fu assassinato in circostanze mai chiarite. Il
suo successore, il giovane Filippo VI, riuscì a destreggiarsi bene. Si alleò con
Napoleone per attaccare occupare il Portogallo grazie alla forza militare che
dimostrò riuscì a influire sulla debole politica spagnola. Questa politica ebbe
un esito fortunato, visto che Napoleone, con il fianco coperto dai suoi alleati
iberici, riuscì a far fronte anche alla disfatta in Russia e a trovare le forze
per vincere ancora a Lipsia contro la VI coalizione antifrancese. Nel 1830, le
insurrezioni a Parigi costrinsero il debole Napoleone II, manipolato dai
numerosi amanti della madre, ad abdicare, la popolazione acclamava a gran voce
il giovane principe Filippo del Listenburgo. Filippo VI, per non precludere al
figlio tale opportunità senza sconvolgere gli equilibri europei, decise di
modificare la legge di successione abolendo il privilegio maschile, e
successivamente abdicò. Suo figlio Filippo abdicò a sua volta, recandosi poi a
Parigi dove fu proclamato Imperatore di Francia. Il trono del Listenburgo passò
quindi a Maria, secondogenita di Filippo VI, che era sposata con il nobile
tedesco Leopoldo di Sassonia-Coburgo-Gotha. Leopoldo fu appunto il capostipite
dell'attuale casa reale listemburghese.
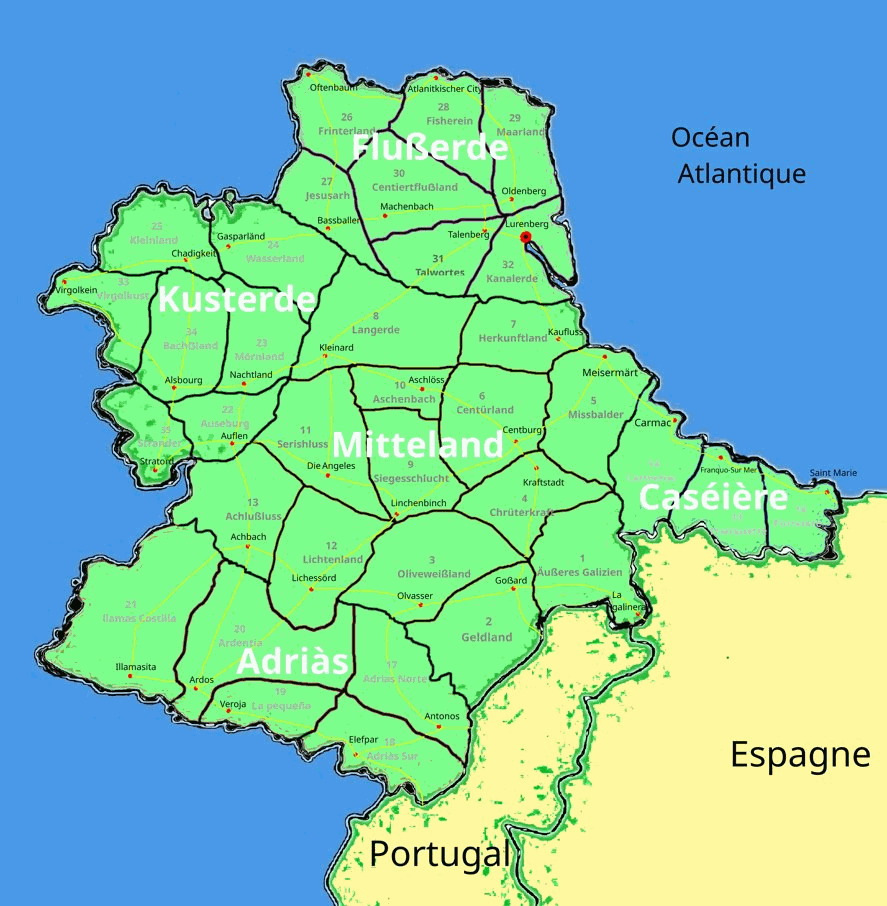
Il XIX secolo
il resto del XIX secolo fu per il
Listenburgo un periodo di pace e sviluppo economico. Re Leopoldo favorì la
nascita delle prime vere industrie, sfruttando le miniere di carbone e di ferro
che furono scoperte nel paese. La natura montuosa del territorio rese comunque
difficile e costosa la costruzione di ferrovie. In alcuni casi le montagne
furono sfidate con ponti e gallerie all'avanguardia per l'epoca. Nonostante lo
sviluppo industriale, molti listenburghesi decisero di emigrare oltremare,
dirigendosi in aree diverse a seconda della regione di provenienze. Gli abitanti
del cosiddetto "vecchio Listenburgo" (ossia il nucleo più antico del Ducato,
Flusserde, Kusterde e Mitteland) emigravano prevalentemente verso il Nordamerica,
mentre gli abitanti dell'Adriàs, che hanno come idioma regionale un dialetto
spagnolo, si imbarcavano prevalentemente per raggiungere l'America Latina. La
loro era, tra l'altro, un'emigrazione tradizionale, iniziata già nel corso dei
secoli precedenti, approfittando delle rotte già esistenti tra la Spagna e le
sue colonie. Il suo successore Leopoldo fu invece un sovrano ben poco amato.
Convinto che il Listenburgo dovesse possedere una colonia in Africa per essere
riconosciuto come un paese degno, fece occupare dei territori africani e vi
impiantò un sistema di sfruttamento crudele, per il quale i listenburghesi
esprimono ancora oggi vergogna.
Re Alberto III
Re Alberto III, successore dello
spregiudicato Leopoldo II, fu un sovrano amante del popolo e promosse riforme
che portarono il Listenburgo a diventare un paese democratico secondo il
concetto contemporaneo del termine. La nuova Costituzione stabilì un parlamento
federale, con la camera bassa (Landtag) dotata di ruolo preponderante e quella
alta (Bundesrat) per la coesione economica e culturale, visto che le regioni
dell'Adriàs e del Caséière sono ancora oggi eterogenee, avendo vissuto una
storia diversa per 2 o 3 secoli prima di unirsi al resto del paese. Re Alberto
si adoperò anche per la promozione dei diritti sociali per i lavoratori, le
donne, l'educazione, la salute. Il felice regno di Alberto ebbe fine quando, nel
1933, uno squilibrato di nome Adolf Hitler lo assassinò durante un incontro
pubblico. Durante l'interrogatorio, sembra che l'assassino abbia sbraitato frasi
deliranti, sostenendo che il Listenburgo non esistesse, che stava vivendo in un
incubo e che desiderava tornare al mondo reale, dove lui stesso sarebbe stato in
procinto di costruire un "Reich millenario". John Steinbeck, scrittore americano
premio Nobel per la letteratura nel 1962, scrisse proprio una storia fantastica
ambientata nel delirante mondo tratteggiato da Adolf Hitler. Nel suo romanzo,
l'Impero Francese non è sopravvissuto alla campagna di Russia, l'Europa ha
continuato ad autodistruggersi in guerre tra nazioni e Adolf Hitler è infine
arrivato al potere in Germania, portando con sé una ideologia politica
agghiacciante.
Da Re Leopoldo III ai
giorni nostri
Leopoldo III fu uno dei sovrani
promotori dell'Unione Europea, lo spazio di pace e collaborazione economica che
lega indissolubilmente i paesi del continente europeo. Promotore della
modernità, Leopoldo fu il primo monarca ad abbandonare gli abiti sfarzosi, ormai
anacronistici e a vestire come i borghesi. Liberalizzò poi i matrimoni dei
nobili, facendo sì che potessero sposare borghesi senza pregiudizio. Abolito
anche l'antico istituto giuridico del matrimonio morganatico, inviso alle
organizzazioni per i diritti umani Leopoldo fu anche il primo sovrano ad
apparire in televisione e in un'opera cinematografica.
Il Listenburgo ha vissuto gli ultimi anni sotto Re Alberto II, figlio e
successore di Leopoldo III. La grande importanza da sempre attribuita al tema
dell'istruzione ha permesso al paese di cogliere le opportunità della nuova
economia sostenibile e digitale, ponendosi all'avanguardia in Europa e nel
Mondo. Il Listenburgo si sta anche affermando come meta turistica, soprattutto
da quando sui social network ne è stata divulgata l'esistenza. E' sempre stato
in effetti un paese piuttosto difficile da raggiungere, per quanto sia sempre
stato lì, nel nordovest della Penisola Iberica, proprio dove finiscono Spagna e
Portogallo. Non vedere il Listenburgo è un bel problema, fa assomigliare un po'
di più il mondo a quello dove si sarebbero svolte ben due guerre mondiali…
Riepilogo dei sovrani del Listenburgo:
Duchi del Listenburgo:
Alberto I - 1525-1568
Alberto II - 1568-1618
Federico I - 1618-1632
Carlo I - 1632-1680
Carlo II - 1680-1685
Filippo I - 1685-1701
Filippo II - 1701-1723
Filippo III - 1723-1752
Re del Listenburgo:
Filippo III - 1723-1752
Filippo IV - 1752-1785
Filippo V - 1785-1793
Filippo VI - 1793-1830
Leopoldo I - 1830-1865
Leopoldo II - 1865-1909
Alberto III - 1909-1933
Leopoldo III - 1933-1983
Alberto IV - 1983-2013
Filippo VII - 2013-oggi.
.
Nel discorso si inserisce a questo punto Strataghemma:
Scusa, Bhrihskwobhloukstroy, ma mi sfugge il nesso causale fra presenza di un'ulteriore massa continentale ad ovest dell'Iberia (chiamiamola Atlantide) ed impero indoeuropeo. Perchè gli indoeuropei di Atlantide (celti? germanici? Storicamente sono loro due i più occidentali) dovrebbero avere più fortuna di quelli storici nel progetto di unità fino all'India (che credo che storicamente abbia raggiunto il punto più vicino al completamento con Alessandro Magno)?
.
Bhrihskwobhloukstroy non si fa pregare a rispondergli:
Se Atlantide avesse avuto più territorî abitati (questo fittizio era sommerso anche nel 9600 a.C. nella Realtà) avrebbe avuto più guerrieri (i numeri di Platone sono del tutto inverosimili per l’Epipaleolitico; sono paragonabile alla Wehrmacht nella Seconda Guerra Mondiale) e perciò avrebbe potuto vincere la resistenza di Atene, a quel punto – se stiamo alla rappresentazione che ne viene offerta – senza più ostacoli al proprio progetto geopolitico di sottomettere l’intera Europa e Asia (ovviamente quest’ultima da intendere secondo le conoscenze dell’epoca di Solone/Crizia/Platone)...
.
Prosegue serrato il dialogo a due:
Ma nel Paleolitico gli Indoeuropei in Europa neanche c'erano, e non credo ci fossero grandi Imperi in lotta fra di loro (non c'erano i presupposti di densità abitativa, gli Imperi son nati con l'Agricoltura, e gli Imperi delle Steppe sono una risposta agli Imperi Agricoli senza i quali non potrebbero esistere)...
.
Che in Europa non ci fossero gli Indoeuropei è un luogo comune, ma tutto da dimostrare. Non che per parte mia abbia la dimostrazione del contrario, però se non altro ci sono più indizi sulla loro presenza (oltretutto pressoché esclusiva, a parte gli Uralici e ovviamente le regioni di convenzionale confine col resto dell’Eurasia; che il basco sia indoeuropeo è invece, a mio modestissimo giudizio, dimostrato da una dozzina d’anni, anche se non risaputo) che il contrario (e comunque la ricostruzione delle postulate lingue non indoeuropee per ipotesi presistenti all’indoeuropeo ha un livello epistemologico spaventosamente più basso – al limite dell’apoditticità – che la ricostruzione dell’indoeuropeo e in gran parte è obiettivamente falsificata).
Ovviamente non c’erano Imperi, ma un collegamento fra Comunità Politiche anche su grandi estensioni è del tutto possibile anche presso i Cacciatori-Raccoglitori ed è questo che basta...
.
Beh, sì, i rapporti commerciali o di matrimonio (in continuum da una Tribù all'altra ovviamente, nessuno si sposta fisicamente da un lato all'altro dell'Eurasia ma funziona come un'enorme gioco del telefono senza fili) esistevano certamente anche nel Paleolitico, e ne abbiamo le prove. Ma come si riverserebbe questo in un impero indoeuropeo dopo l'urbanizzazione e le sue conseguenze a livello di frammentazione linguistica? Non credo che l'identità comune indoeuropea sarebbe potuta sopravvivere una volta che parte il processo di creazione delle identità nazionali ad uso e consumo degli stati...
.
Dipende dalla persistenza o meno dei fattori che storicamente hanno frantumato l’unità indoeuropea (altrimenti questo potrebbe tranquillamente sussitere come continuità territoriale). Il più importante di questi, in base alla diffusione areale delle mutazioni linguistiche, risulta con epicentro in Mesopotamia ed è chiaramente da identificare col prestigio del sumerico e poi dell’accadico (da cui a catena tutti gli altri processi di rottura dell’unità indoeuropea, a parte il tocario, che ha risentito invece degli equilibrî in Cina, a loro volta comunque non predeterminati verso il solo esito che hanno storicamente avuto).
I collegamenti interni a tutta l’Indoeuropa, che sono dimostrabili fino al Calcolitico (innovazioni terminologiche comuni – come provato dalla fonetica storica – in un’epoca in cui le popolazioni di lingua indoeuropea dovevano già essere nelle Sedi storiche, in base all’evidenza genetica elementare ossia che non ci sono state immigrazioni successive), avrebbero come minimo permesso alle tradizioni indoeuropee mesopotamiche (il cosiddetto “eufratico”) di non essere fagocitate dal sumerico e dall’accadico e questo sarebbe bastato a preservare l’anello di congiunzione fra indoeuropeo d’Europa (+ Anatolia) e d’Asia, in pratica conservando l’intera Indoeuropa come nella Storia vera è accaduto all’enorme area residuale del celtico (che in gran parte non è stata il portato di espansioni protostoriche – eccettuati ovviamente i Galati dell’Europa Orientale e d’Anatolia – ma la persistenza di comunità preistoriche sul posto, senza particolari innovazioni a parte alcune molto banali ed esse stesse in gran parte comuni a due terzi dell’Indoeuropa).
A questo punto, prima o poi i movimenti che nella Storia hanno portato all’Impero Persiano non avrebbero avuto limiti ‘etnici’ fino agli estremi dell’Indoeuropa.
.
Se prendiamo per buona la teoria della trasmissione patrilineale della lingua, per cui le madri insegnano ai figli la lingua dei mariti, teoria supportata dal fatto che la diffusione delle lingue si sovrappone meglio alla diffusione degli aplogruppi del cromosoma Y (patrilineali) rispetto alla diffusione di quelli mitocondriali (matrilineali). Nella visione tradizionale (quella che tu chiami luogo comune) della diffusione delle lingue indoeuropee queste sarebbero proprie dei maschi R1, delle donne a loro legate da legami di parentela, e delle popolazioni da questi sottomesse (i maschi I, J, ed altri presenti sul continente europeo). Nella tua visione nel Paleolitico già si parlava indoeuropeo, quindi la lingua "tradizionale" delle comunità di maschi I e J è l'indoeuropeo.
La prima criticità è che
la lingua tipica dei maschi J fuori dall'Europa è il Semitico e non certo
l'Indoeuropeo, da cui derivano le teorie secondo le quali gli agricoltori
europei pre-yamnaya (prevalentemente maschi J) parlavano lingue para-semitiche
(più imparentate al semitico che ad altro).
La seconda criticità è che siccome i maschi R1 sono indubitamente di lingua
indoeuropea, dobbiamo estendere questa loro "indoeuropeicità" fino ai maschi I
L'ultimo antenato comune di maschi I e maschi R1 è IJK, quindi la lingua
Ancestrale (che nella tua visione sarebbe indoeuropeo antichissimo, o sbaglio?)
sarebbe propria di tutti i maschi discendenti da IJK.
Ciò includerebbe fra gli altri gli uralici (tipicamente N) i sino-tibetani i
turanici e gli austronesiani (tipicamente O) e i denè-yeniseyani con tutti gli
altri nativi americani (tipicamente Q) nella nozione di "indoeuropei" a meno di
non creare per loro tante eccezioni alla regola generale (che in realtà è una
correlazione, ma vabbè) della coincidenza fra aplogruppi patrilineali e lingue
parlate.
Mi scuso in anticipo per eventuali erramenti nel mio ragionamento...
.
Comincio dalle «criticità»:
1) la lingua del capostipite degli Aplogruppi Ie J (chiamiamolo “il signor IJ”, anche se sembra un olandese trasposto nella Preistoria) è comunque un motivo di controversia, perché praticamente tutti i portatori di I sono di lingua indoeuropea (dagli Scandinavi ai Sardi; questi ultimi rappresentano naturalmente gli eredi dei Paleosardi, per cui il punto cruciale nello specifico riguarda l’affiliazione del paleosardo o delle lingue dei Paleosardi e, in mancanza di attestazioni dirette incontrovertibili, la toponomastica presenta un quadro tale da suggerire fortemente anzitutto una varietà indoeuropea occidentale assimilabile a un celtico arcaico e in aggiunta un’altra varietà molto vicina all’italico perlomeno a livello di fonologia diacronica), mentre i portatori di J sono in assoluta maggioranza Semiti, ma in Anatolia rappresentano – in mancanza di altri candidabili a rivestire tale ruolo – gli eredi di lingue variamente affiliabili ma di certo non semitiche e comunque in grande maggioranza sicuramente indoeuropee (appunto anatoliche in senso stretto). In breve, il signor IJ è l’antenato di quasi tutti i Semiti, ma al contempo la maggior parte dei suoi discendenti sono gli Anatolici, i Paleosardi e altri Indoeuropei, soprattutto Germani e Slavi (compresi gli abitanti premagiari dell’Ungheria).
Come interpretare questi dati di fatto?
A) Erano tutti Semiti (in pratica gli Agricoltori Neolitici) e in Europa hanno lasciato traccia in toponimi di etimo semitico (questa è la celebre tesi di Theo Vennemann gen. Nierfeld);
B) Erano Semiti e Indoeuropei (gli stessi Agricoltori Neolitici) e in Europa erano tutti indoeuropei (questa è l’ancora più famosa tesi di Sir Colin Renfrew; i toponimi semitici secondo Vennemann andrebbero di conseguenza interpretati come indoeuropei, secondo l’analisi tradizionale);
C) Il Signor IJ parlava l’antenato di indoeuropeo e semitico e i suo discendenti ne hanno fatto rispettivamente l’indoeuropeo e il semitico.
Quel che posso argomentare di persona in modo indipendente è che la toponomastica ritenuta semitica da Vennemann è più ragionevolmente indoeuropea, caso per caso.
2) Dalla scelta fra le tre precedenti alternative (A-B-C) deriva quella per risolvere la seconda «criticità» (che si potrebbe rivelare un punto di forza). È infatti evidente che il Signor IJK (antenato del Signor IJ) ha avuto come discendenti tutti i locutori delle lingue delle famiglie sopra elencate (dalla quasi totalità degli Indoeuropei – compresi soprattutto i portatori di R – ai già citati Semiti a tutti i Cinesi, Polinesiani, Uralici, Altaici e la stragrande maggioranza degli Amerindi, fino addirittura ai Neoguineani e agli estinti Tasmaniani). Questo è, a prescindere dalla maggiore o minore compatibilità fra le varie ipotesi interpretative, uno dei più forti argomenti a favore dell’idea che tutte queste famiglie linguistiche siano genealogicamente apparentate. Altrimenti formulato, ciò significa che il Signor IJK (vissuto verso la fine del Paleolitico Inferiore, ca. 57˙000-47˙000 a.C.) parlava con ogni verosimiglianza la protolingua da cui derivano tutte queste famiglie linguistiche e si tratta di un’ipotesi assolutamente compatibile con tutto quello che possiamo immaginare per tale altezza cronologica.
Da qui ritorniamo al Signor IJ (vissuto in un arco di tempo compreso fra il 47˙700 e il 42˙600 a.C., presumibilmente fra il Mar Nero e il Mar Caspio, all’epoca comunicanti). Come già constatato, i suoi discendenti sono tutti i Semiti, ma in proporzione maggiore sono ed erano già nella Protostoria indoeuropei. Le tre ipotesi viste al punto precedente si traducono nelle seguenti interpretazioni:
A) il Signor IJ parlava protosemitico e la maggioranza dei suoi discendenti ha cambiato lingua, passando all’indoeuropeo preistorico o a qualche protolingua secondaria da questo derivata;
B) il Signor IJ parlava l’antenato dell’indoeuropeo e del semitico e i suoi discendenti ne hanno sviluppato da un lato l’indoeuropeo (insieme ad altri discendenti di IJK, fra i quali il Signor R [del Cromosoma Y] vissuto poco più a Est venti millenni più tardi) e dall’altro il semitico;
C) coincide con B).
Per comprendere le ipotesi B-C, con “antenato dell’indoeuropeo e del semitico” bisogna intendere una ‘protolingua da cui derivano sia l’indoeuropeo sia il semitico’, ma non per forza solo queste due famiglie (che infatti non rappresentano un nodo genealogico esclusivo, essendo invece apparentate perlomeno anche col caucasico meridionale, l’uralico, l’altaico e il drāviḍico [elamo-drāviḍico] da un lato, col caucasico settentrionale, lo jenisejano e l’amerindio dall’altro). Naturalmente, la questione più delicata è il rapporto genalogico fra questo insieme di famiglie linguistiche e la macrofamiglia austrica (che comprenderebbe sia il sino-tibeto-birmano sia l’austronesiano) e su questo la discussione è apertissima; ai nostri fini, però, il punto cruciale è: chi ha sviluppato l’indoeuropeo preistorico? La risposta obbligata, date le premesse, può essere soltanto: una comunità di Discendenti di IJK che includeva, al proprio interno, sia alcuni Discendenti di IJ sia alcuni Discendenti di K (in particolare il Signor R [del Cromosoma Y], ma anche molti Discendenti del Signor L [del Cromosoma Y]) e pure alcuni Discendenti di G (che dunque non hanno IJK fra i proprî antenati, ma solo il comune progenitore GHIJK, vissuto prima del 46˙500 a.C. e che parlava una lingua sostanzialmente simile a quella del Signor IJK). La differenza fra mutazioni genetiche e mutamenti linguistici è infatti che le prime sono strettamente individuali, mentre le seconde sono per definizione condivise da una comunità e che questa comunità sia geneticamente omogenea è solo un’eventualità (statisticamente neppure maggioritaria); nelle ipotesi B e C (che qui coincidono), la comunità che ha elaborato i mutamenti all’origine dell’indoeuropeo preistorico doveva essere relativamente eterogenea a livello genetico (ossia comprendere Discendenti di G, H, IJ e K; tralascio F, ma l’impostazione sarebbe analoga). Questo scenario è evidentemente del tutto ipotetico, ma di certo non presenta alcuna criticità intrinseca: è una ricostruzione affatto plausibile. Non è dimostrata, ma neppure si confuta da sé.
L’alternativa rimane allora fra A e B-C (che possiamo, per semplicità, chiamare B e basta). Il contrasto specifico è:
A) i Discendenti del Signor I e una parte di quelli del Signor J hanno sostituito la propria lingua protosemitica con l’indoeuropeo preistorico o una protolingua secondaria da questo derivata;
B) i Discendenti del Signor I (vissuto fra il 40˙900 e il 25˙500 a.C., presumibilmente in Europa) e una parte di quelli del Signor J (vissuto fra il 40˙900 e il 29˙500 a.C. fra il Caucaso, l’Anatolia e il Mediterraneo Orientale) facevano parte della comunità che ha elaborato l’indoeuropeo preistorico.
Lo scenario B è non solo simile, ma identico a quello appena visto in relazione all’origine dell’indoeuropeo, che dunque si collocherebbe fra Europa, Caucaso, Anatolia e Levante nel Paleolitico Superiore.
Possiamo quindi ridurre l’opposizione fra A e B in questi termini: per A il Signor IJ e i suoi discendenti (fino al Neolitico) non hanno mai parlato alcuna forma di indoeuropeo, dopodiché la maggior parte di questi lo ha adottato abbandonando la propria ancestrale lingua (proto)semitica, mentre per B semplicemente non esiste alcuna di queste restrizioni (ossia: IJ parlava un antenato dell’indoeuropeo e del semitico – detto convenzionalmente “nostratico” – e una parte maggioritaria dei suoi discendenti ha preso parte all’elaborazione dell’indoeuropeo) e in compenso non c’è bisogno di postulare una sostituzione linguistica di massa in Anatolia ed Europa. In termini astratti, A ha due postulati in più rispetto a B: niente di risolutivo (entrambe le ipotesi restano verosimili), semplicemente le mette in una gerarchia di complessità che forse in prima approssimazione non risultava evidente.
È chiaro che i postulati in più hanno bisogno di indizi. Per il primo non saprei quali immaginare (quale lingua parlasse il portatore di una mutazione genetica è un problema irresolubile in sé e per sé) e quindi temo che sia destinato a rimanere puramente speculativo; per il secondo invece l’indizio invocato dagli stessi Sostenitori dell’ipotesi sono appunto le tracce semitiche in Europa e su qui si può discutere concretamente: come detto, a questo livello – in cui valgono le considerazioni glottologiche – ho motivo di ritenere che le etimologie indoeuropee dei dati linguistici in esame siano sistematicamente superiori a quelle semitiche, ma resterò sempre a disposizione per trattarne nello specifico.
.
C'è spazio anche per il contributo di Dario Carcano:
Secondo voi chi uccise Edoardo V d'Inghilterra e suo fratello Riccardo, entrambi figli del re Edoardo IV e della regina Elizabeth Woodville, i cosiddetti "Principi nella Torre"?
La storia dei due principi
nella torre è tanto affascinante quanto misteriosa, perché sappiamo pochissimo
su cosa sia successo durante la cattività dei due principi; inoltre il fatto che
siano passati sei secoli dai fatti non aiuta a dissipare le molte bugie che
probabilmente sono state dette su questa vicenda, sia da parte yorkista che da
parte tudoriana.
Anche per questo i due principi Edoardo e Riccardo sono un leitmotiv nella
storia alternativa made in England, il PoD su cui l'inglese medio ha speculato
almeno una volta nella sua vita, anche se non sa cosa sia una ucronia...
Le uniche cose certe in
questa storia sono che nel 1483 i due principi sono stati confinati nella torre
di Londra dal loro zio, il principe Riccardo, duca di Gloucester; che poco dopo
questo confinamento sono stati dichiarati frutto di una unione illegittima e
quindi esclusi dalla successione (permettendo al duca di Gloucester di ascendere
al trono come Riccardo III), e che dal quel momento in poi sono stati visti
sempre meno fino a sparire del tutto.
Sappiamo anche che nel 1490, cinque anni dopo la sconfitta del partito yorkista
e l'inizio del regno di Enrico VII, apparve in Francia un tale che sosteneva di
essere il principe Riccardo di Shrewsbury, appunto uno dei due principi nella
torre, e che molte persone riconobbero in lui tratti di Edoardo IV e anche degli
scomparsi principi nella torre; questo Riccardo sarà supportato da vari sovrani
europei nella sua rivendicazione al trono inglese, ma sarà sconfitto e catturato
da Enrico VII, che sotto tortura gli farà confessare di essre Perkin Warbek, un
fiammingo figlio di un funzionario di Tournai, che aveva appreso l'inglese
lavorando al seguito di un mercante di stoffe.
Nel 1674 durante degli scavi nella torre di Londra furono trovati due scheletri
di bambini, che saranno attribuiti ai due principi e sepolti a Westminster per
volontà di re Carlo II; tuttavia non saranno gli unici scheletri rinvenuti nella
torre, e nei secoli successivi si susseguiranno numerose le richieste di
ulteriori scavi, specialmente nelle cripte dei sovrani York, in cerca di
sepolture che possano essere quelle dei due principi.
Piccola nota a margine: la
prima stagione della serie comica "Blackadder" - trasmessa dalla BBC nel 1983 -
ha come premessa che Enrico VII abbia riscritto la Storia, facendo passare
l'idea che lui abbia vinto la battaglia di Bosworth e Riccardo III abbia ucciso
i suoi due nipoti, mentre in realtà Riccardo fu uno zio amorevole e Enrico VII a
Bosworth fu sconfitto dagli yorkisti, e che dopo questa battaglia e la morte di
Riccardo III sia stato il nipote di lui, Riccardo di Shrewsbury, a succedergli
al trono come Riccardo IV, il cui regno poi è stato condannato ad una damnatio
memoriae una volta che Enrico VII ha preso il potere, e cancellato dai libri di
Storia.
La serie nella prima stagione segue le vicende del secondogenito di Riccardo IV,
il principe Edmund "the Blackadder" (interpretato da un giovane Rowan Atkinson),
che ordirà un sacco di trame per impossessarsi del trono. Trame che però gli si
ritorceranno sempre contro a causa della sua stupidità.
.
Aggiungiamo l'ucronia di Alessio Borrelli:
Papa Innocenzo VIII, in conflitto con Ferdinando I di Napoli a causa del mancato pagamento da parte di quest'ultimo delle Decime Ecclesiastiche, aveva scomunicato il Re di Napoli con una bolla dell'11 settembre 1489, offrendo il regno al sovrano francese Carlo VIII; nonostante nel 1492 Innocenzo, in punto di morte, avesse assolto Ferdinando, il regno rimase un pomo della discordia lanciato nelle politiche italiane. A questo si aggiunse la morte, quello stesso anno, di Lorenzo de' Medici, Signore di Firenze e perno della stabilità politica tra gli stati regionali. Pacificati i rapporti con le potenze europee, Carlo VIII, che vantava attraverso la nonna paterna, Maria d'Angiò, un lontano diritto ereditario alla corona del Regno di Napoli, indirizzò le risorse della Francia verso la conquista di quel reame, incoraggiato inizialmente da Ludovico Sforza, detto Il Moro (che ancora non era Duca di Milano ma ne era solo reggente) e sollecitato dai suoi consiglieri.
Ma è a questo punto che la storia cambia. Papa Alessandro VI, al secolo Rodrigo Borgia, eletto al trono pontificio nel 1492, ha un piano preciso per la politica italiana. Sa perfettamente che nessuno dei vari stati italiani è abbastanza forte da poter sottomettere gli altri, di certo non lo Stato della Chiesa, ma abbastanza debole da soccombere alle grandi monarchie nazionali che si sono sviluppate in Spagna e Francia, o al Sacro Romano Impero. Non di meno non aveva abbandonato il suo sogno di influenzare e guidare la vita politica della penisola. Egli temeva, inoltre, che la discesa del Re di Francia e la conquista del napoletano potesse limitare il campo d'azione del Papato sia in campo politico sia religioso. Si fece quindi difensore del re di Napoli, che tanto a lungo aveva lottato col suo predecessore, Innocenzo VIII. Il 7 maggio, tramite il suo legato a Napoli, cardinale Juan Borgia, fece incoronare Alfonso II re di Napoli e rammentò come ormai ritirata la scomunica lanciata da Innocenzo VIII sul regno partenopeo. Carlo VIII, giudicando un affronto queste iniziative del Papa e incitato dal nemico mortale di questi, il Cardinale Giuliano della Rovere, scese in Italia alla testa del suo esercito, il 3 settembre 1494. A questo punto Alessandro VI agì con sorprendente energia. Dopo aver scomunicato Carlo VIII per essere penetrato nella penisola con intenti bellicosi contro lo Stato della Chiesa e contro nazioni cattoliche, riuscì a portare la maggior parte delle signorie italiane dalla sua parte, rievocando la Lega Italica.
Riuscì a portare dalla sua parte Ludovico il Moro, assicurandogli l'appoggio papale per la futura elezione a Duca di Milano e facendogli realizzare che le pretese di Carlo VIII si sarebbero presto dirette contro la Lombardia. Col ducato di Milano si avrà anche l'adesione della Repubblica di Genova alla lega. Riuscì a portare nella Lega Venezia, anch'essa preoccupata dall'espansionismo francese. Mandò il Cardinale Giovanni de' Medici a consigliare il debole Piero de' Medici, che garantirà alla lega il suo appoggio alla Lega (altra missione del cardinale Giovanni e quella di organizzare l'omicidio del frate Savonarola). Riuscì infine a convincere il consiglio di reggenza del giovane duca Carlo Giovanni Amedeo di Savoia a dichiarare la propria appartenenza alla Lega Italica, unico modo per liberarsi del vassallaggio che ormai la Francia aveva imposto sulle terre savoiarde.
Sul versante interno, Alessandro VI riesce a far arrestare ed imprigionare Giuliano Della Rovere (che muore poco dopo in carcere in circostanze mai chiarite), quindi procede alla scomunica e alla repressione della famiglia Colonna con la scusa di essere in combutta col cardinale traditore ed i Francesi con l'aiuto delle truppe napoletane dirette verso nord.
L'11 settembre 1494 si ha, ad Asti, una prima battaglia tra le truppe francesi penetrate nel Piemonte e le truppe savoiarde. Queste ultime vengono sconfitte e a più riprese costrette a ritirarsi ma danno ai membri della Lega Italica il tempo di riunirsi sotto il comando di Francesco II Gonzaga, marchese di Mantova ed il cardinale Cesare Borgia.
Il 2 maggio 1495 la flotta francese si scontra con quella genovese nella battaglia navale di Rapallo. Lo scontro avvenne all'alba, e fu una sconfitta totale per i francesi: tutte le navi vennero catturate, e, contemporaneamente, a terra, un contingente di truppe sbarcate dalla flotta genovese al comando di Gian Ludovico Fieschi e Giovanni Adorno, aiutati dai Rapallini, sbaragliarono i transalpini rimasti a terra prendendo il controllo dell'abitato. Il successo ottenuto venne incrementato pochi giorni dopo quando un convoglio di dodici velieri venne catturato nelle acque di Sestri Levante. Nel frattempo Carlo riesce a passare, grazie alla forza delle sue artiglierie e a i mercenari svizzeri attraverso il Piemonte, dirigendosi verso il ducato di Ferrara, unico alleato rimastogli in Italia. I racconti delle grandi stragi perpetrate da Carlo VIII e delle potenti armi al seguito delle sue armate (fu la prima volta che in Italia furono usate le artiglierie) riscossero grandi timori nelle corti italiane. Per la prima volta, oltre alle truppe mercenarie, vennero schierate da parte delle signorie italiane anche un gran numero di leve popolari (queste, contrariamente alle truppe mercenarie, non diserteranno in gran numero all'intensificarsi della battaglia). Sul campo si scontrarono circa 10.000 francesi (tra cui un piccolo contingente di Ercole I d'Este di Ferrara) e circa 30.000 italiani (in HL furono circa 12.000 tra lombardi e mercenari veneti, ma qui vanno aggiunti l'esercito napoletano e papalino che non erano stati sconfitti dalla discesa di Carlo verso Napoli, fiorentini e i resti delle forze sabaude, oltre alle leve popolari). In questa HL la battaglia è altrettanto sanguinosa ma porta al completo annientamento delle forze francesi, oltre alla cattura di Carlo VIII. Questo farà atto di costrizione dinanzi a Papa Alessandro VI è prometterà (dietro il pagamento di un grosso riscatto) di non mettere mai più piede in Italia.
Carlo fece ritorno a capo chino in Francia. Ma per l'Italia le conseguenze furono altrettanto catastrofiche. Ora l'Europa intera sapeva, tramite i soldati francesi e tedeschi, che l'Italia era una terra incredibilmente ricca e facilmente conquistabile perché divisa e difesa quasi esclusivamente da mercenari.
Conscio di questo, Alessandro VI si prodigò affinché la Lega italica rimanesse in piedi, onde difendere la penisola dai futuri attacchi stranieri.
Il Papa era stato un facile profeta. Luigi XII, successore di Carlo VIII, cercò di riprendere là dove il suo predecessore aveva fallito. Conscio però del potere che con la precedente guerra della Lega Italica Papa Alessandro VI aveva guadagnato in Italia, il re francese cercò dapprincipio un approccio con Rodrigo Borgia. Nel 1499 il sovrano francese promise al Papa l'impegno di appoggiare il figlio Cesare Borgia nel suo progetto di conquista della Romagna oltre alla concessione del Ducato di Valentinois. Il messo francese comunicò pure l'intenzione di acquisire il ducato di Milano, cercando l'appoggio di Venezia a cui avrebbe concesso Cremona e la Ghiara d'Adda. Nel frattempo il regno di Napoli sarebbe stato spartito tra la Francia e Aragona. Pur trattandosi di offerte allettanti, Alessandro VI sa qual'e il peso che ha ottenuto nella penisola dopo la sconfitta di Carlo VIII. Sa inoltre di poter mettere le mani sulla Romagna con l'aiuto della Lega stessa, così come sa bene che difficilmente quei territori potranno rimanere nelle mani della sua famiglia con una presenza così massiccia di Francia e Spagna nello stivale. Così, mentre rabbonisce Luigi XII mostrandosi possibilista e prendendo tempo, riconferendo alla corona di Francia il titolo di "Maestà Cristianissima" (titolo revocato a Carlo VIII), Papa Borgia prende contatti coi veneziani. Se da un lato svela ai veneziani le proposte francesi (ed, in effetti, questi non ne rimangono impassibili) dall'altro li invita a riflettere: meglio avere alle porte il ducato di Milano, per quanto i rapporti tra i due non siano mai stati idilliaci, che il forte regno di Francia, la cui fame non si sarebbe certo placata. Prima o poi i francesi avrebbero guardato con appetito anche alla ricca Venezia. Papà Rodrigo promise in fine a Venezia, per il suo appoggio nella guerra a venire, future compensazioni nel ducato di Ferrara, che non aderiva alla Lega Italica.
Una volta ottenuta l'adesione di Venezia, Papa Alessandro avvisò il duca di Milano e il re di Napoli dell'imminente guerra. Nel 1499 c'è il secco rifiuto del Papa e di Venezia ad allearsi con Luigi XII. Questa veniva accompagnata dall'ammonizione a scendere in Italia in armi come fece Carlo VIII e all'annuncio di chiamata alle armi della Lega Italica, a cui aderivano Ducato di Savoia, Ducato di Milano, Repubblica di Genova, Repubblica di Venezia, Marchesato di Mantova, Signoria di Firenze, Stato della Chiesa e Regno di Napoli. Penetrato in Lombardia passando per la Svizzera Luigi XII, alla testa di un'armata composta da svizzeri e francesi, si scontra a Milano, il 2 settembre 1499 con le truppe della Lega, composte da Venezia, Milano, Savoia, Mantova e Firenze. L'esito è infausto per il re francese è solo le truppe svizzere gli consentono di ritirarsi in territorio elvetico e di sfuggire alla cattura.
Nel frattempo, in seguito all'accordo segreto di Granada, l'11 novembre 1500 truppe aragonesi attraversarono le stretto di Messina, sbarcando in Calabria. Qui vennero affrontate dalle truppe napoletano-papaline guidate da Cesare Borgia che ha appena assunto Leonardo da Vinci come architetto ed ingegnere militare. Cesare Borgia riesce a respingere l'attacco aragonese, infliggendo loro una dura sconfitta a Barletta (La Disfatta di Barletta) mentre una flotta mista veneto-genovese costringe i legni spagnoli a ritirarsi nei porti siciliani.
Il 31 gennaio 1502 fu siglata la Pace di Genova con cui, ancora una volta la Francia si impegnava a riconoscere come inviolabili i confini col ducato di Savoia e col papato (Avignone) e a tenersi fuori dagli affari italiani, mentre venivano riconosciuti come possedimenti aragonesi la Sicilia è la Sardegna è veniva sancita la divisione tra le casate aragonesi di Spagna e Napoli.
Alla fine della guerra, con la motivazione ufficiale di festeggiare, seppur in ritardo, il giubileo del 1500 e la vittoria conseguita dalla Lega Italica, Rodrigo Borgia invita in San Pietro i suoi alleati. Sono presenti in Vaticano: Papa Alessandro VI e suo figlio, il cardinale Cesare Borgia; il figlio del duca di Savoia Carlo (futuro Carlo II), Lorenzo, figlio di Piero, de' Medici, signore di Firenze; Ferdinando d'Aragona, duca di Calabria ed erede al trono di Napoli; Ludovico il Moro, signore di Milano, il Doge di Venezia Leonardo Loredan. Oltre ai festeggiamenti di rito per la vittoria contro i franco-aragonesi Papa Alessandro VI espone loro il motivo di quella riunione. Quello che il Borgia ha in mente è una risistemazione dei confini italiani che porti alla scomparsa dei piccoli e sparuti territori a vantaggio dei membri della Lega Italica. I signori della Lega dovranno inoltre firmare un trattato di alleanza perpetua, impegnando l'onore delle proprie casate per le generazioni a venire, giurando di risolvere sempre con la diplomazia e nel concerto di tutte le signorie alleate e di difendersi vicevolmente da minacce straniere.
Queste le decisioni prese da quella che sarà ricordata negli annali come i "Patti Lateranensi":
Il Ducato di Savoia aveva diritto di inglobare nei suoi possedimenti il Marchesato di Saluzzo, il marchesato di Monferrato, il marchesato di Ceva, la contea di Tenda e la contea d'Asti.
Al Ducato di Milano veniva riconosciuto il diritto di espandersi nei territori tirrenici del ducato di Ferrara (Reggio e Modena) mentre la Repubblica di Genova poteva impossessarsi del Marchesato di Massa.
Ducato di Toscana: in quest'occasione i medici ricevevano il titolo di Duchi di Toscana e veniva loro riconosciuto il diritto di impossessarsi delle Repubbliche di Siena, Lucca e Piombino.
La Repubblica di Venezia (dopo aver annesso nel 1500 la contea di Gorizia, già rivendicata dall'Austria, grazie a una bolla papale di Alessandro VI) si vedeva garantito il diritto di espandersi nei territori adriatici del Ducato di Ferrara, alleato storico della Francia (si supponeva, a ragione, che la Francia dopo le due sconfitte subite nelle guerre italiane e gli enormi costi sostenuti non sarebbe intervenuta).
Veniva inoltre garantita dal Papa il futuro appoggio della chiesa per l'annessione del Vescovato di Trento (la cui nomina doveva però tornare sotto egida papale) Lo Stato della Chiesa si sarebbe esteso sulle coste dell'Adriatico fino alla Romagna (inglobando sino alla linea Bologna-Imola-Faenza-Ravenna). Papa Alessandro stabiliva in questa sede che il titolo di duca di Romagna sarebbe spettato al figlio Cesare una volta svestiti gli abiti talari e che, pur sottoposto al governo papale, a questo e ai suoi discendenti sarebbe rimasto.
Infine al Regno di Napoli (che aveva da poco acquisito grazie alla Lega la sua completa indipendenza dall'Aragona) sarebbero state cedute, in cambio dell'aiuto delle sue truppe, le città di Benevento e Pontecorvo dal Papa e i porti di Bari, Brindisi e Otranto (sui quali però la Serenissima manteneva intatti tutti i suoi diritti, compreso quello di avere negli stessi propri uomini d'arme). Veniva lasciato intatto, vista la sua passata e probabile futura adesione alla lega il territorio del Marchesato di Mantova. In questa stessa sede veniva deciso anche di convocare una riunione futura per decidere l'eliminazione di dazi e gabelle interne ed esterne (limitatamente ai mercanti dei vari stati della lega) e la fissazione dei tassi di cambio delle varie monete del regno. Quanto deciso dai patti lateranensi venne approvato dai signori lì convenuti e si diedero inizio ai preparativi per le future guerre italiane.
.
Per farci sapere che ne pensate, scriveteci a questo indirizzo.
