di Iacopo
L'ultima vera occasione che l'Impero d'Oriente ebbe per coronare il suo progetto geopolitico fu durante il regno di Giustiniano: già con Eraclio la vittoria può essere solamente militare. Giustiniano tuttavia voltò le spalle al progetto di assimilazione della Persia. Io credo che lo fece per un chiaro progetto politico, portando avanti gli interessi dei cristiani del Levante e dell'Egitto (gli stessi interessi che un secolo e mezzo dopo avrebbero portato al sorgere del Califfato): credo che Bisanzio fosse contesa fra una fazione costantiniana, teodosiana e leonina, compiutamente imperiale, cattolica e ellenistica, e varie tensioni contrarie all'espansione dell'impero (o meglio, alla creazione di un impero incentrato sul Levante), che si esprimevano con il monofisismo e l'arianesimo (strumenti volti ad impedire la pace in occidente).
Mi pare di vedere i segni della lotta fra le due correnti fin dalla conquista romana del mondo ellenistico: la nascita del cristianesimo basato in Anatolia, la contromossa levantina portata avanti da Elagabalo, Aureliano e infine da Ario, la definitiva presa del potere da parte dei greci all'epoca di Costantino, e la continuazione del piano di integrazione dei Goti sotto Teodosio e Flavio Ezio, nonché il tentativo, portato avanti da Agostino, di strappare l'Africa agli eresiarchi alessandrini, e così via.
Sono certo che Giustiniano, in quanto monofisita e tutto sommato persofilo, fosse un esponente della corrente che chiamo levantina.
Come impedire che queste tensioni rallentino troppo l'impero? Credo ci siano due pod utili: la morte di Anastasio I e la rivolta del Nika.
Nel primo caso, avremmo una successione diversa da quella, guidata dalle eminenze grigie monofisiste, che portò sul trono Giustino. Nel secondo caso Giustiniano viene deposto, verosimilmente sale al torno Flavio Pompeo, e la strategia bizantina cambia del tutto.
532: la rivolta del Nika rovescia l'imperatore Giustiniano. Flavio Pompeo, monofisista moderato sposato ad una cattolica, sale sul trono. Il suo primo atto è firmare la pace coi Sasanidi di Kavadh, per evitare altre sconfitte sul fronte più delicato dell'impero.
535 / 562: con il pretesto di reinsediare i figli di Teodora e Giustiniano sul trono, i Persiani invadono la Siria e l'Armenia Romane. Flavio Pompeo e Belisario conducono la controffensiva, e infliggono una dura sconfitta ai generali sassanidi alle porte di Antiochia. Mentre Flavio rimane in città, per assicurarsi che i monofisiti levantini non facciano brutti scherzi, Belisario varca l'Eufrate e si impossessa di Carre, Maida e Nisibide. La guerra procede per molti anni sui passi montani in Armenia e più a nord, mentre in Mesopotamia gli eserciti bizantini riescono a saccheggiare Seleucia e a deportarne la popolazione. Infine, la pace viene firmata: il confine bizantino è spostato ad est, l'alta mesopotamia passa sotto l'autorità dell'impero e viene affidata a Belisario, mentre l'Albania diviene indipendente ed è insediata dagli Alani.
535: in Italia, Teodato fa deporre e assassinare la regina Amalasunta e diviene re dei Goti: nel giro di pochi anni il regno piomba nel caos, fra pretendenti e signorotti. Intanto Narsete, il diabolico eunuco armeno, riesce a far deporre il monofisita Teodosio dalla cattedra di Alessandria, e scompagina le fila della fazione monofisita con i suoi mezzi poco ortodossi. I levantini impiegheranno anni per riprendersi dal duro colpo inflitto dalle spie bizantine.
538: Narsete è inviato con un manipolo di uomini a prendere possesso della Sicilia, dove la Guerra Civile Gotica ha lasciato un vuoto di potere.
541: i Bulgari compaiono sul Danubio, saccheggiando la Mesia e parte della Tracia. Il regno Ostrogoto è riunificato da Totila, che però deve vedersela con gli intrighi e le divisioni disseminate dall'Esarca di Sicilia Narsete.
548: Re Antalas dei Berberi, dopo una campagna di vent'anni, sconfigge definitivamente i vandali e fonda il Regno dei Mori.
550: sobillati dagli Eruli alleati di Narsete, i Longobardi calano in Italia ponendo fine al regno Ostrogoto.
552: il regno dei Gepidi è distrutto dagli Avari che si stanziano in Pannonia.
565: Flavio Pompeo muore di vecchiaia, gli succede il figlio Giovanni. Gli Avari attaccano i Balcani.
572: a causa dell'alleanza fra i Romani e i Turchi, scoppia di nuovo la guerra con la Persia.
573: gli Avari sconfiggono i Bizantini, conquistando Sirmium che diventa loro capitale.
574: viste le sconfitte militari, Giovanni abdica a favore del figlio Giovanni II Mistaco.
572 / 591: Grande guerra Persiana: Giovanni II Mistaco e i suoi due generali, Tiberio e Maurizio, conducono una grande campagna di conquista che culmina con la caduta della dinastia Sasanide. Conquistata l'Atropatene e gran parte del Caucaso, nel 576 i Bizantini danno inizio alla più ardimentosa campagna in oriente dai tempi di Traiano: calano in Mesopotamia, saccheggiano nuovamente Seleucia ed espugnano la stessa Ctesifonte nel 577. Nel 579 muore Cosroe, si dice straziato dal dolore per la perdita dei suoi diecimila cavalli. Il suo successore, Ormisda IV, riuscì a trattenere i Romani fra il Tigri e il Grande Zaab, ma senza poterli ricacciare. A poco valsero gli attacchi di Avari (583) e Ghassanidi (sconfitti nel 584). Nel 582 muore Giovanni Mistaco, e gli succede sul campo il suo luogotenente Maurizio. L'attacco dei Gokturk, finanziato e organizzato dai bizantini, scompagina definitivamente l'impero Sasanide: nel 589 scoppia la guerra civile, e Ormisda è deposto a favore del figlio Cosroe II. Mentre i Romani avanzano da Ovest e i Turchi da Est, l'impero si frammenta in una dozzina di potentati guidati dai generali del vecchio regime, sconfitti uno alla volta dall'imperatore Maurizio e dal suo generale, Romano.
592: Maurizio torna a Bisanzio, lasciando Narsete e Romano in Oriente. L'impero è sull'orlo del collasso, sfiancato da una guerra ventennale e da una leva militare che ha privato le campagne di manodopera. Gli Avari, gli Slavi e i Bulgari liquidano definitivamente il Limes Danubiano.
602: una rivolta dell'esercito depone Maurizio a favore del tiranno Foca.
610: la situazione dell'impero è ancora peggiorata: di fatto l'unità imperiale è un miraggio. Dallo Ionio allo Stretto di Hormuz, i signori della guerra romei si saltano al collo l'un l'altro, unendosi solo di rado per contrastare la riconquista dei generali persiani. Eraclio, governatore di Lazica, piomba sulla capitale e depone Foca, facendosi acclamare Imperatore.
622: dopo dodici anni di preparazione, Eraclio lancia la grande campagna di riunificazione che riporta tutte le province asiatiche dell'impero sotto il dominio bizantino. Stabilisce il confine con i Turchi presso il fiume Atrak, e comincia il lungo processo di assimilazione della cultura persiana.
641: Morte di Eraclio, l'impero è unito e saldo.
Eraclio stabilisce definitivamente il Latino come lingua della corte: regnando su un impero composto per un terzo da Greci, per un terzo da Copto-Siriaci e per un terzo da Persiani, l'utilizzo di una lingua "neutrale" sembra la scelta più ovvia. Inoltre il sistema dei Themata è esteso in tutte le regioni conquistate, e la leva militare permette di far interagire pacificamente i vari elementi etnici dell'Impero.
Viene riaperta l'antica Strada del Re, con una variante però a Nisibide (che cambia nome in Trivium): una via settentrionale che congiunge la Mesopotamia del Nord a Nyshapur (Nea Augustopolis). Lungo queste vie commerciali parallele si combatterà la grande lotta fra Alessandria e Bisanzio nel due secoli successivi.
Gli ultimi rimasugli sasanidi si rifugiano sui monti dell'Afghanistan ed in Asia Centrale, esposti alle incursioni turche e sempre più deboli e divisi, tanto da doversi spesso umiliare a chiedere l'aiuto dei Catapani di Parthia. Fin dalla metà dell'ottavo secolo questi sasanidi orientali entreranno in India, conquistandone anche alcuni regni (su commissione romana).
Il saccheggio della Persia porta a Costantinopoli una ricchezza mai vista: nel giro di vent'anni essa diventa la più grande città mai vista sul pianeta, e una nuova cerchia muraria viene aggiunta alle precedenti. Le incursioni slave e avare nei balcani si fermano, e lentamente i popoli barbari sono conquistati dall'oro e dalla vittoriosa cultura bizantina.
L'unico vero cambiamento politico nel secolo seguente la vittoria di Eraclio è la sostituzione dei Bulgari, vecchi alleati dei Persiani, con i Cazari. Costoro prendono possesso del bassopiano sarmatico e insediano i loro alleati Magiari presso il fiume Dniestr. Intanto gli Slavi, liberati dal giogo degli Avari, vengono fissati nei Balcani Occidentali e in Moravia.
La politica imperiale nei confronti degli Slavi è ondivaga: gli imperatori da una parte ne finanziano i regnanti perchè non saccheggino i territori imperiali e ne favoriscono l'insediamento a sud del Limes Danubiano in funzione anti-bulgara; dall'altro lato però perseguitano i culti eretici che trovano fra i nuovi venuti terreno fertile, e lasciano i nuovi alleati in uno stato di semi-babrarie, almeno fino al nono secolo.
I Regni Romano-Barbarici osservano con stupore gli ambasciatori bizantini carichi d'oro che entrano nelle corti dei loro sovrani, chiedendo formale adesione al progetto imperiale (e ascoltano con gioia le spie egiziane che rinforzano le posizioni ariane con oro e consigli militari).
Il Regno dei Visigoti, ariano, riceve grande supporto (dal Levante) nel suo tentativo di unione dinastica con i principati germanici delle Gallie, specie dopo che nel 595 i Mori si sono convertiti al Monofisismo.
Quando però diventa evidente che la monarchia visigotica è in declino, i i Franchi potrebbero varcare i Pirenei in ogni momento, i levantini non hanno scrupoli a riversare sull'Iberia i nuovi
alleati Mori, che ivi fondano un duraturo regno monofisita.
I Franchi, a loro volta, sono supportati dalla corte di Costantinopoli, che favorisce il sorgere della dinastia Carolingia di Maestri di Palazzo.
I Longobardi invece tentennano fra le due posizioni: essendo Ariani, preferirebbero supportare i Goti, ma essendo anche i più vicini a Bisanzio, ne subiscono maggiormente l'influenza. Per rimarcare lo stato ereticale dei Longobardi, i Bizantini intervengono due volte a supporto del Papa, senza mai però prendere possesso dei territori romani.
Appare evidente che fra il 650 e il 750 le due fazioni principali dell'impero si combattono per interposta persona in Europa Occidentale.
A partire dal 750 quattro fenomeni contemporanei portano alla fine della prima fase dell'Impero:
1) Incursioni e quindi invasioni di Vichinghi e Variaghi, con conseguente liquidazione dei Cazari e liberazione dei Magiari.
2) Lotta Iconoclasta e invasioni arabe (guidate dai Levantine per scrolalrsi di dosso la mano bizantina)
3) unificazione della Pars Occidentalis sotto la corona dei Carolingi
4) Predicazione dei senti Cirillo e Metodio in Persia, traduzione dei vangeli in
persiano ed elaborazione dell'Alfabeto Glacolitico, un ibrido greco-aramaico dal quale deriverà l'Alfabeto Cirillico usato
stabilmente in Persia.
A questi fenomeni si deve aggiungere l'ultima delle grandi vittorie bizantine in Asia Centrale: la Battaglia di Talas.
Fra il 750 e il 900 l'impero attraversa una nuova fase di trasformazione, prima con le guerre civili fra l'elemento Monofisista-Iconoclasta-Copto-Semita-Gotico-Neoplatonico e quello Ortodosso-Iconodulo-Bizantino-Iranico-Franco-Aristotelico. Per mantenere la continuità imperiale, dobbiamo presupporre la rovina dell'Egitto e della parte Monofisita e la restaurazione del culto delle icone.
La sostituzione dei Khazari con il Rus di Kiev nell'area nordpontica potrebbe avvenire nell'ambito delle lotte fra iconoduli e iconoclasti: i Khazari, in quanto ebrei, parteggerebbero per questi ultimi (un'alleanza Egitto-Steppe avvenne anche nella nostra TL, fra Mamelucchi e Orda d'Oro) L'alternativa sarebbe che nello stesso periodo, invece di una lotta fratricida, avvenga la conquista dell'India, e che l'elemento neoplatonico scalzi il precedente impero in un batter d'occhio, come è avvenuto per gli arabi. Questa opzione però mi sembra improbabile.
La risorgenza culturale persiana, la sempre più tesa situazione egiziana e l'arrivo di nuovi giocatori sullo scacchiere europeo, potrebbe convincere alcune frange bizantine a mettere insieme un piano analogo alal Rivoluzione Abbaside, esteso però ad Anatolia, Egitto e tutta l'Arabia. I Monofisiti si rifugerebbero così in Nordafrica e Spagna.
In ogni caso l'Egitto rimane un problema spinoso per l'impero, che può essere risolto solo bypassando il Levante nei commerci con l'Oriente (taglio dell'istmo di Suez o canale fra Volga e Don -o apertura di altre vie, come avvenuto storicamente a partire dal quindicesimo secolo), o assimilandolo in maniera più completa (difficile!).
690: i Mori intervengono in Iberia, conquistando il regno dei Visigoti prima che possano farlo i Franchi Carolingi.
Lotta Iconoclasta:
726 Inizia il periodo della Lotta Iconoclasta nell'Impero.
732: Carlo Martello sconfigge i Mori a Poitiers,
749: Muore Giovanni di Damasco, campione dell'Iconodulia e Patriarca di
Antiochia.
751: Battaglia di Talas, le armate bizantine, sotto l'insegna della Crux Flavia (piuttosto che della Theotokos) sconfiggono i Turchi comandati
dal generale sino-coreano Cao Xien. la Crux Flavia fu adottata per accogliere nelel fila romee anche i transfughi ariani, sconfitti più
volte dall'esercito sino-turco.
787: Concilio di Nicea (iconodulo)
795: i Franchi liquidano gli Avari per conto dell'Impero Bizantino.
800: Carlo Magno Imperatore. Il suo dominio si estende dai Pirenei alla Moldava e al Danubio, giungendo fino nel profondo sud Italia, dove gli ultimi ducati Longobardi combattono, finanziati dai Franchi, contro l'Impero. Carlo e il Papa si alleano in funzione anti-imperiale.
813: rivincita Iconoclasta, guerra civile fra Alessandria e Bisanzio.
814: muore Carlo, l'Occidente va incontro allo sfascio. I ducati Longobardi, voltando gabbana, risalgono la penisola e occupano Tuscia e Lunigiana, premendo su Roma.
819: Fondazione del regno neo-sasanidi dei Samanidi a Bukhara.
827: Nell'ambito della Lotta Iconoclasta, i Mori conquistano la Sicilia, lasciando solo Siracusa ed Agrigento in mani bizantine.
833: Grande Moravia, stato slavo di ubbidienza imperiale in Europa Centrale.
843: fine delle Lotte Iconoclaste, l'impero dei Franchi si sfascia.
Vendetta dell'Impero
850 ca: Cirillo e Metodio traducono i Vangeli in Persiano, la fazione egizio-levantina ha perduto iniziativa.
861: i Variaghi attaccano Costantinopoli.
895: i Peceneghi si spostano in Sogdiana.
907: fine della Grande Moravia, i Magiari si spostano in Pannonia.
909-969: invasioni moresche in Egitto, Arabia, Siria e Iberia mettono fine al potere Levantino e alla lotta iconoclasta.
900-976 l'impero va incontro alla decomposizione in principati. Cumani, Carlucchi e Peceneghi arruolati negli eserciti.
911: alleanza fra Bisanzio e i Variaghi del Rus di Kiev.
950-1250: guerre fra impero e regni occidentali.
955: Ottone I sconfigge i Magiari a Lechfeld e fonda il Sacro Romano Impero della Nazione Germanica. Da Bisanzio gli viene riconosciuto il titolo di Autocrator ma non quello di Basileus.
957-973: Ottone in Italia, sconfigge i Longobardi e sottomette il Papa. Alleanza fra Impero e Ottoni, Bisanzio cede Ravenna come segno di buona volontà, mentre i Tedeschi attaccano i Magiari. Ottone sposa la principessa Teofano.
960: rinascita dei cinesi sotto la dinastia Song: le steppe diventano di nuovo pericolose, movimenti fra gli Oghuz.
962: Fondazione della dinastia Gazacide da parte dei Peceneghi.
969: I Variaghi del Rus distruggono definitivamente il khanato dei Khazari, i Solomonidi saccheggiano Alessandria e portano le reliquie di San Marco ad Axum.
Basilio e i Selgiuchidi
976-1025 Basilio il grande imperatore. Alleanza con gli Ottoni e i Turchi, eserciti turchi riconquistano l'Impero per Basilio, con l'esclusione dell'Afghanistan e dell'India.
976-990: Basilio conduce campagne in Anatolia e Grecia, patrocina la conversione degli Slavi e si libera di alcuni traditori.
991-994: Campagne levantine di Basilio, riconquista di Seleucia, Damasco, Mosul, Ray.
999: i Gazacidi conquistano la Persia.
996-999: Campagne balcaniche e pontine di Basilio.
1000-1018: grande campagna asiatica, riconquista dell'Impero e distruzione dei Gazacidi.
1023: ultima campagna di Basilio.
1025: morte di Basilio il Grande.
1029: lasciati orfani dalla morte di Basilio, i suoi generali turchi continuano la sua opera.
1030-1072: i Normanni conquistano uno alla volta i ducati meridionali e le capitanate bizantine in Italia.
1031: i Selgiuchidi sconfiggono i Peceneghi e conquistano Gazaca. I Gazacidi si rifugiano in India.
1058: i Tolonidi invadono la Siria. I Selgiuchidi li sconfiggono, quindi chiamano i Solomonidi etiopi a prendere possesso dell'Egitto come dell'Arabia. Gli Ilaliti in Nordafrica.
1071: Alp Arslan a Bisanzio è nominato Porfirostratego, i Selgiuchidi diventano il vero potere dell'Impero, con il Basileo limitato a funzioni cerimoniali.
1081-1085: I normanni tentano la conquista dell'Epiro (con l'avallo papale e franco), ma sono sconfitti dai Selgiuchidi.
1090: Fondata la setta degli Assassini.
1092: Basilio Sha assassinato, proprio mentre sta per dare il via alla (ri)conqusita dell'Egitto. Lo status pretoriano dei selgiuchidi finisce, e l'impero comincia a dare segni di cedimento.
1094: Battaglia di Livonia, vittoria di Selgiuchidi e Russi sui Cumani, l'impero raggiunge la massima estensione. Nella regione compresa fra il confine imperiale e quello russo inizia il lungo processo di formazione del popolo romeno.
1095: Spedizioni francesi contro l'impero, con lo scopo di portare i Solomonidi al fianco dei Franchi.
1098: i Comneni al potere i Grecia: con un colpo di stato, Bisanzio torna in mano greca e i i Selgiuchidi, sempre meno uniti, devono rinunciare al loro ruolo di protettori della capitale (e alle loro campagne europee).
Comneni sul Mare, Corasmiani sulla Terra, Assassini ovunque
1127: gli Jurchen respingono i Song verso sud.
1131-1170: Apogeo di Kilwa, in Africa, città-stato fondata da coloni imperiali -solomonidi e persiani, innanzitutto.
1150ca: Mercanti indiani della Gorgiaria portano il cristianesimo in Indonesia.
1153: i Selgiuchidi si estinguono, nuova epoca aurea in Persia e nel Levante, accompagnata però dalla completa frammentazione dell'Impero in staterelli, sui quali dominano i Comneni di Bisanzio e i Solomonidi di Alessandria.
1186: gli ultimi Gazacidi sono sostituiti dalla dinastia di Costantino di Gor, che porta anche Lahore e l'India sotto il dominio turco.
1200-1348: Periodo Siratiano in Africa, fioriscono le città-stato e i commerci, colonizzazione del Madagascar e spedizioni mercantili fino a Bali, dove il cristianesimo nestoriano tipicamente africano è introdotto.
1200: i Corasmiani si liberano del giogo dei Qarakitai pagani e cominciano a riunificare l'Impero.
1204: i Crociati conquistano Costantinopoli. Gli ultimi discendenti dei Selgiuchidi non intervengono, lasciando che gli europei occupino lentamente il Mare di Mezzo. Gli Slavi e i Rumeni calano dai Balcani, l'unico brandello di Impero in Europa rimane Bisanzio.
1215: i Goridi di Lahore sono scalzati dai sovrani di Delhi.
Il Disastro Mongolo
1231: la Corasmia è annessa dai Mongoli.
1240: i Mongoli conquistano la Russia.
1256: i Mongoli conquistano il Levante.
1261: la famiglia dei Paleologi riconquista Bisanzio.
La Rinascita
1354: inizia l'ascesa dei Turchi Tiberi come Porfirostrateghi dei Paleologi.
1404: Battaglia di Ancyra tra Paleologi e Timuridi: Tamerlano Cesare deporta l'ultimo imperatore Paleologo in Oriente, lasciando l'Impero nel caos.
1450: estensione dell'impero all'India, all'Africa e all'Indonesia.
1453: i turchi Tiberi conquistano Costantinopoli. L'impero ha ora quattro volti:
lo Zarato Russo, nel Bassopiano sarmatico, con mire sull'Asia centrale e sulla Siberia
l'Arcontato Solomonide, con mire mercantili su tutta l'Africa, l'Arabia e il Mare Arabico, fino in Indonesia
l'Impero Tiberio, retto dall'Autocrate Padishah di Costantinopoli, che ripropone il progetto politico dell'Impero Bizantino
lo Zarato di Sogdiana dal quale nascera l'Autocrazia Mughal.
1453: Tiberio Costantino, Arconte dei turchi Tiberi, conquista Costantinopoli e ne fa la sua capitale, rivendicando tra l'altro la discendenza da Enea.
1501: inizio della revanche iranica in Persia.
1514: a Chaldiran i Tiberi confinano i persiani sul loro altopiano.
1517: i Tiberi conqusitano l'Egitto e lo riportano all'obbedienza imperiale.
1527: i Mughal, discendenti di Tamerlano Cesare, iniziano la conquista dell'India.
Alcune questioni sollevate dalla conquista della Persia:
Integrazione religiosa dei popoli iranici: Eraclio capisce immediatamente che l'Impero deve cambiare, se vuole digerire la Persia, ma capisce anche che proporsi come un semplice erede dei Sasanidi sarebbe una sconfitta. La politica di integrazione dunque procede come un treno su due binari: la religione di Stato cristiana ed il servizio militare, nel quale siriaci, iranici, armeni e greci sono affiancati.
La popolazione dell'ex impero Sasanide viene forzatamente (anche se, almeno da principio, solo nominalmente) convertita al cristianesimo. Sapendo che il Patriarcato di Costantinopoli avrebbe condizionato in maniera fin troppo pensate la politica imperiale, Eraclio rivitalizza il vecchio Patriarcato di Antiochia, con giurisdizione sui territori macroasiatici dell'Impero. La Cattedra di Antiochia ha anche lo scopo di ridurre il prestigio della chiesa nestoriana di Seleucia-Ctesifonte. L'operazione ha un parziale successo, anche grazie alla simbologia mariana adottata per i reggimenti dell'esercito. I Nestoriani tuttavia non sono perseguitati, e la distruzione di Ctesifonte ha una funzione più politica che religiosa. A subire invece una dura persecuzione sono i seguaci di Mani e gli Zoroastriani, almeno nelle città più importanti.
Il cristianesimo nestoriano si diffonde prepotentemente ad oriente, ma avendo perso la propria base mesopotamica, non sarà più una religione unitaria e gerarchica.
L'impero si presenta così religiosamente diviso in tre varianti della stessa confessione: il Credo Calcedoniano, maggioritario nell'Ellade, in Anatolia e sempre meglio radicato in Siria del Nord e in Oriente, il Nestorianesimo, in declino ma piuttosto vitale come variante iranica del cristianesimo imperiale, ed il monofisismo-arianesimo, maggioritario in Egitto e Siria e ben radicato presso i barbari occidentali. Ne Eraclio ne i suoi successori convocheranno un concilio, temendo che le divisioni possano aggravarsi piuttosto che risolversi.
Un grande vantaggio dei Calcedoniani è l'esercito. La leva non è più obbligatoria, ma la despoliazione dell'Oriente lascia migliaia di persone sul lastrico, e la via d'uscita dalla povertà urbana offerta dall'Impero è appunto arruolarsi. La religione dell'esercito è Calcedoniana: i riti quotidiani sono officiati da presbiteri ortodossi, i monaci seguono le armate in marcia, i vessilli rappresentano la Theotokos eccetera. Le truppe imperiali, nel settimo e nell'ottavo secolo, si scontrano per lo più contro ribelli, Turchi o Alani che sconfinano, e signorotti indo-persiani: tutte lotte nelle quali si affina la percezione di appartenenza ad un impero unico, universale e voluto da Dio.
La Chiesa copta, dal canto suo, diffonde i suoi predicatori nel grande deserto africano, fino ai regni dei Mori, presso i quali inizia la lunga opera di conversione, ed i Arabia, dove molte sette monofisite radicali animano le incursioni dei predoni beduini verso la Siria e la Mesopotamia: lo scopo dei Monofisiti è quello di destabilizzare l'impero e diffondere insicurezza.
Integrazione culturale della Persia: Eraclio cambia il suo titolo, da Imperator, Caesar et Augustus (Autocrator, Kaisar kai Augoustos) a Imperator et Basileus, onde significare l'accumulazione sulla stessa persona dei titoli di Imperatore e Grande Re. Rifiutò tuttavia i rituali persiani, e l'assimilazione della figura imperiale a quella divina. Fece anzi distruggere le meravigliose sculture giganti di Cosroe e dei suoi predecessori. Infine, malgrado la componente iranica fosse etnicamente maggioritaria, non aggiunse nessun titolo aramaico o persiano alla titolatura imperiale, ed impose che l'intero rituale pubblico -dalla corti di giustizia più periferiche a quella imperiale- venisse eseguito in latino. Proibì anche l'uso liturgico della lingua persiana e dell'aramaico, facendo bruciare la biblioteca di Dara e quella di Antiochia, distruggendo così per sempre i più antichi testi della religione cristiana.
Manichei, Zoroastriani, Mandei e Neoplatici dovettero scegliere fra la morte per spada e la fuga in India. La cultura iranica venne umiliata e profondamente ferita dalla conquista imperiale, tanto che per un secolo non vennero in pratica prodotti testi in persiano, e si dovranno aspettare almeno cinquecento anni per notare una risorgenza dell'antica nazione iranica.
Chiaramente la situazione di un impero in cui la lingua ufficiale non è parlata da nessuno dei popoli che lo compongono è molto difficile da mantenere, dunque, nei secoli seguenti alla conquista, il Latino sarà sostituito dal Romeo, ossia l'evoluzione bizantina del greco della koinè.
Integrazione economica dei popoli conquistati: Le provincie ex-sasanidi sono saccheggiate. I tesori dei feudatari e dei templi sono portati con gran fasto a Bisanzio. I territori conquistati sono divisi in themata, ossia strutture amministrative affini agli esarcati, nei quali un governatore-generale, detto Stratego o Duce in occidente e Catapano o Satrapo in oriente, riunisce in se tutti i poteri militari e civili, si occupa della coscrizione e dell'urbanistica, nonché della riscossione delle imposte imperiali. Per evitare che il sistema degeneri in un feudalesimo decentrato, Eraclio stabilisce la durata massima della carica di Stratego a vent'anni, sottoponendola inoltre a verifiche quinquennali presso la corte di Costantinopoli. Per accedere alla carica di Stratego bisogna essere di fede Calcedoniana e in generale aver fatto carriera nell'esercito (ma non è sempre detto). La nomina degli strateghi è prerogativa imperiale, tranne che per il Themata vicini alla capitale, nei quali la carica è ereditaria (la Tracia in particolare è amministrata dal Porfirogenito), e per l'Egitto, dove la situazione è adir poco complessa, e spesso il Patriarca di Alessandria copre anche le funzioni di Catapano.
In Persia e in oriente, gli Strateghi viene affidato il compito di espropriare, se necessario con le armi, i latifondi, e ridividerli fra i veterani dell'esercito. Ai contadini viene offerta la vita di poveri inurbati, e spesso queste masse di diseredati sono spostate forzatamente da un capo all'altro dell'Impero, mentre i latifondisti sono di solito messi a morte, anche se viene permesso al figlio di un satrapo persiano che sia cresciuto a Bisanzio come ostaggio di riprendere i propri territori a prezzo di favore. Un altro modo per mettere al sicuro se stessi ed il proprio patrimonio è farsi monaci e fondare un monastero nei propri territori.
Il Qanat viene espanso e portato ad altissimi livelli di efficienza, ed inizia la costruzione di un vallo lungo la linea Hormuz-Gilan. Questi lavori pubblici permettono di impiegare le masse senza lavoro ed evitare rivolte e altri fatti pericolosi.
Cliccate qui se volete leggere l'ucronia sullo stesso tema di Enrico Pizzo, mentre cliccando qui leggerete la versione di Basileus TFT.
.
Diamo la parola all'amico Damiano Lanzoni:
Anch'io ho avuto un'idea per permettere la sopravvivenza dell'Impero Romano, con queste modalità: ad occidente Odoacre depone Romolo Augustolo ma assume il titolo di Imperatore d'Occidente e viene poi scalzato da Teodorico (dinastia Ostrogota). La guerra Gotica sarà quindi una guerra civile tra due pretendenti (uno dei quali appoggiato da Giustiniano). Al termine della guerra la parte filo bizantina viene sconfitta; ma il titolo imperiale cade preda dell'invasione longobarda. Poi sarà Carlo Magno a prendere il titolo e la storia continua più o meno come nella nostra TL fino a quando Napoleone non prende su di se il titolo Imperiale.
Nel frattempo una signoria italiana (da buon Mantovano direi ad esempio i Gonzaga; ma una vale l'altra) è riuscita a riunire buona parte della penisola. In questa TL in Italia, nonostante la divisione in staterelli, è continuata a sopravvivere l'idea di far parte comunque di un qualcosa di più grande e di essere comunque il "cuore" dell'antico Impero e anche repubbliche come Lucca, Genova o Venezia sono (nella forma) più simili a signorie elettive che comunque formalmente si dichiarano parte della tradizione dell'Impero Romano.
Questa signoria, dicevo, dopo aver resistito fieramente a Napoleone si presenta al congresso di Vienna godendo di ampio prestigio (tipo la Prussia in ambito tedesco; ma con un orientamento più diplomatico che militaresco) e riesce a ottenere la corona imperiale e (nella prima metà dell'800) riesce a riunificare la penisola italiana.
Nel frattempo la storia dell'Impero d'Oriente è praticamente uguale alla nostra; ma dopo la caduta di Costantinopoli nel 1453 (prendendo spunto dall'ucronia "Il Despostato di Morea" di Massimiliano Paleari) inizia la riconquista greca dell'Impero.
A metà dell'ottocento una congiuntura dinastica fa ereditare entrambe le corone alla stessa persona, ed inizialmente i governi dei due paesi non vorrebbero che ciò influisse sulla loro politica; ma le due parti dell'impero vengono letteralmente travolte da un'ondata di entusiasmo popolare che vede l'unificazione delle due corone come un presagio al ritorno ad antiche glorie. I due paesi iniziano quindi una politica di avvicinamento che culmina il primo gennaio del 1900 con la proclamazione della ricostituzione dell'Impero Romano.
Ecco in rosso un'idea dell'estensione odierna dell'Impero:
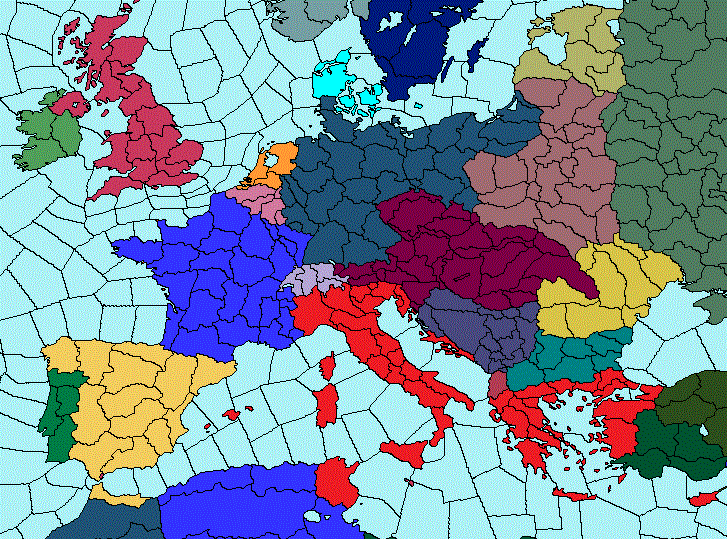
.
Subito Bhrihskwobhloukstroy commenta:
Nell'ipotesi dei Gonzaga (la migliore, dato che erano Eredi anche dei Paleologi), la loro Eredità va comunque agli Asburgo-Lorena (fra il 1708 e il 1746), per cui al più tardi Francesco I. sarebbe il primo Sovrano dell’Impero riunito. Questo rende più verosimile la (altrimenti difficile) resistenza a Napoleone, l’ampio prestigio al Congresso di Vienna e l‘unificazione della Penisola Appenninica nel XIX. secolo (in pratica una rivincita delle Guerre di Successione).
.
E ora, l'idea di Basileus TFT:
Dopo aver faticosamente riconquistato l'Italia ai Goti, Narsete venne lasciato a governare la provincia. Il suo governo fu molto parsimonioso e equilibrato. Ricostruì diversi villaggi e città distrutte (fra le quali Milano), riformò l'esercito imperiale, fu generoso nei confronti del popolino minuto che aveva sofferto oltre alla guerra delle forti carestie. Purtroppo la situazione finì con la morte di Giustiniano, suo figlio Giustino II mal vedeva Narsete e la sua popolarità, inoltre gli abitanti della città di Roma manifestarono risentimento verso la sua politica fiscale nella città e chiesero che fosse sostituito. Così Giustino mandò al suo posto il prefetto Longino, uomo fedele ma senza particolari doti. Quando, qualche anno dopo, i longobardi invasero l'Italia, Longino credette si trattasse di un attacco per fare razzia e poi tornare verso nord. Quando si accorse che i Longobardi erano venuti per restare era ormai troppo tardi. Il grosso del nord Italia era caduto nelle loro mani, le maggiori città resistevano agli assedi isolate e con poche truppe. Longino non e i suoi generale non seppero prendere l'iniziativa e si limitarono ad assicurarsi alcune zone-chiave, lasciando il resto al suo destino, senza impegnare militarmente Longobardi.
Ma se invece gli abitanti di Roma non si lamentano e Giustino lascia Narsete al suo posto? Narsete aveva decenni di esperienza nella guerra, era amato dall'esercito, aveva un'intelligenza e una abilità tattica superiore a qualunque generale in quel momento, conosceva l'Italia e i suoi abitanti. Non a caso aveva posto i 4 forti principali del suo esercito in val d'Ossola (in previsione di un attacco franco) e gli altri a Cividale del Friuli, Castelseprio e nella pianura veneta...
.
Risponde Federico Sangalli:
Longino inoltre convinse Rosmunda ad uccidere il suo amante Elmichi, con il quale aveva complottato per uccidere suo marito, il Re dei Longobardi Alboino. Se Rosmunda non uccide Elmichi e Elmichi non uccide Rosmunda i due, che erano comunque sostenuti da una parte, seppur non maggioritaria, del popolo longobardo, potrebbero essere posti a capo di un regno longobardo vassallo dei bizantini per esempio in Friuli.
.
Enrico Pizzo tuttavia obietta:
Stiamo parlando del mio periodo storico preferito? Mi ha sempre affascinato l'Italia del VI secolo, in cui gran parte delle costruzioni classiche erano ormai abbandonate, ma non da cosi tanto tempo da essere distrutte.
Ma Narsete aveva gli effettivi per respingere i Longobardi? La sensazione è che l'invasione Longobarda fosse stata, in qualche modo, autorizzata da Costantinopoli. I Longobardi entrano in Friuli nel 567 e la reazione Bizantina arriva solo nel 569. Inoltre i Longobardi nella loro invasione seguono la Postumia, mentre Ravenna fa fortificare le città lungo la Annia e l'Emilia-Altinate, due linee quasi parallele.
.
E Basileus TFT reagisce:
« Narsete aveva gli effettivi per respingere i longobardi? » Ni, nel senso Narsete aveva sicuramente uomini molto esigui rispetto ai longobardi ma questo poteva essere tranquillamente compensato dalla sua superiorità tattica, dalla conoscenza del territorio, dalle armi ed addestramento migliore, dalla posizione, dal maggior vettovagliamento, dalle fortificazioni ecc. ecc.
« La sensazione è che l'invasione Longobarda fosse stata, in qualche modo, autorizzata da Costantinopoli. » Assolutamente NO, la reazione tardiva nasce dal fatto che Longino male interpretò l'attacco longobardo, interpretandolo come una scorreria e non come un'invasione. La prassi per questo tipo di problema era lasciare che il nemico razziasse trincerandosi nelle città e poi uscire una volta che se ne fossero andati, cosa che getta il principio della difesa elastica di Eraclio/Costante II nel sistema dei Themata, ma sto divagando. Quando appunto ci si accorse dell'errore Longino, che non era certo un genio militare, lasciò le città italiane ancora fedeli ai Romani in balia di se stesse, mentre un gran numero di Goti defezionava a favore dei longobardi vedendo come tirava il vento. Possibile un regno foederato in Friuli-Slovenia o ancora, se Narsete li costringe a ripiegare a est potrebbero gettarsi sulla Dalmazia, allora controllata da varie tribù slave.
.
Enrico però non demorde:
Ma alcune città, ad esempio Vicenza e Verona, vorrei dire anche Treviso e Brescia ma dovrei controllare, hanno aperto le porte ai Longobardi. Mentre per altre, Iulia Concordia, Altino, Padova, i Longobardi hanno evitato sia la città che il territorio circostante.
.
E il grande Bhrihskwobhloukstroy puntualizza:
Sia i Longobardi sia gli Slavi in Dalmazia (che erano parte di un unico movimento geostrategico) hanno trovato l'alleanza di fatto delle popolazioni non romanizzate nei confini dell'Impero: dovunque ci siano varianti nei toponimi, quelle slave (e, nei rarissimi casi disponibili, anche quelle germaniche, per esempio Laibach per Lubiana) riflettono la forma non romanizzata.
Addirittura, i Paleoveneti dovevano conoscere i Longobardi fin dalla Preistoria indoeuropea, dato che il nome originario di questi ultimi, *Loṅgʱo-bhardho-es ("Lunghe Barbe"), è divenuto regolarmente in venetico *Longofardōs (questo esito è esclusivamente venetico, non latino né italico) ed è all'origine del glottonimo argentino lunfardo; invece, in Transpadana, i *Laŋgobardōz germanici sono stati resi col nome celtico del poeta compensato con un vaso, *longo-bardos (il che è il motivo della trasformazione - altrimenti irregolare - del latino classico Langobardī nel volgare Longobardi).
A Nord delle Alpi, un'intera Confederazione celtica, i Carantānī (traduzione celtica di Veneti), sono diventati direttamente sloveni (il nome di Lubiana presenta un fenomeno dialettale tardogallico sconosciuto al latino).
Caporetto, invece, è stato assunto in protoslavo dalla forma latina volgare (e infatti nella zona aveva avuto luogo una colonizzazione latina precoce).
.
E ora, la grande proposta di Paolo Maltagliati:
Britannia est omnis divisa in partes tres
P.O.D.:
L'usurpatore d'occidente Costantino III invia suo figlio Costante in Britannia,
per domarne le sollevazioni contro di lui, derivate principalmente dal fatto
che, pur partita l'usurpazione di Costantino dalla stessa Britannia, l'isola era
stata abbandonata a se stessa e in balia delle devastanti incursioni sassoni,
perché Costantino era concentrato contro i generali di Onorio, Saro e Stilicone.
[In HL, Costantino manda il figlio in Hispania con il suo – apparentemente –
fidato generale Geronzio]
1 - Dal ritiro delle legioni romane alla prima ‘tripartizione’ della Britannia
410 – 411: Costantino III viene tradito da Geronzio, proprio mentre il generale Costanzo oltrepassa le Alpi per marciare contro di lui. Costanzo prima sconfigge Geronzio, poi assedia Costantino ad Arles; tradito dai suoi, Costantino è costretto alla resa. Costante decide di abbandonare il padre al proprio destino e sigla un trattato di sottomissione a Flavio Costanzo.
412: Sollevazione contro Costante di alcuni membri della nobiltà romano-britannica locale. Costante è costretto a scappare da Londinium; stabilisce il suo quartier generale meridionale a Corinium, anche se spesso risiede al nord, a Eburacum. dall’aristocrazia del nord (a lui generalmente più fedele di quella meridionale) viene spesso soprannominato ‘Protettore’ (in lingua brettone Godebog)
415: In concomitanza con una grande incursione sassone sulle coste sud-orientali dell'isola, che colpisce la stessa Londinium, Costante sconfigge i propri nemici presso Verulamium. Nonostante ciò, ritenendo la vecchia capitale troppo esposta alle scorrerie dei barbari, mantiene la propria capitale meridionale a Corinium, maggiormente difendibile. Alcune malelingue sostengono che Costante abbia preso accordi con i sassoni e abbia 'lasciato loro' le coste orientali dell'isola.
421: Ascesa al trono - e morte solo sette mesi più tardi – di Flavio Costanzo come co-imperatore di Onorio. Pare che Costanzo volesse organizzare una campagna di riconquista della Britannia, ma, fortunatamente per Costante, morì prima di realizzare il suo intento. Costante cerca e parzialmente ottiene l'aiuto dei Franchi per arginare le incursioni sassoni. Diversi contingenti franchi si stanziano a Londinium (pur sempre la città più grande dell'isola), non particolarmente apprezzati dalla popolazione locale.
423: Morte di Onorio e usurpazione di Giovanni Primicerio. Costante spera di approfittarne e sbarca in Gallia. Sottomette l'Armorica, ma viene sconfitto da Teodorico I, re dei Visigoti (il quale afferma di agire in nome del legittimo imperatore, con una certa qual ipocrisia). In assenza di Costante, l'aristocrazia londinese si ribella al suo dominio, cercando l'appoggio dei sassoni contro la guardia franca. Quest'ultima è costretta a fuggire dalla città, ma Verulamium apre loro le porte e lì riescono a riorganizzarsi e sconfiggere i londinesi e i contingenti sassoni loro alleati.
425: Accordi di Aquileia tra Galla Placidia (che torna a Ravenna da Costantinopoli) e il generale Flavio Ezio. Valentiniano III, figlio di Galla Placidia, diventa imperatore d'occidente. Costante invia una delegazione a Ravenna per sondare la situazione politica e ottenere il riconoscimento del proprio dominio in Britannia.
427: Ribellione di Deva Victrix al dominio di Costante. I Franchi di Londinio e Verulamio vengono chiamati a combattere contro Deva. Non vi sono fonti certe, ma probabilmente i devani cercarono di imporre come proprio sovrano Quinto Aurelio Simmaco, in quel momento residente in Britannia e che doveva avere una certa fama, il quale tuttavia rifiutò. Riuscì però a mediare tra gli insorti e Costante. Alcuni sostengono che dietro la ribellione di Deva vi sia un tentativo di corruzione da parte di alleati di Flavio Ezio per ripristinare il controllo di Ravenna sulla Britannia, ma è estremamente improbabile (anche perché il generale piuttosto cercò di guadagnarsi l'alleanza di Costante nelle sue campagne contro Teodorico I dei visigoti). A seguito di tale vicenda Quinto Aurelio Simmaco sposerà la figlia di Costante.
429-430: Guerra tra Bonifacio ed Ezio. Costante si schiera con Bonifacio, in realtà al solo scopo di ritentare l'occupazione della Gallia. Con l'aiuto franco occupa nuovamente l'Armorica. Morte misteriosa (anche qui, i pettegolezzi si sprecano su chi possa essere stato il colpevole) del figlio di Costante. Quest'ultimo adotta come successore il genero Aurelio Simmaco (forse il mandante stesso dell’assassinio del cognato).
433: Dopo il ritorno di Ezio al potere, il vecchio Costante cerca di riavvicinarglisi. Sebastiano, genero di Bonifacio, fugge in Britannia convinto di essere protetto da un alleato. Costante tuttavia vede l'occasione per riallacciare i rapporti con Ezio e prima lo accoglie, poi lo fa uccidere, inviandone notizia ad Ezio. Quest'ultimo tuttavia minaccia Costante, intimandogli di rompere con i franchi e di evacuare l'Armorica. Costante inizialmente tergiversa, ma la paura di Rua, re degli unni (e alleato di Ezio), è tale da spingerlo a obbedire.
434: morte di Costante, ormai soprannominato anche ‘il vecchio’ (soprannominato in brettone Coel Hen Godebog e nei secoli successivi mitizzato come grande sovrano; peraltro Coel Hen Godebog onava all’epoca *KailoΣ SenoΣ U̯otepākoΣ.). Aurelio Simmaco riesce a schiacciare una ribellione contro di lui dell'aristocrazia britannica, comandata da Vortigerno. Dopo aver mostrato il pugno di ferro contro gli insorti, non perde tempo e organizza una campagna contro i pirati sassoni (collusi, forse, con i ribelli). Fatto ciò, riporta la capitale a Londinium. Per ribadire i buoni rapporti della Britannia con Ezio, Simmaco fa sposare sua figlia, Aurelia Memmia, con Carpilione, figlio del matrimonio morganatico di Ezio con una figlia del re dei visigoti Teodorico.
437: Aurelio sconfigge il ribelle Tibattone in Armorica per conto di Ezio. Ezio però non ne è particolarmente felice, visto che teme un possibile ampliamento degli orizzonti politici di Simmaco. Motivo per cui Ezio avrebbe rifiutato l'aiuto propostogli da Aurelio Simmaco per combattere contro i Visigoti (che stanno imperversando in Narbonese). Quando poi ci sarà la crisi unna, molti rinfacceranno ciò ad Ezio.
440: Ezio dispone a proprio piacimento di foederati germanici da stanziare in Gallia contro i bagaudi. Alcuni capi bagaudi (o, piuttosto, i latifondisti della Gallia, che storicamente non gradirono molto le politiche di Ezio), inviano appelli a Simmaco, perché li difenda dai barbari. Aurelio Simmaco, indeciso sul da farsi viene però (provvidenzialmente?) assassinato da Carpilione, che prende il potere in nome del padre in Britannia. Nel contempo, però, inizia una grande invasione sassone. Vortigerno si autoproclama signore della Britannia. Appena prima di questi eventi, la sorella di Valentiniano III, Giusta Grata Onoria, viene esiliata/data in sposa a Ambrosio Aureliano, figlio maschio di Aurelio Simmaco. Per Simmaco era stato un grande successo diplomatico, ma la realtà era che Onoria era stata allontanata per volere di Valentiniano. La giovane erede di Teodosio non fa in tempo ad acclimatarsi in Britannia che improvvisamente è costretta a fuggire con il suo nuovo marito ed è in pericolo di vita. Deva apre le porte a Ambrosio Aureliano, che ottiene anche il supporto di molti signori locali della Britannia Seconda e della Britannia Valeria.
440 – 445: Guerra tra Carpilione, Ambrosio e Vortigerno, che in realtà semplicemente avvantaggia la penetrazione sassone dalle coste orientali verso ovest. Ambrosio libera Eburacum da un assedio sassone e la Britannia Cesarea settentrionale, di solito piuttosto neutrale nelle dispute di potere, si schiera con lui. Ambrosio recluta tra le sue file anche i Pitti di Habitancium o 'tra i due valli'. Sconfigge Vortigerno nel 443 (per quanto Vortigerno stesso riesca a fuggire) nella battaglia delle rovine di Camulodunum, per poi assediare Carpilione a Corinium. Catturato, il figlio di Ezio viene infine ucciso per mano dello stesso Ambrosio. Quest'ultimo ha vinto la guerra, ma i sassoni hanno esteso il loro controllo in molte regioni, l'economia dell'isola è a pezzi e gli eserciti romano-britanni decimati. Secondo le cronache, Onoria in un primo momento tenterà di defezionare il campo del marito per ottenere da Carpilione la possibilità di tornare a Ravenna, invece che rimanere nella nebbiosa Britannia; cambiata però posizione (probabilmente per timore che Ezio potesse usarla per un matrimonio politico anche peggiore), si rivelerà decisiva come sostegno morale e politico ad Ambrosio e – stando ad alcune leggende – si rivelerà fondamentale per ingannare ed intrappolare Carpilione e consegnarlo ad Ambrosio stesso.
445 - 449: Dopo la morte del figlio di Ezio, i rapporti tra quest’ultimo e Ambrosio Aureliano sono ai minimi storici; in un primo momento Ambrosio è graziato da una spedizione punitiva del generale romano per via dell’impegno di quest’ultimo contro i Suebi in Hispania. Dopo aver negoziato lo stanziamento unno in Pannonia, Ezio propone ad Attila di inviare il generale sciro Edeco in Britannia, su navi romane, per liberarsi di Ambrosio Aureliano.
449: spedizione di Edeco in Britannia. Ambrosio Aureliano si allea temporaneamente con i capi sassoni Hengist e Horsa per fermare Edeco. Quest’ultimo sconfigge i sassoni e uccide Horsa, mentre Hengist sopravvive. Più di uno storico sospetta che Ambrosio Aureliano abbia di fatto tradito e condotto i sassoni in una trappola, allo scopo di indebolirli (scommettendo sul fatto che prima o poi Edeco se ne sarebbe andato).
450: Dopo la morte di Clodione, guerra civile tra i franchi (forse dovuta alle manovre di un Attila che già premedita lo scontro con l’impero e di Ezio, che vede nei Franchi un contraltare alla crescente potenza del re visigoto Teodorico ). Vittoria del candidato pro-Roma, Meroveo. Molti franchi dello schieramento perdente si rifugiano a Londinio (de facto ormai difesa contro i sassoni unicamente dai franchi, pur sotto l’alta autorità di Ambrosio).
451: Attila e Ezio rompono i rapporti; gli Unni invadono la Gallia. Edeco, intrappolato in Britannia, è indeciso sul da farsi. Tregua tra Ambrosio ed Edeco, in cambio del rifiuto del primo di mandare aiuti ad Ezio contro Attila (che in effetti li aveva chiesti). Vittoria della coalizione anti-unna ai campi Catalaunici.
451 - 453: Ezio cerca di farsi consegnare Edeco come ostaggio da Ambrosio Aureliano, ma quest’ultimo rifiuta. Hengist organizza una grande campagna di vendetta contro Edeco e i romano-britanni. Chiede e apparentemente ottiene il supporto di Faramondo, comandante dei franchi, probabilmente insoddisfatto dei suoi rapporti con Ambrosio Aureliano.
454-455: Morte di Ezio. Ambrosio tira un sospiro di sollievo. Battaglia di Aylesford (il nome pregermanico di Aylesford potrebbe forse essere il tanto discusso Madus) tra Hengist da un lato e Ambrosio Aureliano, e vittoria del primo; il secondo si ritira verso nord-ovest (prima a Eburaco, poi a Deva, più difendibile). Pur tuttavia, Hengist continua a non essere fortunato con le alleanze: Faramondo, che ha tenuto i suoi uomini di rincalzo, attacca alle spalle il capo sassone sulla via del ritorno.
456: battaglia di Verulamio: Faramondo sconfigge anche Edeco, mandato da Ambrosio a Corinio. il principe Franco è dunque l’uomo forte della Britannia centro-meridionale. Ambrosio stipula un’alleanza con ‘re Nectanio di Caledonia’ (Nechtan, un sovrano pitto).
457: Battaglia di Crecganford: sconfitta di Faramondo contro Æsc, figlio di Hengist. Assedio di Londinio (da cui si deduce che nel frattempo intorno alla città sia stata costruita la prima cinta muraria di una certa entità).
460: Convegno dei lunghi coltelli: nell’impossibilità di portare avanti la battaglia, apparentemente Hengist e suo figlio chiedono pace a Faramondo e Ambrosio. in realtà, giunti sul punto di ritrovo, il capo sassone cerca di uccidere i due rivali. Faramondo sopravvive, nonostante venga ferito, mentre Ambrosio viene ucciso e con lui alcuni comandanti del suo seguito (non sappiamo se Edeco sia tra questi, ma dopo questo evento non abbiamo più notizie di lui ). Onoria si proclama imperatrice, in quanto unica erede della dinastia Teodosiana dalla morte di Valentiniano III. Co-imperatore viene nominato suo figlio (e teoricamente di Ambrosio, anche se qualcuno solleva dubbi) Costantino Ulteriano, poi detto ‘il drago’.
466: Battaglia di Wippedesfleot: sconfitta di Æsc contro ‘Franchi, Britanni e Romani’. Prima menzione di Britanni e Romani come due enti separati, per quanto non si capisca di preciso se sono definizioni etno-linguistiche o semplicemente politiche (intendendo dunque con romani i principi che obbediscono a ‘Roma’, cioè a Onoria e Costantino Ulteriano, con britanni invece i capi autonomi).
470: morte di Faramondo. Suo figlio Clotario si proclama ‘re dei franchi di Britannia’. Secondo la leggenda in questo anno avviene la ‘spartizionue di Letoceto’, ossia un’alleanza tra Clotario e Costantino Ulteriano in cui i due si spartirebbero la Britannia. Il nord e l’ovest al romano, il sud e l’est (meno le parti occupate dai sassoni e dagli angli) al franco. Presenti a questo incontro vengono nominati diversi personaggi importanti (e che spesso appaiono nelle saghe epiche) tra cui il Magister Militum Myrddin, detto ‘il selvaggio’, il conte Urien di Eburaco, Corotic di Luguvallio, Cunedda di Deva. Non è ancora chiarissimo se questi personaggi siano da considerare come vassalli di Costantino oppure come signori ormai quasi del tutto indipendenti. Presente come mediatore viene citato anche re Nectanio dei Pitti. La maggior parte degli storici moderni, però, dubita che una tale spartizione sia mai effettivamente avvenuta nei termini descritti.
477: Ælle il sassone guida una nuova invasione di pirati sassoni dalla terraferma. Clotario pensa di usare i sassoni ‘nuovi’ contro i sassoni ‘vecchi’, ma compie l’errore di dare ad Ælle troppo potere . Battaglia di Duroverno e grave sconfitta dei franchi contro i sassoni, tutto il Kent, il Sussex e l’Atrebatia sono occupate. Meglio va a Costantino che sconfigge un tentativo di assalto a Lindum e insegue i nemici sassoni per poi annientarli presso le grandi paludi di Durobrivo. Pochi sono i sassoni di questa spedizione che riescono a ritirarsi dall’altro lato del vallo del diavolo (le fortificazioni sassoni sull’unica via asciutta tra le paludi verso l’East Anglia). Molto probabilmente si tratta di una spedizione indipendente, non comandata dal ‘re’ (autoproclamatosi tale) sassone Æsc. Secondo alcuni storici, è da questa impresa che Ulteriano prenderà il soprannome di ‘drago’ con cui è famoso nelle saghe.
479: guerra di Dumnonia, che fa comprendere l’evoluzione in senso feudale della Britannia. il conte Erbino (Erbin) di Dumnonia giunge infatti a contesa con il conte Gurlaiso (Gorlois) di Trevena (tecnicamente suo sottoposto, peraltro) e ne sfocia una guerra. Gurlaiso arriva a chiedere l’aiuto degli juti stanziatisi a Witwara e i franco-britanni di Clotario. Per tutta risposta, Guinello di Glevia fu chiamato in aiuto da Erbino. Poiché le scaramucce tra i due schieramenti rischiavano di diventare il cavallo di Troia per una infiltrazione nemica, Costantino fu costretto a intervenire. l’imperatore punì severamente Gurlaiso, il quale, tuttavia, rifiutando l’arbitrato del suo sovrano si trincerò nella fortezza di Trevena. Sconfitto, fu condannato a morte (secondo la leggenda, prese come moglie la moglie di Gurlaiso, adottandone le figlie. Sempre secondo le saghe, fu convinto a farlo - e non abbandonarle a loro stesse - per intercessione di San Petroc). Il fatto che nascano delle guerre private tra conti fa comprendere che anche dal lato ‘romano’ c’è stato un graduale declino delle strutture amministrative imperiali, probabilmente in conseguenza dei continui conflitti.
485: Battaglia di Mercredesburne tra Ælle e i franchi, dall’esito incerto. E’ però evidente che i sassoni si impossessano della regione poi detta, appunto, del Sussex. Gli insediamenti angli nella regione del Deifr si sottomettono all’autorità di Costantino Ulteriano.
487 - 491: Campagna settentrionale di Costantino: consolidamento del controllo imperiale sulla costa nord-orientale della Britannia, con l’omaggio da parte dei signori angli che si erano stanziati a nord della grande palude dell’Abo (Huber); sottomissione vassallatica dei principi ‘d’oltre vallo’ (il già citato Corotic, ‘re Caio’ e il ‘principe Gualcafedo (Gwalltafwyn), figlio di Lot’), come erano chiamati i signori di Alt Clut e Gododdin. Costantino è ospitato dal signore di Din Eidyn e riceve in quella circostanza gli omaggi di diversi signori ‘Di Caledonia’ (ovvero dei Pitti e forse anche dei primi scoti di Dal Riata), tra cui Drest figlio di Nectanio, ‘re’ dei Pitti. Per quanto sia da dubitare che ciò comportasse qualcosa a livello sostanziale, è evidente l’interesse da parte di Costantino Ulteriano di stabilizzare ed aumentare la propria influenza nel nord, probabilmente per avere le spalle coperte in ottica di eventuali offensive a sud.
492: Morte di Onoria alla veneranda età di 74 anni. Fu decisiva nella costruzione dell’ideale della Continuatio Britannica, ossia che in virtù della discendenza teodosiana la Britannia fosse l’unico vero impero d’occidente legittimo. Prospettiva ribadita a maggior ragione dopo la consegna delle insegne imperiali d’occidente a Costantinopoli da parte di Odoacre (leggenda vuole che Costantino Ulteriano e il figlio Artorio abbiano in più di una occasione rivendicato la cessione delle summenzionate insegne, mandando ambasciate presso l’imperatore d’oriente Anastasio, che vennero tuttavia derise come barbariche. Per tutta risposta i membri della delegazione britannica affermarono che i barbari erano piuttosto gli orientali, poiché secondo i principi dinastici, anche il trono di Costantinopoli sarebbe dovuto passare ai britanni almeno dalla morte di santa Pulcheria e suo marito Marciano, mostrando così una notevole conoscenza delle genealogie imperiali. La leggenda ovviamente è priva di fondamento storico, oltre che essere stata concepita in tempi molto successivi, però contribuì nei secoli a venire al prestigio del titolo imperiale in Britannia). Negli ultimi anni della sua vita si dedicò alla fondazione di numerosi monasteri ed elargizioni pie, tanto che la chiesa celtica la considera santa (per il cattolicesimo la questione è controversa).
495: Scoppia la prima
‘disputa sui riti’. Con la diffusione del monachesimo, i centri di maggior
diffusione del cristianesimo (specie nelle campagne) sono, appunto, piccoli
cenobi di monaci eremiti, fondati in luoghi isolati (perlomeno, fin tanto che
intorno ad essi non si forma una comunità di devoti). I vescovi dei centri
urbani (i quali, tranne pochi, sono in decadenza) non sempre vedono di buon
occhio tale fenomeno, sentendosi soppiantati a livello gerarchico. In più,
iniziano a comparire alcune divergenze di natura dottrinale tra quanto
professato dai vescovi e quanto invece dagli abati dei principali monasteri (e
durante la loro peregrinatio pro Christo, nelle campagne, elemento distintivo
del monachesimo celtico). Infine, la divergenza è anche sulla lingua: i monaci
tendono a prediligere l’uso dei dialetti brettoni, predominanti nei villaggi
rurali; al contrario, i vescovi prediligono il latino (o, a onore del vero, il
dialetto latino locale). le rivalità emergono in maniera esplosiva in occasione
del battesimo di alcuni capi degli Abiani/Umbiani, o ‘Angli delle paludi’, che
si erano stabiliti, appunto, intorno alla vasta baia paludosa dell’Abo/Humber.
Il battesimo fu infatti opera di ‘San Nennio e alcuni suoi seguaci’ (ammesso che
sia effettivamente successo, chi sia effettivamente questo san Nennio, se San
Trynian, San Finnian di Clonfard o San Finnian di Movilla è piuttosto difficile,
se non impossibile, da stabilire). Il vescovo di Eburaco, di cui non sappiamo il
nome, accusò i monaci di aver agito ignorando la sua giurisdizione, oltre che
aver insegnato ai pagani delle pratiche eretiche. Costantino Ulteriano dovette
intervenire nella disputa, stabilendo un ‘doppio livello’ gerarchico: in
pratica, gli abati non erano sottoposti all’autorità vescovile e anzi, erano
equiparabili come autorità ai vescovi stessi. Allo stesso tempo però, venivano
dati ampi poteri giurisdizionali ai ‘quattro vescovadi’ ossia Eburaco, Lindum,
Verulamio e Corinio, che teoricamente dovevano ‘coprire’ i quattro punti
cardinali della Britannia (nord, est, sud e ovest). Inutile dire che la reale
influenza di tali vescovadi era inversamente proporzionale alla distanza dalla
sede cattedrale. A ciò è da aggiungere il fatto che mentre Eburaco e Lindum
riuscirono a riaffermarsi come centri di potere, Corinium (e conseguentemente il
suo vescovo) persero progressivamente di importanza a discapito di Caerleon,
Glevum e Deva. Il caso di Verulamium è invece a sé, in quanto, nonostante la
competizione con Londinio ne decrebbe lentamente nel tempo l’importanza, i
‘franco-romani’ ne fecero comunque il punto di riferimento religioso del proprio
territorio. Del resto, Sigberto, signore dei franchi a quel tempo, non accettò
il compromesso e anzi cercò di estromettere dai suoi territori qualsiasi
‘infiltrazione’ monastica di provenienza soprattutto dalla Dumnonia e
dall’Ovest, con il risultato che il vescovo di Verulamio (che iniziava ad essere
chiamata Albano, dal nome del santo patrono, nonché martire cristiano della fine
del III secolo) divenne l’autorità suprema della chiesa cristiana della
britannia franco-romana. Alcuni storici e linguisti moderni ascrivono alla
disputa sui riti l’inizio della separazione linguistica tra Britannia celtica e
Britannia romanza.
496: morte di Costantino Ulteriano, gli succede il giovane figlio Artorio
Ambrosiano, poi detto ‘il grande’. Poiché nell’ultimo periodo del suo regno
Ulteriano ha privilegiato il nord, tenendo corte prevalentemente ad Eburaco o
più raramente Deva, le province meridionali si ribellano. A capo della rivolta
vi sono diversi nobili del sud-ovest, tra cui Geraint di Dumnonia, Marco di
Cornovaglia, Usai del Ceredigion. a peggiorare la situazione, Cissa, figlio di
Ælle stipula una nuova alleanza con i franchi per conquistare l’impero
britannico, approfittando del fatto che il nuovo sovrano deve vedersela con una
rivolta generalizzata ed è poco più che un ragazzo.
498: Battaglia di Venona, la coalizione franco-sassone sconfigge il conte di Lindum; rotte le linee di difesa imperiali, i vincitori marciano verso ovest. Artorio riesce a domare la rivolta al suo dominio nelle province occidentali (non si sa se sconfiggendo i nemici o convincendoli a deporre le armi con favori), portando dalla propria parte i signori della Dumnonia.
499: Battaglia del monte Badonico: tremenda sconfitta dei franco-sassoni. Di ubicazione incerta, probabilmente tra Glevo e Corinio. Sigberto viene catturato da Artorio e gli giura sottomissione. Per quanto vi siano state discrete perdite anche tra i sassoni, questi ultimi riescono comunque ad approfittare del crollo franco per conquistare Londinio. Verulamio/Albano torna de jure sotto il controllo imperiale, ma il potere sulla regione viene di fatto affidato al vescovo della città come reggente per Childerico, secondogenito di Sigberto. Artorio inizia a dimorare stabilmente a Glevo, facendone la propria capitale.
501: sottomissione formale di Budic di Bretagna ad Artorio come legittimo imperatore d’occidente. Per quanto il resoconto di ciò sia piuttosto inaffidabile, è probabilmente vero che Artorio abbia progressivamente esteso prestigio e influenza dall’altra parte della Manica e incoraggiato i legami con l’Armorica, sia religiosi, sia politici, sia economici (che genereranno anche un discreto flusso di popolazione nei due sensi)
501 - 530 ca.: Pax
Artoriana. Dopo la grande vittoria del Monte Badonico, periodo di relativa pace,
in cui Artorio può consolidare ed estendere la propria influenza, per quanto
l’affermazione ‘tutti i signori dell’isola di Britannia, compresi i Caledoni
d’oltre vallo, gli erano sottomessi’ sia senza dubbio esagerata. Come in altri
regno romano-barbarici, si sviluppano le basi di un sistema
vassallatico-beneficiario, con una gestione patrimonialistica del potere e
l’emergere di grandi famiglie di conti, oltre all’insorgere di contese che a
volte sfociano in guerre private-locali. Ciò detto, Artorio pare abbia
sviluppato anche un organismo assembleare che ad intervalli regolari gli
permette di radunare presso la corte i principali feudatari del regno. Da questo
strumento politico, piuttosto simile ai capitolari franchi, nacque la successiva
leggenda della tavola rotonda, grande assise presso cui si riunivano i
principali e più fidati cavalieri del mitico re, i quali partecipavano alle sue
mirabolanti imprese guerresche.
Durante questo periodo non si ferma comunque l’infiltrazione dell’elemento
anglo-sassone in Britannia, per quanto in diverse zone prenda ormai più le forme
di un ripopolamento di zone abbandonate (con il benestare stesso di Artorio) che
di una vera invasione. Il caso più eclatante di anglosassoni ‘autorizzati’ e
sottomessi all’impero fu lungo la costa meridionale e appena all’interno, in
quella che approssimativamente era l’Atrebatia in epoca romana, presso cui si
stanziò il capo sassone Cerdico (anche se al giorno d’oggi si specula sul fatto
che il nome tradisca origini britanniche, per cui fosse in realtà un capo
britannico alla guida di un seguito armato anglosassone), che rimase per tutta
la sua vita fedele alleato di Artorio e che quest’ultimo ‘usò’ per tenere
d’occhio da un lato i franco-romani della Britannia centro-meridionale, centrati
intorno ad Albano-Verulamio, dall’altro la sempre piuttosto riottosa nobiltà
della Dumnonia. Altro caso importante fu l’infeudazione delle grandi paludi del
Deifr, tra Lindo ed Eburaco, a tribù angle ‘cristiane’ (prima esplicita menzione
di anglosassoni cristianizzati), con la missione di bonificarle. In aggiunta,
Artorio permise che dalla stessa zona partissero dei coloni Anglosassoni verso
nord, tra i due valli, per fortificare i confini ‘con i caledoni’, nella zona ‘
poi detta di Bernicia’. Peraltro questo dato indica abbastanza chiaramente che i
rapporti con Gododdin e Alt Clut alternavano momenti di pace (il principe Lot di
Gododdin spesso appare come cavaliere della tavola rotonda, nelle saghe) e
sottomissione, a momenti di ribellione e guerra.
Per quanto riguarda il nord, abbiamo anche menzione di relazioni positive tra
Artorio e ‘il conte Gallo Domanio (Comgall Mac Domangairt), sire degli scoti,
che dall’isola di Ibernia si erano insediati in Caledonia e che spesso con i
Caledoni scendevano a contesa’.
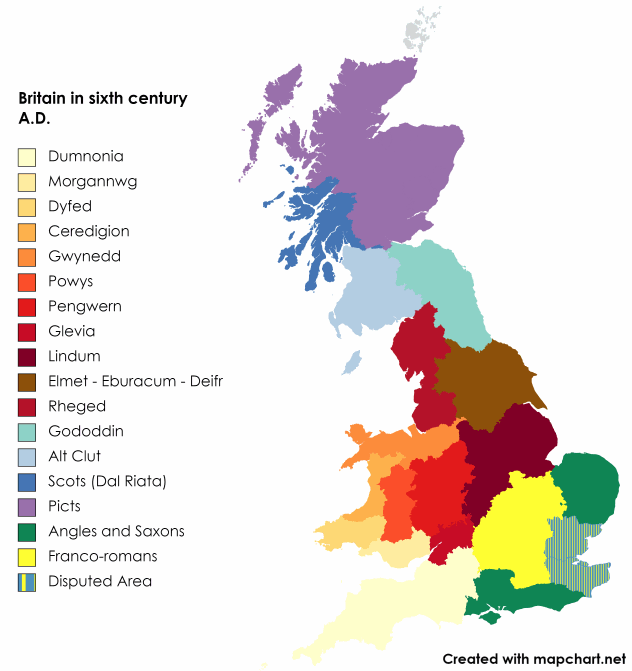
517: Secondo la tradizione, anno del sinodo di Glevo: gli arcivescovi di Eburaco e Verulamio ed il vescovo di Lindo (i ‘vescovi orientali’) scrissero una nota congiunta che accusava di pelagianesimo san Dubricio di Llandaf, il quale aveva, stando a successive leggende, incoronato Artorio. Su ordine del sovrano, venne convocato dunque un sinodo di tutti i principali vescovi e abati dell’isola, perché Dubricio potesse difendersi dalle accuse e per sancire una precisa definizione di quali effettivamente fossero i comportamenti ‘pelagianizzanti’. Per i tre prelati accusatori il sinodo si trasformò in una sconfitta, dato che Dubricio venne giudicato innocente da qualsiasi accusa di eresia. Per quanto riguarda gli ‘atti pelagiani’, i prelati ‘orientali’ erano sostenitori di una linea particolarmente dura (che a quanto pare andava anche a toccare la lingua in cui si amministravano i sacramenti, prova che nella britannia dell’ovest spesso si usava la lingua britannica per dire messa anziché il latino), mentre i prelati occidentali obiettavano che molte riforme proposte nulla avevano a che vedere con il combattere l’eresia pelagiana. Per quanto venisse stabilita l’esistenza di alcune deviazioni dall’ortodossia nella pratica comune che era necessario correggere, il verdetto fu comunque in generale favorevole alla linea occidentale (cosa che comunque non impedì ai tre vescovi sopracitati di imporre per un lungo periodo i propri parametri nelle zone di propria pertinenza). Per quanto la storiografia recente sia propensa a ridurre l’importanza simbolica di tale evento (a favore di una interpretazione gradualista), a questa data si fa tradizionalmente risalire la divisione tra ‘cristianesimo celtico’ (occidentale, in lingua brettone) e ‘cristianesimo latino’ (orientale, in latino medievale di Britannia). Quest’ultimo non è da confondersi con il ‘cristianesimo romano’ (spesso poi anche chiamato impropriamente ‘cristianesimo anglosassone’), ossia quello portato, a partire dal 600 d.C., dalla missione di Agostino di Canterbury.
530 - 535 d.C.: Crisi dinastica con la morte dei figli maggiori di Artorio, Aimaro e Lucio Artoriano. Le fonti in merito non danno una spiegazione chiara di ciò che è accaduto; le interpretazioni vanno dalla morte in battaglia (contro il padre o contro il terzo fratello per difendere il padre, a seconda), all’incidente di caccia o, forse, un tentativo di colpo di stato contro il padre.
536 d.C.: morte di
Artorio. Inizio degli anni ‘senza estate’, con devastanti carestie in tutta
Europa, Britannia compresa. regno di Medrauzio (Medraut/Mordred) Artoriano, su
cui graveranno diverse leggende nere, tra cui: quella di non essere figlio
legittimo di Artorio (questa è però probabilmente vera); quella di aver ucciso
Artorio per prendere il potere approfittando della morte dei suoi fratelli
maggiori; quella di aver istigato i fratelli maggiori alla ribellione contro il
padre, per poi ucciderli (e uccidere Artorio); quella di essere figlio di un
incesto tra Artorio e la sua sorellastra Morgana; quella di aver violentato la
madre dopo aver ucciso il padre; quella di aver venduto la propria anima alle
forze del male per portare alla rovina il regno (per vendicarsi di un qualche
torto subito dal padre).
La probabile verità è che i difficilissimi anni dopo il periodo pacifico e
prospero di Artorio dovevano avere un capro espiatorio. Di recente si è supposto
che nella diffusione di questa leggenda nera forse abbia qualcosa a che fare
Costantino di Dumnonia, che nella letteratura britannica passa addirittura come
un santo. Approfittando della debolezza della posizione del figlio di Artorio,
infatti, Costantino probabilmente tentò di usurpare il trono di Glevo o,
quantomeno, ribellarsi al potere imperiale.
536 - 556: ‘Anni neri’. La grande carestia è seguita da una altrettanto devastante epidemia di peste, mentre continue ribellioni spezzano l’unità dell’impero. In questo periodo emerge come uomo forte la figura di Costantino (Custennin) di Dumnonia, il quale si (auto?)proclama reggente dell’impero in virtù di una non certissima relazione di parentela con Artorio (di cui è nipote, quindi figlio di un fratello di Artorio; o cugino, quindi figlio di uno dei fratelli di Costantino Ulteriano). Il fatto però che le leggende in lingua romanza del nord e le leggende scote considerino Medrauzio vittima di tradimento da parte di Costantino di Dumnonia, ci fa capire che ci fu una vera e propria guerra civile. Probabilmente Medrazio, con la sua famiglia, si rifugiò ad Eburaco e cercò l’aiuto di Pitti, Scoti e Sassoni per riprendersi il regno. In particolare, tra questi ultimi, si affidò all’ausilio del clan degli Iclingas, i cui capi erano Cnebba e Cinevaldo (che si stanziarono nella regione tra Rata e Durobrivo); allo stesso tempo, anche Cinrico (Cynrin), figlio di Cerdico, fu un feroce rivale di Costantino di Dumnonia, per quanto non sappiamo se per espandere i propri domini personali o per fedeltà a Medrauzio. il dominio semi-indipendente franco-romano di Albano, mai più veramente ripresosi dopo la battaglia del Monte Badonico, di fatto in questo periodo scompare, o meglio viene ‘sostituito’: si crea infatti la signoria di Albania, un feudo semi-indipendente romano-sassone. Il primo dei signori dell’Albania britannica è un certo Cingo, che secondo la leggenda sconfigge a duello Cunimondo dei franchi su preghiera del vescovo di Albano, in quanto Cunimondo era dedito a pratiche eretiche, magia nera e opprimeva il popolo. Questa storia molto probabilmente delinea uno scontro interno tra una fazione guidata dai franchi (probabilmente favorevole a Costantino) e una guidata dal vescovo (probabilmente favorevole a Medrauzio o, quantomeno, a Cinrico), con la vittoria della seconda.
ca. 550: Ascesa di Artorio II Cangrande (Melehan/ Maelgwn), figlio di Medrauzio. Le opinioni su di lui sono più variegate rispetto a quelle di suo padre (o, per alcuni storici moderni, di suo nonno), visto che alcune fonti lo descrivono come un tiranno peggiore del padre, altre come un eroe o addirittura un santo. E’ probabile che il suo indubitabile lavoro per il ripristino dell’autorità regia dopo gli anni neri, oltre al suo essere vittorioso in diverse battaglie contro quelli che ormai non potevano essere considerati altro che usurpatori (nonostante gli sforzi per legittimarsi) difficilmente avrebbero potuto avvenire senza che avesse le potenze celesti dalla sua parte, agli occhi di cronisti posteriori. Le maggiori resistenze a considerarlo una figura interamente positiva si devono presumibilmente al fatto di essersi circondato di uomini del nord, albaniani, sassoni cristianizzati, caledoni e scoti, piuttosto che l’aristocrazia del sud-ovest (ancora troppo legata all’usurpatore)
556: Battaglia di Beran Byrig, che pone simbolicamente fine agli ‘anni neri’. Di ubicazione incerta, vede la vittoria di Cangrande, assieme ai suoi alleati sassoni comandati da Cinrico e suo figlio, Ciaulino (Ceawlin) contro Costantino di Dumnonia (che forse muore nello scontro). La domanda che ancora adesso è di difficile risposta è per quale motivo la leggenda nera nei confronti di Medrauzio non sia stata ‘cancellata’ dalla propaganda del vincitore e la figura di Costantino sia rimasta sostanzialmente positiva. Forse (ma è una mera speculazione), Cangrande tentò una politica (non necessariamente riuscita) di riconciliazione con i ribelli, per quanto ciò implicasse l’accettazione della demonizzazione del padre. A riprova di ciò è la leggenda secondo cui la morte di Costantino non sia stata per mano di Cangrande (che al contrario lo graziò), ma per mano del suo parente Conan di Cornovaglia, peraltro descritto in maniera negativa e che, per questo gesto, venne condannato a morte dallo stesso Cangrande. E’ da aggiungere che, sempre secondo questa versione, Conan si fa interprete della ‘giustizia di Dio’, espiando così l’unico grande peccato di Costantino, ossia quello di aver sparso sangue - reale, per giunta - su suolo consacrato (poiché dopo la battaglia vittoriosa contro Medrauzio, i figli di quest’ultimo si erano rifugiati all’interno di una chiesa, ma vennero inseguiti da Costantino fin dentro l’edificio. Solo Cangrande riuscì fortunosamente a sopravvivere, mentre i suoi fratelli vennero uccisi).
563: Arrivo di San Colomba dall’Irlanda presso il re di Dal Riata Conaglio (Conall). Successivamente si recherà alla corte di Re Bridei dei Pitti (che da lui forse sarà convertito al cristianesimo). Dopo aver fondato l’abbazia di Iona, con l’intenzione di farne un centro culturale e missionario, si recherà anche presso la corte di Cangrande, diventandone per diverso tempo consigliere. Da ciò deduciamo che l’imperatore teneva corte a Eburaco (evidentemente i territori dell’ovest e del sud non erano ancora completamente sotto il suo controllo). Alcune fonti sostengono che egli mediò un trattato di pace tra Bridei e Cangrande, ai ferri corti per l’influenza nella terra tra i due valli (che di fatto significava una guerra per procura tra i vari principati della zona, principalmente Gododdin e Alt Clut); in particolare c’erano state diverse scaramucce tra il principe Roderico (Rhydderch), figlio del re di Alt Clut e Guendoleo (Gwendoleu), conte di Arfderydd da un lato e le incursioni del romano-sassone Addone (Adda) lungo la costa orientale tra i due valli, dall’altro.
570 ca.: Deva diventa la capitale dell’impero di Britannia. Nel frattempo, cresce enormemente il potere di Ermanrico (Eormenric), re sassone di Canzia (Kent), che in questo periodo sottomette alla sua autorità i principi sassoni vicini. Il principato dei sassoni occidentali si divide in una fazione fedele a Cangrande e una allineata ad Ermanrico, il quale può peraltro contare sull’amicizia con il re franco Cariberto di Neustria.
571: Sale al trono Artorio III Ruino (Rhun), detto ‘l’alto’ (Hir). L’inizio del suo regno non è dei più felici. Cutvulfo (Cuthwulf), fratello di Ciaolino, fedele però a Ermanrico (nonché pagano), conquista l’Albania con la battaglia di Bedecano (Bedcanford) e se ne proclama signore, forse con l’aiuto di mercenari franchi.
573: Roderico, ora re di Alt Clut, sconfigge Guendoleo, di fatto segnando la perdita del controllo imperiale sulla costa nord-occidentale della Britannia.
577: Dopo i rovesci iniziali, Ruino mette a segno una grande vittoria nella battaglia di Duramia (Deorham o Dyrham). Glevo e Corinio tornano fermamente sotto il controllo imperiale.
580 ca. ‘Ricostruzione’ del dominio imperiale nel nord-ovest e oltre il vallo, grazie agli sforzi di Urien di Reghedia (Rheged), Gallago di Elmezia (Gwallawc ap Llennawc), Teodorico il sassone e Morgante di Brinecia (Deoric e Morcant), i quali riducono a miti consigli Roderico, il quale dopo una serie di sconfitte si sottomette all’imperatore Ruino. Le lotte per guadagnarsi il favore dell’imperatore minano però l’armonia tra i conti del nord, con il risultato che Morgante cerca di assassinare (o forse riesce a farlo, in alcune versioni) Urien, al fine di creare un grande regno indipendente del nord. Ruino interviene prontamente e punisce Morgante, soprattutto grazie alla fedeltà di Teodorico, il quale ottiene parte delle terre confiscate al traditore, mentre la restante porzione va proprio a Urien (nelle versioni che vogliono quest’ultimo morto, nell’isola tidale in cui Morgante intrappola e uccide Urien, Ruino pensa di far costruire un grande monastero alla sua memoria, l’abbazia di Medicauzia (Ynys Medcaut; HL: Lindisfarne)). Secondo gli storici moderni, la ‘concessione di Teodorico’ è la base dell’espansione del volgare latino-britannico settentrionale (che probabilmente già in questo periodo era abbastanza nettamente distinguibile da quello meridionale, l’albaniano) oltre il vallo di Adriano, lungo la costa orientale.
Continua...
Postilla: Collegare miti e leggende
con una razionalizzazione storica di quel periodo non è semplicissimo. Alcune
note sparse:
1) La decisione di agganciare la dinastia arturiana con quella reale del Gwynedd
è piuttosto arbitraria, anche se, al di là dell’assonanza del nome tra il
supposto figlio di Mordred e alcuni re gwyneddiani del VI secolo (‘Grande Cane’,
ossia Meleuno – Meglecuno), davvero ritengo che storicamente la battaglia di
Camlann ci sia stata e sia da intendersi come un conflitto tra i britanni
‘settentrionali’ (quindi compreso il Gwynedd) e i britanni ‘meridionali’
(compresa quindi la Dumnonia). Non per niente è considerata dalle triadi gallesi
la prima delle ‘tre inutili battaglie dei britanni’ (inutili perché vedono
britanni contro altri britanni e che alla fine avvantaggiano solamente i
sassoni).
2) Il diverso posizionamento degli Hwisse – Wessex, degli Iclingas – Merciani e
dei Deirani e Berniciani nello scacchiere delle alleanze (ossia sassoni ‘di
parte imperiale’ e più meno cristianizzati) invece è pressoché diretta
conseguenza del mancato crollo della ‘latinità’ (anche a livello ideologico –
religioso ), soprattutto intorno a Eburacum, Lindum e Verulamium. Per
intenderci, Deirani, Berniciani e Merciani in questa TL si latinizzeranno
pressoché totalmente; i sassoni dell’ovest invece subiranno una sorte simile ai
franchi d’Austrasia (in parte si latinizzeranno o minimamente britonizzeranno,
mentre un’altra parte rimarrà germanica o addirittura si rigermanizzerà)
3) Ecco svelate le ‘tre parti’ del titolo: la Britannia romana, quella
brittonica, quella anglosassone. Chiaramente si tratta di una semplificazione
letteraria, poiché:
A) come spero si sia notato, le varianti linguistiche all’interno di ciascuno di
questi continuum si stanno allontanando tra di loro (per contingenze
geografiche, politiche, religiose) al punto da diventare vere e proprie lingue a
sé. Per dire, il romanzo di Britannia già a fine sesto secolo ha una sua
versione meridionale (l’albaniano) distinta da quella settentrionale (centrata
su Lindum, Eburacum e la Bernicia) e il processo non farà che continuare,
perlomeno fin dove sono arrivato a pensare a grandissime linee questa ucronia
(ossia fino all’anno mille). Stessa cosa vale chiaramente per il britannico,
anche se non l’ho fatto rilevare nel testo.
B) se dovessi considerare l’intera isola di Gran Bretagna, chiaramente la
divisione non sarebbe solo in ‘tre parti’: ci sarebbero i Pitti e gli Scoti che
farebbero ‘parte’ a sé. Se poi dovessi considerare in proiezione anche il futuro
rispetto a dove sono arrivato, almeno per un certo periodo dovrei considerare
anche il norreno.
.
Gli risponde il grande Bhrihskwobhloukstroy:
Riguardo all'aspetto linguistico della Tua ucronia, provo a ricapitolare alcune nozioni (abbastanza banali) in merito:
1) Grado di differenziazione interna del britannoromanzo: nel resto della Romània continua (dalla Spagna alla Gallia all’Italia e alla Dalmazia), i confini fra rami o diasistemi di basiletti (ove tali rami vengono comunemente chiamati con i glottonimi popolari: spagnolo, occitanico, francese, cisalpino, italiano, dalmatico &c.) si sovrappongono a quelli delle Diocesi (naturalmente le imperiali, non ecclesiastiche); a quelli delle singole Provinc(i)e, invece, i confini dei sottorami (guascone, linguadociano, alverniate, delfinatese, provenzale &c.). Ne consegue che il gruppo britannoromanzo sarebbe differenziato al proprio interno più o meno come le regioni “dialettali” francesi, nonostante le vistose e importanti divisioni politiche (che nei secoli decisivi sono state presenti anche in Gallia). In pratica: tutto il britannoromanzo sarebbe stato percepito come un’unica “lingua” (tecnicamente invece un diasistema) e – ciò che può avere notevoli conseguenze – avrebbe potuto elaborare un acroletto comune (di cui non sto a tentare di ricostruire, in modo inevitabilmente arbitrario, una denominazione, se non solo per dare un’idea: *bretagnano?).
2) Caratteristiche linguistiche del britannoromanzo: è l’oggetto di un filone di studî – non ucronici – realmente esistito (nonché tuttora esistente) e le posizioni si possono raggruppare in due. La più comune, fortemente indiziata dai latinismi (volgari) in britannico, è che fosse un insieme di varietà romanze occidentali (difficile da distinguere dal galloromanzo comune, di fatto un normanno preistorico); la seconda è che invece rappresentasse un’area arcaizzante in quanto marginale e isolata (dunque simile, ovviamente per conservativismo e non per contatto, al sardo). In effetti le due posizioni sono lontane e apparentemente inconciliabili, ma l’iberoromanzo fornisce un modello per salvarle entrambe: un sottogruppo comprendente varietà abbastanza diverse quali i mozarabici da un lato (a loro volta ben distinti fra loro, alcuni innovativi altri arcaici) e le tradizioni tuttora esistenti dall’altro (notoriamente distinte almeno fra gallego-portoghese, asturiano, cantabrico, castigliano, aragonese e catalano-valenziano-balearico). Si nota, fra l’altro, che le varietà più arcaiche – quindi più vicine al latino – sono al contempo quelle dei maggiori centri romani della Penisola e che poi sono rimaste più distanti dal nuovo centro innovatore (la Gallia): proiettate sulla Britannia, le due caratteristiche non sono però più solidali fra loro (giacché i principali centri romani sono anche i più vicini alla Gallia) e quindi bisogna incrociarli. Per semplificare in modo brutale, potremmo individuare un ‘polo’ arcaico (vagamente simile al sardo) a settentrione del Vallo (sia perché marginale sia perché seriore) e uno galloromanzo a Londra (una sorta di normanno arcaico, con qualche innovazione in meno, sia perché più marginale sia perché la città era un importantissimo centro romano, dunque più sintonizzato con l’ufficialità conservatrice).
3) Divergenza del britannico e dell’anglosassone ucronici da quelli storici: la causa più significativa sarebbe la (assai) maggiore esposizione a una lingua romanza (che, fra i due poli, sarebbe più spesso il londinese). Non so che trattamento ucronico hai in progetto per i Normanni, ma questa circostanza costituisce una sorta di garanzia che i normannismi di entrambi i gruppi (anglosassone e britannico) ricorrerebbero almeno in egual misura e abbastanza simili a quelli storici.
Fra gli etnici, inclinerei ad *albanico, *eburacio e *lindico (come italianizzazioni del tardolatino, che a sua volta trascriveva gli omologhi dal sostrato britannico); in britannoromanzo potrebbero suonare, molto approssimativamente, *aubagne, *yvourais e *lendge.
Mi aspetto l’osservazione di qualche (direi – a quel che devo constatare – pressoché ucronico) lettore dei nostri messaggi: il britannoromanzo e il francese non verrebbero percepiti come “dialetti della stessa lingua” (quali in effetti sarebbero, ma non nell’accezione non tecnica di questi termini)? Credo di immaginare la Tua risposta e che la mia le corrisponda: dipende dalla Storia geopolitica dei secoli successivi....
.
Chiudiamo con la nota di Filippo Euronymous Marani Tassinari:
Vi propongo una cartina della raccolta di racconti ucronici di Harry Turtledove "L'agente di Bisanzio". In questo universo l'Impero Bizantino ha evitato le invasioni arabe e mantenuto il proprio status di superpotenza, e ovviamente mantiene la propria rivalità con i persiani sasanidi. Il narratore è una specie di "James Bond" bizantino. I racconti sono davvero interessanti e scritti molto bene; inoltre tra una avventura e l'altra la nostra spia scopre il cannocchiale, i vaccini e la stampa!
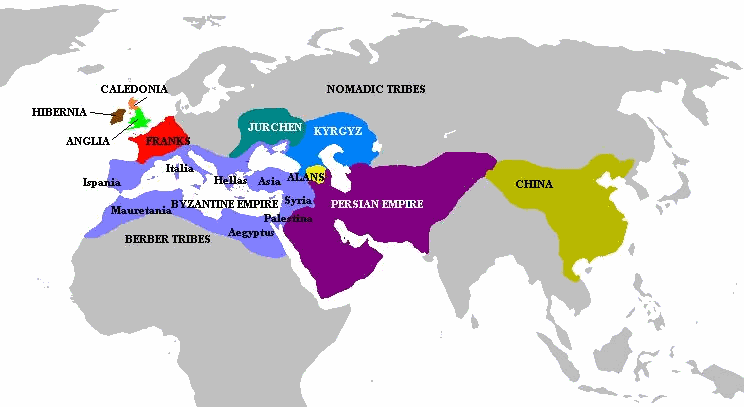
.
Se volete partecipare alla discussione, scriveteci a questo indirizzo.
