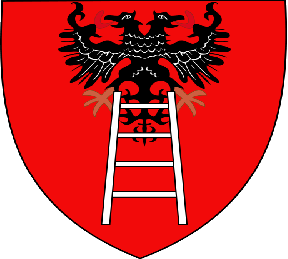
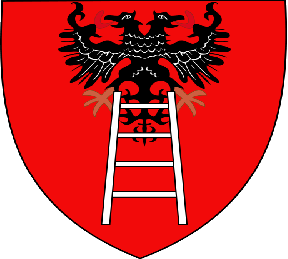
A livello ucronico, molto spesso si parla dei “candidati eccellenti” per l'unificazione tardo-medievale italiana. Di solito si passa direttamente dal duecento, con Federico II di Svevia e, al più, Ezzelino da Romano, direttamente alla fine del trecento: i più popolari sono Gian Galeazzo Visconti e Ladislao d'Angiò, vissuti tra l'altro in un periodo molto vicino.
A volte, invece, si punta sul cavallo veneziano, nell'ipotesi del fallimento dell'insediamento dello Sforza a Milano e la caduta della capitale viscontea nelle mani della Serenissima repubblica.
Molto meno accreditata è la carta scaligera. Eppure,
Cangrande della Scala può a buon diritto essere considerato un serio candidato al titolo di aspirante re d'Italia. Se le sue vittorie appaiono meno sfolgoranti di quelle del Visconti un cinquantennio abbondante dopo la morte dello scaligero, non sono certo meno trascurabili, anche perché evidenziano, nel loro complesso, una progettualità nel costruirsi un'omogenea base di potere nell'Italia nord-orientale, foriera di interessanti sviluppi.
E' grazie a questa base che il suo successore Mastino II potrà lanciarsi nelle sue campagne di conquista. Ma se Mastino era fornito quanto il cugino di talento militare(anzi, molto di più), la stessa cosa non si può dire per quanto riguarda l'ambito politico, diplomatico e strategico. E il troppo voler con la forza delle armi in tempi rapidi determinò un'alleanza generale anti-veronese che segnò la parola fine alle ambizioni di gloria della casa scaligera.
Cangrande morì relativamente giovane e senza un erede diretto legittimo. Aveva 38 anni e si era appena assicurato il dominio sulle antiche rivali, Padova e Treviso. Era pronto per il compito successivo, il più difficile: il consolidamento dei suoi successi e l'espansione del suo raggio di influenza (anche al di fuori dei confini italiani).
La riesumazione del suo corpo nel 2004 avvalorò una tesi che era sempre stata trascurata dalla storiografia italiana: la sua morte fu molto probabilmente dovuta ad avvelenamento da digitale. Forse si trattò di un errato dosaggio di quella che veniva considerata, presa in piccole quantità, una medicina.
Sia come sia, poniamo che l'abile signore di Verona non rimanga intossicato e raggiunga un'età veneranda, nonostante i suoi problemi al fegato...
Siamo nel 1329. Dopo i trionfi di rito per l'assunzione del potere anche a Treviso, prevalgono ora i dubbi. I due alleati di ferro di un tempo, Milano e Venezia, ora sono preoccupati dell'espansionismo veronese. I primi, in particolare dopo lo sfoggio di soverchia potenza e ricchezza durante l'incoronazione di Ludovico il Bavaro, sono ormai palesemente gelosi del suo ascendente e del suo strapotere sullo schieramento ghibellino. I secondi, dopo la conquista di Treviso, non gradiscono un vicino di casa così ingombrante. E i pretesi diritti scaligeri sulle saline rovighesi rappresentano un'ulteriore fonte d'irritazione.
Evidentemente, ora è il momento di rallentare il passo. Perdere un alleato come Milano e la vitale collaborazione economica con i Veneziani sarebbe un colpo mortale. Tanto più che nemmeno oltralpe si guarda con fiducia a Cangrande. E i guelfi non attendono altro che un suo isolamento diplomatico per sferrare un colpo mortale. E I rapporti con Napoli e con la curia sono, come sempre, pessimi.
Come prima cosa, decide di dare una base legale al proprio potere. Rispolvera l'antico concetto di “marca veronese”, leggermente modificato, in ossequio ai mutati tempi, in “marche veronese e trevigiana”. L'ultimo detentore legale del titolo, era stato, un secolo prima, Ezzelino da Romano.
Cangrande offre perciò all'imperatore una cifra spropositata per ottenere il titolo di marchese. Il bavaro però la prende male e rifiuta malamente, per quanto i soldi gli facessero comodo. L'unica cosa che è disposto a dargli è il titolo di vicario imperiale per Padova e Treviso. Ma quello, ormai, è un titolo che non soddisfa più lo scaligero. Nonostante ciò, il signore di Verona comincia comunque ad usare il termine di “marchio Veronae et Tarvisii” nei documenti ufficiali.
In secondo luogo, decide di regolare la posizione nei confronti della Serenissima repubblica. Quest'ultima, per tradizione, non si allea mai con una potenza della terraferma, seguendo una politica di rigida neutralità. Ma se non si può parlare di alleanza, quella che il doge stipula con
Cangrande è qualcosa che ci va molto vicino: oltre alla concessione della cittadinanza veneziana al “marchese”, onore che in laguna si era estremamente parchi a concedere, il signore scaligero concede la presenza di un console veneziano non solo a Verona, ma anche a Vicenza, Padova e Treviso, oltre che alla riduzione del dazio di porta nelle seguenti città per i commercianti della Serenissima.
Verona diventa così l'intermediario privilegiato di Venezia per i suoi commerci con l'Italia settentrionale e l'impero germanico.
Nel 1330 Cangrande decide di riprendere il conflitto con Brescia. I ghibellini bresciani riescono nel colpo di mano e aprono le porte della città all'esercito veronese.
Cangrande decide di affidare la città a Pinalla Aliprandi, in qualità di vicario per Azzone Visconti. In pratica, sta regalando Brescia ai Visconti, nel tentativo di rinsaldare l'amicizia tra le due potenze ghibelline. Azzone si rende conto delle finalità della manovra. Dopotutto, però, ne è compiaciuto: per lui è una evidente manifestazione dei limiti del potere scaligero: Verona ha un bisogno estremo dell'amicizia di Milano.
Cangrande, inoltre, sostiene, contro il pontefice, l'elezione ad arcivescovo di Milano di Giovanni Visconti contro Aicardo Antimiani (che comunque era vescovo di una città in cui non poteva mettere piede).
Ulteriore sforzo di buona volontà di
Cangrande nei confronti dei Visconti si può osservare nella vicenda di Lodrisio.
Lodrisio, zio di Azzone, rimasto escluso dalla spartizione del potere in seno alla famiglia, trama per conquistare Milano. Riesce ad organizzare una base di potere tra cremonese e mantovano. I Gonzaga, che da poco hanno silurato i Bonaccolsi a Mantova, sono propensi a sostenere l'ambizioso Lodrisio. Nel frattempo i Gonzaga si assicuravano il controllo di Modena e Reggio. Anche Parma e Piacenza garantiscono il loro sostegno. Lodrisio invia messi a
Cangrande, garantendogli, se fosse diventato signore di Milano, ampie garanzie politiche ed economiche. Per tutta risposta lo scaligero imprigiona i messi e li spedisce ad Azzone, garantendogli sostegno militare contro
Lodrisio.
Mentre si susseguono rapidamente questi eventi, appare chiaro al fronte guelfo che occorre muovere una guerra totale all'asse Visconti-Della Scala prima che sia troppo tardi, approfittando della scheggia impazzita rappresentata da Lodrisio.
Ma l'unità dei guelfi non è così compatta. Inoltre i ghibellini in molte città del centro iniziano a rialzare la testa, creando disordini e tumulti.
A sconvolgere le carte è anche l'azione del duo Bertrando del Poggetto (vicario del papa e di fatto signore di Bologna)-Giovanni di Boemia. Quest'ultimo, sceso in Italia, strappa ai Visconti Brescia, trasformandola nella sua base operativa, e prende il controllo anche di Parma, Piacenza, Vercelli e Pavia.
Firenze, capofila del guelfismo in Italia, a questo punto non sa che fare. Appoggiare le mire egemoniche di Giovanni e Bertrando in nome del partito guelfo per annientare Visconti e Scaligeri, o ribaltare le alleanze per sconfiggerli?
Molte città guelfe si fanno le stesse domande.
Cangrande e suo nipote Mastino da una parte, Azzone e Giovanni Visconti dall'altra faticano a fermare la triplice minaccia di Giovanni di Boemia, Bertrando del Poggetto e Feltrino Gonzaga.
Ad accorrere, inaspettatamente, in loro aiuto, ci pensa re Roberto d'Angiò, che, dando prova di spregiudicato realismo politico (anche perché le città guelfe del settentrione guardavano a lui come signore e non voleva che il papa riducesse la sua influenza politica), decise di tenere dieta a Genova, nel 1332 tra i rappresentanti delle città italiane ostili al sovrano boemo ed al legato pontificio, senza distinzione tra guelfi e ghibellini.
Roberto promosse così una insolita lega anti-bolognese, cui parteciparono le ghibelline Verona, Milano e Ferrara e le guelfe Napoli e Firenze.
Nel 1333, con l'aiuto determinante di Mastino della Scala, la lega di Genova sconfigge pesantemente le truppe di Bertrando nei pressi di Ferrara. Giovanni di Boemia concluse una frettolosa pace e se ne tornò in patria, abbandonando al suo destino il legato. Quest'ultimo riuscì a scappare e trincerarsi con suoi uomini a Bologna. Ma era la stessa città ad essere stufa del suo dominio tirannico e dell'eccessivo fiscalismo volto al mantenimento del suo esercito mercenario. I felsinei si ribellarono e abbatterono il suo governo. Solo grazie alla mediazione fiorentina poté lasciare incolume l'Italia per tornare alla corte
avignonese.
Ai vincitori, le spoglie. Chiusi i conti con i due stranieri, Cangrande della Scala e Giovanni Visconti si preparano a regolare i nemici casalinghi. Una dopo l'altra cadono sotto il dominio milanese Brescia, Vercelli, Pavia, Piacenza, Parma. Gli Este, muovendo da Ferrara in alleanza con i veronesi, prendono Modena e Reggio. Brescia viene annessa al dominio scaligero; invece Mantova la prende Verona, con un gesto nemmeno poi tanto corretto, visto che prima dell'uragano di Giovanni di Boemia, Verona aveva deciso di donarla, più o meno, all'orbita milanese. La parabola dei Gonzaga finisce ancor prima di incominciare.
Questi eventi rappresentano un punto di svolta per la situazione italiana. Roberto, impegnato nelle dispute per il controllo della Sicilia con gli aragonesi, non riesce ad intervenire; i papi di Avignone, dopo il fallimento di Bertrando sono sulla difensiva. Solo Firenze sembra ancora resistere all'ondata di ghibellinismo che avanza in Italia, soprattutto per merito della diarchia Milano-Verona.
Ora quest'ultima città domina anche il medio corso del Po, grazie al controllo su Mantova.
Le città di Lucca, Pistoia e Pisa, tradizionalmente anti-fiorentine, dopo la morte di Castruccio Castracani videro una ripresa delle attività della fazione guelfa. Al che le parti ghibelline delle tre città si riunirono a Pisa, creando una lega ed invocando l'aiuto dei “tiranni de' lombardi”, ovvero Mastino della Scala e Luchino Visconti.
Siamo nel 1337. Sembrava fosse finalmente giunto il momento decisivo per mettere la parola fine alla potenza fiorentina, in grado di frustrare qualsiasi tentativo di conquista dell'Italia.
Roberto d'Angiò accorse in aiuto della città, mentre si andava formando un imponente esercito.
I comandanti ghibellini erano Mastino della Scala, Obizzo III d'Este, Luchino Visconti, Giovanni di Monferrato.
Nei pressi di Scarperia l'esercito guelfo e quello ghibellino si scontrarono. Fu, forse la battaglia più importante combattuta sul suolo italico dai tempi dei romani.
Alla fine della giornata, il campo apparteneva ai ghibellini. Molti però furono i morti illustri dall'una e dall'altra parte. Su tutti, lo stesso Luchino Visconti.
Firenze si era preparata alla possibilità di un assedio, ma la gravità della sconfitta ne aveva reso l'esito quasi scontato. Mastino, inoltre, era riuscito a convincere i milanesi a restare nonostante la morte del proprio comandante, mentre così non si poteva dire del contingente napoletano di Roberto, che preferì tornare a Napoli e già si preparava a stipulare una pace con i vincitori.
Il 20 luglio del 1338, Firenze veniva espugnata. I ghibellini rientrati si abbandonarono ad ogni sorta di vendetta contro i nemici che li avevano esiliati ed espropriato tutti i loro beni. A capo della città fu posto un consiglio di 10 uomini di provata fede ghibellina, sottomessi, però alle grazie milanesi e veronesi. Capo di questo consiglio venne posto come podestà il vecchio Truffino degli Amidei, che, però, di fatto, rispondeva più alle potenze “forestiere” che l'avevano voluto in quella posizione, piuttosto che al popolo fiorentino o al consiglio stesso.
Il trionfo del ghibellinismo nell'Italia centro-settentrionale lasciava però presagire una triste sorte per le libertà. Stava per finire il tempo delle signorie e si avviava, lentamente ma inesorabilmente quello degli stati regionali.
A questo punto, sembrò inevitabile che gran parte delle città toscane o umbre si “collegassero” a Milano o Verona. La colleganza permetteva di mantenere, in ottica di chi la chiedeva, una libertà formale in cambio di una certa tranquillità sociale e di una difesa militare in caso di guai.
A questo punto, gli attori principali nello scenario italiano sono Milano, Verona e Napoli. Nel ruolo di comprimari di un certo peso vi sono gli Este di Ferrara, Venezia, Genova, il Monferrato, i Savoia, i conti di Gorizia, gli aragonesi in Sicilia. Oltre, ovviamente al papato ed all'impero, che non mancavano di influire nei continui mutamenti politici in corso.
E' chiaro però che il panorama degli attori era destinato a restringersi ulteriormente. Era chiaro sia a Giovanni Visconti, che dopo la morte di Luchino aveva chiamato al governo i tre figli di Stefano Visconti, sia a
Cangrande della Scala, che nel frattempo era riuscito ad avere, finalmente, un figlio legittimo.
La sua prima moglie Giovanna d'Antiochia, di cui era bisnonno il grande Federico II non gli aveva dato eredi legittimi. Nel 1330 morì in circostanze misteriose. Alcuni insinuano che per motivi di pragmatismo politico l'abbia fatta uccidere
Cangrande stesso. L'anno successivo, nel 1331, lo scaligero sposò Agnese, figlia del conte Enrico II di Gorizia. Nonostante le ragioni del matrimonio fossero squisitamente politiche, alcuni cronisti del tempo affermano che fosse un'unione felice. Sia come sia, Agnese rimase subito incinta di un maschio, chiamato
Cangrande II.
Per Cangrande, l'alleanza dinastica con i Gorizia era strumentale al suo nuovo obiettivo, la sottomissione della patria friulana. Pagano della Torre, morto nel '32, aveva lasciato il posto al francese Betrando, uomo molto capace e con un'alta considerazione di sé, sia come sovrano temporale della patria friulana, sia come guida spirituale del patriarcato di Aquileia. Sin dal suo insediamento, gli screzi con i veronesi non erano mancati (e nemmeno con i veneziani).
Lo scaligero, tuttavia, non aveva potuto porvi “adeguato rimedio” dal momento che era assorbito dalle operazioni contro Lodrisio Visconti, contro Giovanni di Boemia, contro Roberto d'Angiò.
All'alba del '39, con Firenze “sistemata”, era giunto il momento di dare una soluzione al problema friulano. Il controllo del patriarcato di Aquileia era oltretutto di una certa importanza per il controllo dei passi alpini in direzione dell'impero germanico.
Betrando quindi, scelse molto male il momento in cui tentare di distruggere la potenza dei conti di Gorizia. Quanto il patriarca pose l'assedio, nel 1340 a Gorizia, il conte Enrico II non poté fare altro che chiedere aiuto a
Cangrande (era chiaro che il conte non era troppo entusiasta dell'idea. Si rassegnò a farlo quando pensò di non avere altre alternative).
Inizialmente, Bertrando reagì bene: spinse un esercito verso Treviso, saccheggiando i territori intorno alla città.
Ma, mentre il nipote Mastino era impegnato in Toscana, Cangrande condusse personalmente il suo esercito nel trevigiano, per poi passare il Piave. Sconfisse i patriarchini nei pressi di Conegliano, poi avanzò ulteriormente. I nobili friulani, mal tollerando le tendenze accentratrici del patriarca, approfittarono dell'occasione per ribellarsi. Gualtiero ed Enrico di Spilimbergo, Federico da Portis e Giovanni di Villalta passarono dalla parte di
Cangrande, in cambio, ovviamente, di garanzie sulle loro autonomie nel caso di una conquista scaligera della patria friulana.
Bertrando, a questo punto, abbandonato l'assedio di Gorizia, si trincerò a Udine, cercando di addivenire ad una pace di compromesso con la mediazione veneziana.
Le trattative, tuttavia, fallirono, mentre, man mano che l'esercito scaligero avanzava, molti borghi davano la loro obbedienza a
Cangrande.
Nel 1342 Udine venne assediata e presa, mentre Cangrande si prendeva una nuova scomunica dal papa.
La presa di possesso della patria friulana, non significò tuttavia, la fine del patriarcato di Aquileia. Il signore veronese trattò magnanimamente Bertrando, addirittura concedendogli di mantenere il suo ruolo di patriarca.
Cangrande mantenne e garantì molti statuti, autonomie e concessioni di privilegi, in particolare a Udine e Cividale, mentre fece costruire alcune fortezze per meglio sorvegliare i passi alpini presso Pontebba.
Venezia non fu soddisfatta della piega che avevano preso gli eventi. Ma, ancora una volta, Cangrande ribadì privilegi e concessioni alla Serenissima repubblica. Anzi. Vendette al Doge tutti i diritti ed i possedimenti del patriarcato di Aquileia (con che giustificazione giuridica, non sappiamo) in terra istriana, cosa che contribuì a quietare gli animi in laguna.
Ancora meno soddisfatti furono, ma per altre ragioni, l'imperatore Ludovico e Alberto II d'Asburgo; il primo perché vedeva aumentare ancora la potenza di un alleato divenuto fin troppo pericolo. Il secondo perché voleva approfittare del caos per prendersi un'ampia fetta del Friuli e dei possedimenti dei Gorizia (che controllavano diverse parti del Tirolo).
Per la successiva decina d'anni,
Cangrande tentò di tenersi lontano da campagne militari. Era diventato indiscutibilmente il signore più potente d'Italia e pochi, ormai, osavano sfidare la sua potenza. Dopo la campagna friulana, i Visconti avevano sviluppato un atteggiamento di sorda ostilità nei confronti degli scaligeri, ma non si erano mai sentiti sufficientemente sicuri per sferrare il primo colpo. Inoltre, i litigi tra Matteo II, Galeazzo II e Bernabò non aiutavano. La linea di confine sull'Oglio resse.
Verona divenne ricca, molto ricca, ed anche le altre città del dominio, Vicenza, Padova, Bassano, Treviso, Feltre, Belluno, Brescia, Mantova poterono godere della pace che si era venuta a creare, dopo anni e anni di interminabili conflitti.
Nel 1342, venne eletto un nuovo papa, con il nome di Clemente VI. Con quest'ultimo
Cangrande cercò di ristabilire dei rapporti quantomeno formalmente accettabili. Clemente era politicamente più flessibile del suo predecessore. Si rese conto di quanto ormai fosse perfettamente inutile continuare a rifiutare la situazione che si era venuta a creare in Italia. Pensò bene di utilizzare
Cangrande contro quello che considerava il vero nemico della chiesa in quel momento, l'imperatore Ludovico. Anche lo scaligero non aveva nessun motivo per amare l'imperatore che gli aveva rifiutato la concessione del marchesato, ma preferì andarci cauto con le profferte del papa.
Ad ogni modo, poco tempo dopo, quando Carlo di Boemia (figlio di Giovanni) venne elevato al rango di anti-imperatore,
Cangrande gli garantì la simpatia per la sua causa, parecchi soldi ed, eventualmente, il suo sostegno militare. Carlo gli fu tanto riconoscente da impegnarsi a dare in sposa la sua figlia decenne primogenita Margherita al piccolo
Cangrande II, una volta che i due avessero raggiunto un'età consona.
Ludovico morì nel 1347 prima che si arrivasse allo scontro decisivo, privando così il sovrano di Verona dell'opportunità di “mostrare il suo valore e coprirsi di gloria in nome di una giusta e santa impresa”.
Nel 1348 giunse la grande peste. A Verona morì più di un terzo della popolazione. Cangrande, tuttavia sopravvisse, pur decidendo di rimanere in città. Era già molto malato ed era convinto, a detta dei suoi memorialisti, di non aver molto da vivere. Presto però sembrò ristabilirsi perfettamente. Cosa che gli permise di conquistare ciò cui spasmodicamente anelava.
Nel 1350, infatti, Cangrande pretese un compenso per il suo appoggio all'imperatore: il tanto agognato titolo di “Marchese di Verona e Treviso”, cui fece aggiungere, giusto per gradire, anche quello di “custode perpetuo del patriarcato di Aquileia”. Titolo, tra l'altro, trasmissibile per via ereditaria. Dopo aver tergiversato un po', di fronte ad un bel mucchio di soldi (100mila fiorini d'oro), Carlo IV alla fine cedette.
E' anche merito suo se al giorno d'oggi, la regione che va dal Mincio a ovest al Livenza a est, è chiamata comunemente “Marche” (non si poteva mica chiamare Veneto come nella nostra Timeline, no?).
Ora che l'Italia intera pareva inchinarsi alla sua potenza, ecco che da parte papale arrivò una nuova grana. O una nuova opportunità da sfruttare per ingrandire la propria egemonia.
Il vescovo Egidio Albornoz, era stato infatti inviato in Italia, con soldi, uomini e speranze per porre fine allo stato di allegra confusione e conflitti di potere che regnavano nell'ormai ex-stato della chiesa. Inizialmente
Cangrande non se ne curò troppo. Era convinto che il legato pontificio sarebbe stato fatto fuori in poco tempo. Ma quando Giovanni Vico venne sconfitto e fece atto di sottomissione all'Albornoz, lo scaligero dovette ricredersi. E, cosa ancor più sconvolgente, l'intrepido cardinale aveva tutta l'intenzione di sottomettere anche Perugia, la marca anconetana e la Romagna. Visti i risultati, ne sarebbe anche stato capace!
Purtroppo per lui, la sfida arrivava troppo tardi per il suo fisico.
Nel 1354, il marchese Cangrande I spirò. Fondatore della potenza scaligera, lascerà al suo erede Cangrande II il compito di portare a termine l'opera da lui incominciata: fondare un regno.

Cangrande I della Scala, Museo Castelvecchio a Verona
Il giovane Cangrande II, come primo atto, dovette dimostrare a tutti di essere degno figlio di suo padre. Sventò una congiura del suo ambizioso parente, Mastino, che era ansioso di prendere il posto del suo defunto cugino. Ma il figlio non era magnanimo quanto il padre. Mastino venne giustiziato assieme a suo fratello Alberto e a tutti coloro che si scoprirono coinvolti nella congiura contro di lui.
Come secondo passo, decise di non perder tempo e allearsi con Galeotto e Guastafamiglia Malatesta, signori di Rimini e di diverse città della marca anconetana e con Francesco Ordelaffi, signore di Forlì. Aldobrandino III, signore di Ferrara, Modena e Reggio, decise invece di correre il rischio di allearsi con l'Albornoz(alleatosi con Gentile da Mogliano e Rodolfo da Varano, signore di Camerino) per liberarsi della pesante “amicizia” veronese.
Malatesta Guastafamiglia sconfisse senza troppa difficoltà Gentile da Mogliano. Cangrande II si preparava ad affrontare Aldobrandino d'Este. A Bondeno sul Panaro, tuttavia, fu sorpreso dalle forze di Bernardino da Polenta, signore di Ravenna, segretamente alleatosi con l'estense, e fu costretto a ritirarsi oltre il Po. Altra pessima notizia, nell'anconetano Galeotto si era fatto pesantemente battere da Rodolfo da Varano e Albornoz si accingeva a prendere possesso di Ancona.
Nel frattempo, a peggiorare la situazione, Carlo IV aveva deciso di scendere in Italia con un piccolo esercito. L'imperatore, dopo aver attraversato con grandi onori le marche trevigiana e veronese, entrò nel territorio milanese e, manco a dirlo, si mise a litigare con Bernabò Visconti. Per tutta risposta l'imperatore decise di regolare quel suddito così indisponente mandandogli contro il suo esercito, comandato da Marcovaldo di Raudeck. Che puntualmente fu annientato dalle milizie milanesi.
Ma Bernabò fece finta di credere che l'attacco fosse stato pianificato di comune accordo con
Cangrande II, per indebolire la potenza viscontea in Lombardia.
Perciò decise di approntare un esercito per saccheggiare i dintorni di Brescia e Mantova. Era di fatto una dichiarazione di guerra.
La triplice minaccia, forse anche frutto di una sottovalutazione da parte dei nemici delle capacità del giovane
Cangrande II, era potenzialmente in grado di porre fine all'egemonia veronese nell'Italia settentrionale. Non lasciandosi scoraggiare, lo scaligero decise di chiedere aiuto ai Veneziani. Chiese alla Serenissima aiuto contro i da Polenta di Ravenna e Cervia, e inviare parte della flotta a Rimini e ad Ancona per impedire che si arrendessero. Nel caso, i veneziani potevano tenersele pure, Ravenna e Cervia. Con Bernardino da Polenta impegnato a difendersi dagli attacchi veneziani, poté procedere contro Aldobrandino, lasciando che Bernabò seminasse distruzione nelle campagne di Brescia, Mantova e Verona e dando ordine di rinsaldare fortezze e guarnigioni.
Cangrande si spinse verso ovest, prendendo Carpi, Correggio e Novellara, per poi puntare a sud, verso Reggio. Nel frattempo, ingaggiò le truppe del famoso capitano di ventura tedesco Anichino da Bongardo (che erano precedentemente al servizio proprio di Bernardino da Polenta).
Bernabò, saputo che Cangrande, alla testa di un grande esercito era alle porte di Reggio, decise di muoversi verso sud e lasciar perdere quanto aveva in programma, ossia l'assedio di Brescia.
Era quello che su cui lo scaligero contava: si ritirò a Carpi, in attesa dell'arrivo di Bernabò.
Finalmente l'esercito visconteo arrivò, e ingaggiò battaglia con gli scaligeri. Mentre le sorti della battaglia erano ancora in bilico, ed anzi, sembravano lentamente volgere a favore dei milanesi, ecco che dalla vicina Correggio, giunse alle spalle di Bernabò la compagnia mercenaria di Anichino, che capovolse l'andamento dello scontro.
Cangrande, nonostante un alto numero di perdite rimase padrone del campo, catturando vivo lo stesso signore di Milano.
Il veronese, assieme ai prigionieri, si diresse verso Cremona, che aprì le porte al suo signore, scoprendo solo dopo che era stato fatto prigioniero dal nemico. A questo punto decise di chiamare Galeazzo II e intavolare trattative per il rilascio di suo fratello. Il signore di Verona si sarebbe “accontentato” di Cremona, Soncino e Lonato. Galeazzo II, impegnato a ovest e con un esercito di gran lunga insufficiente ad affrontare, dopo la mazzata presa da Bernabò,
Cangrande II, pur volendo, molto probabilmente, lasciar marcire suo fratello nelle prigioni di Verona, non poté far altro che accettare.
Il signore veronese non aveva voluto sparare troppo alto, cercando di pretendere cose impossibili, come la cessione della fortificatissima Bergamo. Anzi, se Galeazzo II avesse rifiutato, sarebbe stato disposto anche a cedere sul possesso di Cremona. La sua priorità era neutralizzare Milano, non cercare di abbatterla.
Ma, foriero di importanti conseguenze è il secondo punto del trattato di pace tra Galeazzo II e
Cangrande II: L'appena nata Violante Visconti, figlia del primo, si sarebbe dovuta sposare, giunta in età da marito, all'eventuale figlio maschio di
Cangrande, che si era da poco unito ufficialmente con la promessa sposa (già dal 1345. Merito, ovviamente, dei buoni uffici di
Cangrande I) Margherita di Boemia, figlia di Carlo IV (altro matrimonio nato per motivi politici che si rivelò straordinariamente felice).
La notizia della vittoria di Cangrande II su Bernabò fa il giro dell'Italia. E spaventa molti. Bernabò era infatti considerato l'uomo più potente della penisola, ora che il vecchio Cangrande I era morto. E' ovvio che, pertanto, la cosa faccia un certo scalpore.
A questo punto, (siamo nel 1357)
Cangrande decide di usare la carta della diplomazia contro Aldobrandino: pace mediata da Venezia, che si prende Cervia da Guido da Polenta come pegno (ma non Ravenna).
Per quanto riguarda l'Albornoz, che si prenda pure Ancona, ma non tocchi Rimini, Fano e Senigallia, di proprietà degli “alleati” Malatesta.
Ovviamente, tale padre, tale figlio: a fronte di questo conflitto contro la santa chiesa
Cangrande II si becca una bella scomunica.
Nel 1358, è la volta di Venezia chiedere aiuto agli scaligeri: re Luigi d'Ungheria è ansioso di conquistare la Dalmazia e chiede aiuto a
Cangrande II. Il re prospetta al marchese l'annessione di tutti i territori della Serenissima repubblica in Istria se avesse partecipato. Ma
Cangrande II preferisce una Venezia forte e sua alleata e rifiuta. Anzi, si lega alla città lagunare. Alla notizia che il veronese si sarebbe schierato contro il re d'Ungheria, gli Asburgo ritirano il proprio sostegno all'impresa. I conti di Gorizia, invece, stufi dello strapotere veronese, si alleano a Luigi.
Cangrande II non bada a spese. Allestisce un'imponente armata per assediare Gorizia, che cade. Fa armare a spese proprie 10 galee e invia un contingente a difendere le città dalmate e istriane dell'alleata attaccate dalle armate ungheresi.
Re Luigi, visto che non riesce a cavare un ragno dal buco, firma una tregua con Venezia e Verona, ma schiuma rabbia ed è pronto a meditare vendetta per l'inaspettato affronto subito.
(P.S.: niente Ragusa)
Gli anni '60 del '300 arrivano senza altri sussulti, a parte per l'arrivo di orde di mercenari inglesi rimasti “senza lavoro” dopo la pace di Bretigny. Una di queste compagnie, la “compagnia bianca del falco”, al comando del famoso condottiero John Hawkwood, italianizzato in Giovanni Acuto, verrà ingaggiata proprio da Cangrande II, inizialmente per evitare che combini guai o che qualche suo nemico la possa usare contro di lui.
Nel 1360 nasce Cangrande III, suo figlio primogenito. Con suo sommo dolore, però, la regina Margherita muore di parto.
L'anno successivo Cangrande ha in mente un'idea per rimaritarsi. Un'idea tanto folle quanto ambiziosa. Infatti in quello stesso anno la regina Giovanna di Napoli rimane (di nuovo) vedova. Pertanto
Cangrande manda all'angioina la propria proposta di matrimonio. Che, al colmo della sorpresa per tutti, accetta!
Lo scaligero può così aggiungere ai propri titoli anche quello di duca di Calabria.
In men che non si dica, è la mobilitazione generale: Luigi d'Ungheria torna di gran carriera nel sud per far vedere i sorci verdi a
Cangrande II e a Giovanna, i due suoi nemici giurati.
Cangrande chiede l'aiuto veneziano e milanese. I francesi e l'impero si chiamano fuori: non vogliono avere niente a che fare con la vicenda. Federico di Sicilia, invece, amico di Cangrande II, decide di rimanere neutrale, ossia di sospendere la guerra del vespro.
Giovanni Acuto ha così l'occasione di costruirsi una fama imperitura sul suolo italiano, assieme all'altro grande condottiero dello schieramento veronese-napoletano, Francesco Novello da Carrara.
Fu una guerra lunga e senza esclusione di colpi, che durò fino al 1367. Ma alla fine, come nelle due occasioni precedenti, Luigi d'Ungheria fu costretto a ritirarsi spinto dalla ribellione dei suoi stessi uomini.
Per i suoi meriti, l'acuto venne insignito del titolo di conte di Barcellona.
Nell'ultima battaglia contro Luigi morì Gian Galeazzo, figlio primogenito di Galeazzo II, che aveva voluto a tutti i costi partecipare all'impresa al fianco di
Cangrande II.
Ferito sul campo di battaglia, spirò la sera successiva. Venne sepolto a Corigliano Calabro. Riesumato il suo corpo nel 2004, si è scoperto che senza dubbio è stato avvelenato. I sospetti cadono ovviamente su
Cangrande II, che voleva assicurare al figlio, evidentemente, le maggiori possibilità di rivendicare anche il dominio visconteo.
Nello stesso anno, 1367, Cangrande II ha un figlio da Giovanna. Leggenda narra che Cangrande avesse chiuso nel palazzo la regina e che mandasse in giro una sua sosia con il pancione, dato che si dubitava seriamente che l'angioina potesse avere figli. Purtroppo, per Renato Francesco non si possono fare indagini genetiche perché il suo corpo non si è conservato a dovere.
Seguono anni relativamente tranquilli. Nel 1372 con il trattato di Avignone Federico IV e Giovanna pongono fine ufficialmente alla guerra del vespro. La Sicilia aragonese diventa “regno di Trinacria”, in legame vassallatico con il regno di Sicilia, di cui è titolare Giovanna.
Cangrande, inoltre, suggerisce che l'erede del regno di Sicilia sposi la figlia del re di Trinacria, per cementare questa amicizia. Federico non ha ancora figli maschi, ma accetta, non considerando la cosa un problema. Avrà di che pentirsi?
Ma chi è l'erede del regno di Sicilia? Giovanna non si è, in effetti, decisa ancora ufficialmente per suo figlio Renato Francesco.
Sempre secondo la leggenda, la proclamazione del piccolo Renato Francesco come erede nel 1373 avviene perché
Cangrande minaccia la regina di morte. In realtà sono i cronisti fiorentini del '500 che dipingono
Cangrande II come un tiranno spietato, cinico, calcolatore, ateo e anche un po' sanguinario. Né i cronisti veronesi, né quelli napoletani menzionano nulla del genere. Anzi, questi ultimi sostengono che tra i due coniugi, se non amore, ci fosse quantomeno intesa e rispetto reciproco.
Nel 1378 si scatena, una volta per tutte, la guerra per Milano. Con la morte di Galeazzo II, Bernabò (che nel frattempo ha anche conquistato Bologna) rimane padrone del campo, ed è ben deciso di lasciare la sua signoria ai figli. Cangrande non è dell'avviso. Vuole che anche Cangrande III abbia diritto ad un pezzo della torta, in quanto marito di Violante: Bergamo, la Valcamonica e Piacenza.
Bernabò rifiuta e solleva una grande lega antiveronese: partecipano anche Estensi, Monferrato, la lega delle città toscane, gli Ordelaffi di Forlì.
A questa questione si aggiunge anche lo scisma della chiesa. Il tutto viene trasformato in un conflitto per l'obbedienza. Verona sostiene Avignone, mentre Milano (ed i suoi alleati) Roma. Alla partita partecipano, come presenze passeggere, anche il re d'Ungheria, i francesi, gli aragonesi, gli imperiali...
Fu il capolavoro militare e diplomatico di Cangrande II. Lui decise di seguire direttamente le operazioni in Lombardia e sul confine orientale contro gli ungheresi. Al figlio primogenito, con l'assistenza di Francesco Novello da Carrara affidò il compito di debellare i nemici nell'Italia centrale e, infine, a Giovanni Acuto affidò il compito di difendere la regina e il giovane erede al trono di Napoli dalle mire di Carlo di Durazzo.
Ormai, ed era ciò che i nemici italiani non avevano ben compreso, era di fatto impossibile scalzare i veronesi dalla loro posizione di preminenza. Non tanto per le conquiste di Cangrande II (che, comunque, va ricordato, godeva dei favori della ricchissima Serenissima e delle considerevoli entrate del regno del sud), ma per quelle di suo padre. Il processo di integrazione economica e di organizzazione dei commerci che il grande Cangrande I aveva messo in piedi aveva permesso a Verona di essere molto più ricca delle avversarie.
L'unico nemico veramente serio e potenzialmente più ricco era Milano, che tuttavia, aveva dilapidato il proprio potenziale vantaggio nei conflitti interni tra i diversi membri della casata ed in politiche di vedute troppo ristrette e limitate. La parola fine sulle possibilità di vittoria di Milano era definitivamente arrivato, forse, quando Milano non era riuscita ad approfittare del conflitto di Cangrande per Napoli contro Luigi d'Ungheria.
Ad ogni modo, il momento culminante della guerra furono tre fatti quasi concomitanti:
1383: Milano viene conquistata da CanGande II e Ferrara da Cangrande II e Francesco Novello
1384: Muore Carlo di Durazzo, probabilmente assassinato da un sicario.
Forte di queste vittorie ormai decisive, Cangrande effettua un vero e proprio ribaltone politico: promette ad Urbano VI la difesa del Patrimonio di San Pietro e della causa romana in cambio dell'incoronazione di suo figlio Cangrande III al titolo di Rex Italiae.
E nella notte di natale del 1384, con la benedizione del papa e dell'imperatore, che comunque mantiene il suo titolo di re dei romani, nasce ufficialmente il nuovo regno d'Italia.
E' ancora un'identità giuridica piuttosto indistinta, che avrà bisogno ancora di molto lavoro per essere portata a termine. Ma la strada è già segnata, anche in senso dell'unificazione del regno d'Italia con quello di Sicilia.
I successori dei due Cangrande sapranno meritarsi il titolo per cui i due scaligeri hanno tanto faticato? Cosa li aspetterà alle soglie dell'età moderna?
.
Ecco il commento del solito Bhrihskwobhloukstroy:
Straordinaria e dirompente; certo i due punti di massima fortuna sono il benestare dell'Imperatore (solo con Venceslao sarebbe stato possibile, tuttavia con somme di denaro mai viste né prima né dopo, visto il prezzo che ha fatto pagare 'solo'per i titoli ducali a Gian Galeazzo Visconti) e del Papa. Sarà molto interessante conoscere, tra l'altro, il destino di Genova e Pisa, anche se determinanti rimarranno l'Impero e la Francia. Le direttrici di espansione continueranno da Napoli verso la Grecia, con l'alleanza di Venezia?
.
Paolo gli risponde:
La direttrice di espansione rimane in realtà abbastanza aperta. In linea di massima sì, la somma delle ambizioni veneziane e napoletane non può che condurre verso il levante. Il problema però è che io lascio di fatto insoluto il problema del rapporto con la Francia. Inoltre, penso che gli scaligeri successivi potrebbero prendere in considerazione la prospettiva di assorbire gli Asburgo per contendere la corona imperiale al blocco lussemburghese. Strano ma vero, la prospettiva di una crociata contro i Turchi (con in prospettiva la conquista del titolo imperiale d'oriente) sarebbe un ordine del giorno più pressante rispetto alla nostra Timeline. La sfida tra della scala e Lussemburgo si giocherebbe anche per Costantinopoli.
.
E Bhrihskwobhloukstroy replica:
È proprio così, la Storiografia moderna vulgata si è lasciata troppo suggestionare dalla prospettiva dei secoli seguenti e ha trascurato due 'percezioni' che all'epoca erano ben vive: che del novero delle grandi Dinastie nell'àmbito dell'Impero rientrassero anche le Casate di origine feudale a Sud delle Alpi (tanto più nella Marca Veronese e Trevigiana, che ha fatto parte specificamente del Regno di Germania in quanto Marca della Baviera prima e della Carantania poi) e che il percorso obbligato di tutti i progetti geopolitici era l'asse Roma-Costantinopoli, ossia in concreto costruire uno Stato territoriale, elevarlo a Regno, conquistare la Corona del Sacro Romano Impero, unirla a quella dell'Impero d'Oriente e riassorbire lo Stato Pontificio.
A questo punto però mi sia permessa (per tornare all'ucronia iniziale) una considerazione di fondo: praticamente quattro secoli (dal XV. al XIX.) sono stati 'sprecati' nel tentativo sistematicamente frustrato di unificazione (qualunque ne fosse il pretesto e chiunque ne fosse il promotore) non dico della Cisalpina, ma almeno della Transapdana: fosse il Repubblicone da Venezia alla Svizzera a Genova oppure la Monarchia 'Longobarda' dei (burgundi) Savoia o ancora l'incameramento del Regno d'Italia nella Lombardia sotto il diretto controllo dell'Impero o invece la riunificazione 'gallica' da parte della Francia, con la Spagna prima a fianco dell'Austria poi nel Patto Borbonico, tutto si è sempre risolto in un passo avanti e due indietro. Mentre dai Comuni a Giangaleazzo Visconti la tendenza è stata all'aggregazione, poi il meccanismo si è inceppato e sproporzionate risorse sono state bruciate nel vano tentativo di realizzare una soluzione unitaria. Alla fine il machiavellico Palmerston e il localista Bismarck, con la decisiva assenza dell'offeso Alessandro II., hanno propiziato un esito (prima incredibile) a favore dei Savoia compromettendo per sempre (da allora) la tradizionale diarchia austro-francese... Per rompere ucronicamente questo meccanismo bisognerebbe 'intervenire' su Carlo il Grosso o, al più tardi, su Ugo Capeto.
.
A questo punto, Paolo aggiunge:
Ora vi propongo una cronologia che con una serie di giochetti dinastici porta al risultato della ‘Lotaringia di Verdun’ sotto un Visconti. In alcuni punti è certamente forzata, eppure allo stesso tempo è assai timorosa (perché cambiando qualcosa potrebbe benissimo portare anche il titolo imperiale e l’intera penisola iberica ai Visconti stessi).
Il presupposto di partenza è che la progressiva fusione tra Visconti e Scaligeri, unitamente al mancato sviluppo di Venezia come potenza di terraferma, porti ad un blocco ghibellino pressoché unitario ed esteso all’intera Cisalpina difficilmente decostruibile dal papato.
Resta chiaro che la ‘sceneggiata’ di cui faccio menzione è ingiustificabile e folle, eppure non mi erano venute al tempo idee migliori per giustificare un titolo regio. Ora come ora eviterei di menzionarla.
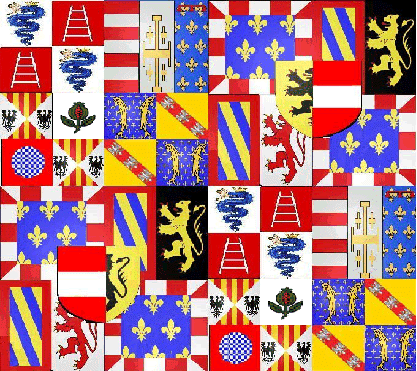
PoD: Mastino II della Scala preferisce accordarsi con i Veneziani per il controllo delle saline sul delta del Po. Non pone la catena sul fiume a Ostiglia e non fa costruire il 'castello delle saline' a Chioggia. La potenza scaligera preferisce attuare un atteggiamento amichevole verso Venezia e non decade. Alternanza di fasi di guerra e pace comunque non decisive tra Visconti e Della Scala per i quaranta anni successivi; nel contempo, espansione delle sfere di influenza e dei domini di Milano e Verona in Emilia e in Romagna.
1372: Federico IV di Sicilia
sposa, vedovo di Costanza, in seconde nozze Violante, figlia di Galeazzo II
Visconti. Matrimonio fortemente voluto dalla fazione dei 'baroni latini',
capeggiata dai Chiaramonte.
Alla coppia nasce l'anno dopo un figlio maschio, Pietro.
1377: morte di Federico IV. Reggenza di Violante e di Artale Chiaramonte in nome dell'infante Pietro. Gli Alagona, della fazione 'catalana' dei baroni dell'isola, chiedono ausilio a Pietro IV re di Aragona, suggerendogli di sposare Maria, primogenita di Federico IV.
1377-1378: guerra di successione siciliana: Maria viene rapita dai Chiaramonte, sperando di farla sposare a un Visconti (Gian Galeazzo). Battaglia navale delle Egadi tra la flotta catalana e quella genovese. Vittoria dei secondi. Artale sconfigge le forze catalane sull'isola con l'ausilio di Rodolfo Visconti, terzogenito di Bernabò.
1380: per via del fallimento del progetto matrimoniale tra Gian Galeazzo e Maria d'Aragona, quest'ultima viene data in sposa al sunnominato Rodolfo Visconti,mentre Gian Galeazzo sposa la cugina Caterina. Rodolfo viene insignito della reggenza per il piccolo Pietro con la benedizione della regina consorte Violante.
1385: Guerra di successione milanese. Gian Galeazzo, alleato di Antonio della Scala, figlio di Cansignorio della Scala esautora Bernabò e diviene signore unico di Milano.
1388: Matrimonio tra Valentina Visconti e Canfrancesco della Scala, figlio di Antonio. Unione delle due principali famiglie ghibelline del regno di Lombardia.
1390-1391: Luigi d'Angiò, re di Napoli si allea con Firenze contro l'alleanza ghibellina. Molti signori della Romagna si alleano all'angioino per sottrarsi all'influenza di Verona e Milano.
1392: Gian Galeazzo e Antonio comprano, per la somma complessiva di 150mila fiorini d'oro, in parte pagati anche dalla repubblica di Venezia, il titolo ducale (100mila fiorini per il Visconti, 50mila per lo scaligero) dall'imperatore Venceslao.
1395: Facino Cane, condottiero al soldo di Antonio della Scala, assieme ai Malatesta di Rimini, sconfigge gli Este e i Da Polenta; Pesaro, Fano e Senigallia si sottomettono al duca di Verona.
1396: Assedio navale veneziano di Ancona. Gian Galeazzo raduna un grande esercito per marciare contro Firenze.
1398: Firenze viene
conquistata da Canfrancesco, in nome del suocero. Viene nominato un Podestà
ghibellino, affiancato da un'assemblea di dieci membri, i 'dieci di balia'.
Morte di Antonio della Scala. Canfrancesco riconosciuto erede al ducato di
Verona ('fasti di Perugia').
1402: Gian Galeazzo Visconti muore di Peste, lasciando come eredi Giovanni Maria e Filippo Maria. Valentina, spinta dal marito, cerca di ottenere la reggenza del ducato. Facino Cane le si oppone.
1402-1406: ribellioni al dominio visconteo in molte città. Alcune di esse accettano la dedizione a Canfrancesco.
1407: vendetta antighibellina in Firenze. I dieci scacciano il podestà.
1408: Ladislao di Durazzo, re di Napoli, assedia Roma, che si consegna al sovrano. Molte città dedite ai Visconti in centro Italia si sottomettono al sovrano angioino. Tra di esse spicca Perugia.
1409: nuovo cambio di fronte di Firenze, che si allea con Canfrancesco per limitare l'espansione di Ladislao. I fiorentini riescono, in occasione della lontananza del re, a scacciare la guarnigione angioina da Roma. Luigi II d'Angiò sigla una strana alleanza con i ghibellini contro Ladislao.
1411: grandi vittorie di Ladislao. Firenze sigla pace separata con lui.
1412: Luigi si ritira dal teatro italiano e Ladislao sigla una tregua con i suoi nemici. Morte di Giovanni Maria Visconti e di Facino Cane, che si dice, stesse tramando un'alleanza con Ladislao per impossessarsi di Milano.
1413: Ladislao riprende le ostilità contro Roma. Canfrancesco nicchia, intento a cercare di recuperare almeno alcune delle città ribellatesi al dominio visconteo in nome della moglie e del di lui secondogenito, nel frattempo 'esiliato' a Verona. Filippo Maria è costretto a sposare la cugina Taddea della Scala, figlia di Canfrancesco e Valentina.
1414: morte di Ladislao di Durazzo. Nasce Cangaleazzo, figlio di Filippo Maria e Taddea.
1416: Morte di Canfrancesco, cui Valentina ha dato solo figlie femmine. Erede presuntivo al ducato veronese è, almeno se l'imperatore acconsente, proprio Cangaleazzo. Ribellione di diverse città al dominio veronese. Filippo Maria manifesta una accorta capacità diplomatica e una discreta abilità militare e riesce a recuperare tutto il dominio scaligero a nord del Po e una parte di quello a sud.
1419 - 1421: guerra tra Filippo Maria e Venezia. Firenze si allea alla Serenissima, seguita a ruota da Ferrara, Camerino, Rimini.
1420: morte prematura di Alberto V d'Asburgo, della linea albertina della casata (probabilmente assassinio). Ernesto d'Asburgo cerca di ottenerne i domini (notare che Ernesto d'Asburgo è figlio di Leopoldo d'Asburgo e Verde Visconti, figlia di Bernabò), alleandosi con Federico Tascavuota del Tirolo.
1421: L'alleanza con Federico
Tascavuota non ottiene gli effetti sperati. Ernesto ottiene un prestito di
svariate migliaia di ducati da parte di Filippo Maria Visconti. Dopo alterne
vicende, l'imperatore Sigismondo accetta finalmente di pronunciarsi in suo
favore.
Filippo Maria ottiene agevolazioni economiche sulle miniere di argento e sui
dazi di passaggio dei valichi alpini.
Sigismondo tuttavia ottiene di scorporare dall'Austria propria tutti i territori
a nord del Danubio, cedendoli a Federico Wettin, detto 'il bellicoso', già
langravio di Meissen.
1423: Ancona si ribella al dominio veneziano e si collega all'alleanza ghibellina. La guerra è sia militare, sia economica.
1424: 'tradimento' dei Medici, che passano segretamente dalla parte ghibellina. Venezia, in cambio di garanzie economiche, in particolare sul passaggio della valle dell'Adige, stipula la pace. Firenze però non molla ancora.
1426: al grido di 'pane e
pace!', Cosimo Medici abbatte il governo dei dieci e si proclama gonfaloniere
della repubblica. Subito intavola trattative di pace con Filippo Maria e il
fronte ghibellino. Firenze diviene 'alleata perpetua' di Milano. Cleofa
Visconti, figlia secondogenita di Filippo Maria, sposa Giovanni Medici, figlio
di Cosimo.
Alfonso d'Aragona stipula una pace con Filippo Maria e Renato.
1427: fallimento dell'operazione aragonese di conquista della Sardegna, col concorso genovese e visconteo.
1427- 1430: apogeo del potere di Filippo Maria, che progressivamente sottomette, militarmente o diplomaticamente, diverse città toscane, umbre e marchigiane. Ironicamente, professa di farlo in nome del pontefice. Martino V mastica amaro, ma allo stesso tempo sente il bisogno di farsi aiutare dal Visconti per attuare una campagna contro i padri conciliari riuniti a Basilea. Tenta segretamente di allearsi a Giovanna II d'Angiò contro Filippo Maria, ma il papa litiga con la regina e le trattative si concludono in un nulla di fatto.
1431: Sigismondo fa sposare Elisabetta di Lussemburgo, sua unica figlia, a Federico II Wettin, figlio del 'bellicoso' di cui sopra.
1432: i Visconti, in alleanza con gli Asburgo d'Austria, sconfiggono la confederazione elvetica al passo del Lucomagno. Bianca Maria, figlia terzogenita di Filippo Maria, sposa Federico d'Asburgo, figlio di Ernesto.
1433-1436: Alfonso il
Magnanimo (verificata l'impossibilità di rivendicare il trono napoletano con le
forze di cui dispone) allestisce una vasta campagna militare contro il regno di
Granada, che conquista in tre anni.
Successivamente strapperà anche Tangeri al sultano di Fez.
1434: Cangaleazzo viene fatto sposare a Eleonora di Sicilia.
1435: muore Giovanna II d'Angiò, regina di Napoli. Il trono è rivendicato da Renato d'Angiò, conte di Provenza. Ribellione dei baroni, che chiedono l'ausilio del nuovo pontefice, Eugenio IV. Pace tra il duca di Borgogna ed il re di Francia.
1436: Guerra tra Portogallo e Aragona per il controllo di Tangeri.
1437: Renato riesce a ottenere il trono di Napoli. La figlia Yolanda di Bar viene promessa in sposa a Francesco, fratello minore di Cangaleazzo.
1438: morte di Sigismondo. Federico II Wettin e Federico V d'Asburgo si scontrano per il titolo imperiale. Vince Federico, appoggiato da Filippo il buono di Borgogna e i suoi banchieri fiamminghi.
1438: Filippo Maria fa allestire a Genova una flotta da mandare in aiuto ad Alfonso (in cambio della rinuncia aragonese alla rivendicazione del regno di Sardegna). Nel contempo scoppiano però conflitti dinastici in Portogallo, che stipula una pace.
1440: Nasce Gian Mastino, figlio di Cangaleazzo.
1442: Ribellione di Ginevra
al dominio sabaudo. I Savoia chiamano in aiuto Filippo di Borgogna.
Eventualmente, tale alleanza è in funzione di un conflitto contro Filippo Maria
Visconti e Cangaleazzo. Guerra tra Savoia e Visconti. Gli svizzeri, stretti tra
gli scomodi vicini Visconti e Valois, firmano pace separata.
I Borgognoni conquistano Ginevra, mentre i Visconti Ivrea.
1443: Filipo Maria ingaggia con una forte somma di denaro la confederazione elvetica. Nel contempo propone una spartizione del ducato sabaudo a Filippo il buono.
1444: Filippo il buono accetta le condizioni di Filippo Maria: Chablais e Ginevrino alla Borgogna; Contea di Savoia, Val di Susa, Val D'Aosta rimangono ai Savoia-Chambery; principato di Piemonte con Ivrea ai Visconti; Nizza alla contea di Provenza.
1445-1451: 'Crociata' di Alfonso il magnanimo in nord Africa. Conquista di Tenes, Orano, Melilla, Nador, Arzila, Tetuan. Fonda così il 'regno di Tingitania'. Affida il regno all'amato figlio bastardo Ferdinando (Ferrante).
1452: accordo matrimoniale tra Alfonso e Cangaleazzo: Ferdinando di Granada e Tingitania sposa Bona, figlia primogenita del Visconti.
1446: 'Sceneggiata di Roma'. In presenza del pontefice e dell'imperatore, chiamato per l'occasione, Canfrancesco prende dalle mani del papa la corona di rex langobardorum e la cede all'imperatore, il quale viene incoronato con la corona ferrea. In cambio l'imperatore concede a Cangaleazzo il titolo neoconiato di rex Lombardiae, oltre al vicariato generale. Si dice che ciò costò a Cangaleazzo una somma astronomica, ma non si sa di preciso quanto. Trattato di 'colleganza eterna' dei Dogi di Venezia, Genova e Ancona, oltre al gonfaloniere di Firenze con il rex Lombardiae.
1447: Morte di Filippo Maria Visconti.
1456: con la mediazione di
Cangaleazzo e del delfino Luigi, Filippo di Borgogna e Renato d'Angiò proclamano
una solenne riconciliazione. Ire di Carlo VII re di Francia.
Accordo di Chambery: Renato vende al sovrano la contea di Maine, che li avrebbe
girati come appannaggio vitalizio al delfino Luigi (ricordiamo che il figlio era
decisamente in rotta con il padre, in questo periodo); in cambio gli Angioini
avrebbero ottenuto a titolo di risarcimento il Viennois. Filippo avrebbe venduto
i suoi diritti ai possedimenti borgognoni all'interno dei vescovati lorenesi.
1459: Grande ribellione delle arti contro Cangaleazzo, repressa con violenza. Abolizione delle arti.
1462: Grande ribellione delle cortes di Barcellona contro Giovanni II d'Aragona (fratello di Alfonso il Magnanimo).
1465: Luigi XI di Francia chiede alla Borgogna la restituzione delle città della Somme devolute al ducato in virtù del trattato di Arras debbano essere restituite. Carlo, figlio di Filippo si oppone e crea la 'lega del bene pubblico' contro il sovrano.
1466: le cortes di Barcellona
chiamano come sovrano Carlo di Francia, fratello di re Luigi XI.
Vittoria di Monthlery della lega (grazie al fatto che in questa TL Renato è
propenso ad appoggiare Carlo, quindi manda suo figlio Giovanni a sostegno della
lega).
Trattato di Conflans: cessione di Etampes alla Bretagna, riconoscimento dei
diritti borgognoni sulle città della valle della Somme, riconoscimento della
dipendenza diretta del ducato di Bar dal Sacro Romano Impero senza alcuna
ingerenza del regno di Francia, cui Renato doveva obbedienza vassallatica solo
in quando conte del Viennois; cessione a Giovanni V d'Armagnac del viscontado di
Bayonne; cessione a Carlo, duca di Berry e fratello del re di Francia del ducato
di Guienna a titolo vitalizio. Gastone di Foix, alleato del re di Francia,
avrebbe ceduto sempre a Giovanni V d'Armagnac la contea di Comminges.
1469: Federico Tascavuota del Tirolo vende i suoi diritti sull'Alsazia a Carlo il Temerario di Borgogna.
1471: Carlo il Temerario annette la Gheldria. Divisione di Pedralbes: Carlo di Guienna diviene re di Catalogna e conte d'Aragona a Nord dell'Ebro. Giovanni II re di Aragona e conte di Valencia a sud dell'Ebro.
1473: Carlo il Temerario annette la Frisia occidentale. Gli svizzeri dichiarano guerra a Carlo. Ad essi si legano la lega delle città sveve e alsaziane, i vescovati di Metz e Verdun (Toul decide di appoggiare Carlo), i Savoia. La lega anti-borgognona ha il tacito appoggio di Can Galeazzo.
1473: Verde, figlia di Francesco, fratello di Cangaleazzo, sposa Giacomo II di Lusignano re di Cipro. Gian Mastino sposa XXX. Grande vittoria di Carlo di Borgogna contro i confederati a Mulhouse. Renato II, figlio di Yolanda di Bar e Francesco Visconti si sposa con Maria di Borgogna (Francesco Visconti appoggia la famiglia d'adozione, naturalmente)
1474: Can Galeazzo rompe gli indugi e si allea con Luigi re di Francia contro Carlo di Borgogna e Renato d'Angiò. Morte di Enrico di Castiglia, inizio della guerra di successione castigliana: da una parte Giovanna detta la Beltraneja, moglie di re Alfonso del Portogallo; dall'altra Isabella, moglie di Ferdinando d'Aragona, figlio di Giovanni II d'Aragona.
1475: Giovanni II d'Angiò,
erede di Renato, muore. Unica erede di Renato resterebbe Yolanda di Bar, sposata
a Francesco, fratello di Can Galeazzo. Quest'ultimo, in virtù della
considerazione che unico erede di tutti i domini angioini sarebbe stato comunque
il nipote Renato II (detto Renatino), per assicurargli una successione stabile,
firma una pace separata con gli Angiò, del resto non fidandosi troppo nemmeno
delle mire egemoniche di Luigi XI.
Sconfitta degli svizzeri e degli alsaziani, i cui territori vengono in gran
parte incamerati dalla Borgogna. Il re di Francia in compenso guadagna territori
in Guascogna e Guienna, a danno di Albret, Armagnac e del fratello. Il titolo di
duchi di Savoia passava agli Angiò. I Savoia rimanevano conti solo di Aosta e di
qualche valle laterale. I Vescovati di Metz e Verdun annessi ai possedimenti
lorenesi.
1477: morte di Carlo il Temerario di Borgogna. Luigi si annette Rethel, Eu, Iles, Nevers, Vertus, Semur, Chinon e lo Charolais. Renato II viene incoronato come Rex Lotharingiae.
1478: pace di Toros de Guisando: il Leon va alla Beltraneja (e dunque al Portogallo); la Castiglia a Isabella (e dunque all'Aragona).
1480: nasce Filippo Maria, figlio di Maria di Borgogna e Renato II d'Angiò.
1481: Gian Mastino Visconti muore senza eredi legittimi. Cangaleazzo, in forte crisi depressiva, decide di affidare il suo regno in testamento alla figlia Bona e al di lei figlio Alfonso di Granada.
1485: morte di Cangaleazzo. Dopo una iniziale serie di screzi, Renatino accetta che la corona lombarda passi ad Alfonso. In cambio la Sicilia passa nel novero delle corone di Renatino.
1486: Alfonso di Lombardia e Granada sposa Margherita d'Asburgo figlia di Massimiliano, arciduca d'Austria. Maria di Borgogna muore di parto. Poco dopo muore anche Francesco Visconti. Renatino a questo punto affida la reggenza della Lotaringia a Francesco II di Bretagna, mentre lui va a risiedere a Napoli.
1488: Anna di Bretagna viene data in sposa a Massimiliano d'Asburgo. Renatino affida allo stesso Massimiliano la reggenza in Lotaringia.
1490: Morte di Renatino. Il
re di Francia approfitta per muovere guerra. Alfonso di Lombardia ottiene la
reggenza per disposizione testamentaria di Napoli, Sicilia e Provenza.
Carlo VIII di Francia annette la Borgogna ducale e il pays de Retz, ma non la
Bretagna.
1494: accordo matrimoniale di famiglia. Alfonso darà in sposa la figlia novenne Giovanna (con l'assenso di Massimiliano d'Asburgo) al quattordicenne Filippo Maria Visconti. Morte di Ferrante di Granada.
1503: Massimiliano d'Asburgo muore. Si rinnova la guerra con la Francia. Filippo Maria e Alfonso firmano un accordo segreto con Enrico VII Tudor, al quale 'danno' in sposa Anna di Bretagna, rapendola prima che possa catturarla Luigi XII (il nuovo re francese). Alfonso deve cedere all'imperatore l'Austria alta e bassa e la Stira, tenendosi Tirolo, Carinzia e Carniola.
1516: Morte di Alfonso. Con i
suoi figli premorti a lui, unico erede anche dei suoi possedimenti diviene
Filippo Maria Visconti.
Ecco la titolazione completa: “Filippo Maria, per grazia di Dio e per
intercessione della Beata Vergine Maria re di Granada e Tingitania, duca di
Murcia, conte di Huelva, re di Maiorca, re d'Italia, Lombardia, Napoli e
Sicilia, duca di Milano, duca di Verona, doge supremo di Venezia, Genova e Noli,
podestà perpetuo di Lucca Pisa e Siena, primo gonfaloniere di giustizia di
Firenze, re di Lotaringia, duca e conte di Borgogna, barone di Montbeliàrd,
conte di Ferrette, conte di Brisgau, conte d'Alsazia, visconte del Vaud, duca di
Piccardia, conte di Boulogne, conte di Vermandois, conte di Artois, conte di
Fiandra, conte di Hainault, duca di Brabante, duca di Lussemburgo, duca di
Limburgo, conte di Namur, duca di Gheldria, conte di Zutphen, conte di Olanda,
conte di Zelanda, duca di Lorena, duca di Bar, conte di Viennois, conte di
Savoia, conte di Provenza, conte del Tirolo, duca di Carniola, duca di Carinzia,
re di Cipro e di Gerusalemme”.
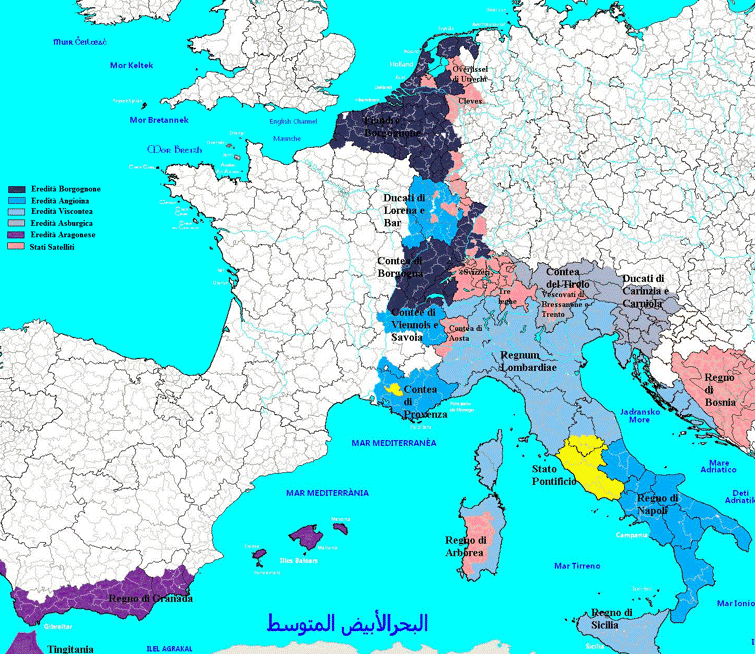
.
E Bhrihskwobhloukstroy commenta:
Propongo un provvisorio schema di raggruppamento delle ucronie per unificare l'Italia in anticipo:
Primo
criterio:
a) «Italia unificata» ma non unita ad altri Stati
b) «Italia unificata» e anche unita ad altri Stati
Secondo
criterio:
a) che alterano la Genealogia:
a1) ‘tautologiche’ (Domanda: «Come fare in modo che X non muoia senza Eredi /
senza Eredi maschi]?»; Risposta: «Fargli nascere un Erede [maschio]»);
a2) diversi Matrimonî; in questo modo però la costruzione della Storia dei
successivi dodici secoli diventa sempre più
arbitraria o inevitabilmente molto generica);
b) che non alterano la Genealogia
Terzo
criterio:
a) introducono un Punto di Divergenza anteriore (per esempio Magiari e
Vichinghi più forti)
b) partono dall’843/855
Quarto
criterio:
a) modificano un dato strutturale (per esempio le Leggi di Successione)
b) modificano specifiche decisioni apparentemente indifferenti
(che non riguardano Matrimonî né Successioni), ma che nella realtà hanno avuto
conseguenze decisive
.
C'è anche la proposta di Renato Balduzzi: Ezzelino Re d'Italia!
Ezzelino III da Romano fu uno dei primi signori di fatto della storia medievale italiana. Fu un abile condottiero, riuscendo a sottomettere con l'appoggio imperiale quasi tutto il Veneto e buona parte della Lombardia, dove divenne vicario imperiale. Uomo di straordinaria crudeltà e disprezzo per i sacramenti, nel 1250 venne scomunicato dal papa Alessandro IV, che indisse una crociata contro i suoi domini per annientarlo e quindi indebolire il potere imperiale appena dopo la morte di Federico II. Man mano abbandonato dai suoi alleati storici, venne rovinosamente sconfitto a Cassano d'Adda, dove il tiranno morì in seguito alle ferite riportate in battaglia. E se invece Ezzelino riesce a passare dalla parte guelfa al momento giusto, cosa succede? Senz'altro dovrà ribaltare tutte le sue alleanze, che comunque gli si sono ritorte contro. L'ex amico Oberto Pelavicino sarà probabilmente uno dei primi a cadere: nonostante la resistenza della popolazione, Ezzelino conquista Milano e tutto il suo contado, spingendosi fino al Piemonte orientale. Da qui potrà attaccare altre città ghibelline, come Ferrara, estendendo il proprio dominio a quasi tutta la Pianura Padana. Avendo alla conquista della Lombardia già 65 anni, egli passerà in breve tempo i suoi domini al figlio Pietro, figlio del matrimonio con Selvaggia II, figlia di Federico II di Svevia. E' quindi probabile un altro cambio di bandiera e forse la restaurazione alla fine del Duecento del regno d'Italia imperiale sotto la dinastia dei Da Romano, con un pontefice ormai impossibilitato ad intervenire...
.
E ora, l'idea di Generalissimus:
Complice anche il fallimento di tutte le trattative diplomatiche, comprese quelle di Caterina da Siena e Bernabò Visconti, la Guerra degli Otto Santi, scatenata da Firenze contro i legati pontifici che stavano riassoggettando i territori dello Stato della Chiesa in vista dell'imminente ritorno del papa da Avignone a Roma, continua e si conclude con la vittoria delle città assoggettate contro il Papa. Milano, Lucca, Siena, Pisa, Arezzo, Viterbo, Perugia, Città di Castello, Montefiascone, Foligno, Spoleto, Gubbio, Terni, Narni, Todi, Assisi, Chiusi, Orvieto, Orte, Toscanella, Radicofani, Sarteano, Camerino, Fermo, Ascoli, Bologna, Bolsena e altre città si liberano da ogni influenza papale. Cosa succede all'Italia e al potere temporale dei Papi? Vista la situazione il Papa deciderà di rimanere ad Avignone? E che accade se le infuocate lettere di Coluccio Salutati riescono a far deflagrare la rivolta anche nella stessa Roma?
.
Gli risponde di nuovo Paolo:
Si può pensare che:
I) Firenze prosegue la guerra
II) Rivoluzione, riuscita, di Roma, che si eleva a repubblica
A questo punto potrebbe succedere quanto segue:
a) Bernabò vedendo l’andamento della cosa, decide di “allearsi” a Firenze.
b) a Milano si alleano, ovviamente, anche Pisa, Lucca e Siena (malgrado l’ostilità reciproca).
c) Firenze ha paura dell’alleato, ma dato che Napoli in questo momento è un po’ in una situazione complessa, non può far altro che digerire la cosa.
d) rovesciamento del governo fiorentino. i filoghibellini tentano un colpo di stato, fallito, che scatena una reazione guelfa estremista.
d) la repubblica romana si allea con Bernabò.
e) Firenze su allea con Venezia.
f) guerra tra Firenze e Milano.
g) Firenze viene piallata.
h) coalizione filo-francese contro Milano
Poi tutto dipende da cosa fanno Angioini, Aragonesi e Venezia a questo punto (e francesi anche).
.
Diamo adesso la parola a Tommaso Mazzoni:
Poche dinastie sono sopravvissute dal medioevo fino ai giorni nostri in linea Maschile; l'impresa è riuscita sostanzialmente ai Capetingi, ai Savoia, agli Hohenzollern, ai Lorena, ai Wittelsbach e ai Wettin, e alcune casate Irlandesi e Gallesi. Si potrebbe obiettare che anche ai Medici e ai Visconti sia in realtà riuscito tramite linee più o meno legittime, ma escluse dalla successione, ma, appunto, sono escluse dalla successione, e non è a loro a cui è dedicata questa serie di PoD.
1) Asburgo Eterni: il figlio di Carlo VI, Leopoldo Giovanni, campa fino a 65 anni, sposa la cugina Maria Giuseppa e mette al mondo Giuseppe Carlo Leopoldo, futuro imperatore a sua volta, quindi la Guerra di Successione Austriaca non scoppia, non solo, Carlo VI si evita tutte le concessioni necessarie per far firmare la Pargmatica Sanzione, quindi niente Guerra di Successione Polacca, e niente Guerra Austro-Turca del 1735-1739. Scoppierà una guerra per la Lorena e la Guerra di Successione Toscana.
2) Medici Eterni: Ferdinando de' Medici non prende la sifilide, mette al mondo vari figli fra cui l'erede Cosimo IV; per Francesco di Lorena ci vuole un'altro feudo, magari il Ducato di Milano, oppure la Boemia. Come si comporternno Ferdinando III e i suoi successori nelle future guerre europee? Cercheranno di far valere i propri diritti su Parma?
3) Farnese eterni: Enrichetta d'Este, Duchessa Vedova di Parma, risulta effettivamente incinta, e da lei nasce un figlio Maschio, battezzato Antonio II, che nonostante le trame di Elisabetta Farnese, vive e cresce, sotto la reggenza della Madre ed è quindi alleato, attraverso Casa d'Este, degli Asburgo; Riusciranno questi Farnese Ucronici a prosperare? E come?
4) Este eterni: Rinaldo Ercole non muore poco dopo la nascita e succede al padre nei diritti al trono di Modena, come Rinaldo II; sposerà una principessa Austriaca e avrà un figlio, Ercole IV che, forse, sarà meno reazionario di Francesco IV (altrimenti l'unico possibile cambiamento è l'annessione di Modena all'Austria, ma la cosa mi pare improbabile).
5) Normanni eterni: Guglielmo Adelin non muore e ha un gran numero di discendenti, succede al padre come Guglielmo III, ed è succeduto dal figlio Enrico II; cosa cambia senza i Plantageneti sul trono d'Inghilterra? Meno Conflitti con la Francia? (I Normanni erano vassalli abbastanza leali); Magari l'interesse Inglese si volge da subito verso Irlanda, Scozia e Galles. La Francia, senza distrazioni a nord, inizierà prima la sua corsa ad est?
6) Lusignano di Cipro eterni: Caterina Cornaro dà alla luce almeno un figlio maschio e la stirpe dei Lusignano può continuare a regnare sull'Isola. Non essendo più un possedimento veneziano, potrebbe eventualmente riscuotere più simpatie la sua difesa da parte degli altri Stati Cristiani. Addirittura potrebbe essere scongiurata perfino l'invasione se la popolazione si coinvolge nella lotta, mentre nella HL i greci rimasero perlopiù indifferenti allo scontro o, addirittura, parteggiarono per i turchi.
Mel di Borgo Valbelluna (BL), il castello di Zumelle (foto di Enrico Pizzo)
.
Chiudiamo per ora con l'intervento del nostro Bhrihskwobhloukstroy:
Nel 1328 Castruccio Castracani non torna a Pistoia e resta a Roma con Ludovico IV, hanno abbastanza cavalieri per annientare Roberto d'Angiò, con le forze del Regno di Sicilia (anche senza Trinacria) tornano nel Regno Longobardo, entro due anni Giovanni di Boemia si può presentare esattamente come nella Storia vera e riconciliare Guelfi e Ghibellini, mentre Ludovico si comporta veramente come Braccio Secolare del Processo di Pisa contro Giovanni XXII, a questo punto sottomette o incamera la Provenza Angioina (con gli annessi Piemonte e Liguria), si presenta ad Avignone e arresta Giovanni XXII (altrimenti questi fugge, ma viene catturato da Edoardo III). È il momento più delicato della Successione Capetingia e Ludovico può sfruttare l'occasione.
Chissà cosa avrebbero pensato quelli che nel novembre del 1327 si trovavano in qualche Abbazia dell'Appennino Settentrionale e temevano Bertrando del Poggetto...
In quel momento Giovanni XXII non poteva avere scampo. Chissà come si sarebbe comportato... Nessuno di noi crede ad alcuno dei pregiudizi sul cosiddetto Medioevo, purché non siamo tanto ingenui da escludere che fosse davvero possibile una condanna del Papa al rogo; avrebbe Jacques Duèze (/d'Euse) ritrattato (come di fatto ha implicitamente ritrattato nella Storia vera)? Avrebbe chiesto perdono a Niccolò V (Papa Rainalducci)? Avrebbe fatto la fine di Hus dando magari inizio allo Scisma dei “Caorsiti”?
Forse oggi non ci faremmo caso più di tanto, in pratica sarebbe stato anticipato il ritorno da Avignone a Roma, con in più un Papa divenuto Antipapa. È possibile che non avvenisse lo Scisma (propriamente detto) d'Occidente ed è molto verosimile che l'Impero sarebbe stato enormemente più forte – senza bisogno di altri Punti di Divergenza: sicuramente la Guerra di Successione Spagnola – se avesse avuto ugualmente luogo – sarebbe stata vinta dagli Asburgo (con tutto quello che ne consegue e che ho da ultimo riassunto nell'ucronia su Macao Olandese), ma è possibile che la Francia rimanesse a sua volta inglese e dunque che Filippo II diventasse Re Consorte dei Regni della cui Titolarità si fregiava, compresa la Francia (anche in questo caso con le ovvie conseguenze sia sull'Inghilterra sia sui Paesi Bassi). Contemporaneamente, Polonia e Ungheria sarebbero state e rimaste lussemburghesi o (/e) poi asburgiche e così via con tutte le ripercussioni sulla Riforma. Insomma, una valanga di conseguenze che renderebbero il Mondo attuale davvero diverso da come lo conosciamo (geopoliticamente)
.
Se volete contribuire alle discussioni in corso, scriveteci a questo indirizzo.
