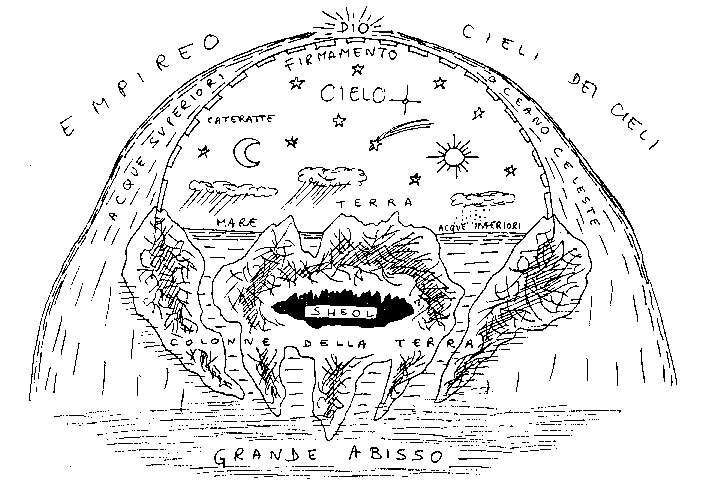
Chi legge il versetto 4 del Salmo 148 vi trova questa sibillina invocazione:
« Lodatelo, cieli dei cieli, e voi acque al di sopra dei cieli! »
Non si può assolutamente capirne il significato se non si fa riferimento alla visione cosmologica degli antichi popoli mesopotamici, Ebrei inclusi, rappresentata dal seguente disegno:
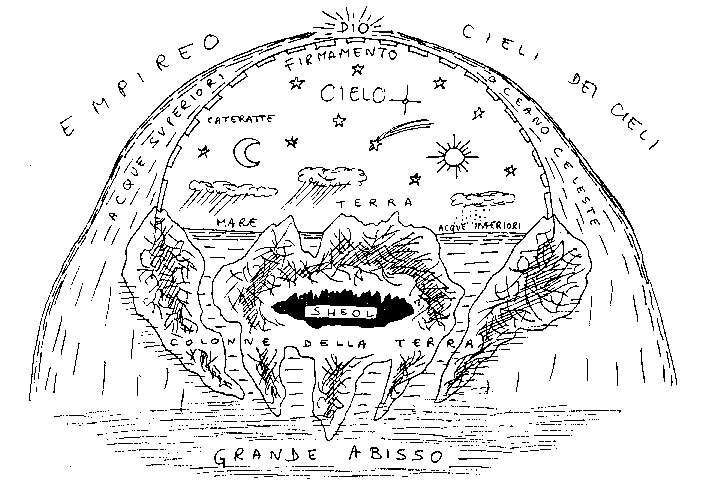
Questa primissima teoria cosmologica, sviluppata probabilmente già nel 4000 a.C., era formula sulla base di dati empirici raccolti durante semplici osservazioni del cielo. Essa si fondava sull'assunzione (a quei tempi data per scontata) che la Terra fosse piatta e poggiasse su colonne. Ma queste a loro volta dove poggiavano? Su di un ipotetico Abisso (in ebraico Tehom), riempito dalle "acque inferiori". La Terra è sormontata da un firmamento, inteso come una vera e propria calotta di vetro, che di giorno appare azzurro perché... al di sopra di esso si trovano altre acque, le "acque superiori" appunto, e su di esse altri cieli, i "Cieli dei Cieli", sede della trascendenza divina. Alla luce di tutto questo si capisce perché, nel secondo giorno della Creazione, Iddio separa "le acque inferiori dalle superiori", creando l'ordine (Cosmos) dal Caos primigenio, ed anche perché JHWH decide di distruggere l'umanità per mezzo di un diluvio: rimuovendo la separazione tra i due oceani, tutto ritorna nell'alveo di un Disordine primordiale indistinto ed i peccatori sono spazzati via senza possibilità di scampo.
Una concezione puerile? Può darsi;
tuttavia, anche dopo la scoperta della sfericità
della Terra ad opera di Pitagora (VI sec. a.C.), la maggior parte dei filosofi
assunse che essa fosse ferma al centro dell'universo, e che tutti i corpi
celesti si muovessero lungo orbite stabili intorno a essa; il che non appare
meno puerile, se confrontato con le conoscenze attuali. Eppure, tale
concezione ricevette il consenso del filosofo Aristotele
e dell'astronomo Tolomeo, entrambi sostenitori
dell'ipotesi di un universo finito, sostanzialmente statico. Soprattutto a causa
del prestigio di Aristotele, l'ipotesi che la Terra costituisse il centro
dell'universo rimase praticamente immutata fino al 1543, quando l'astronomo  polacco
Niccolò Copernico
(1473-1543) pubblicò il « De
Revolutionibus Orbium Coelestium » (Sulla rivoluzione delle sfere
celesti). Egli propose un nuovo modello planetario che vedeva i pianeti muoversi
su orbite circolari intorno al Sole (secondo la teoria situato al centro
dell'universo), riconoscendo così che il moto delle stelle fosse dovuto in
realtà alla rotazione della Terra intorno al proprio asse. Il passo successivo
venne compiuto dall'astronomo tedesco Giovanni Keplero
(1571-1630) il quale, convinto sostenitore del sistema copernicano, enunciò le
tre leggi che regolano il moto dei pianeti. L'ipotesi copernicana trovò poi in
Galileo uno dei più illustri sostenitori. Il matematico e fisico britannico
Isaac Newton dedusse le leggi di Keplero dai principi generali del moto e dalla
teoria della gravitazione universale, dimostrando la validità generale di
queste teorie.
polacco
Niccolò Copernico
(1473-1543) pubblicò il « De
Revolutionibus Orbium Coelestium » (Sulla rivoluzione delle sfere
celesti). Egli propose un nuovo modello planetario che vedeva i pianeti muoversi
su orbite circolari intorno al Sole (secondo la teoria situato al centro
dell'universo), riconoscendo così che il moto delle stelle fosse dovuto in
realtà alla rotazione della Terra intorno al proprio asse. Il passo successivo
venne compiuto dall'astronomo tedesco Giovanni Keplero
(1571-1630) il quale, convinto sostenitore del sistema copernicano, enunciò le
tre leggi che regolano il moto dei pianeti. L'ipotesi copernicana trovò poi in
Galileo uno dei più illustri sostenitori. Il matematico e fisico britannico
Isaac Newton dedusse le leggi di Keplero dai principi generali del moto e dalla
teoria della gravitazione universale, dimostrando la validità generale di
queste teorie.
Perché la cosmologia potesse basarsi su
considerazioni quantitative, e quindi divenire una scienza esatta, fu necessario
attendere che gli astronomi fossero in grado di determinare la distanza dei
corpi celesti. Una prima misura della distanza delle stelle venne eseguita
all'inizio del XIX secolo dall'astronomo tedesco Friedrich
Wilhelm Bessel. Egli valutò che la distanza della
stella 61 Cygni fosse pari a 600.000 volte la
distanza della Terra dal Sole. Nel 1917 l'astronomo statunitense Harlow Shapley
fornì le prime indicazioni sulle dimensioni della nostra galassia, la Via
Lattea, attribuendole un diametro di circa 350.000 anni luce. Egli, tuttavia,
trascurò l'assorbimento della luce proveniente dalle stelle distanti da parte
delle particelle di polvere galattica. Questo fenomeno riduce la luminosità
apparente degli oggetti più lontani, facendoli sembrare più distanti di quanto
non siano realmente. Shapley ottenne così una sovrastima delle effettive
dimensioni della Via Lattea. Attualmente, per il diametro della parte visibile
della galassia si assume il valore di 30.000 parsec (1)
(circa 100.000 anni luce). L'astronomo danese Jan Hendrik Oort scoprì che
il Sole impiega circa 250 milioni di anni per compiere un'orbita completa
intorno al centro della Via Lattea, e da questo risultato dedusse, in base alla
terza legge di Keplero, che la massa della nostra galassia è pari a circa 100
miliardi di masse solari.

Nel 1912 l'astronomo statunitense Vesto
M. Slipher osservò che le righe degli spettri di emissione della maggior
parte delle galassie presentavano un caratteristico spostamento verso lunghezze
d'onda maggiori. Questo fenomeno, interpretato sulla base dell'effetto Doppler (3),
dimostrava che la maggior parte delle galassie si sta allontanando dalla nostra.
Nel 1929, confrontando le distanze di
alcune galassie (determinate in base al metodo delle variabili cefeidi), con gli
spostamenti verso il rosso osservati da Slipher, Hubble scoprì che la velocità
di recessione delle galassie è direttamente proporzionale alla loro distanza.
Questo risultato, noto come legge di Hubble, è tuttora uno dei più importanti
principi della cosmologia. La determinazione del rapporto tra la velocità di
recessione e la distanza di una galassia (detto costante di Hubble) è uno dei
problemi aperti della cosmologia; la notevole incertezza sul valore di questa
costante è dovuta al fatto che, ancora oggi, è tutt'altro che semplice
stabilire con precisione la distanza delle galassie e degli oggetti celesti in
generale. In base alle più recenti misure effettuate con il telescopio spaziale
Hubble, il valore della costante di Hubble risulta oggi compreso tra i 40 e i 70
Km/s per megaparsec (un megaparsec equivale a un milione di parsec).
(1) Unità di misura di lunghezza utilizzata, insieme all'anno luce, per le distanze delle stelle. Un parsec è la distanza di una stella che ha una parallasse, cioè uno spostamento apparente della posizione (se osservata dagli estremi opposti dell'orbita terrestre), di due secondi d'arco. La parola parsec è un'abbreviazione delle parole parallasse e secondo. Questa distanza corrisponde a 30,86 miliardi di km; un parsec equivale a 3,26 anni-luce e a 206.265 unità astronomiche.
(2) Stella di luminosità variabile, il cui prototipo è la stella delta del Cefeo, scoperta nel 1784 dall'astronomo dilettante John Goodricke. Peculiarità delle Cefeidi è di mostrare incrementi repentini della luminosità, seguiti da diminuzioni molto più lente. Nel 1941 l'astrofisico britannico Arthur Eddington suggerì l'idea, succesivamente verificata come corretta, che alla base della variabilità delle Cefeidi ci sia la periodica ionizzazione e deionizzazione dell'elio contenuto negli strati superficiali della materia stellare. Eddington riuscì anche a dare una spiegazione fisica del fatto che una stella Cefeide mostra una ben precisa relazione fra la sua luminosità massima e il periodo di variazione di questa. Tale relazione, detta relazione periodo-luminosità, era già stata osservata e determinata nel 1912, dall'astronoma statunitense Henrietta Leavitt. È importantissima in cosmologia, perché mette in relazione il periodo di variabilità della Cefeide con il suo splendore assoluto, e consente dunque, una volta misurato il periodo di variabilità, di dedurne la luminosità intrinseca. Confrontando quest'ultima con la luminosità apparente della stella, è possibile successivamente dedurre la distanza della stessa. Grazie a qusta relazione, ed essendo stelle di grande luminosità e dunque osservabili anche se si trovano a distanze enormi, le variabili Cefeidi costituiscono uno dei pochi “indicatori di distanza” che gli astronomi possono utilizzare.
(3) Apparente variazione della lunghezza, o della frequenza, di un'onda sonora o luminosa quando la sorgente emittente si muove rispetto all'osservatore. L'effetto, che prende il nome dal fisico austriaco Christian Johann Doppler, è dovuto al fatto che le onde percepite dall'osservatore si susseguono con frequenza maggiore se la sorgente è in avvicinamento e con frequenza minore nel caso contrario. Così, se una sorgente che emette un suono di altezza costante si muove verso l'osservatore, questi percepisce un suono più acuto, mentre se essa si allontana egli percepisce un suono più grave. Il fenomeno si osserva, ad esempio, quando si ode il fischio di un treno dalla banchina di una stazione oppure da un altro treno. Analogamente, le linee dello spettro di un corpo luminoso, come una stella, risultano spostate verso il violetto, se esso si sta avvicinando alla Terra, e verso il rosso se si sta allontanando.