
Per comprendere la principale opera di Kierkegaard bisogna rileggere un passaggio famosissimo dell'epopea di Abramo:
« Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo, Abramo!». Rispose: «Eccomi!». Riprese Iddio: «Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco, và nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò». Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. » (Genesi 22, 1-3)

Secondo il filosofo danese, infatti, simbolo della fede è Abramo che, in nome della fede in Dio, alza il coltello sul proprio figlio. Ma come fa Abramo ad essere sicuro che è proprio Dio ad avergli comandato di uccidere il figlio Isacco? E se si accetta la fede, come fa Abramo, allora l'autentica vita religiosa appare in tutta la sua paradossalità, giacché la fede in un Dio che ordina di uccidere il proprio unico figlio ed il principio morale che impone di amare il proprio figlio, entrano inevitabilmente in conflitto e conducono il credente dinanzi ad una tragica scelta. La fede è paradosso e angoscia di fronte a Dio come possibilità infinita. Nella sua grande opera Timore e tremore (1843), Søren Kierkegaard illustrò proprio la necessità di compiere il "salto" nella vita religiosa, nonostante essa sia "assurda" e rischiosa. L'individuo vi è condotto dal sentimento dell'angoscia (Il concetto dell'angoscia, 1844), che è fondamentalmente timore del nulla ma nel contempo apertura di un orizzonte di libertà. « L'angoscia è la possibilità della libertà - scrisse in essa il grande filosofo, - soltanto quest'angoscia ha, mediante la fede, la capacità di formare assolutamente, in quanto distrugge tutte le finitezze, scoprendo tutte le loro illusioni ». L'angoscia forma "il discepolo della possibilità" e prepara "il cavaliere della fede."
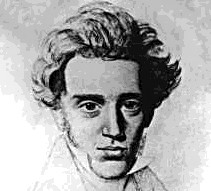 Søren
Aabye Kierkegaard (Copenaghen 1813-1855) ricevette un'educazione pietista
e venne assai influenzato dal padre, ricco mercante e scrupoloso luterano dalla
cupa religiosità. Studiando teologia e filosofia presso l'Università di
Copenaghen si accostò alla filosofia hegeliana, dalla quale prese le distanze
dopo breve tempo. Nel 1840 si fidanzò con la diciassettenne Regine Olsen; il
matrimonio tuttavia gli parve incompatibile con la vocazione filosofica che
sentiva crescere dentro di sé. Laureatosi in filosofia nel 1841 con una
dissertazione intitolata Sul concetto di ironia, nel 1842 ruppe all'improvviso
il fidanzamento e decise di utilizzare l'eredità lasciatagli dal padre per
dedicarsi interamente all'attività intellettuale.
Søren
Aabye Kierkegaard (Copenaghen 1813-1855) ricevette un'educazione pietista
e venne assai influenzato dal padre, ricco mercante e scrupoloso luterano dalla
cupa religiosità. Studiando teologia e filosofia presso l'Università di
Copenaghen si accostò alla filosofia hegeliana, dalla quale prese le distanze
dopo breve tempo. Nel 1840 si fidanzò con la diciassettenne Regine Olsen; il
matrimonio tuttavia gli parve incompatibile con la vocazione filosofica che
sentiva crescere dentro di sé. Laureatosi in filosofia nel 1841 con una
dissertazione intitolata Sul concetto di ironia, nel 1842 ruppe all'improvviso
il fidanzamento e decise di utilizzare l'eredità lasciatagli dal padre per
dedicarsi interamente all'attività intellettuale.
Verso la fine della sua vita Kierkegaard innescò una polemica con la Chiesa luterana danese e con il giornale satirico "Il Corsaro", rispondendo agli attacchi di entrambi dalle colonne della rivista "Il Momento", da lui stesso fondata. Gli ultimi scritti, come La malattia mortale (1849), danno rilievo alla sofferenza, intesa come essenza di una fede autentica, riflettendo una visione sempre più cupa del cristianesimo. Lo sforzo che gli richiedevano l'inesauribile attività di scrittore e le battaglie pubbliche cui prese parte compromisero gradualmente la sua salute. Nell'ottobre del 1855 fu colpito da paralisi; morì un mese dopo.
Kierkegaard si definì "scrittore cristiano": il suo interesse per l'esistenza del singolo e per il valore delle scelte individuali impresse segni profondi nella teologia e nella filosofia contemporanee, in modo particolare nell'esistenzialismo.Opere di Kierkegaard:
| 1841 |
Sul concetto di ironia con riferimento costante a Socrate (dissertazione di laurea) |
| 1843 |
Aut-aut (pubblicato con lo pseudonimo di Victor Eremita) |
| 1843 |
Timore e tremore (con lo pseudonimo di Johannes de Silentio) |
| 1843 |
La ripresa (con lo pseudonimo di Costantin Constantius) |
| 1844 |
Briciole di filosofia (con lo pseudonimo di Johannes Climacus) |
| 1844 |
Il concetto dell'angoscia (con lo pseudonimo di Vigilius Haufniensis) |
| 1845 |
Stadi nel cammino della vita (con lo pseudonimo di Hilarius Bogbinder) |
| 1846 |
Postilla conclusiva non scientifica (con lo pseudonimo di Johannes Climacus) |
| 1847 |
Discorsi cristiani (raccolta di discorsi edificanti) |
| 1849 |
La malattia mortale (con lo pseudonimo di Anticlimacus) |
| 1850 |
Esercizio del cristianesimo (con lo pseudonimo di Anticlimacus) |