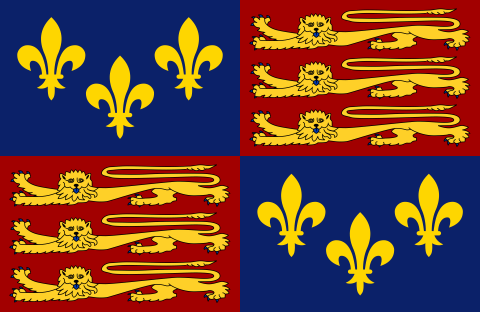
Montjoie, Saint-Georges!
ovvero: i Plantageneti sul trono di Francia
di feder
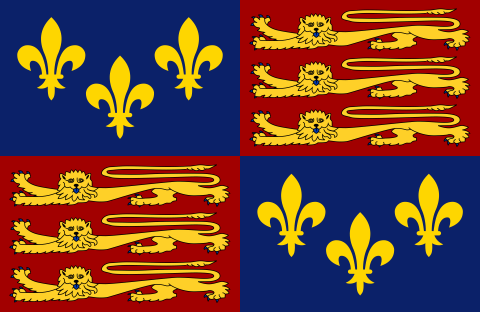
Dedicata al nostro Comandante. Possa ogni giorno ispirarci a scrivere ucronie sempre nuove!
.
La Guerra dei Cent'Anni fu certamente tra
i più importanti conflitti dell'età medievale, e, forse, della storia intera.
Quand'essa iniziò, le battaglie erano ancora decise dall'assalto di forza bruta
e dalle cariche di cavalleria; per quand'essa finì, venivano già schierate le
prime bombarde e gli eserciti erano costituiti perlopiù di coscritti in massa.
Ma non solo guerra: lo stato costante di belligeranza tra Francia e Inghilterra
infatti contribuì a dare forma ad entrambe le nazioni, perlomeno nelle
caratteristiche per le quali le conosciamo (e apprezziamo?) oggi. Per i secoli
successivi l'Inghilterra, sconfitta sul continente, abbandonò ogni proposito di
espansione in terraferma, dedicandosi al mare; la Francia vittoriosa in
battaglia, invece, si illuse di poter proiettare quest'influenza sull'intera
Europa, perseguendo una politica di egemonia che avrebbe toccato il suo
(effimero, c'è da dirlo) apice solo sotto Napoleone, a quasi quattrocento anni
dalla conclusione del conflitto.
Instillare un punto di divergenza all'interno di questa magnitudinale serie di
eventi è perciò una faccenda delicata, su cui, come forse sapranno i più dediti
di voi, mi sono arrovellato per anni. La stessa storiografia è incerta sulle
ragioni dell'esito del conflitto: perché un'Inghilterra che fino a quel momento
aveva determinato il corso generale del conflitto vincendo, se non ad ogni
accorrenza, quantomeno il grosso degli scontri, aveva potuto essere battuta da
una Francia ridotta ai minimi termini, guidata da un sovrano debole, ostaggio
dell'ingombrante partito armagnacco?
Certamente buona parte della responsabilità è da ricercarsi nella figura di
Giovanna d'Arco (o, per dirla alla francese, la Pulzella) che gli storici
romantici, in specie ottocenteschi, hanno individuato come artefice della c.d.
riscossa morale della Nazione, la quale avrebbe indubbiamente condotto alla
vittoria. Io mi trovo solo parzialmente d'accordo con questa interpretazione: se
è vero che il valore dell'operato militare di Giovanna fu risibile, bisogna
riconoscere che le più fondate ragioni della ripresa francese devono essere
riconosciute nella sproporzione di uomini e mezzi messi in campo dalle corone
dei due Paesi. A metà del secolo, il re di Francia, che pure ometteva di far
pagare le tasse al clero e ai suoi nobili, poteva annoverare ben 17 milioni di
sudditi; a suo confronto, l'isola d'Inghilterra, con appena 3 milioni di
abitanti, impallidiva.
Un altro fattore, a mio giudizio più decisivo, della sconfitta inglese fu
rappresentato dall'improvvisa morte, probabilmente causata dalla dissenteria
contratta durante l'assedio di Meaux, del giovanissimo Enrico V. Tant'è vero che
io mi ritengo convinto che, qualora la data della dipartita di Enrico V fosse
allontanata di qualche decennio, in accordo con la durata naturale della vita di
un individuo, questi, che ne aveva certamente la stoffa, sarebbe potuto
diventare una delle figure di monarchi più decisive della storia inglese, quasi
un rifondatore del Regno. Basti pensare a cosa accadde dopo l'incidente che ne
causò la morte: con il figlio, Enrico VI, ancora in fasce, il potere venne
spartito fra i suoi due fratelli: l'abile Giovanni di Lancaster, duca di Bedford,
cui spettò la tutela del minore e la reggenza di Francia, e l'imbelle Goffredo,
duca di Gloucester, cui andò il titolo di Lord Protettore d'Inghilterra. La
moltiplicazione dei centri di comando, connessa alla litigiosità del consiglio
di reggenza del piccolo Enrico VI, può essere individuata come una delle ragioni
principali per cui gli Inglesi, da parte vincente, si trovarono di lì a poco a
essere ributtati a mare senza troppi onori.
Proviamo a immaginare cosa sarebbe successo se nel 1422 Enrico V non avesse
lasciato prematuramente questo mondo a Vincennes, vicino Parigi. Sicuramente la
campagna contro il Delfino sarebbe continuata, con importanti successi: al
momento della sua morte, il re era in viaggio verso la valle della Loira, di cui
l'esercito inglese avrebbe disposto facilmente. Con gli inglesi che,
approfittando dell'inverno, mettono a ferro e fuoco l'Angiò e il Maine, Giovanni
VI di Bretagna non si sarebbe azzardato a disertare il campo borgognone, temendo
la ritorsione del duca di Bedford, lasciato a governare le retrovie da Rouen. Un
anno dopo, Enrico V ha espugnato Orléans. Subito prima di attraversare il fiume
il re, che vuole assicurarsi di avere le spalle ben coperte, chiama a raccolta
gli alleati di Borgogna e di Bretagna alla sua corte, con cui sigla gli accordi
omonimi. Enrico V promette le più ampie libertà e garanzie; in cambio, egli si
aspetta fedeltà. Nessuno poteva sapere che la pace di Orléans sarebbe diventata
la pietra miliare del nuovo ordine in Francia.
Già, perché già l'anno successivo, con il passaggio della Loira, il Re sconfigge
il Delfino in una durissima battaglia presso Vierzon, quasi una seconda
Azincourt. Per gli armagnacchi le perdite sono altissime, e l'ostinata
resistenza di Iolanda d'Aragona, la quale aveva fatto praticamente una propria
creatura del non-fu Carlo VII, è risolta dal decisivo assedio di Bourges, con il
quale il Delfino è finalmente preso prigioniero. I suoi tentativi di fuga sono
rintuzzati dalla sorveglianza inglese. Enrico V rinuncia a metterlo sotto
processo per tradimento e lesa maestà verso la persona del Re di Francia (!)
com'era sua iniziale intenzione; egli invece scambia la vita di Carlo e della
sua bella moglie Maria, figlia di Iolanda, con la resa di quest'ultima, capofila
della fazione armagnacca. La famiglia Valois può continuare a vivere nei suoi
feudi ereditari, prima fra tutti, ovviamente, la contea omonima, al confine con
la Piccardia. Un trattato di pace è siglato ad Arras, nel 1425: segna la fine
delle ostilità sul continente e, nel complesso, l'inizio del governo inglese
sulla Francia.
.
Il regno di Enrico V (1413-1442, dal 1422 come reggente di Francia)
Il passaggio di potere con i Valois fu
rapido, ma non indolore. Prima di tutto, perché la fazione armagnacca era sì
sconfitta, ma non distrutta. In particolare, Enrico V si trovò non poco da fare
nel triennio 1428-1431, quando il potere inglese si trovò a fare i conti con
un'agitatrice di popolo che passava sotto il nome di Giovanna, della famiglia
d'Arco. Questa batteva l'Occitania, asserendo di aver ricevuto delle visioni da
Cristo e di poter guidare i Francesi alla vittoria. Le sue predicazioni furono
all'origine di un vasto movimento di rivolta, che per un periodo compromise
seriamente l'egemonia inglese sul mezzogiorno della Francia. Fortunatamente,
l'eretica (quasi sicuramente spalleggiata da Iolanda e da altri elementi della
nobiltà ostili) decise baldanzosamente di marciare a nord, invece che
fortificarsi nel sud, circondando la fedele piazzaforte di Bordeaux. Enrico V
inviò suo fratello Giovanni ad occuparsene, che fece piazza pulita della
rivolta. La Pulzella venne messa al rogo, con il beneplacito della Chiesa, che
temeva il riaccendersi dell'eresia albigese. Per questo servizio, il re gli
passò il titolo di duca d'Aquitania, con il compito di sovrintendere alla
gestione della zona.
La strada per la ripresa era tuttavia lunga, e tutta in salita. Nondimeno,
Enrico V la intraprese con rinnovata fedeltà. Per ripopolare le aree rimaste
vuote dalla guerra, il re chiamò in Francia elementi della popolazione inglese
(contadini, artigiani, ma soprattutto soldati arruolati), i quali si insediarono
soprattutto in Normandia, contribuendo a cementificare il potere regio in loco.
Re Enrico sistemò la propria corte a Parigi, dove aveva sede il consiglio di
reggenza di suo figlio guidato dal cardinale Beaufort e dalla regina Caterina;
in ogni caso, egli governava da Caen con il supporto dei suoi veterani,
sovrintendo all'opera di colonizzazione e stabilizzazione. Così, anche se il
grande esercito della conquista era stato disciolto, di quando in quando qualche
nobile mostrava segnali di irrequietezza, il re poteva partire all'assalto, e
stroncare la rivolta prima che questa diventasse seria. I nobili più riottosi si
riunirono spesso in cosiddette leghe (la più famosa rimase quella del Bene
Pubblico, sulla quale c'erano forti presunzioni di spalleggiamento da parte dei
Valois di Piccardia e di Borgogna), ma Enrico V si dimostrò in grado di
impiegare con fermezza lo scettro del sovrano, impedendo le derive centrifughe
della feudalità francese.
Più in generale, Enrico V importò in Francia il modello di regno normanno,
centralizzando l'amministrazione e imponendo una tassazione più egalitaria a
tutte le fasce della popolazione; così facendo, il re si alienò il supporto di
numerosi elementi della nobiltà, ma al suo posto guadagnò la fiducia della
nascente classe borghese-mercantile. Il diritto franco fu naturalmente abolito
in luogo di quello comune, ma l'utilizzo di quello romano, che aveva larga
circolazione nel meridione, venne tollerato. Conoscendo le difficoltà di
governare su un Paese diviso, il re abolì la divisione in cinque assemblee dei
Parlamenti locali, che erano costituiti su base regionale, a favore di un'unica
riunione permanente, convocata alla presenza del re a Parigi. In questa, il
terzo stato (borghesi, avvocati, medici, mercanti, professionisti di vario
genere) facevano la parte del leone. Anche l'Università di Parigi, cui fu
demandato l'arduo compito di tradurre e adattare il complesso
burocratico-amministrativo inglese alla Francia, fu ampiamente cooptata nel
potere, avallando di fatto il cambio di dinastia. Fu l'atto di riforma degli
Stati Generali, cui, pur subordinati alla supervisione del Parlamento inglese,
Enrico V allocò la potestà di acconsentire (o meno) all'imposizione di nuovi
tributi sul territorio del continente.
Enrico V sistemò anche l'ambigua questione con gli Stati "collegati" alla nuova
monarchia franco-britannica. I primi pensieri del monarca si rivolsero
ovviamente alla Scozia, sulla quale, profittando della persona di Giacomo I, che
era cresciuto in Inghilterra come ostaggio, Enrico V tentò di stabilire una
forma di larvato protettorato. Già dal 1425, quando il re di Scozia aveva
intrapreso una forte politica punitiva nei confronti dei nobili, Enrico V si
dimostrò compiacente ai suoi interessi, inviandogli il fratello Goffredo a
comando di un esercito come braccio destro. La repressione regia
sull'aristocrazia, ovviamente agita per mezzo degli Inglesi, fu feroce: intere
famiglie, come gli Albany-Stuart, vennero decimate. Negli anni successivi
importanti figure della resistenza incontrarono una tragica fine: prima di
tutto, Murdoch Stewart, giudice di Scozia; tre anni dopo toccò ad Alessandro di
Islay, conte di Ross, che venne preso in custodia in flagranza mentre attendeva
ai lavori del Parlamento in Inverness. Archibald Douglas fu arrestato nel 1431,
seguito da Giorgio, II conte di March, nel 1434. Pur tuttavia, nell'agosto del
1436 Giacomo fallì miseramente nell'assedio del castello di Roxburgh, e come
conseguenza dovette fronteggiare l'inefficace tentativo di trarlo in arresto di
fronte all'intero concilio ad opera di Robert Graham. Scampato a Graham, Giacomo
venne comunque ucciso a Perth nella notte fra il 20 e il 21 febbraio 1437 per
mano di un partigiano dell'indipendenza scozzese. Gli succedeva così il
figlioletto Giacomo II, sotto la reggenza congiunta della madre e di Goffredo,
longa manus di Enrico V che ombrava sulla Scozia.
Meno sanguinosi furono gli sviluppi della Francia. Nel 1435, a una nuova
convenzione, il re ricompensò finalmente la duratura amicizia di Filippo il
Buono, cui riconobbe le due regioni della Lorena e del Bar, oltre che la
definitiva indipendenza dalla corona di Francia. Analogo provvedimento arrivò
nei confronti di Bretagna e Provenza, nel secondo caso sottoponendo ovviamente
il riconoscimento alla promessa della vecchia Iolanda di cessare le proprie
interferenze nella politica interna del Regno di Francia. Sconfitti in Francia,
gli Angiò si diedero perciò a consolidare la propria posizione in Italia: da una
posizione di forte alleanza col Papa, che vedeva con preoccupazione la stretta
inglese sul clero francese, Iolanda sovraintese alla succesione di suo figlio
Renato sul trono di Napoli, al posto del fratello Luigi (III). La guerra contro
Alfonso V vide la coalizione degli Angiò, di Genova e del Papa, oltre che la
protezione eminente di Enrico V, che vedeva con favore lo spostamento del
baricentro di interessi angioino dalla Francia all'Italia. Il re d'Inghilterra
inviò una sostanziosa condotta nel meridione, che rintuzzò il tentativo di
assedio di Napoli condotto da Alfonso V. Peggio ancora, la flotta francese si
unì con quella genovese, sconfiggendo la flotta aragonese al largo di Palermo e
bloccando il sovrano in Sicilia. A queste condizioni, l'Aragona fu costretta a
siglare una pace, che vedeva il mezzogiorno, separato dall'epoca dei Vespri,
finalmente riunito nella persona di Renato (fedele vassallo papale). Un
matrimonio riappacificatore tra Giovanni II, figlio di Renato e duca di
Calabria, e Maria, figlia illegittima di Alfonso V, venne celebrato. Il tutto
mentre i I genovesi ricevevano, a titolo d'affitto, Stromboli, le Eolie, le
Egadi, Pantelleria e Lipari, insieme a una vasta gamma di privilegi commerciali
sulla Sicilia.

.
Il regno di Enrico VI (1442-1454, 1454-1471)
Ma Enrico V non vide la fine della guerra,
poiché si spense infine nel 1442, a seguito di una vita costituita da lunga
serie di trionfi e successi. A comando della duplice monarchia gli sarebbe
succeduto il figlio Enrico VI, debole e malato di mente. Uomo estremamente pio,
Enrico VI era refrattario al potere, e soprattutto dilaniato, nell'esercizio
della sua carica, dai contrasti fra la fazione gallicana (costituita dai
suprematisti della corona di Francia) e quella anglicana (costituita dai
suprematisti della corona d'Inghilterra). I secondi in particolare, guidati da
Riccardo d'Aquitania (HL: York), succeduto al duca di Bedford
nell'amministrazione del sud per nomina di Enrico V, e Goffredo di Gloucester,
lord di Scozia, reclamavano l'ammorbidimento del sovrano nel controllo
esercitato dagli Inglesi sulla Francia e il favore che il sovrano sembrava
esercitare a beneplacito dei suoi nobili francesi. Gli animi si scaldarono
ulteriormente quando il re annunciò di voler prendere in moglie Margherita d'Angiò,
figlia del Re di Napoli Renato I, cosa che avrebbe certamente determinato il
sopravvento della fazione gallicana su quella anglicana. Peggio ancora: in
cambio del matrimonio, Renato pretese la restituzione dei territori atavici
della famiglia, cioè la contea comitale d'Angiò (ovviamente a titolo di
feudatario del Re di Francia).
Quando l'accordo venne alla luce, le cose degenerarono rapidamente. In un
banchetto, Goffredo di Gloucester dichiarò pubblicamente che l'autorità del Re
era compromessa dalla sua malattia, il che aveva causato il dilapidamento del
patrimonio ereditato da Enrico V. La corte, ormai in mano alla fazione gallicana,
reagì molto negativamente: scavalcando l'autorità del Parlamento inglese (nonché
la legge scozzese con cui s'aprì un conflitto di diritto) nel 1447 il re, la
regina e i loro fidi convocarono Gloucester dinnanzi agli Stati Generali di
Francia, costituiti dal clero e dalla nobiltà del continente, vicini alle
volontà del sovrano. Per avallare l'atto illegittimo, Enrico VI utilizzò le tesi
dell'Università di Parigi, per le quali l'interpretazione del diritto suprema
nello Stato era quella sancita dalla residenza della persona del sovrano
(quindi, quella di Francia). Lo scandalo fu grande, ma alla fine il processo non
si tenne, perché durante la sua traduzione in Francia Gloucester morì
misteriosamente, non si sa se avvelenato o per cause naturali.
Al re sembrò di essersi liberato di in incubo. Ma fu un sollievo momentaneo,
perché subito dopo la contesa si riaccese nella persona di Riccardo d'Aquitania,
che alzò la posta in gioco, accusando la corte di aver orchestrato l'assassinio
del Lord Protettore di Scozia. La situazione era poi aggravata dal fatto che,
con la sua morte, scompariva anche la pesante tutela esercitata dagli Inglesi
sul regno di Scozia, con Giacomo II che, seppur neutrale, rialzava la testa.
Riccardo rincarò allora la dose, accusando il re di star lavorando per la rovina
della corona d'Inghilterra; ma la sua fazione era allora in minoranza assoluta,
e così il sovrano poté bandire il monarca in Irlanda, con il formale compito di
combattere gli irriducibili nativi dell'isola.
Per gli angioini, l'esilio di Riccardo rappresentò un'occasione d'oro, dato che
tutti i suoi possedimenti nel sud della Francia vennero espropriati e attribuiti
alla famiglia, sempre più dominante a corte. In particolare, Margherita d'Angiò
gestiva gli affari della corona, soprassedendo al debole marito e sotto la
vigile supervisione del padre Renato I. Il passaggio di proprietà del
mezzogiorno vide il concreto pericolo di costituirsi di un vero e proprio impero
angioino nel Mediterraneo occidentale, governato da Napoli. Questo anche perché,
forte dell'ascendente esercitato sulla duplice monarchia, re Renato dispose la
ripresa della guerra contro Alfonso V, con lo scopo di rivendicare i diritti
della madre Iolanda sul Paese. L'inconcludente scontro, stavolta agito perlopiù
per via di terra, prosciugò buona parte delle energie e delle risorse di Enrico
VI, svuotando il tesoro regio. Avendo imparato dalla sconfitta rimediata contro
Enrico V, Alfonso V rifiutò di ingaggiare direttamente i navigli angioini,
impiegandosi in una tattica mordi e fuggi che causò grossi danni alla Francia
meridionale. Il re giunse a spingersi, con i propri raid navali, fino a razziare
Tolone e bloccare il porto di Marsiglia, paralizzando di fatto il commercio
francese nel Mediterraneo.
La crisi economica sortiva così i propri effetti, facendo il gioco di Riccardo.
Nel 1450, l'irlandese Jack Cade, probabilmente d'accordo con il sopracitato
esule, guidò un'importante rivolta nel Kent, che giunse perfino a prendere la
sguarnita Londra. Dimostrando un'insolita energia, Enrico VI sbarcò in
Inghilterra e riuscì a domare la ribellione, ma la liberazione della capitale fu
soltanto l'ennesima occasione per inasprire i contrasti fra il Parlamento
inglese e il sovrano, accusato di non aver disposto abbastanza risorse per
difendere Londra, impegnato com'era a fare il gioco degli angioini. La
situazione era già abbastanza grave, quando in Inghilterra giunse la notizia
della sconfitta accusata dal capitano Talbot nella battaglia di Girona, che
permise ad Alfonso V di catturare senza colpo ferire l'intera regione del
Rossiglione. Enrico VI, già debole di mente, scelse di tornare in Francia, ma
nemmeno gli odori di casa poterono riavere il monarca dal vero e proprio shock
catatonico in cui era caduto. La regina Margherita, constatata l'incapacità
d'intendere e di volere del re, chiese per sé la reggenza, ma il 3 aprile 1454
fu Riccardo d'Aquitania ad essere nominato Lord Protettore d'Inghilterra dal
Parlamento, che Enrico V aveva stabilito come assemblea apicale della monarchia,
ottenendo con ciò finalmente la posizione di peso che da tanto tempo desiderava.
Tanto fu trionfale il ritorno di Riccardo dall'esilio quanto dura la vendetta
che egli distribuì sui gallicani. Innanzitutto, con i suoi veterani irlandesi
che lo spalleggiavano, Riccardo revocò le concessioni di terra agli angioini,
recuperando i suoi domini nel sud della Francia e siglando con Alfonso V un pace
che gli riconosceva tutte le sue conquiste. La regina venne allontanata dal
figlio e dalla corte, mentre i fratelli della regina, Luigi, detto l'Ardito,
marchese d'Angiò, e Iolanda, detta la Cieca, principessa di Napoli (tutti,
insomma, con l'esclusione di Giovanni, duca di Calabria, ed erede al trono di
Napoli, allora in Italia) furono imprigionati; solo l'intercessione del padre,
che restava un alleato chiave della duplice monarchia, poté salvarli
dall'esecuzione. Il regno di terrore di Riccardo s'interruppe soltanto con il
rinsavimento di Enrico VI, verso la fine di quell'anno.
Disperando di aver perso il potere, Riccardo si ritirò a sud, nei suoi
possedimenti di Guascogna. L'anno successivo, forte di una nuova alleanza
stipulata con il matrimonio di suo figlio Edoardo con Eleonora, figlia del re
d'Aragona, Riccardo getta finalmente la maschera, rivendicando per sé e i suoi
discendenti il trono franco-inglese. Enrico VI libera gli angioini dal carcere,
rimandando Iolanda in Italia e insignendo Luigi del titolo di luogotenente di
Francia, con il compito di debellare la resistenza aquitana. Così iniziava una
volta per tutte la sanguinolenta guerra civile plantageneta, che sarebbe passata
alla storia con il nome di Guerra delle Due Rose.
.
La Guerra delle Due Rose: breve cronologia
1455: la marcia verso nord di Riccardo (II)
si conclude con la prima battaglia dell'Angoulême, dove le forze regie tentano
di sbarrare la strada per Parigi ai ribelli. La battaglia finisce con uno
schiacciante successo per gli aquitani, che uccidono in battaglia Luigi,
secondogenito di Renato I, fratello della regina, luogotenente generale di
Francia e marchese d'Angiò. Il duca d'Aquitania riprende il titolo di Lord
Protettore, stavolta esteso anche al regno di Francia, ma l'anno successivo
viene scacciato nuovamente dagli intrighi della regina Margherita, che propaga
sentimenti anti-aquitani a corte. La guerra riprende.
23 settembre 1459: battaglia di Bourges, vittoria aquitana.
12 ottobre 1459: battaglia del ponte di Tours, stavolta una vittoria angioina.
Sfruttando il ristretto spazio del fiume, i militi del re riescono con successo
ad arrestare l'avanzata aquitana e ributtare l'esercito nemico indietro. Sulla
base di un'interpretazione molto estensiva di Levitico 25:23 propugnata
dall'Università di Parigi (le terre non si venderanno per sempre; perché la
terra è mia e voi state da me come stranieri e ospiti), la regina dichiara tutti
gli atti compiuti da Riccardo (II), dalla sua famiglia o dai suoi alleati nulli,
e le proprietà dei soggetti giuridici così individuati sono confiscate. Riccardo
fugge per la seconda volta in Irlanda.
10 luglio 1460: l'esilio di Riccardo in Irlanda dà modo al pretendente di
avvicinare la nobiltà delle isole, colpevolmente ignorata dalla corte che ha
sede in Francia, e Riccardo finisce per stringere alleanza con Riccardo Neville,
16esimo conte di Warwick, in sostituzione di quella stipulata con Alfonso
d'Aragona, morto due anni prima. Margherita spedisce il marito in Inghilterra
onde arrestare l'avanzata nemica, ma si rivela una mossa sbagliata: a
Northampton, gli aquitani vincono e prendono il sovrano ostaggio. Il crudele
conte di Warwick fa massacrare tutti gli altri prigionieri. La regina sposta la
sua corte da Parigi a Rouen, per seguire con maggiore attenzione gli eventi
della guerra.
10 ottobre 1460: Riccardo di York ritorna in Inghilterra, dove viene dichiarato
erede al trono dal Parlamento. Reciproca scomunica tra questo e gli Stati
Generali, che rifiutano di riconoscere il dispositivo. In risposta, la regina fa
sbarcare sull'isola un nuovo esercito, stavolta composto da francesi.
30 dicembre 1460: battaglia di Wakefield. Gli aquitani sono sconfitti e
Riccardo, duca d'Aquitania, viene ucciso. Gli succede il figlio Edoardo, al
momento governatore dei possedimenti di famiglia da Bordeaux, che tramite il suo
matrimonio con Eleonora d'Aragona, riaccende i legami con la corona iberica.
Giovanni II d'Aragona accetta di supportare la causa aquitana, nel tentativo di
stornare da sé la minaccia angioina. Renato I ha infatti puntato da tempo la
Sardegna, ma di fronte al pericolo corso dalla figlia accetta di posticipare i
suoi piani, inviando in Francia mezzi e risorse. Senza che nessuno se ne fosse
accorto, il conflitto ha rapidamente assunto portata europea.
2 febbraio 1461: battaglia di Tolosa, Edoardo vittorioso si spinge verso la
Provenza.
17 febbraio 1461: battaglia di Nimes, una vittoria per la casa d'Angiò: con il
supporto di Renato I Enrico VI è finalmente liberato. Pur tuttavia Renato,
preoccupato da un tentativo di sbarco aragonese in Sicilia, paralizza la
partita, prendendo in custodia il re per tenerlo al sicuro. Gli aquitani si
trovano la via libera per Parigi.
4 marzo 1461: Edoardo d'Aquitania è unto re di Francia e d'Inghilterra nella
cattedrale di Reims.
6 marzo 1461: seconda battaglia dell'Angoulême, stavolta combattuta a parti
invertite. Edoardo vince, ma non ha le forze per assediare Parigi. La regina
Margherita e il principe Edoardo, figlio di Enrico VI, raggiungono il re nel suo
esilio di Provenza. Sono inaugurati i primi dieci anni di regno, sepppur
contrastati, di Edoardo IV.
24 giugno 1465: Enrico VI è catturato sulla via per Parigi, entro la quale
cercava di penetrare per guidarne la resistenza. Edoardo lo spedisce oltre
Manica, come prigioniero della Torre di Londra. La tutela del rivale è affidata
al vigile occhio del conte di Warwick, il quale frattanto ha governato
l'Inghilterra per conto della fazione aquitana, in spregio alla volontà del
Parlamento.
1 giugno 1470: dopo alcuni battibecchi con Edoardo, che gli ha rifiutato
l'ufficializzazione della carica da lui ricoperta (il titolo di Lord Protettore
d'Inghilterra) adducendo a pretesto l'ostilità dell'assemblea inglese, Warwick
invita a Londra la regina Margherita e il figlio Edoardo, cui mette a
disposizione un nuovo esercito. Il 13 ottobre dello stesso anno, Riccardo
Neville cambia casacca, schierandosi con gli angioini; Enrico VI è restaurato
sul trono d'Inghilterra.
14 marzo 1471: Edoardo d'Aquitania arriva in Inghilterra con le sue truppe per
aver ragione del ritorno di fiamma angioino.
14 aprile 1471: battaglia di Barnet, vittoria per gli aquitani. Warwick è ucciso
nella furia dello scontro.
4 maggio 1471: battaglia di Tewkesbury, rovina degli angioini. Il principe
Edoardo viene trafitto da una freccia e muore, la regina Margherita è tratta
prigioniera. Due settimane dopo, Enrico VI viene ritrovato cadavere nella Torre
di Londra, forse suicida; tutto ciò che resta della fazione angioina è
rappresentato da Enrico Tudor, conte di Champagne, che fugge in Italia sotto la
protezione di Renato I. Gli aquitani dominano incontrastati su Francia e
Inghilterra.
.
Il regno di Edoardo IV (1471-1483) e di Riccardo III (1483)
Il regno di Edoardo IV rappresentò un
parziale ritorno alla normalità, dopo quasi dieci anni di regno. Il nuovo re, il
primo a governare da Londra da più di cinquant'anni, fece della supremazia
dell'elemento inglese su quello francese il pallino della sua politica: egli
rinvigorì la politica di ricolonizzazione della campagne, sostituì numerosi
nobili francesi con altrettanti inglesi e tentò di ottenere una dispensa papale
per includere il territorio del Regno di Francia sotto l'autorità
dell'arcivescovo di Canterbury. L'Università di Parigi viene chiusa e i suoi
studenti dispersi, tutto a favore di quelle di Oxford e Cambridge. Egli giunse
al punto di concepire perfino l'ardito progetto di abolire gli Stati Generali di
Francia, inviando i rappresentanti di quest'ultimo al Parlamento inglese.
Allo scopo di operare a pieno regime la centralizzazione da lui immaginata,
Edoardo IV si circondò di valenti amministratori, fra cui spiccavano i suoi due
fratelli: Giorgio, duca di Normandia, e Riccardo, duca di York, cui affidò
rispettivamente il titolo di Lord Protettore di Francia e il comando della
campagna contro la Scozia, agita con il pretesto di installare sul trono
scozzese il pretendente Alessandro IV, fratello di re Giacomo III. La
suddivisione del potere garantì una parziale ripresa della duplice monarchia, ma
in ultima analisi, l'aver piazzato degli uomini così intraprendenti in posizioni
chiave si rivelò una scelta pessima, giacché questi ultimi iniziarono (a loro
volta) a coltivare ambizioni di potere.
Il primo ad agire fu Giorgio di Normandia. Egli, nella sua veste di Protettore
di Francia, osservava con interessi gli sviluppi della potenza borgognone, che
tentava al momento di espandersi a scapito degli angioini. Le trattative,
comunque, furono lunghe e difficoltose, dal momento che il duca di Borgogna
temeva il tentativo di un colpo sinistro da parte del Lord Protettore che
mirasse ad annettere il suo dominio alla corona di Francia. Il tempo trascorso
alla corte di Digione non fu esattamente tempo perso per Giorgio; questo perché,
nel corso del patteggio, il nobile cavaliere ebbe occasione di conoscere ad
amare (piacevolmente ricambiato) la giovane figlia del duca, Maria, che
trascorreva allora la maggior parte del suo tempo immersa nelle romanze. Lo
sviluppo, per il momento innocuo, sarebbe poi stato gravido di conseguenze.
Finalmente, nel luglio del 1474, Giorgio stipulò un trattato di amicizia
perpetua con il duca di Borgogna, Carlo il Temerario, che lo impegnò nel
preparare guerra a Renato I. L'anno seguente, nel luglio del 1475, il Lord
Protettore di Francia invase la Provenza, sperando di vedersi riconosciuta la
mano della figlia di Carlo, Maria, una volta che la moglie, Isabella Neville,
già malata, fosse morta. La vecchia volpe di Renato, pur impegnato in guerra,
seppe però offrire un accordo migliore: il re di Napoli concesse a titolo
definitivo i tre ducati di Lorena, di Bar (a Carlo il Temerario) e di Angiò (a
Giorgio di Normandia) per vedersi restituita la figlia, l'ex regina Margherita,
e dichiararsi estraneo una volta per tutte alle vicende della duplice monarchia.
Stizzito dal tradimento, Carlo il Temerario, revocò la promessa di matrimonio,
offrendo Maria a uno dei figli (Edoardo o Riccardo) di re Edoardo in persona, il
tutto a patto che il sovrano accettasse di punire suo fratello Giorgio. Edoardo
IV, rapito dalla prospettiva di far ereditare ai suoi figli il possesso del
complesso di territori più ricco del continente (Lorena, Champagne, Fiandre) non
se lo fa ripetere due volte, e dopo aver fatto passare una legge che disconosce
la successione dei discendenti del fratello, il re sbarca in Francia. Però la
spedizione punitiva, come l'aveva immaginata Edoardo, s'impantana rapidamente in
una guerra di posizione, dal momento che Giorgio, deciso a non arrendersi, si
ritira nel sud. Peraltro, la resistenza del Lord Protettore è aumentata dal
supporto dei Francesi, i quali vedevano nell'aquitano la propria principale
garanzia di autonomia.
Le cose per Edoardo, poi, peggiorano ulteriormente quando, inaspettatamente per
tutti i convenuti, a soli due anni dallo scoppio della guerra, Carlo il
Temerario muore nel corso di una battaglia da lui intrapresa in alleanza con
l'imperatore contro gli Svizzeri. Il duca di Borgogna lascia una figlia giovane,
senza alcuna direzione oltre che l'amore; è così che Giorgio, novello vedovo (la
morte di Isabella a seguito di complicazioni da parto si colloca nel dicembre
1476), si reca a Digione per cogliere il fiore di Maria di Borgogna. I quasi tre
anni di matrimonio (uno dei pochi, in età medievale, in cui la donna avesse
realmente potuto esercitare libertà di scelta del partito) daranno importante
frutto: due bambini, Filippo (nato nel 1478) e Maria (nata nel 1480) che
resteranno al centro della storia della regione.
Le nozze, celebrate in fretta e furia, paiono invertire le sorti del conflitto:
con il supporto dell'eredità borgognona, di gran lunga la più facoltosa
d'Europa, Giorgio attinge infatti ad abbastanza pecunia da allestire un grande
esercito per affrontare il fratello Edoardo in battaglia. I primi risultati sono
tuttavia infausti: sfortunatamente i mercenari profusamente assoldati da Giorgio
sul campo di battaglia restano nelle retrovie. Anche i suoi Francesi, a fronte
del sistematico saccheggio operato da Edoardo IV, sono demoralizzati, e molti
nobili iniziano a defezionare le fila del Lord Protettore. Nel 1479, un primo
abboccamento a nord della Loira dà esiti inconcludenti, ma costringe le sfinite
truppe di Giorgio a riunirsi nella fedele Caen, onde riprendere le forze. Col
senno di poi, si rivelerà una scelta sbagliatissima.
Questo perché, poco dopo, Edoardo circonda Caen, tagliando fuori tutti i
contatti della città con l'esterno. L'assedio è durissimo e si prolunga per un
anno, causando grosse sofferenze alla zona circostante, ma alla fine il truce
inverno del 1480 ha ragione della resistenza del Lord Protettore di Francia, che
viene catturato e condannato a morte (la tradizione vuole che sia stato annegato
in una tinozza di malvasia). Ovviamente, Maria di Borgogna soffre orribilmente,
ma da sola non può nulla contro lo strapotere del re d'Inghilterra, e così,
d'accordo con i sioi ministri, sigla un accordo di pace, che la vede costretta
al matrimonio con uno degli eredi di Edoardo IV, Edoardo (V) o Riccardo. La
povera Maria sarebbe poi morta per una caduta da cavallo, due anni dopo. Alcuni
cronisti, forse di parte, sostengono che si fosse trattato di un evento per
nulla accidentale, ma spinto dalla disfatta della Borgogna.
A questo punto restano solo Edoardo IV e suo fratello Riccardo, che da York si è
spinto fino a sottomettere nuovamente la Scozia e regna sulla porzione
settentrionale della corona inglese e sulle Highlands per conto di Alessandro IV
(Giacomo III, che languisce in prigione, sarà poi liberato dai suoi nobili).
Edoardo è però anziano, mentre i suoi figli sono giovani; egli decide così di
avvicinare il fratello, assegnandogli la reggenza e il titolo di Lord Protettore
di Francia e d'Inghilterra (che si vanno ad assommare a quello di Scozia). Mai
decisione fu più sbagliata: con Edoardo IV sul letto di morte, Riccardo fa
imprigionare e poi assassinare i principini Edoardo e Riccardo nella Torre di
Londra, cosicché nessuno possa opporsi al suo potere. Edoardo IV muore solo per
lasciar posto al fratello minore Riccardo, che si proclama re come terzo del suo
nome.
All'apparenza, il potere plantageneto è all'apice della sua forza, come solo con
Enrico V era stato, più di cinquant'anni prima. Ma in realtà, il trono di
Riccardo III è tutt'altro che stabile, minato dalle voci sulla sua infedeltà e
sull'assassinio dei principi della Torre. Nel 1483, una prima rivolta inglese è
schiacciata. Ma quando nel 1485 il fuoco della ribellione si accende in Francia,
Riccardo III, impegnato a regolare la questione della successione, non ha modo
di intervenire immediatamente, e così è proprio Enrico Tudor, ultimo dei
Plantageneti rivali, ad assumerne il comando. Tudor non è uno sprovveduto, e
perciò durante la sua ascesa si circonda di nobili e soldati francesi, che
possano spalleggiarlo nel suo tentativo di acquistare il trono. Come segno di
buona volontà, Enrico fa sposare lo zio Gaspare con Anna di Valois, nipote di
quel Delfino che i suoi antenati avevano spodestato e che aveva continuato la
sua vita in una prigione dorata. Nel loro matrimonio, la Francia e l'Inghilterra
sono ricongiunte in un'alleanza di comodo, a scapito dell'integrità della
dinastia plantageneta. In un atto di aperta ribellione, Enrico Tudor riunisce
illegalmente gli Stati Generali di Francia, da cui si fa proclamare monarca. La
Sorbona, riaperta, avalla il passaggio di potere come favore divino.
Enrico Tudor sbarca nel sud del Galles, regione natia della famiglia, con un
piccolo contingente di truppe francesi e successivamente marcia attraverso la
regione, reclutando ulteriori forze. Le truppe di Enrico si scontrarono con
quelle di Riccardo nella battaglia di Bosworth Field, combattuta a pochi
chilometri da Leicester. Riccardo, al comando di una coraggiosa carica di
cavalleria che avrebbe potuto alterare le sorti della battaglia, viene
sciaguratamente accerchiato e ucciso (Un cheval, un cheval, mon royaume pour un
cheva!). Lo scontro segna la fine della Guerra delle Due Rose e l'ascesa al
trono della dinastia Tudor con Enrico, che prese il doppio nome di Enrico VII
d'Inghilterra e IV di Francia, celebrando l'unione delle due corone.
.
Il regno di Enrico VII e IV (1485-1509)
L'ascesa al trono della dinastia Tudor
rappresentò, a conti fatti, la rivalsa dell'elemento francese, che dopo quasi un
secolo tornava al potere. Questo perché Enrico VII e IV fu il primo monarca a
stabilire a Parigi una volta per tutte la sede della corte, stabilendo il
francese come lingua ufficiale di quest'ultima. L'inglese rimase nell'uso
sull'isola, ma la lingua scomparve completamente dal corso legale, dato che
tutti gli editti del re, le sentenze dei tribunali e l'amministrazione della
giustizia erano redatti in francese. Fra gli organi di governo, solo il
Parlamento inglese, sul cui regolamento interno il re non aveva autorità
diretta, continuò ad utilizzare l'inglese nelle sue sedute, ma Enrico VII e IV
seppe abilmente circuire il problema evitando di convocarlo. Il sovrano sistemò
anche l'annosa problematica del rapporto di supremazia fra questo e gli Stati
Generali di Francia, dichiarando ciascuna delle due assemblee sovrana ed
autonoma dall'altra nell'ambito del regno da essa sovraintesa. La dichiarazionre
era d'importanza notevole, dato che statuiva per la prima volta l'eguaglianza
formale fra le due parti della duplice monarchia, unite nella sola persona del
monarca; ma allora la faccenda passò sotto silenzio, dato che il re si preoccupò
di governare con il supporto esclusivo di una pattuglia di parlamentari di
entrambe le assemblee, che seguiva la corte e prendeva il nome di Camera
Stellata. Enrico VII e IV cercò anche di realizzare il proposito del suo
predecessore plantageneto, unificando le strutture ecclesiastiche francese e
inglese sotto l'arcivescovo di Canterbury, ma dovette gettare la spugna dinnanzi
al diniego del Papa. Il sovrano si vendicò, decretando l'estensione del sistema
di diritto anglo-normanno all'intero territorio da lui governato, con
l'abolizione pressoché totale del diritto romano-canonico. I giudici itineranti
del re così cavalcavano la Francia, correggendo torti e togliendo ai potenti,
come mai era accaduto sotto i dinasti capetingi.
Tale politica di stabilizzazione fu resa possibile anche da un'oculata gestione
del fisco. Enrico VII e IV si dimostrò ricettivo all'antica tradizione
burocratica dei suoi antenati, centralizzando l'amministrazione e distribuendo
la tassazione, in modo tale da aumentare l'efficienza della stessa. Il maggior
peso fiscale percepito, comunque, non fu esente da malcontento: soprattutto
durante i primi anni del regno di Enrico, le occasioni di rivolte nelle zone
rurali furono molte e dettagliate. In ogni caso, la fedeltà incondizionata del
clan Valois, sempre più forte a corte e radicato nel territorio, si rivelò
bastevole ad evitare che queste esplodessero fino a mettere in pericolo il
potere Tudor sulla Francia. Altrettanto non si può dire dell'Inghilterra, dove,
nel 1487, scoppiò una vasta ribellione di delusi e scontenti del nuovo ordine al
comando di John de la Pole, importante nobile della leva aristocratica solo
parzialmente gallicizzata, e che era stato dichiarato erede provvisorio al trono
durante il breve regno di Riccardo III. John de la Pole (che con la sua famiglia
parlava francese) innalzò il vessillo della libertà inglese contro l'oppressione
del continente, giungendo al punto di schierare un falso Riccardo (IV), principe
della Torre, come legittimo re d'Inghilterra. La rivolta giunse a prendere
Londra, forse con l'implicito supporto del Parlamento, ma venne ugualmente
schiacciata. Enrico VII e IV si dimostrò implacabile con i fedeli della causa
aquitana: gli irriducibili vennero messi al carcere o uccisi sotto tortura, con
le loro terre, espropriate, che andavano ad aggiungersi al crescente demanio
reale. Lo strozzamento delle campagne, così favorito, si dimostrò cruciale nel
raggiungere due obiettivi; il primo, togliere la base di potere ad eventuali
future rivolte, venne pienamente raggiunto: ai primordi del XVI secolo il potere
della corte di Parigi sull'Inghilterra era ferreo come non lo era mai stato
quello di un monarca inglese dai tempi di Enrico Cortomantello. Il secondo,
favorire l'urbanizzazione, incontrò solo un parziale successo: lo stato di pace
interno ai due regni significò che ad incrementare fu più la migrazione di
giovani e diseredati inglesi all'interno delle già ricche città di Francia,
piuttosto che andare ad ingrossare le fila degli insediamenti urbani inglesi.
Alcuni centri, comunque, come York, Norville (HL: Norwich), Bristóle (HL:
Bristol) Cantorbéry (HL: Canterbury), Exeter, Noucastle (HL: Newcastle) ed
ovviamente Londra rimasero di una certa importanza per la propria posizione
strategica.
In ogni caso, la questione centrale del regno di Enrico VII e IV fu, molto
prevedibilmente, quella borgognona. Nel 1482 Maria era morta, lasciando solo due
figli piccoli, sulla cui eredità si appuntavano gli sguardi di tutta Europa. In
primo luogo, comunque, gli interessati erano due: l'imperatore del Sacro Romano
Impero Federico III e, ovviamente, il re di Francia e Inghilterra Enrico VII e
IV; l'uno intendeva assumere il patronato del ducato, l'altro arrotondare i
confini del suo dominio in modo da non dover più temere repentini attacchi su
Parigi. La questione poi, assume ancora più importanza quando si prende in esame
il fatto che i due bambini erano plantageneti, figli di Giorgio, Lord Protettore
di Francia, e di conseguenza potevano vantare una pretesa al duplice trono ben
più solida di quella che lo stesso Enrico possedeva.
Per il momento, comunque, la minaccia era inesistente: il piccolo Riccardo
Filippo di Valois-Bordeaux (tecnicamente, un plantageneto e un capetingio) aveva
solo quattro anni quando la madre morì, lasciando l'amministrazione del
territorio in mano a un consiglio di reggenza composto dai maggiorenti del
ducato, i quali comprendevano la necessità di venire a patti per evitare la
guerra con il re d'Inghilterra e di Francia. Con il trattato di Arras (1482),
dieci anni dopo confermato da quello di Senlis (1493), Federico ed Enrico
stipularono un compromesso, spartendosi la tutela dei bambini (oltre che il
territorio): una volta divenuto adulto, Riccardo Filippo, che spergiurava di
mettere da parte ogni pretesa al duplice trono, sarebbe stato il solo a
governare, con la qualifica di principe imperiale. Quello che era stato il
territorio governato da Carlo il Temerario veniva ora elevato a regno di
Lotaringia, realizzando, in un certo senso, per via postuma i sogni di gloria di
quest'ultimo. In cambio, la piccola Maria Margherita sarebbe andata in sposa al
delfino di Galles, Arturo, portando con sé una dote rappresentata dalla Borgogna
propria (con Digione e Châtillon), Charolais, Mâcon, Nevers, Auxerre, Illes e
Champagne.

Enrico VII e IV, capostipite della gallicizzante dinastia dei Tudor, sarebbe morto solo nel 1509, a termine di un proficuo regno che vide la ripresa della potenza anglo-francese in Europa. Più di vent'anni di sostanziale pace furono di grande aiuto per cementificare la presa della nuova dinastia sul popolo, e far digerire l'esilio dei plantageneti (o ciò che ne restava) in terra di Lotaringia, con grande beneficio per la stabilità di entrambi i regni. È anche per questa ragione che, quando Enrico VIII salì al trono, nessuno poteva prevedere l'assoluto scompiglio che avrebbe portato sul continente l'esplosione della riforma protestante, la quale avrebbe inaugurato nella duplice monarchia e nel mondo un'epoca di sconvolgimenti senza precedenti.
.
Il regno di Renato I (1435-1480)
Ma per procedere con l'analisi degli
effetti della riforma, è necessario soffermarsi in partenza sugli sviluppi che
avevano condotto al mutare dell'Italia, cuore pulsante delle arti, della
filosofia, delle scienze, della fede e del commercio medioevali, da centro della
cristianità a penisola periferica, ma pur sempre scacchiere strategico primario.
Di seguito sono, per l'ausilio di chi legge, riassunti gli eventi che hanno
determinato lo svolgersi delle guerre d'Italia così come le conosciamo. Buona
lettura.
1435-1480: lungo regno di Renato I il Buono, che respinge gli aragonesi,
favorisce il commercio con i plantageneti e centralizza l'amministrazione su
modello francese. Più che per tutto questo, comunque, Renato I sarà ricordato
per essersi fatto autorevole interprete e grande attore delle vicende d'Italia,
inaugurando un'epoca di pace che sarebbe culminata con la pace di Gaeta (1454).
1447: Niccolò V ascende al soglio di San Pietro. Il nuovo Papa, concentrato sul
rifiorimento di Roma e sull'agevolazione della cultura, si stringe in una
politica di stretta alleanza con il re di Napoli. In cambio della sua tutela, il
Papa revoca la concessione del titolo regio di Corsica e Sardegna ad Alfonso V
d'Aragona. L'isola, a lungo contesa sarebbe poi caduta definitivamente nelle
mani genovesi-napoletane con la morte del loro rivale (1458).
1450: dopo una breve guerra civile, il condottiero Francesco Sforza ha ragione
degli ambrosiani e prende il controllo di Milano. Da amico del re di Napoli (sua
figlia Ippolita avrebbe sposato il nipote di Renato, Giovanni) egli riprende
immediatamente la guerra contro Venezia. A Castiglione (1450) il grande militare
egli arresta l'avanzata della Serenissima verso occidente; negli anni
successivi, lo Sforza si spinge sino a Ghedi (1453), dove infligge una nuova,
durissima sconfitta ai nemici della Lombardia. I veneti abbandonano tutti i loro
possedimenti al di qua del Mincio, ripiegando a est.
1453: il terrore causato per la caduta di Costantinopoli conduce alla necessità
di stipulare una pace generale nella penisola. Come già pronosticato, gli
inviati di Francesco I, Cosimo de' Medici, Niccolò V e della Serenissima si
incontrano l'anno successivo a Gaeta sotto il benestare del re di Napoli per
siglare un accordo basato sul concetto di bilanciamento delle potenze. Renato I
offre supporto a Venezia nel suo sforzo contro i Turchi, ma in cambio le
conquiste dello Sforza (Bergamo e Brescia tornano all'ovile) sono riconosciute.
L'atmosfera di pace è suggellata dalla promessa di matrimonio scambiata tra
Giovanni III, principe di Taranto (8 anni) e Ippolita, secondogenita del duca di
Milano (3 anni). Le condizioni di relativa tranquillità conducono a una
rinascita dello scambio su grande scala; sulle stesse vie, viaggiano pittori,
poeti e scultori.
1458: Alfonso V muore, quasi uno sconfitto della storia. Alla sua dipartita, le
cortes rifiutano di riconoscere la successione di suo figlio illegittimo
Ferdinando, elevando al suo posto il fratello dello scomparso Giovanni II, da
subito preso nella guerra civile navarrina contro suo figlio Carlo, principe di
Viana. Ferdinando, che rifiuta di riconoscere la legittimità della consegna di
poteri, fugge sulle Baleari e se ne proclama sovrano con l'interessato supporto
delle finanze napoletane. Anch'egli, tuttavia, non si rivelerà essere che
l'ennesima pedina nella rete di alleanze che Renato I sta intessendo, finendo
con lo sposarsi con Iolanda d'Angiò, figlia di quest'ultimo.
1459: congresso di Mantova, indetto dal nuovo papa Pio II contro la minaccia
ottomana, a cui la duplice monarchia, impegnata nella guerra civile, non può
prendere parte. Anche se l'imperatore Federico III, in polemica con le
città-Stato italiane, sceglie di non partecipare, il supporto di Renato I spinge
Milano, Venezia e Genova sullo stesso carro anti-turco. Solo Firenze (molto
cinicamente) si sfila dalla nuova crociata, che verrà comunque detta "italica".
1460: grazie agli aiuti inviati da Renato I in qualità di (preteso) principe
d'Achea, non cade il despotato di Morea, ultimo stato bizantino. Numerosi
Italiani (in specie veneziani e napoletani) si installano al servizio dei
Paleologi, formalmente imperatori romani, propagando la conversione dei Greci al
cattolicesimo in accordo con il precedente concilio di Firenze. Renato I ottiene
direttamente Corfù da Venezia, e in cambio le cede le importante piazzaforti di
Mistrà e Malvasìa. Gli ottomani si rifanno distruggendo il regno di Bosnia, cui
la sola tutela veneziana non giova. La Serenissima inizia a sentire il peso (e
gli svantaggi) di condurre una politica estera pienamente indipendente.
1462: un tentativo di Giovanni II d'Aragona di sottomettere le Baleari viene
frustrato dall'intervento della flotta genovese, opportunamente assoldata dalla
longa manus del re di Napoli. Con l'apertura di un fondaco a Minorca (l'intera
isola finirà per essere concessa alla Superba in modo da ripagare un largo
debito), la Superba estende il predominio del suo impero commerciale all'intero
Mediterraneo occidentale.
1463: apertura dell'Accademia platonica di Napoli, per volere del filosofo
Marsilio Ficino e grazie alla protezione di Renato I d'Angiò. Il ruolo svolto da
questo circolo sarà importantissimo nel passaggio delle idee classiche
dall'Oriente in Occidente.
1465-1468: come conseguenza dell'espulsione dei genovesi da Cipro, scoppia la
quinta e ultima guerra genovese-veneziana (al contrario della storia reale,
infatti, a causa dei recenti successi qui Genova si sente abbastanza forte da
sfidare ancora Venezia). Per cinque anni le due marine si scontrano inutilmente
al largo delle coste greche e nello Ionio, proprio sotto lo sguardo del re di
Napoli; sarà proprio quest'ultimo, infine, a mediare la pace fra le due. Il
possesso di Cipro viene riconosciuto a Venezia, che provvede a far sposare il
figlio bastardo dell'ultimo re Lusignano, Giacomo (II), con una nobildonna
veneziana, tale Caterina Cornaro; in cambio, viene verbalizzata la spartizione
del Mediterraneo nelle reciproche zone d'influenza, con Genova (che ormai ha
monopolizzato il commercio del vino francese, della stoffa inglese, del sale,
dell'oro e del corallo africano) a Occidente e Venezia a Oriente. Sono gli
Accordi del Re (30 luglio 1468).
1465: papa Paolo II (veneto) emette sua sponte una bolla che pone fine ai
tentativi di conciliazione con gli hussiti, autorizzandone lo sterminio. Da
vent'anni a questa parte, è il primo pontefice a tentare una politica estera
senza l'esplicito appoggio dell'influente Renato I. Altrove, la congiura del
Soderini ordita nell'ombra per impedire la successione di Piero de' Medici viene
stroncata nel sangue da quest'ultimo.
1466: Galeazzo Maria, figlio di Francesco I Sforza, nonchè parente acquisito di
Renato I tramite il matrimonio della sorella Ippolita con il nipote ed erede di
quest'ultimo Giovanni III, succede al padre nel governo del ducato di Milano.
Tirannico e crudele, si farà odiare dal popolino per la sua incompetenza. In
compenso, il duca rafforza l'amicizia con Napoli: suo figlio Gian Galeazzo è
fidanzato a Isabella Maria, figlia di sua sorella. Pochi anni dopo, egli
giungerà al punto di assecondare le pretese di dedizione di Genova attribuite a
Renato I, trasferendone la protezione al re di Napoli.
1467: battaglia della Ricciardina, combattuta presso Bologna. Lo scontro vede
Sforza, Medici e Angiò coalizzati nello sbarrare la via di Firenze agli esuli
guidati dagli ultimi fedeli del Soderini, spalleggiati da Venezia. Paolo II, da
buon fedele di San Marco, non si sbilancia (c'è un emissario della Santa Sede a
vegliare sulla baruffa), dunque l'esito è inconcludente. Firenze resta in mano
ai Medici, con cui angioini e Sforza rinsaldano i propri rapporti.
1469: Lorenzo il Magnifico assume la signoria di Firenze, confermando la
politica di pace e alleanza strategica con Napoli e Milano: più tardi egli
sposerà la bella Clarice Orsini, alleandosi con la potente famiglia romana. In
Spagna, il matrimonio tra Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona porta
all'unificazione delle due corone; Renato I inizia a temere per la pressione
aragonese sulle Baleari, e tenta di stringere ulteriormente la presa su queste
ultime, inviando condotte genovesi a stabilirsi in diverse città portuali
dell'emirato di Granada. Agli arabi, la cosa viene presentata come un male
necessario alla difesa contro i re cattolici, ma intanto Renato I si è
assicurato il passaggio dei suoi navigli verso l'Atlantico. Soprattutto, egli
chiama alla sua corte i nipoti, figli di Iolanda, tra cui spicca Isabella
(Renato I, comprensibilmente, teme che l'ipotetico figlio delle maestà
cattoliche possa prenderla in moglie, annettendosi le isole). Ferdinando I,
impotente come il padre Alfonso V, non può nemmeno tenersi l'erede omonimo:
Alfonso II crescerà come condottiero italiano, al servizio delle guerre angioine.
1471: Paolo II muore. Al successivo conclave, il primo dopo il 1305 a disporre
di un sistema funzionante con i due terzi della maggioranza costituita da
cardinali italiani a causa dell'assenza di sei cardinali stranieri (perlopiù
impiegati al seguito della guerra civile plantageneta), le due principali
fazioni sono quella del cardinale Guillaume d'Estouteville, cardinale e abate
francese (sostenuto, prevedibilmente, dai plantageneti) e quella di Latino
Orsini, già vescovo di Conza, arcivescovo di Trani, amministratore apostolico di
Bari e Polignano, nonché legato papale nominato a Napoli (e perciò ritenuto
pericolosamente vicino a Renato I). La fazione di Orsini, in particolare,
ottiene una grande vittoria preconclave riuscendo a convincere il resto del
Collegio Cardinalizio a escludere i cardinali in pectore creati da papa Paolo II,
in esplicito contrasto con l'ultimo volere e testamento del precedente
pontefice. I due partiti citati sopra possono essere chiamati più specificamente
dei pieschi (in riferimento ai cardinali creati da Pio II, perlopiù italiani ed
amichevoli nei confronti del re di Napoli) e dei paoleschi (in riferimento ai
cardinali creati da Paolo II, perlopiù stranieri e riassertori dell'autonomia
del potere pontificio). Come nel conclavi precedenti, Basilio Bessarione emerge
come il favorito della prima ora, solo per venire prevedibilmente escluso a
causa dei pregiudizi sulla sua origine greca e la supposta (mai provata)
cripto-ortodossia. Alla fine, Renato riesce a convincere il suo alleato Galeazzo
Maria a convergere sul candidato Orsini (Lorenzo de' Medici, in qualità di
marito di una Orsini, era già d'accordo), che così viene eletto Papa con il nome
di Niccolò VI (in parte, come tributo a Nicola III, già papa Orsini. Ma poi
soprattutto come segnale di continuità rispetto alla politica di collaborazione
con il re di Napoli inaugurata da Niccolò V, che lo aveva anche elevato a
cardinale e arcivescovo).
1472: rinvigorimento dei tentativi crociati contro gli ottomani. Galee
pontificie, napoletane e veneziane conquistano Smirne, che viene affidata alla
potestà del fratello di Galeazzo Maria, Ludovico. Renato fa così anche gli
interessi del duca, che avendone forse subodorato la doppiezza, voleva
allontanare il fratello dall'ambiente di corte. Come ricompensa, Galeazzo Maria
garantisce alla coppia ereditaria (Gian Galeazzo e Isabella) il possesso di
Pavia.
1473: come ricompensa per il servigio degli anni precedenti, Giuliano de'
Medici, fratello di Lorenzo e già inviato fiorentino presso le corti di Milano e
di Napoli, viene creato cardinale. Braccio destro del pontefice Orsini, Giuliano
si rivelerà, per la sua bellezza, il suo carattere estroverso e la sua nobiltà
di spirito, sempre più vicino al papa Niccolò VI. Per intanto, l'Orsini ne fa il
suo legato a Venezia, con il difficile compito di gestire le burrascose
relazioni con la Serenissima (dove, peraltro, Giuliano non era del tutto
sgradito).
1476: congiura del Lampugnani, Galeazzo Maria viene assassinato sul sagrato
della chiesa di Santo Stefano. Nuovo duca diventa il piccolo Gian Galeazzo
Maria, sotto la tutela congiunta della madre Bona di Savoia e dello zio
Ludovico, detto il Moro per le sue connessioni con la Turchia, che inizia da
subito a intrigare per togliere di mezzo la duchessa madre.
1477: i soldati dell'Impero ottomano devastano Croazia, Slovenia e Carinzia, poi
entrano in Italia varcando l'Isonzo e giungono fino al Piave. Per la prima
volta, Venezia non ha la forza di arrestare l'esercito del Turco. Lo stesso
anno, Niccolò VI muore, e Giuliano de' Medici gli succede senza problemi,
assumendo il nome di Alessandro VI, come il mito dei suoi sogni cavallereschi.
1478: congiura dei Pazzi a danno di Lorenzo il Magnifico. Pur senza l'appoggio
del Papa (qui il della Rovere è molto meno influente), l'assenza di Giuliano de'
Medici, impiegato proprio presso come Santo Padre, fa sì che Lorenzo il
Magnifico resti ucciso. La signoria di Firenze viene assunta dalla madre Clarice
Orsini per conto del figlio Piero, che si trova in una posizione molto debole,
accerchiata da sostenitori del regime repubblicano; ella di conseguenza accetta
l'offerta di Renato I, che concede al piccolo Piero la mano di sua nipote
Isabella in moglie. La tutela legale sul bambino, comunque, è spartita tra
Clarice e papa Alessandro VI, che spartisce il suo tempo tra Roma e Firenze. La
stretta relazione nata fra le due città favorisce, tra le altre cose, lo scambio
di geni, artigiani e artisti.
1479: Venezia conclude la pace con gli ottomani, perdendo un gran numero di
posizioni commerciali e possedimenti. La difesa della Morea, coadiuvata con i
Paleologi e Napoli, diventa una priorità al fine di mantenere perlomeno un
frammento di territorio greco.
1480: Bona di Savoia è estromessa dalla reggenza di Milano a favore
dell'ambizioso Ludovico, che rinchiude il nipotino Gian Galeazzo nella gabbia
dorata del castello di Pavia. Purtroppo, le inquietudini nutrite da Renato I a
questo riguardo (Gian Galeazzo era pur sempre il promesso sposo di sua pronipote
Isabella Maria) non hanno modo di concretizzarsi, stante la morte del sovrano,
avvenuta verso la conclusione dell'anno alla veneranda età (per l'epoca era
davvero straordinario) di 71 anni. Tanto a lungo aveva vissuto il sovrano, che
si fece fatica a tracciare la corretta discendenza della corona: da Giovanni II,
detto il Granduca poiché era stato duca di Calabria, e cioè erede al trono, per
tutta la vita, l'investitura a succedere era passata al di lui figlio Giovanni
III, principe di Taranto (il marito di Ippolita Maria, figlia di Francesco
Sforza) e poi, con il decesso di quest'ultimo, al di lui fratello Carlo IV,
ragionevolmente chiamato l'Improbabile. Renato convalidò il passaggio di
cariche, autorizzando il nipote a sposare la moglie del fratello defunto, con la
quale concepì anche un bambino, Luigi (V), che venne insignito del titolo di
principe di Taranto. Purtroppo per lui, anche Carlo IV non sarebbe sopravvissuto
al padre, lasciando questa valle di lacrime nell'anno del Signore 1473. A questo
punto, Ippolita Maria era madre di tre bambini: Roberto e Isabella (figli di
Giovanni III il Giovane) da un lato, Luigi V dall'altro, tutti pronipoti di
Renato I il Buono e tutti egualmente validi nel diritto di succedergli. Dopo
molte considerazioni e il parere di importanti giuristi (famoso, in questo
contesto, rimase il contributo di Agostino Dati, filosofo e oratore lodato, fra
gli altri, da Erasmo da Rotterdam), il re aveva deciso di accordare il proprio
favore al piccolo Roberto, in accordo con la teoria della discesa della potestà
regia esclusivamente per primogenitura. Rimane superfluo notare come, con un
bambino sul trono di Napoli, il vero potere rimase nelle mani della madre,
Ippolita, la regina che avrebbe in seguito ricevuto il soprannome di arbitra dei
destini d'Italia.
.
Il regno di Roberto II (1480-1496)
Il regno di Roberto II, o, com'era più
spesso chiamato dai suoi sudditi, Robertino, coincise per una buona metà con la
reggenza di sua madre, Ippolita, fine politica, nonché donna straordinariamente
colta. Buona parte della prima azione politica di Ippolita si dedicò proprio al
fine di riorganizzare e modernizzare l'apparato dello Stato, opera titanica, ma
già iniziata con il ritorno al potere degli angioini. Già Renato I di Napoli, a
suo tempo, aveva mirato a dissolvere il particolarismo feudale e fare del potere
regio la sola leva di vita del paese. In questo quadro, lo scontro con i baroni
era sorto inevitabilmente attorno al problema di una riforma organica dello
Stato, i cui cardini erano la riduzione del potere baronale, lo sviluppo della
vita economica e la promozione a classe dirigente dei nuovi imprenditori e
mercanti napoletani. Strumento di questa politica fu la riforma fiscale, che
affidava nuovi compiti alle amministrazioni comunali (molto incentivata fu la
fondazione di nuove università), incoraggiandole a sottrarsi, per quanto
possibile, al peso feudale. E in verità, è stato calcolato che allora nel regno
del sud, su 2000 centri abitati, poco più di 200 erano assegnati al regio
demanio, cioè alle dirette dipendenze del re e della corte, mentre tutti gli
altri erano controllati dai baroni. Il che significava che il potere feudale nel
suo complesso era il vero titolare delle risorse e delle finanze del Regno, e
che la corte angioina nei fatti era resa subalterna all'organizzazione baronale.
Ippolita era decisa a cambiare questo fatto, favorendo in ogni modo l'estensione
numerica delle città demaniali, sottraendole al peso feudale e incorporandole
alla propria diretta amministrazione. Ma l'impresa non era di poco conto: la
feudalità era organizzata attorno al nome di poche potenti dinastie, a loro
tempo chiamate dalla Francia per essere al servizio degli angioini e ora
ossificate nel territorio. Questa ristretta classe dirigente si avvaleva
dell'alleanza e del favore dello Stato Pontificio. Da tempi remoti ormai, il
papa aveva costretto il Regno a considerarsi territorio a lui infeudato, e
nessuno poteva aspirare al trono senza l'assenso esplicito e l'investitura
formale del pontefice. Oltre a ciò, il papa vantava antiche pretese e vecchi
privilegi su parecchie terre e città meridionali, e inoltre governava
direttamente, attraverso vescovi e abati, tutta la Chiesa del Regno, fornita di
propria e autonoma giurisdizione, di propri tribunali distinti da quelli regi e
da quelli feudali, e di proprie finanze provenienti dalla fittissima rete di
proprietà ecclesiastiche. Baroni e Chiesa si coalizzarono contro la regina
madre, percepita come debole e isolata. Nel 1485, profittando anche del velato
supporto di papa Alessandro VI, del resto connesso agli sviluppi di politica
estera che affronteremo a breve, scoppiò una vasta ribellione della feudalità,
conosciuta come Congiura dei Baroni. Ippolita reagì con inattesa energia:
alternando profferte e minacce (tanto famosa quanto evanescente rimase la
promessa della sua mano, e, in prospettiva, del trono), ella riuscì a spaccare
il fronte unito degli elementi a lei ostili, reclutando anzi alcuni individui al
suo servizio. Il temuto condottiero Roberto Sanseverino (alcuni sostengono,
amante della regina) fu uno di questi: con il suo supporto, la sovrana riuscì a
sconfiggere in diverse battaglie campali i del Balzo, gli Acquaviva, i
Caracciolo, i Guevara (i Senerchia stavano, invece, col re) e, complice anche il
riavvicinamento col Papa, domare la rivolta. Pregevole risultato dell'opera di
centralizzazione operata dalla Sforza fu la creazione di un apparato burocratico
capillare ed esteso, capace di radicare la volontà del re in ogni angolo del
Regno. Alla fine del suo dominio, le casse di Napoli straripavano di denaro, e
il monarca angioino poteva a buon diritto definirsi il sovrano più ricco del
continente.
Strumento del predominio era anche un adeguato grado di prestigio. La regina
madre, molto ricettiva agli stimoli che le provenivano dalla riscoperta dei
classici, si spinse molto a questo proposito per trasformare la corte angioina
in un ricettacolo di poeti e artisti non secondo alle altre città d'Italia,
portando Napoli (ma anche Bari, che Ippolita amministrava per conto del fratello
Ludovico) alle più alte vette della cultura rinascimentale. In particolare,
Ippolita si dimostrò particolarmente ricettiva alle istanze esplorative
presentate, fra gli altri, da Genova. Fu proprio merito dell'attenzione
riservatole da Isabella, in effetti, se in quegli anni la città del dio Giano,
rispolverato l'ordinamento degli otto capitani di libertà in luogo di quello
dogale (in sostanza, otto patrizi cittadini prescelti dalla regina per governare
in sua vece) si diede completamente al patrocinio del regno di Napoli,
diventandone l'avanguardia sugli oceani. E dico oceani perché, in vero, a
partire dalla metà del secolo, quando la contrapposizione con gli aragonesi si
era fatta insostenibile, le galere genovesi avevano preso a spingersi sempre più
lontano, prima stabilendo una presenza al di sotto del Marocco, poi sbarcando
sulle coste di Capo Verde (dove, per mezzo di intermediari Wolof, gli italiani
potevano commerciare in oro direttamente con l'impero del Mali, che ne era
principale estrattore) e infine gettando l'ancora presso l'odierno Ghana.
Antonio da Noli era capitano generale dell'amministrazione della Zenaga
(Senegal), dove i genovesi avevano fondato il primo emporio stabile in Africa.
Intorno agli anni '70-'80 del '400, il commercio con i nativi africani (ma per i
genovesi si chiamavano möi, e il loro sovrano era il Bon Neigro) era ormai stato
consolidato, portando grandi ricchezze a Genova e a Napoli. Pur tuttavia, il
gran premio, raggiungere l'India, non era ancora stato conseguito. Fu proprio la
regina a imporre una svolta significativa in questo senso: nel 1482, sfruttando
la conoscenza acquisita nei viaggi precedenti, Ippolita inviò verso oriente il
figlio di Antonio, Antoniotto detto Usodimare (abituato alla navigazione).
Questi, partendo dallo Zenaga, prima aveva doppiato il Capo Tempesta, rinominato
per l'occasione Capo della Buona Speranza, e infine era diventato il primo
occidentale a raggiungere l'India, ritornando a Napoli con le famigerate e
preziosissime spezie nel 1485. L'analoga iniziativa portoghese era stata battuta
di due anni. Anche i veneziani erano allibiti: urgeva correre ai ripari.
E ai ripari gli avversari di Napoli corsero immediatamente. In effetti, non si
può pensare che, in assenza di un sovrano forte, il dominio degli Sforza sui due
lati della penisola mancasse di mandare in agitazione buona parte dei governanti
d'Italia. La prima occasione buona per sfidare l'egemonia angioina nella
penisola, capitò con la guerra del sale, appena due anni dopo che Ippolita aveva
assunto la reggenza per Robertino. Papa Alessandro VI (Giuliano de' Medici),
convinto che con la morte di Renato I si fosse finalmente dissolta la pesante
tutela esercitata sul pontificato dai re del sud, mosse guerra a Ferrara,
ardendo perfino di stipulare un'alleanza con Venezia. La manovra diplomatica era
subdola: così facendo, il pontefice intendeva sfilare Roma dal precedente asse
peninsulare anti-veneziano costruito tra Sforza, Medici e Angiò. In questo
contesto, la lealtà dell'aristocrazia napoletana a un re bambino, pur sempre
legata al pontefice da teorici vincoli di vassallaggio, era davvero dubbia. Allo
stesso tempo, il potere di Ippolita (pur sempre una regina straniera) sulla
feudalità meridionale era ancora troppo debole per rischiare di imporre una
guerra al sud. Purtroppo per lui, la resistenza degli Este si rivelò avveduta e
formidabile. In primo luogo, Ercole I, duca per concessione imperiale, si difese
in campo giuridico, argomentando che siccome la città di Ferrara era feudo
imperiale, un attacco portato portato dal pontefice rischiava di scaturire una
rappresaglia da parte dell'imperatore. Una minaccia sottile, ma veramente
infondata: come vedremo più avanti, infatti, a quel tempo Federico III era del
tutto affaccendato in altre questioni. Un messo asburgico arrivò a Roma,
agitando lo spauracchio di fantasmagoriche ripercussioni. Ma non se ne fece
nulla, per cui Ercole I decise di rivolgersi al sovrano allora più potente
d'Italia, cioè il dominus occulto di Milano: Ludovico il Moro.
In effetti, se l'obiettivo di Alessandro VI era quello di rompere la convergenza
storica tra Sforza e Angiò, si può dire che in un certo senso ci riuscì, perché
l'intervento di Ludovico il Moro, cui Ercole I aveva concesso la figlia Beatrice
in moglie, a favore degli Este mise, per la prima volta dall'ascesa di Francesco
Sforza al trono ducale, gli interessi di Milano e di Napoli su una rotta
contrapposta. Come già detto, del resto, Ippolita aveva le mani legate; indi per
cui Ludovico fece, a suo piacimento, il bello e il cattivo tempo sui campi di
battaglia. Mentre le disorganizzate milizie papaline disperavano di non riuscire
a prendere la munitissima Ferrara, il non-duca espugnò, partendo da Brescia, una
ad una le località del Garda che Venezia aveva precedentemente conquistato:
Desenzano, Sirmione, Peschiera, perfino Bardolino, risalendo la sponda est del
lago. Da Bardolino, Ludovico si spinse su Verona, investendo la bella città di
una pioggia d'artiglieria; in seguito, egli prese d'assedio Padova, e tentò di
portare attacchi a Treviso, che resisteva strenuamente. In soli tre anni di
conflitto, forte della neutralità napoletana, ma anche della macchina da guerra
costruita nel tempo dal padre Francesco, Ludovico aveva completamente scardinato
l'equilibrio di potenze inaugurato sotto Renato I. Il progetto del non-duca era
quello di aggirare Treviso e dare fuoco a Venezia, cercando così di bruciare la
flotta della rivale in porto, ma fortunatamente non ce ne fu bisogno, perché
all'alba del 1485 i veneti avevano ormai completato la conquista delle paludi
romagnole, e avevano circondato Ferrara minacciando di portare alla caduta della
città. Ercole I, come capofila dello schieramento emiliano-lombardo, fu così
costretto a sottoscrivere una pace che concedeva le saline in usufrutto ai
veneziani, insieme con il possesso di Rovigo. Ludovico il Moro rientrava nei
suoi confini senza grossi riconoscimenti, eccezion fatta per il divieto di
navigazione sul Garda imposto ai veneziani e la restaurazione degli Scaligeri a
Verona e dei Carraresi a Padova. Una clausola del trattato era importante, e
garantiva a Ludovico di rientrare dalle spese della guerra: tutto il commercio
veneto verso la Germania doveva passare attraverso una di queste città, le
quali, poi, giravano a Milano una parte del ricavato in dazi.
Tuttavia, un non desiderato risultato della brillante performance milanese fu
quella di spingere nuovamente i Medici nelle braccia degli angioini. La
sconfitta duramente incassata aveva fatto invecchiare Alessandro VI prima del
tempo, e il fratello del fu signore di Firenze cercava ora l'appoggio napoletano
per vedere il suo pupillo, il nipote Giovanni, eletto al soglio di san Pietro.
Ippolita fece pagare a peso d'oro questo ritorno all'ovile: il sacro pontefice
doveva riconoscere al re di Napoli i titoli di Difensore della Fede e,
soprattutto, Gonfaloniere della Santa Sede in perpetuo. La trasmissione dei
summenzionati titoli era ereditaria; fu così che Robertino, ormai adulto, si
trasferì a Roma, dove, nel 1486 conobbe e sposò la primogenita di Lorenzo il
Magnifico, Lucrezia. La coppia regale di lì si sarebbe spostata prima a Viterbo
e poi a Spoleto, agendo come una sorta di cappio al collo del Papa, e
frustrandone pesantemente le capacità di condurre una politica estera pienamente
indipendente.
Ippolita, sempre più spaventata dal trattamento che il fratello aveva riservato
a suo nipote Gian Galeazzo, cercò anche, senza successo, di affrettarne il
progettato matrimonio con la figlia Isabella, che si svolse, come da programma,
nel 1489. La previdente regina, comunque, non visse abbastanza per vedere i
propri timori realizzati: ella spirò nell'anno 1488, circondata dall'affetto dei
suoi cari. Al suo capezzale non mancava il figlio; era persino presente il
legato papale, che si preoccupò di somministrarle l'estrema unzione. Mancava,
comunque, un inviato di Ludovico.
Quando la notizia della morte di sua madre lo raggiunse in Umbria, Robertino
pianse. E questo non soltanto per ragioni d'affetto: Ippolita Maria aveva
lasciato in eredità al figlio un regno più ricco e forte di quello che aveva
trovato; il suo genio diplomatico e la sua valenza amministrativa erano
virtualmente insostituibili. Però una cosa, Roberto II, aveva imparato a farla
bene: la guerra. E fu proprio in questo ambito che il novello sovrano fu
inizialmente impiegato: dal 1488 al 1494, subito dopo essere stato unto da papa
Alessandro VI come legittimo successore di Renato il Buono e mentre suo
fratellastro Luigi (V) governava Napoli con successo, il sovrano combattè contro
numerose città (Perugia, Ancona, Bologna...) riottose a sottomettersi
all'autorità pontificia. Roberto II sottomise numerose importanti famiglie, fra
cui i Riario, i della Rovere, e i Bentivoglio. Il papa gongolava, ma in realtà
quelle conquiste erano fatte a titolo proprio: col tempo, Roberto II iniziò a
farsi chiamare duca di Spoleto, oltre che titolare della marca anconitana. Erano
in molti, esterni all'alveo naturale del regno di Napoli, a chiamarlo loro
signore; fra loro si annoveravano gli abitanti di Imola, Faenza, Rimini, Bologna
e Forlì. Nel 1491, pur di evitare un duro assedio, i maggiorenti della
repubblica di Ancona scelsero di dedicarsi al re di Napoli, seguendo una
politica già inaugurata da Genova, e che comportava grossi benefici. Nel 1492
Roberto II intervenne perfino in Toscana, a sostegno dell'inetto figlio di
Lorenzo il Magnifico, Piero, che col tempo aveva messo da parte i saggi consigli
della madre Clarice e della moglie Isabella, per governare come un tiranno sopra
Firenze. Il re sgominò l'effimera repubblica teocratica di Savonarola; con
metodi brutali ma efficaci egli impose l'impiccagione del Soderini e dei suoi
sodali, incrinando una volta per tutte le spinte sovversive dell'antica città.
Il Medici divenne duca di Firenze per concessione angioina. In seguito, Roberto
II seppe inserirsi abilmente nelle rivalità fra le città toscane, ricevendo
l'infeudazione, fra le altre, di Pisa e Arezzo.
A mettere un freno alle tendenze espansionistiche di Napoli, che ormai aveva
soggiogato l'intera Italia centrale, fu soltanto la smodata ambizione di
Ludovico il Moro. Temendo che l'arrivo in età adulta del legittimo duca, Gian
Galeazzo, potesse inficiare la sua presa su Milano, nel 1494 il signore de facto
della Lombardia fa segretamente avvelenare il nipote, che così non uscirà mai da
Pavia. I funerali si svolgono in un'atmosfera cupa: ai presenti, pure se di
parte ludoviciana, risulta impossibile non notare la straordinaria coincidenza
della dipartita. Peggiora la situazione anche l'incoronazione formale del Moro,
che usurpando i diritti del figlioletto di Gian Galeazzo, Francesco, assume il
titolo di duca. In tutto questo, resta viva Isabella, moglie del defunto e
sorella di Roberto II, che ormai ragionevolmente certa del fatto che il Moro
voglia togliere di mezzo lei e i suoi eredi, titolari di una pretesa al ducato
ben più forte della sua, comincia a tessere una trama al fine di fuggire da
Pavia. Nella notte tra l'Immacolata e San Siro, patrono della città, Isabella
evade coi figli dal castello visconteo, attraversa i giardini con il favore del
buio e si mette in viaggio per raggiungere il fratello, che al momento ha
disposto la propria corte a Bologna, in attesa della bella stagione per
riprendere le sue campagne. La principessa raggiunge la fedele Cremona, dove
cinquant'anni prima si era consumato il matrimonio che aveva dato origine alla
dinastia del marito; da lì valuta di oltrepassare il Po sul ponte romano, ma
alla fine rinuncia per timore di venire scoperta e ricondotta a corte, dove
sicuramente la attende una severa punizione. Allora Isabella decide di
rivolgersi a un barcaiolo del fiume, che eccezionalmente devoto e stupito dalla
storia raccontatale dalla duchessa, si offre di trasportarla fino a Ferrara,
territorio estense. La scelta si rivela essere la più assennata, perché la
navigazione fluviale è sicuramente più rapida del viaggio per via di terra; e
così, prima ancora che sia passata una settimana, Isabella riceve asilo alla
corte di Ercole I, presso cui si presenta inizialmente come inviata diplomatica.
Il duca sbatte le ciglia (vedere una donna viaggiare da sola all'epoca è cosa
rara) ma non può certo negare ospitalità a una principessa straniera, specie
perché lui in primis era stato educato alla corte di Renato il Buono e sua
moglie era la figlia di un importante vassallo napoletano, e perciò la accoglie
in via provvisoria. Da qui Isabella si sente abbastanza sicura per decidere di
inviare un messaggio al fratello tramite un servitore, che lo raggiunge prima
del tramonto. Nel frattempo, Ercole I si è riuscito a mettere in contatto con
Ludovico, che gli ha notificato lo status di fuggitiva da attribuire a Isabella,
e finisce per rinchiuderla di nuovo. Ma ormai il danno è già stato fatto:
Roberto II, già sospettoso per il corso degli eventi, viene alterato oltremodo
quando scopre che sua sorella sta essendo illegalmente detenuta presso gli Este.
È il 21 dicembre 1494: per lo stress del viaggio sono morte sia Bianca, sia
Ippolita, figlie di Isabella. Il re circonda Ferrara, intimando la consegna
della sorella coi figli residui, Bona e, soprattutto, l'importantissimo
Francesco, ora erede legittimo al ducato di Milano. Roberto II non perde tempo:
mandando emissari a Roma, Venezia e Firenze, annuncia in fretta e furia la sua
intenzione di invadere la Lombardia con la bella stagione. Risposta positiva
proviene da Venezia, che intende approfittare dell'occasione per rioccupare
Padova e Verona; silenzio invece da Alessandro VI e Piero il Fatuo,
sostanzialmente impotenti. Frattanto, Ludovico il Moro è nel panico: anch'egli
invia messi a Ferrara e Vienna, perfino a Parigi; egli giunge al punto di
ipotecare il Ticino agli svizzeri, in cambio di una prestazione mercenaria. Ma
anche stavolta l'imperatore, complice sempre l'interessamento a est, decide di
restare fuori dalla partita. Analoga risposta proviene dalla duplice monarchia,
dove Enrico VII e IV Tudor si è installato ancora da poco tempo, ed è contrario
a nuove avventure militari. Il destino del Moro è praticamente segnato.
Nel corso dell'inverno, il re non resta fermo: egli si occupa di spazzare via
qualunque resistenza sforzesca a sud del Po, stabilendo il proprio quartier
generale a Piacenza. Non appena iniziano a sciogliersi le prime nevi, Roberto II
passa il grande fiume inastando sia la bandiera della vipera viscontea, sia i
gigli d'oro di Napoli. La marcia del re è inarrestabile: Cremona (già testimone
della fuga di Isabella e che ora torna a ospitarla), Pizzighettone, Codogno
aprono le porte al re. Sulla via di Milano, solo Lodi oppone una debole
resistenza, ma Roberto II non si cura di assediarla, e così in meno di un mese
avanza sino alla capitale. La mossa è rischiosa: stretta Milano d'assedio, le
retrovie del sovrano sono infastidite da continue puntate offensive dei fratelli
di Ludovico, che cercano di impedire al re di chiudere il cerchio intorno a
Milano. Ma alla fine, è la stessa popolazione meneghina a insorgere, stufa del
proprio tiranno: le porte della città sono aperte ai napoletani, e Ludovico si
trincera inutilmente all'interno del castello sforzesco. Egli è tirato fuori
dalla rocca per i capelli e sommariamente processato per omicidio di un parente,
reato per cui sarebbe prevista la morte; ma Roberto II, che ha restaurato sua
sorella sul trono, si dimostra clemente e commuta la pena in esilio al servizio
dei cavalieri di Rodi.
Roberto II, stroncato dalle fatiche di una campagna fulminea, non vivrà ancora a
lungo. Adorato dai sudditi, il re soldato, che un tempo era stato il re
fanciullo, si spegnerà a Milano l'anno successivo (1496), sommerso dalle
amorevoli cure della sorella e dei nipoti. Una vita in moto, trascorsa all'arme
più che nel letto della moglie, ha privato il sovrano del piacere di essere
padre. Un testamento redatto all'ultimo confermerà la volontà dell'angioino di
lasciare ogni cosa al parente maschio più prossimo in vita, e cioè il piccolo
Renato Francesco, figlio di Gian Galeazzo e Isabella.
.
Il regno di Francesco I (1496-1512)
Come per lo zio, anche il regno di
Francesco I trascorse per buona parte nella reggenza di sua madre Isabella.
Conosciuto a Milano come il duchetto e a Napoli come il reuccio, nella persona
del piccolo Francesco si assommava il dominio, esplicito o implicito, su tre
quarti della penisola italiana: fuori dall'ombrello angioino restavano solo
Venezia da un lato, e i Savoia dall'altro. Papa Alessandro VI, sempreverde,
tentò a suo modo di sfruttare la reggenza, piazzando i suoi Medici in ogni dove:
in particolare Rodrigo Borgia, protodiacono e vicecancelliere di Santa Romana
Chiesa, assunse la carica di cappellano di corte. Isabella, che governava da
Milano, lasciò fare, considerando come una politica di alleanza col papato
avrebbe portato più benefici che altro. Ella allentò anche la presa
sull'aristocrazia del sud, in modo tale da ottenerne l'appoggio per la
successione di suo figlio, re proprio iure. Purtroppo per Francesco, egli non
sarà mai incoronato.
Già, perché il precario equilibrio in cui è tenuta la penisola si scioglie con
la morte di Alessandro VI, che spira a 50 anni nell'ottobre del 1503. Al
conclave pare ovvio assistere all'elezione di un candidato favorevole al fronte
angioino, molto influente nella curia. All'interno delle votazioni, però, la
suddetta fazione si spacca: agitando la pretesa che il nipote di Giuliano de'
Medici, Giovanni (figlio di Lorenzo il Magnifico) fosse troppo giovane per
assumere la carica (poco conta se suo zio era diventato pontefice a soli 24 anni
in accordo con la volontà di potenti stranieri), Rodrigo Borgia asserisce di far
convergere i voti sul suo partito. Informata della divisione, la regina non sa
che pesci prendere: se da un lato vorrebbe diminuire la pervasività del potente
clan mediceo, ormai infiltrato in tutti i gangli fondamentali dello Stato,
dall'altro non può rischiare di inimicarselo, per timore di pregiudicare la
precaria posizione del figlio. Dalla rivalità fra il Borgia e i Medici
approfittarono i nemici degli Angiò: organizzandosi con straordinaria rapidità,
il cardinale Giuliano della Rovere, capo della fazione anti-angioina, riesce a
vendere la propria candidatura al Borgia come un candidato di compromesso. Nel
giro di tre votazioni, il della Rovere è eletto papa con il nome di Giulio II,
consegnando alla Storia un risultato sorprendente.
Isabella tenta di stabilire relazioni amichevoli con il nuovo Papa, ma si tratta
di un tentativo infausto, perché, una volta stabilito sul soglio pontificio,
Giulio II mette subito in chiaro di non voler essere l'utile idiota della corte
angioina. Anzi al Santo Padre, egli argomenta, spetta il compito di supremo
arbitro delle contese d'Italia, e da questa posizione di rinnovata autorità egli
ordina lo sgombero di tutte le guarnigioni napoletane dal territorio dello Stato
Pontificio. Ma non basta: appellandosi al contratto feudale, egli dichiara di
non riconoscere la successione di Francesco I al trono dello zio, sostenendo che
la linea regia non può mai passare per via femminile. Così, egli chiama in
Italia Ferdinando delle Baleari, lontano discendente di Renato I per via della
figlia di quest'ultimo, Iolanda (notare la contraddizione con l'argomento
addotto poco prima). Le pretese dinastiche di quest'ultimo sono poco solide, ma
la sua forza è reale: nel 1504 egli sbarca a Napoli e si fa incoronare, con il
supporto dei riottosi baroni, come Ferdinando (II, dato che la numerazione
aragonese si fa discendere dal nonno Ferdinando, figlio di Alfonso il Magnanimo)
re di Napoli, di Sicilia, delle Sardegna e delle Baleari; ad Isabella restano
solo Milano, e l'ambigua fedeltà dei Medici. L'impero angioino è spaccato a
metà.
La guerra totale che ne segue imperversa per cinque anni, caratterizzandosi come
una sorta di scontro finale tra fautori degli angioini e loro oppositori. Giulio
II s'annette una alla volta le piazzaforti napoletane nelle Romagne e Alfonso II
devasta il sud, dato che non tutti hanno accettato pacificamente la sua
conquista. In particolare la Sicilia, protetta anche dalla flotta genovese,
resta un imprendibile bastione e una spina nel fianco per l'aragonese, che deve
vedere i suoi porti costantemente razziati. Il declino del commercio che ne
segue vale ad Alfonso II il supporto dei mercanti e della grande impresa
meridionale; questi, se non vanno in esilio, nell'ombra si rivolgono alla regina
Isabella, fornendole tutta la pecunia necessaria ad assemblare un vasto
esercito. Tuttavia, la regina non si muoveva ancora, volendo assicurarsi anche
l'amicizia dell'imperatore Massimiliano I, succeduto al padre Federico III dieci
anni prima e da allora chiuso in un ostile silenzio nei confronti dell'Italia.
Isabella promise a suo figlio Federico (IV) la mano della figlia Bona (gli
stava, insomma, garantendo un posto di primo piano nella futura guerra di
successione che sarebbe scoppiata alla sua morte). Insieme a questo, Isabella
gli pagò in anticipo la strabiliante somma di 600.000 ducati come dote,
convincendo l'imperatore ad aderire alla nuova Lega di Innsbruck (dove risiedeva
il sovrano) in ottica anti-papalina. Anche Ferrara e Venezia, spaventate dalla
possibilità di perdere terreno in Romagna entrarono a farne parte: così la
calata del principe imperiale in Italia, coadiuvata dagli abitanti, non incontrò
virtualmente nemici. Le forze di Isabella e Federico coalizzate scendono la
penisola sul lato tirrenico, ottenendo una serie di trionfi. Il 6 gennaio 1505
l'Asburgo entra pacificamente a Roma, da cui il papa, spaventato si è ritirato
dandosi alla macchia sulle montagne, e si fa incoronare imperatore da un diacono
in Laterano. Sarà l'ultimo tedesco a riuscire nell'impresa. Successivamente,
egli completa l'obiettivo della sua spedizione prendendo anche Napoli, che è
sottoposta a saccheggio. Quando Ferdinando II ha notizia del sopraggiungere
dell'imperatore, egli abdica e si ritira in un monastero, lasciando al figlio
Alfonso (III) il compito di continuare la lotta.
Apparentemente, tutto sembra andare per il meglio per Isabella: suo figlio è
stato restaurato sul trono, ed ella può continuare a fregiarsi del titolo di
regina. Però, la rapidità della vittoria imperiale (e, soprattutto, la sua
brutalità) spaventa gli italiani, e questa considerazione spinge a un
ribaltamento delle alleanze. Giungendo a patti con Giulio II (sostanzialmente,
uno status quo) la regina straccia il patto di fidanzamento della figlia, che
invece promette ad Alfonso III. Un primo scontro avviene vicino Gaeta, dove
papalini e napoletani tentano di sbarrare la via di casa a Federico IV, ma ha
esito inconcludente. Così, per difendersi dalla vendetta imperiale, la regina
chiama in Italia Enrico V e VIII (notare l'inversione dei numerali
nell'aggiornata titolatura regia) nuovo sovrano della duplice monarchia: la
promessa (non espressa, ma succinta) è quella della sua stessa mano. Le due
grandi potenze si scontrano a Piacenza, su suolo italiano: dopo un sanguinolento
scontro, Enrico V e VIII ha la meglio e il principe Federico è ucciso, privando
Massimiliano della possibilità di ereditare Lombardia e Baviera in un colpo
solo. A succedergli come imperatore sarà allora il secondo figlio maschio,
Rodolfo, detto il PIo.
A questo punto la situazione per Isabella non è migliorata di molto, perché, se
anche si fosse liberata di uno scomodo alleato (Massimiliano I è per giunta
costretto a ripagare integralmente la dota già ricevuta), si è trovata in casa
un nuovo e più scomodo inquilino. La regina madre fa appena in tempo a spedire
Bona a Napoli per sposare Alfonso III (i due governeranno come coniugi,
raccogliendo l'eredità degli Sforza, degli Aragona e degli Angiò) che Enrico V e
VIII si installa nel Castello Sforzesco di Milano, da cui governa. Egli fa
spedire il reuccio, Francesco, in Francia, dove il giovane morirà
inspiegabilmente per una caduta da cavallo poco dopo (1512). Anche Giulio II
lascia questo mondo, appena l'anno successivo. Al conclave seguente, lo scontro
tra la fazione filo-francese e quella filo-italiana è tremendo, tanto più che si
è ormai capito che Enrico V e VIII sta tenendo Isabella prigioniera in Milano in
attesa che il nuovo papa gli conceda il divorzio da sua moglie, Maria di
Lotaringia (il re se l'era presa col consenso paterno dopo che il fratello
Arturo era premorto). Alla fine, vincendo il supporto dei cardinali di fede
imperiale, che certo non possono accettare il predominio dei Tudor in Italia, ad
emergere vittorioso è Giovanni de' Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico,
pupillo di Alessandro VI e signore di Firenze de facto. Il nuovo Papa si schiera
immediatamente in opposizione ai francesi, concedendo l'incoronazione regia e la
sua benedizione alla coppia costituita da Bona e Alfonso. Enrico V e VIII
ovviamente non accetta di farsi da parte così facilmente: nel 1514, egli sposa
forzosamente Isabella, proclamandosi duca di Milano e re del sud iure uxorio; in
seguito, anch'egli manda un esercito verso Napoli al comando del duca d'Orléans,
Luigi. Enrico deve però anche provvedere al fronte contro la Spagna, perché Bona
e Alfonso hanno provveduto a promettere alla maestà cattolica Ferdinando II
l'ipoteca delle Baleari, nonché una (a scelta) della loro prole ventura come
sposa del nuovo regno unificato, quando, dal Trastàmara, la corona passerà agli
Aviz per effetto della successione di Giovanna (da noi conosciuta come la Pazza,
e qui, ovviamente, non ha avuto ragione di maritarsi col figlio dell'imperatore,
ma ha invece sposato Manuele I del Portogallo).
La guerra contro i Tudor sarà lunga e sanguinosa. Nel 1515, la real coppia
riesce per la prima volta a installarsi a Milano, però i due monarchi devono
lasciare nuovamente la città appena tre anni dopo, perché nel 1516 Ferdinando II
è morto e il suo successore, Manuele I il Fortunato, non ha nessuna intenzione
di mettere in pericolo il suo controllo sulle neoacquisite corone di Léon,
Castiglia e Aragona per venire in soccorso degli angioini. Una mossa
intelligente sarà invece quella di supportare con l'oro delle banche italiane
l'elezione del secondo figlio di Massimiliano I, Rodolfo II, a sacro romano
imperatore; questi dimostrerà di saper ricompensare i suoi alleati, scendendo in
Italia con un vasto esercito. Nel 1521, Bona e Alfonso rientrano finalmente a
Milano, e questa volta sarà quella definitiva: nel 1525, Enrico V e VIII Tudor è
sconfitto in una grande battaglia a Pavia, e giura di rinunciare per sempre alle
sue pretese su Milano. Isabella è liberata dalla sua prigionia, e così, una
donna rotta e rovinata dalle sventure della vita può vivere i suoi ultimi anni
in compagnia della figlia, che realizza finalmente quel progetto unitario in
Italia che era stato, a suo tempo, il sogno di Renato I, Ippolita e Roberto II.
L'interesse straniero nelle guerre d'Italia si concluse così con il trattato di
Napoli, siglato nel 1526, che fra le altre cose confermava la Provenza come
parte dell'assetto ereditario sforzesco-aragonese-angioino, ma ometteva di
pronunciarsi sull'ambiguo destino dei Savoia, il cui duca Filiberto era reo di
aver accolto e sposato Maria di Lotaringia, unica sorella del re Filippo IV.
Però il conflitto non aveva ancora finito di martoriare la penisola, e questo a
causa del nuovo papa, Clemente VII. Un Medici, figlio bastardo di Alessandro VI
(in realtà, i suoi sostenitori argomentano di come il concepimento di Giulio de'
Medici fosse avvenuto prima che suo padre Giuliano assumesse la porpora. Il
dibattito è piuttosto interessante), Clemente VII optò per rilanciare la potenza
medicea in Italia, colmando il vuoto di potere che le lotte dinastiche
imperniate su Milano avevano lasciato a cavallo fra Marche e Toscana. A questo
proposito, il Papa aveva concesso al parente Cosimo, del ramo Popolano, il
titolo di duca d'Urbino. Il papa non aveva capito che erano finiti i tempi dei
piccoli Stati regionali: al suo posto, in Europa dominavano le grandi monarchie,
come quella di Enrico V e VIII (Francia e Inghilterra), Manuele I (Castiglia,
Aragona, Léon e Portogallo) e Rodolfo II (Austria, impero, in prospettiva Boemia
e Ungheria). Fra la real coppia e Clemente VII fu impossibile trovare un
accomodamento: nel 1527 Alfonso III calò su Roma con un grosso esercito e la
mise a sacco, prendendo il papa in ostaggio. A fronte della prospettiva di
perdere tutti i suoi possedimenti, Cosimo I accettò di cambiare casacca,
passando al lato regio e venendo confermato come granduca di Toscana al posto
dell'estinto ramo di Cafaggiolo (negli anni successivi, si sarebbe occupato di
sottomettere definitivamente Siena e Lucca con l'appoggio del trono). La resa di
Clemente VII, abbandonato perfino dai suoi familiari, fece eco in tutta Europa.
Non era la prima volta che un papa cedeva Roma, ma era la prima che la
situazione sembrava mostrare tutte le premesse per diventare permanente.
Le trattative tra la real coppia e il papa furono lunghe e faticose. La
monarchia accettò di concedere "in eterno" il possesso di Roma al pontefice,
mentre il papa cedeva ogni pretesa temporale sui territori dell'Italia centrale.
Il primo agosto 1530, alla presenza di Cosimo I di Toscana, dei Gonzaga, dei
Paleologi del Monferrato e di quelli di Morea, degli Este di Ferrara, dei
genovesi (ma non dei veneziani) il figlioletto di Bona e Alfonso venne
incoronato, in spregio ai diritti imperiali, a Bologna re d'Italia da Clemente
VII in una fastosa cerimonia. Ecco, di seguito, per chi se ne dilettasse, la
lista di titoli detenuti dal giovane principe:
Giovanni Francesco (> Gianfrancesco) Maria CESARE I Renato, per volere di Dio RE D'ITALIA, di Napoli, di Sicilia, di Corsica e Sardegna, delle Baleari, di Cipro, d'Armenia e di Gerusalemme; duca di Milano, Genova, Urbino, Spoleto e Bari; marchese anconitano; conte di Pavia e Cremona; principe d'Achea; signore di Asti, Vercelli, Pisa, Arezzo, Perugia, Imola, Faenza, Bologna e Forlì; sindaco di Amalfi. In perpetuo Difensore della Fede e del Santo Sepolcro, Gonfaloniere di Santa Romana Chiesa, garante della Chiesa uniate e amministratore del demanio pontificio sotto il cielo.
(cliccare per ingrandire)
.
Quando abbiamo parlato delle guerre
d'Italia, abbiamo dovuto tenere in disparte le vicessitudini che interessarono i
Savoia. A cavallo fra i due secoli era duca Filiberto II, detto il Bello. Questi
aveva tenuto una politica ondivaga in merito alle invasioni anglofrancesi del
ducato di Milano, concedendo il passo a re Enrico V e VIII, ma senza schierarsi
apertamente a suo favore. Questa neutralità venne letta come abile mosse
diplomatica da Filippo IV di Lotaringia, figlio di Maria e Giorgio di Normandia,
il quale, già succube del potente ceto borghese fiammingo, aveva mantenuto una
linea politica analoga nelle contrapposizioni tra duplice monarchia e impero che
allora imperversavano in Europa. Fu così che, adempiendo alla clausola di piena
equidistanza tra Parigi e Vienna per il soddisfacimento della quale era nato il
regno, egli scelse allora di legarsi in matrimonio proprio con i sabaudi, dando
nel 1514 sua sorella Maria Margherita in moglie al fratello del duca, Carlo III
(i territori che avevano costituito la sua dote restano a Enrico V e VIII).
Margherita e Carlo III furono assieme per tre anni, durante i quali venne
generato un solo figlio. Emanuele FIlippo (HL: Filiberto). Si era allora nel
pieno delle guerre d'Italia, e papa Leone X diede il suo assenso, convinto di
come la creazione di un forte blocco di potere lotaringio al confine tra Francia
e Italia (dal mare del Nord al mar Mediterraneo) avrebbe scampato ai due
contraenti ulteriori guerre. All'epoca, insomma, sembrava essere la scelta
migliore: Filippo IV era ancora giovane e in salute e, sebbene il registro delle
sue precedenti attività sessuali non promettesse benissimo, poteva
ragionevolmente sperare di concepire un figlio prima della fine dei suoi giorni.
Come è prevedibile, le cose non andarono così. Il re di Lotaringia morì
improvvisamente a Bruges nell'ottobre 1516, forse di febbre indotta da tifo
(anche se non manca chi ipotizza la tesi dell'avvelenamento). Il figlio di Carlo
III e Margherita diventava allora l'erede presuntivo al trono, con l'ipotesi di
creare un gigantesco Stato al confine tra Francia, Italia e impero. La questione
non poteva essere risolta altrimenti che con la guerra: nel giro delle alleanze
di allora, Carlo III compì una scelta obbligata, allineandosi con il re di
Francia e Inghilterra, che avrebbe potuto, in caso contrario, soggiogare
rapidamente il territorio lorreno. Contro di lui, si stagliavano la real coppia
di Bona e Alfonso (per ovvie ragioni) ma, novità delle novità, anche
l'imperatore Massimiliano, sommamente indispettito dalla possibilità che un
soggetto enorme si costituisse in terra che giuridicamente apparteneva
all'impero, e rischiando cioè in prospettiva di pregiudicare il dominio
asburgico sulla Germania. La guerra si intrecciò con quella per il destino del
ducato di Milano, combattendosi perlopiù in Italia, e come quest'ultima, fu
costituita per la maggior parte da una serie di tira e molla. Il conflitto fu
aggravato anche dalla necessità, per la parte imperiale, di fare fronte al
divampare della Riforma, cui i sovrani occidentali stringevano pericolosamente
l'occhiolino. Nemmeno lo spauracchio della mobilitazione polacca, cui
Massimiliano era legato in virtù del suo matrimonio con Sofia Jagellone, poté
cambiare lo stato di cose: i Polacchi erano lontani e poco interessati alle
questione europee.
La situazione cambiò lungo il corso degli anni '20, quando al trono imperiale
ascese Rodolfo II, figlio secondogenito di Massimiliano, il quale si fece
protagonista di una politica più conciliatrice verso l'Italia. A seguito della
stessa battaglia di Pavia che decretò la fine delle guerre d'Italia, Rodolfo II
autorizzò Alfonso III a invadere il Piemonte, sottraendo ai Savoia il marchesato
e liberando i loro vassalli dall'obbligo di adempienza. Nel frattempo (1530),
l'ultima discendente dei Valois-Plantageneti ancora in vita, Margherita era
morta, e le città e contee della Lotaringia si dimostravano riottose ad ubbidire
agli ordini di Carlo III. Era chiaro a tutti i contendenti che serviva una
tregua, se non altro per riprisrinare le forze in attesa dello scontro finale.
Con il trattato di Cambresis, Carlo III rinunciava ai suoi possedimenti in
Italia, che passavano alla real coppia di Bona e Alfonso, ma veniva garantito
con i suoi discendenti sul trono di Lotaringia. L'unico a bocca vuota rimase,
come sempre, Enrico V e VIII. Col senno di poi, non stupisce dunque lo strappo
che egli decise di prendere con la Chiesa e l'Europa; ma non corriamo troppo.
.
Scoperte geografiche e pulsioni religiose: un riepilogo
1491: con la benedizione di Enrico VII e
IV, Anna di Bretagna, ultima erede al ducato, sposa Carlo di Valois, figlio di
Luigi il Ragno, grande alleato del re. Il potere Valois sulla corte si espande.
1492: caduta di Granada, i re cattolici completano la riconquista della penisola
iberica. I genovesi però mantengono lo sbocco all'atlantco tramite i loro
possedimenti nel sud dell'Andalusia; più tardi, lo stesso anno, Cristoforo
Colombo scopre le Americhe per conto della Superba.
1493: nella bolla papale Inter Caetera, Alessandro VI dichiara che tutte le
terre 100 miglia nautiche più a ovest delle Azzorre sono da considerarsi
italiane (la pretesa, assurda già all'epoca, sarà poi contemperate da successive
negoziazioni con gli spagnoli).
1495: la tipografia di Aldo Manuzio inizia la sua attività a Venezia,
trasformando la città in uno dei maggiori centri a livello europeo per la
produzione di libri e libelli. Enrico VII e IV rilascia la patente di esplorare
per suo conto le nuove terre a Giovanni Caboto.
1496: Cristoforo Colombo termina la sua seconda visita nell'emisfero
occidentale, durante la quale ha pesantemente ipotecato il controllo dell'isola
di Italica, aprendo numerosi empori per il commercio con i nativi Taino.
1497: Giovanni Caboto è il primo europeo a mettere piede in America
settentrionale. Lo stesso anno anche Amerigo Vespucci, che naviga per conto
della regina di Castiglia, parte da Cadice per le Americhe.
1498: dato che in questa TL Caboto parte da Nantes (più vicina al centro di
potere Tudor) e non da Bristol, egli non incappa nella tempesta che storicamente
gli costò la vita, lasciandolo disperso in mare. Invece, mentre Colombo sta
insediando l'isola di Trinità e la bocca dell'Orinoco nel sud del continente,
Caboto prende contatto con gli Aztechi, aprendo una lucrosa via di commercio di
cui per il momento i Tudor mantengono il monopolio.
1499: Vasco de Gama ritorna a Lisbona, completando il primo periplo portoghese
dell'Africa con rotta in India. I genovesi, concentrati sulle Americhe, perdono
terreno.
1500: con il supporto di navigli greci e napoletani stanziati in Morea, i
veneziani riescono ad impedire la disfatta della seconda battaglia navale di
Lepanto. Modone e Corone restano nelle mani della Repubblica; i Paleologi
conservano il despotato. Sulla fine dell'anno una flotta mista italo-veneta
riesce perfino a portare un contrattacco, riconquistando l'isola di Cefalonia
(aggiunta al demanio regio). La dominazione ottomana sul mare non è totale.
1501: gli Spagnoli scoprono il Brasile, i Portoghesi scoprono l'Isola
dell'Ascensione e pongono una pesante ipoteca sul controllo dei traffici europei
con l'India grazie alla loro miglior posizione. Dopo un inizio brillante, i
genovesi restano bloccati in Guinea.
1502: Cristoforo Colombo parte per il suo quarto e ultimo viaggio, nel corso del
quale mappa l'intera costa americana dalle estreme propaggini dell'impero azteco
alla bocca dell'Orinoco, scopre l'istmo di Panama e vi lascia un insediamento.
Scavalcando l'autorità degli otto capitani di libertà, Isabella lo nomina
Ammiraglio del Mare Oceano e governatore generale di tutti i territori che ha
conquistato. Intanto i genovesi, piccati per essere stati estromessi dall'India,
riparano iniziando a importare schiavi neri dall'Africa a Italica. Il monopolio
sul commercio dei nativi, insieme con la concessione regia di gestire l'intero
commercio italiano con le Americhe, faranno la fortuna della città nel secolo a
venire. Nel frattempo, a Parigi, muore il giovane principe Arturo Tudor,
lasciando campo libero (e la moglie lorrena) al fratello Enrico.
1503: la regina Isabella di Castiglia proibisce l'uso di violenza contro i
nativi. Intanto, un enorme numero di marranos è espulso dalla Spagna, e va a
popolare i possedimenti spagnoli nelle Americhe.
1504: nel contesto degli accordi con Alberto IV, primo duca della Baviera
riunificata, l'imperatore Massimiliano cede i diritti ereditari sulla Baviera di
Sidonia di Baviera, figlia più anziana di Alberto IV, per conto del principe
Federico (IV), che le era fidanzato. La morte improvvisa di Sidonia, l'anno
successivo, tronca sul nascere questi progetti, e spinge il giovane e
ardimentoso principe a lanciarsi nella campagna d'Italia, con la promessa della
mano di Bianca Maria Sforza. Sarà poi suo fratello Rodolfo a ereditare, con la
mano della sorella di Sidonia, Sibilla, la patente del padre per ereditare il
trono. Nel frattempo, Cristoforo Colombo torna a Genova, dove viene eletto Doge
(uno dei pochissimi nel '500; titolo ormai onorifico); lascia il controllo sulle
colonie al figlio Alfonso. Anche Venezia si dimostra attiva sul fronte delle
esplorazioni, non volendo restare indietro: nel contesto delle trattative che
mettono fine alla guerra col Turco, infatti, la Serenissima suggerisce per la
prima volta di costruire un canale a Suez. Il debole Egitto resta comunque
considerato terra neutrale.
1505: i Portoghesi prendono il controllo del commercio con l'Africa orientale,
espellendone gli intermediari arabi. Più tardi, la regina Giovanna ascende al
trono di Castiglia in luogo di sua madre Isabella. Ella regna insieme con
Manuele I del Portogallo.
1508: Amerigo Vespucci è nominato navigatore in capo di Spagna per conto di
Ferdinando II d'Aragona. L'anno precedente, il suo nome è comparso per la prima
volta su una mappa in correlazione con il nuovo continente. Sfondando il limite
simbolo dei 10.000 abitanti, Portoricco (HL: Puerto Rico) diventa la più
popolosa colonia italiana (ed europea) nelle Americhe. Ad abitarla sono perlopiù
schiavi d'Africa; altri sono italiani che scappano dalle guerre che insanguinano
la penisola.
1509: battaglia di Diu, una flotta islamico-veneta tenta di opporsi alle
prevaricazioni portoghesi, che intendono sloggiare i veneziani dall'India.
L'esito è inconcludente: anche se i Portoghesi fanno più vittime grazie alla
superiore qualità delle loro navi, la coalizione conta un maggior numero di
legni e può quindi resistere con moderata efficienza. Per la Serenissima è
comunque un segnale di pericolo: i loro rivali si permettono di attaccare
impunemente gli agenti di commercio veneti all'estero. L'anno seguente,
comunque, i Portoghesi in ritirata occupano Goa.
1511: la Marie-Rose, nave ammiraglia di Enrico V e VIII fortemente desiderata da
quest'ultimo, prende il largo da Caen con a bordo l'intraprendente sovrano. Il
re coltiva grandi sogni di espansione, nel Vecchio e nel Nuovo Mondo. Intanto i
portoghesi sottopongono a brutale saccheggio la città di Malacca.
1512: leggi di Tortona. La corona italiana soppianta definitivamente l'autonomia
genovese nella gestione della condotta dei coloni nelle Americhe.
1514: Selim I sconfigge le forze persiane a Chaldiran. Bloccati dalla
contrapposizione italiana a occidente, i Turchi finiranno per inglobare l'Iran.
1515: primo congresso di Vienna, grande successo per la politica imperiale di
avvicinamento agli Jagelloni perseguita da decenni (Massimiliano I stesso è
sposato a una delle figlie di Casimiro IV, Sofia). Un doppio matrimonio è svolto
per celebrare gli accordi: Luigi, unico figlio di re Ladislao d'Ungheria, sposa
Elisabetta d'Austria, figlia di Rodolfo e nipote di Massimiliano I; il fratello
di Maria, Rodolfo Federico, sposa la figlia di Ladislao, Anna. Anche l'altro
fratello di Rodolfo Federico, Massimiliano, finirà per sposare una Jagellone
(Anna, figlia di Sigismondo I).
1516: dopo aver conquistato l'ultimo beilicco indipendente in Anatolia, il
sultano turco si rivolge all'Egitto, in contravvenzione con i patti stipulati
con Venezia anni e anni prima. Ad Aleppo, i mamelucchi sono sconfitti, però
sull'istmo l'Egitto riesce, con l'aiuto di Venezia, a montare un'adeguata difesa
e a resistere. Come ringraziamento, l'intera penisola del Sinai è ceduta alla
Serenissima, che provvede a fortificarla e costruire il suo canale. Venezia ha
trovato finalmente la sua tanto sospirata finestra sull'India.
1517: Lutero appende le sue 95 tesi alla porta della chiesa del castello di
Wittenberg, in Germania. Egli recrimina alla struttura ecclesiastica la diffusa
corruzione, la simonia e il nepotismo, ma adduce anche motivazioni teologiche.
La morte di Ferdinando II conduce finalmente all'unificazione della Spagna nelle
mani di Giovanna e Manuele.
1518: Federico il Saggio rifiuta di consegnare Lutero ai messi papali,
proteggendo il monaco. L'ultimo degli Abbasidi consegna il titolo di Califfo al
sultano ottomano.
1519: Ulrico Zwingli predica a Zurigo. Pier Terrayl, signore di Bayard (più
facilmente ricordato come chevalier Bayard), conquista l'impero azteco e lo
governa col titolo di duc de Mexique per conto di Enrico V e VIII. Inaugurata
l'epopea degli chevaliers (conquistatori) nelle Americhe. Gli Italiani fondano
Panama, concentrandosi sul possesso dello Stretto, e occupano le Isole Barbare
(HL: Barbados). Rodolfo II è eletto imperatore contro la candidatura del re
franglese grazie al supporto delle banche italiane.
1520: papa Leone X scomunica Lutero. Questi, per tutta risposta, afferma di non
accettare l'allontanamento del "cappellano del re di Napoli", e brucia la bolla
pontificia in pubblica piazza, dinnanzi a una folla di astanti. Cristiano II di
Danimarca, sposato con la figlia di Rodolfo II Cunegonda, sottomette la Svezia,
di cui inizia la lunga resistenza.
1521: Lutero compare di fronte alla dieta imperiale di Worms e rifiuta di
abiurare. In reazione, Rodolfo II fa passare l'editto di Worms, dichiarando
Lutero un bandito e un nemico pubblico e rendendo illegale possedere suoi
scritti. Il monaco deve fuggire rocambolescamente dalla Germania meridionale.
Suo nuovo centro di attività diventa Lubecca, in rotta con l'imperatore per la
preferenza da questo accordata alla Polonia. Nel contesto della contrapposizione
tra veneziani e Spagnoli per il commercio delle spezie, questi ultimi mettono a
segno un colpo da maestro quando Magellano, circumnavigando il mondo, scopre le
isole Giovannine (HL: Filippine) dal nome dell'erede al trono.
1522: da Panama, i primi navigatori italiani si addentrano nel Pacifico sulle
scie di Magellano. Nel 1534, su modello veneziano, la real coppia darà ordine di
tagliare l'istmo, in modo da poter competere per il commercio con l'Oriente.
1523: Lubecca e la Lega Anseatica si uniscono alla Svezia nella lotta contro la
Danimarca. Cristiano II è costretto ad abdicare in favore dello zio Federico,
che si converte al protestantesimo su modello anseatico. Per reazione, la nuova
Svezia indipendente diventa ostinatamente cattolica.
1524: massiccia sollevazione dei contadini tedeschi, infiammati dalla
predicazione protestante. L'anno successivo, nasce ufficialmente il movimento
anabattista, che si espande nella regione del Münster (Germania
nord-occidentale). Giovanni da Verrazzano, al servizio di re Carlo III di
Lotaringia, esplora la baia di New York.
1525: Lutero tiene la prima messa in tedesco. La sua traduzione del Nuovo
Testamento intanto si espande in ogni dove.
1526: battaglia di Mohács, gli ottomani sconfiggono e uccidono re Luigi II
d'Ungheria. La conquista comunque non è integrale, perché Rodolfo Federico,
figlio ed erede dell'imperatore, estende il suo potere su Buda, subentrando come
sovrano del Paese iure uxorio.

1529: seconda dieta di Worms. Alcuni
nobili tedeschi iniziano a disobbedire agli ordini di Rodolfo II, agitando come
pretesto la nuova fede protestante. Nel frattempo, il sovrano, tutto
affaccendato in altre questioni (nello stesso anno, i Turchi assediano per la
prima volta Buda) non può intervenire.
1530: la Confessione di Augsburg, testo fondante del movimento dissidente, viene
presentata a Rodolfo II nella dieta omonima, sollevando critiche e dissapori.
1531: formazione della Lega di Smalcalda per la difesa della religione luterana.
S. Cecilia (Chichen Itzà) è proclamata capitale della colonia di Enotria (Yucàtan)
dagli eredi di Colombo.
1532: compromesso di Norimberga per la pace religiosa. Rodolfo II concede la
libertà di predicare contro la rinnovata fedeltà dei suoi feudatari. Alfonso III,
insieme con il suo ammiraglio Andrea Doria, guida una spedizione contro i pirati
barbareschi che infestano il Mediterraneo e occupa Tunisi e Algeri, poi girate
all'ordine dei Cavalieri Ospitalieri, i quali erano stati scacciati da Rodi
dall'impeto dell'avanzata turca. Lo chevalier Cartier, in competizione con i
Bayard, conquista il Texas e si spinge nelle sue scorribande sino all'estuario
dell'Esprit-Saint (HL: Mississipi).
1533: a seguito della pretesa di vedere il proprio matrimonio con Anne de
Bolenne (dopo Maria Margherita di Lotaringia e Isabella d'Angiò, sua terza
moglie) annullato per l'incapacità di questa di dargli figli maschi, Enrico V e
VIII è scomunicato da papa Clemente VII. Trattato fra i Turchi e gli Asburgo: a
Rodolfo II vanno Croazia e Ungheria propria, la Transilvania è governata dal
voivoda Giovanni Szapolyai sotto patrocinio del sultano.
1534: Atto di Supremazia: Enrico V e VIII si dichiara unico capo delle Chiese di
Francia e Inghilterra. Subito scatta la persecuzione ai danni dei cattolici.
L'imperatore Rodolfo II interviene in Danimarca, scacciandone l'erede del re
Federico (accusato di aver scatenato il malcontento con la sua conversione) e
ripristinandovi Cristiano II, che ha solo figlie femmine. Si progetta di
annettere il regno alla sua morte.
1536: Enrico V e VIII permette la traduzione della Bibbia in francese (e non in
inglese) La Lotaringia accoglie il protestantesimo. Cartier fonda una colonia
Tudor alla foce dell'Esprissaint (>Esprit-Saint). Il ribaltamento delle alleanze
tra Svezia e Impero conduce alla cacciata di Cristiano II dalla penisola dello
Jutland. Cristiano III, figlio di Federico, è re, ma tradisce la promesse fatte
agli svedesi reintroducendo il luteranesimo. Nel quadro delle guerre contro gli
Asburgo, Enrico V e VIII stipula un'alleanza con il Turco che non sortisce alcun
effetto pratico, ma ha ampio scalpore (empia alleanza).
1538: Solimano il Magnifico scaccia gli italiani dall'Africa; solo i Cavalieri
Ospitalieri restano strenuamente sul posto. Però il sultano deve cedere
ulteriore terreno in Ungheria alla controffensiva asburgica. Il voivoda di
Transilvania accetta di lasciare le sue terre a Rodolfo II con la sua morte.
1539: le città di Brema e Lubecca si convertono ufficialmente al luteranesimo.
Per reazione, l'imperatore li priva dei loro privilegi commerciali. Enrico V e
VIII annette Cuba.
1540: l'istituzione della Compagnia di Gesù (i gesuiti) è confermata da papa
Alessandro VII (Alessandro de' Medici, HL: primo duca di Firenze), pronipote di
Lorenzo il Magnifico e ultimo del ramo di Cafaggiolo. Siracusa è saccheggiata
dai corsari barbareschi.
1541: il concilio di Bruges, indetto dal papa con il supporto dell'imperatore e
del re di Lotaringia Carlo III, tenta una mediazione fra cattolici e
protestanti, ma fallisce. Verona intanto, da sempre riottosa alla Serenissima,
diventa protagonista di una primavera religiosa: il teologo Lelio Sozzini
proclama la sua "città di Dio". Navigatori veneziani intanto stabiliscono un
contatto diretto con le isole delle Spezie.
1542: passando per il nuovo canale di San Marco, i veneziani stabiliscono una
presenza in Eritrea in aiuto del regno cristiano d'Etiopia. I musulmani che
periodicamente assediavano l'acrocoro sono ributtati indietro. Intanto Padova
apre le porte ai sociniani.
1543: prima persecuzione bandita da Cesare I Renato contro i protestanti,
benedetta anche dai genitori. Nella repressione subiscono ingiurie anche i
valdesi. Venezia, impegnata su larga scala oltremare, rinuncia a tentare un
assedio di Padova. Incapacitata ad agire contro il socinianesimo che si espande
a macchia d'olio, la Serenissima tollera la predicazione della nuova fede nei
suoi territori.
1544: su spinta di Cristiano III di Danimarca, la Norvegia dichiara il
luteranesimo religione di Stato. Apice della contrapposizione fra blocco
italo-imperiale e anglo-francese: Savoia, Turchi e Tudor attaccano
simultaneamente l'impero approfittando della morte di Rodolfo II, ma suo figlio
Rodolfo Federico fa leva sull'alleanza del re d'Italia, che contrattacca
invadendo la Francia orientale. Alla pace di Crépy, resa possibile grazie
all'atteggiamento accomodante del nuovo imperatore, Enrico V e VIII, preoccupato
dal problema della successione (egli ha solo un erede maschio, il malaticcio
Edoardo II e VI) accetta di chiamarsi fuori dal conflitto. Invece, la guerra tra
Cesare I Renato e Carlo III continuerà fino alla morte di quest'ultimo, dato che
il Savoia non accetta di perdere le terre ancestrali della sua famiglia in
Piemonte. Esploratori veneziani si insediano a Formosa (Taiwan).
1545: concilio di Trento, nasce il catechesimo ufficiale della Chiesa come
strumento di contrapposizione al dilagare dell'eresia. Gli italiani affondano la
sparuta flotta sabauda, giunta nel Mediterraneo con rinforzi dalle Fiandre.
Cesare I Renato afferma il predominio della penisola sul mare.
1546: il conte palatino si fa protestante. Come parziale compensazione, viene
finalmente firmata tra Loraringia e Italia, basata sul principio dell'uti
possidetis. Carlo III, indebolito dal conflitto, deve consentire alla diffusione
del calvinismo nelle sue terre.
1547: la Lega di Smalcalda è sbaragliata dall'imperatore. Il conte palatino è
catturato e costretto all'esilio. Con il favore del nuovo re Edoardo II e VI,
fervente protestante, gli ugonotti (calvinisti francesi) si espandono dalla
Lotaringia alla duplice monarchia, radicandosi soprattutto nel nord
dell'Inghilterra, in Aquitania e in Normandia (centri protagonisti del nuovo
commercio con le Americhe).
1548: Primo utilizzo documentato delle armi da fuoco in Giappone
(presumibilmente importate dai veneziani, che da Formosa controllano tutto il
traffico della regione). L'anno seguente, anche se lo scambio non regolato
avveniva da tempo, il bailo veneto di Formosa inizia a inviare regolari missioni
commerciali alla corte dell'imperatore Ming.
1550: Fausto Sozzini, nipote di Lelio, scrive il Consensus Tigrinus nel
tentativo di unificare il suo dogma con quello dello zio. Rodolfo Federico
elimina la pena di morte per tutti gli eretici all'interno dell'impero. Altan
Khan, signore dei mongoli, oltrepassa la Grande Muraglia e brucia le periferie
di Pechino, segnando il declino della dinastia Ming.
1551: i Cavalieri Ospitalieri evacuano Tunisi, ritornata sotto potestà ottomana.
I Turchi saccheggiano impunemente Malta e le altre isole del canale di Sicilia.
Grandi carestie in Henan (Cina).
1552: ultima guerra scatenata da Carlo III di Savoia contro l'imperatore, che
per mezzo dell'abile figlio Emanuele Filippo ottiene uno strabiliante successo.
In Lorena, Rodolfo Federico è quasi fatto prigioniero, impedendo ulteriori
sviluppi della Controriforma in Germania; la valle del Reno si conferma cuore
pulsante dei riformati, contribuendo ad accentuare la spaccatura con l'Europa
orientale.
1553: la morte di Edoardo II e VI di Francia e Inghilterra segna il punto di non
ritorno nella contrapposizione fra diverse fedi nella duplice monarchia.
Battaglia di Sievershausen: Emanuele Filippo, in alleanza con le forze
protestanti, sconfigge definitivamente l'esercito cattolico della Lega di
Norimberga, ma deve arrestare la sua avanzata perché suo padre Carlo muore di lì
a poco, aizzaando gli animi dei riottosi fiamminghi. Da questa posizione
Emanuele Filippo, convertitosi al calvinismo onde venire incontro alle pretese
di buona parte dei suoi suddit, accetta di scendere a trattative, ma chiede in
cambio una patente imperiale per la libertà di culto nel suo regno.
1554: inizio delle guerre di religione tra calvinisti, cattolici e gallicani
nella duplice monarchia.
1555: pace di Augsburg, che garantisce ai luterani eguali diritti all'interno
dell'impero. L'anno dopo, Rodolfo Federico abdica e si reca in esilio in un
monastero sulle montagne della Slovacchia. Gli succederà il figlio Federico IV,
che governa su un impero diviso.
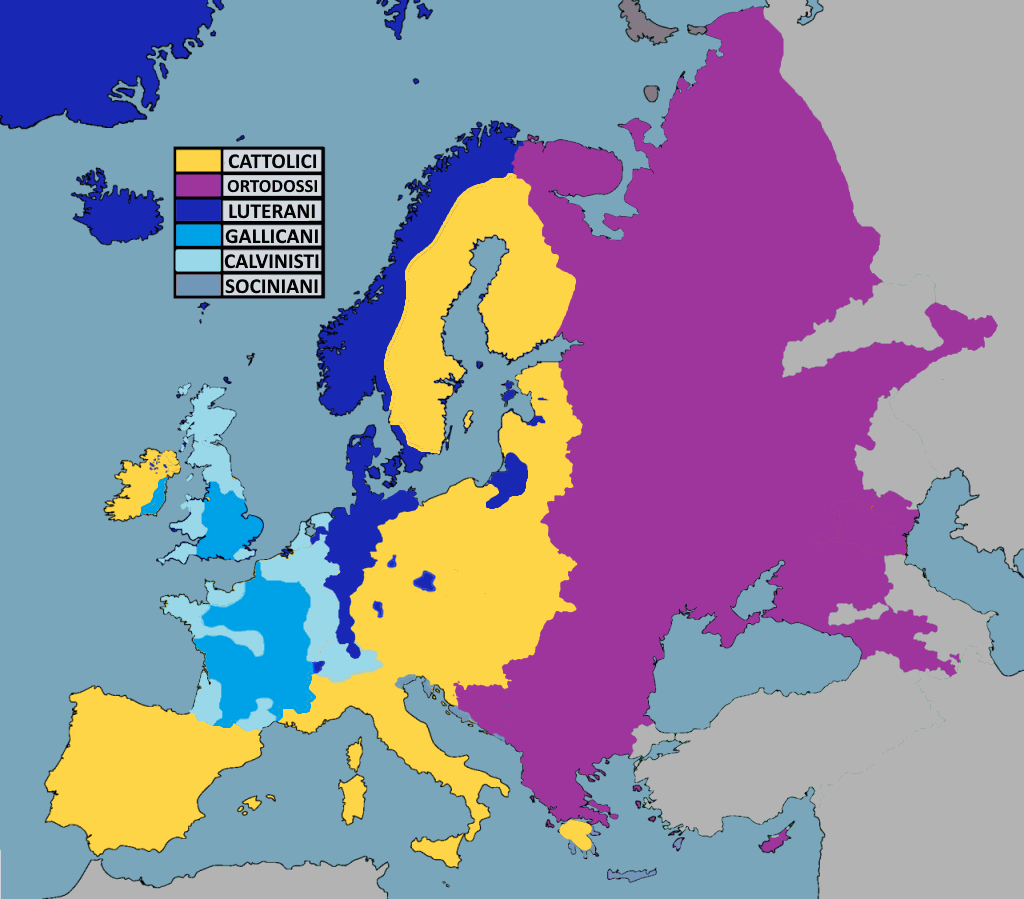
.
La politica religiosa di Enrico V e VII, il regno di Edoardo II e VI (1547-1553) e l'inizio delle guerre di religione (1553-1589)
Enrico V e VIII di Francia e Inghilterra
morì nel 1547, lasciando un'eredità controversa. Se da un lato, infatti, il suo
governo aveva segnato l'inizio dell'espansione Tudor oltremare, con la conquista
dell'impero azteco che aveva portato ai due regni enorme ricchezza, dall'altro
la sua epoca era stata una di guerra su vasta scala, combattuta dilapidando il
patrimonio accumulato dal padre per una ricompensa davvero misera. Nell'ordine,
Enrico V e VIII aveva coltivato l'ambizione di: farsi promotore di una nuova
crociata, conquistare l'Italia, soggiogare la Lotaringia supportando l'ascesa
sabauda e infine farsi eleggere sacro romano imperatore. In tutti questi
obiettivi il re fallì, anche se molto spesso perse di poco (per esempio,
l'elezione di Rodolfo II vide una maggioranza di 4 voti a 3; la concreta
possibilità di un impero Tudor esteso a tutta Europa resta il sogno di molti
ucronisti franglesi). Alla fine del suo regno, Enrico V e VIII era un uomo
rotto, distrutto nelle sue speranze di potere e sogni di gloria, preoccupato
soprattutto dal problema della successione.
La prima e ostinatissima moglie di Enrico V e VIII era stata Maria di Lotaringia,
figlia di Maria di Borgogna e Giorgio di Normandia, ereditata (come il diritto
di successione) dal defunto fratello Arturo, delfino di Galles. Alle prime, il
rapporto fra i due poteva dirsi quantomeno cordiale, se non proprio rispettoso:
Maria non era certo innamorata dell'ambizioso Enrico come lo era stata del
cavalleresco Arturo, ma capiva le necessità per il fratello Filippo IV di
Lotaringia di combinare questa unione, e così acconsentì al matrimonio. Le cose
iniziarono a cambiare quando, dopo dieci anni di unione, Maria si dimostrò
incapace di generare figli che raggiungessero l'età adulta. L'unica era stata
Maria, poi detta la Cattolica, ma per regnare sulla duplice monarchia serviva un
erede forte, ruolo che una donna certamente non poteva ricoprire. Enrico V e
VIII iniziò così a concepire l'ardito progetto di ripudiare la moglie e cercare
nuovo partito, che egli individuò in Isabella d'Angiò, regina e duchessa madre
di Napoli e Milano. Dopotutto, il re di Francia vantava antiche pretese
sull'Italia, che datavano indietro fino a Carlo Magno; e allo stesso tempo, papa
Giulio II, tenace oppositore degli angioini, si dimostrava possibilista a questo
riguardo, non volendo pregiudicare l'alleanza con la duplice monarchia.
Come sappiamo, la discesa in Italia, inizialmente incontrastata, non si
dimostrò, sul lungo periodo, favorevole per il re di Francia e Inghilterra. Gli
angioini, nelle persone di Bona Sforza e Alfonso III d'Aragona dimostrarono di
avere sette vite, alternando la temporanea ritirata nelle loro roccaforti
meridionali con l'alleanza con l'impero, che non desiderava certo confinare con
la monarchia Tudor su tre lati. Il clima per una possibile unione peggiorò
ulteriormente quando, in barba al diritto ecclesiastico, Enrico V e VIII prese
in ostaggio Isabella a conclusione di uno dei ripetuti assedi di Milano,
portandosela prigioniera in Francia. Inizialmente, papa Leone X, alleato degli
angioini, argomentò (e come dargli torto?) che il rapimento poteva difficilmente
definirsi legittimo presupposto per un matrimonio, tanto più che Maria di
Lotaringia era ancora viva e vegeta. Però, con la guerra contro la duplice
monarchia che peggiorava, il Medici fu costretto a riconsiderare le sue
posizioni. Leone X accettò il matrimonio con Isabella come valido e consentì sì
alla dissoluzione dell'unione con Maria di Lotaringia (il matrimonio venne anzi
considerato non consumato), al solo scopo di assecondare i progetti di Filippo
IV, che da sua moglie Caterina d'Aragona aveva avuto una sola figlia, Maria, poi
andata in moglie a Emanuele Filippo. Logicamente, Enrico V e VIII morse il
freno, ma conservò la speranza di ottenere la dissoluzione della nuova unione,
che ormai aveva perso del tutto il suo scopo politico, dal nuovo papa Clemente
VII, promotore di una politica di autonomia della Santa Sede rispetto agli
angioini. Il tentativo, come sappiamo, fu vano: Clemente VII era sì nemico del
predominio della real coppia in Italia (condotta che determinò il truce sacco di
Roma), ma anche un fautore della superiorità assoluta del pontefice in campo
temporale, risultando, insomma, fuori tempo massimo. L'astio fra Parigi e Roma
raggiunse livelli così elevati, come non lo erano stati dallo schiaffo di Anagni,
tre secoli prima. Però nel 1525, dopo quasi tredici anni di infelice unione,
Isabella d'Angiò, che non era nemmeno più alla corte del re, finalmente morì,
liberando il campo perché Enrico V e VIII si trovasse una nuova sposa.
Questa fu individuata dal re nella persona di Anne de Bolenne, giovane esponente
della noblesse inglese appena francesizzata. Il matrimonio, durato appena sei
anni, finì di botto quando il re si rese conto che nemmeno l'inglese riusciva a
dargli il tanto sospirato erede maschio, avendo partorito una sola femmina,
Elisabetta. Fu allora che le pretese di ottenere l'annullamento del matrimonio
divennero ancora più insistenti: la Bolenne infatti, era giovane e sana, e non
c'era ragionevole speranza ch'ella sarebbe morta di lì a poco. Papa Alessandro
VII, però, tutto preso nella sua opera di rilancio della Chiesa universale, non
se la sentì di concedere un tale sgambetto alla dottrina cristiana. La risposta
Tudor fu tanto eclatante quanto tremenda: con l'Atto di Supremazia, il re staccò
forzosamente Francia e Inghilterra dal resto della comunità ecumenica, poi, in
virtù del nuovo titolo di capo della confessione gallicana, si concesse
l'annullamento desiderato. La Bolenne venne imprigionata, processata e
decapitata per tradimento e cospirazione contro il sovrano (crimini infondati).
Il re era ora libero di sposare chi avesse preferito. Ben due mogli spagnole, le
sorelle Isabella e Beatrice, al ritmo di una all'anno (e pensare che erano
figlie del re di Spagna, Manuele I!), si succedettero nell'arduo compito di
fornirgli prole, tutte fallendo miseramente (e patendo una brutta fine; c'è chi
sostiene che per le le loro fortuite morti non si trattò di coincidenze). Il re
era disperato.
Fu a tal punto che si fece avanti Francesco, capo della potente casata dei
Valois, il cui predominio era recentemente passato per estinzione del ramo
principale ai cadetti d'Orléans. Egli aveva sposato Maria d'Aragona, figlia di
Ferdinando II il Cattolico, determinando il ritorno della casata, dopo uno iato
di quasi secoli, all'interno dei grandi giochi internazionali. Suo zio, Luigi,
era stato un valido comandante e gradito aiuto al sovrano durante le guerre
d'Italia, e opportunamente ricompensato con la mano di Anna di Bretagna, ultima
erede del ducato. Alla sua morte, le sue figlie erano rimaste nubili e senza
tutore. Enrico V e VIII decise di fare un tentativo, e scelse la più giovane,
Renata (Reneé), convinto com'era che avesse la maggior probabilità di portare al
concepimento di prole sana. E in effetti, così fu: salutato con immensa gioia e
tripudio, nel 1537 nacque finalmente Edoardo III e VI, subito insignito del
titolo di delfino di Galles. Ancora una volta, il clan Valois venne ricompensato
grandemente: Francesco d'Orléans e suo figlio Enrico salirono agli onori più
alti della corte, e iniziarono a prendere attivamente parte ai consigli di
governo, insieme con la regina Renata. Questa era, con ogni probabilità, l'unica
donna che Enrico avesse mai amato.
Enrico V e VIII morì vecchio nel 1547; Francesco d'Orlèans lo avrebbe seguito di
lì a poco. Come previsto, il piccolo Edoardo III e VI gli successe come sovrano,
venendo incoronato, nell'ordine, re di Francia e Inghilterra. Egli era un
bambino giovane e cagionevole, cresciuto all'insegna della religione gallicana
che il padre aveva voluto creare per suo fine. Con l'Atto di Uniformità del
1549, per esempio, il pio re dodicenne dichiarò per la prima volta un'unica
liturgia della messa per la sua nuova Chiesa, che andava assumendo tratti sempre
più filo-protestanti. Sotto la sua guida, Enrico d'Orléans si sentì infine
abbastanza forte da gettare la maschera, e dichiararsi apertamente calvinista,
venendo ricompensato con il titolo di Lord Protettore (di Francia e
d'Inghilterra). La regina madre Renata, formalmente unica reggente e che molti
accusavano di cripto-cattolicesimo, vedeva tutto questo fervore con ansia e
sospetto, temendo che il procugino volesse soffiargli il potere sul figlio, e
con esso, sul regno. Con l'Orléans che fa firmare condanne a morte e sentenze di
carcere a vita per tutti gli oppositori del nuovo regime, inasprendo la
persecuzione contro i cattolici, la contrapposizione fra i due Valois si fa
sempre più pesante. Il 10 marzo 1550, la congiura di un gruppo di cavalieri
cattolici reduci delle guerre continentali guidata dal principe di Jean du Barry,
amante della regina, e tesa a rapire il giovane re viene scoperta. La
repressione è feroce: centinaia di persone, ritenute "inescusabilmente
consapevoli" (notare la formulazione!) del complotto, sono messe a morte dal
duca d'Orléans. Intanto, incoraggiati dal potere, fra gli estremisti protestanti
si iniziano a diffondere i primi episodi di iconoclastia, che continuano
indisturbati per quasi due anni. In tutti e due i regni, per ben tre anni, in
più di quaranta grandi chiese sono distrutte od oltraggiate statue e immagini
sacre, provocando la reazione della folla, che cerca di catturare e linciare i
responsabili. Mentre la prima seduta bilaterale del Parlamento inglese e degli
Stati Generali di Francia convocata dal sovrano si dimostra inutile
nell'arrestare la spirale di violenza, il fondamentalismo religioso, propagato
anche dalla stampa, diventa un avvistamento comune fra i due regni.
Per la porzione di Paese che era rimasta (segretamente o meno) cattolica, era
chiaro che questo stato di cose non poteva continuare. La situazione, se
possibile, diventava ancora più intollerabile considerando come Edoardo III e
VI, pur circondato dalle migliori cure sia di Enrico, che di Renata, era
soggetto a frequenti malattie. Il 6 luglio 1553, dopo solo sei anni di
disastroso regno, Edoardo III e VI morì, lasciando vuoto il trono che suo padre
aveva lavorato tanto per assicurare a un erede maschio. Nel suo testamento, il
devoto re indicava come successore la nobildonna inglese Jeanne Seymoure,
bisnipote di Enrico IV e VII, scavalcando le sue due sorelle Maria ed
Elisabetta. La ragione ufficiale, addotta nel documento, era lo sfrenato zelo
protestante di questa (comunque presente); quella reale è da attribuirsi alle
manovre di Enrico d'Orléans, che già frequentava la donna da tempo. Nella
mattinata del 10 luglio 1553 Jeanne assumeva il trono; il giorno seguente, la
regina convolava a nozze con Enrico, il quale prese il nome di Enrico VI e IX di
Francia e Inghilterra. Frattanto, era Renata a fuggire dalla corte, dichiarando
di conoscere il vero contenuto del testamento di Edoardo III e VI, il quale
faceva della tanto cara madre la sua erede. Anche Maria la Cattolica, col marito
Luigi di Beja, fratello del re di Spagna Giovanni III, si proclamò a sua volta
regina, supportata in ciò dal Parlamento inglese. Fra tutti i contendenti, solo
Elisabetta non si muoveva.
La guerra civile che si andava delineando aveva perciò tre parti: da un lato i
cattolici di Maria Tudor, che governavano sull'Inghilterra; dall'altro i
calvinisti ugonotti, che regnavano da Parigi: titolari della posizione
giuridicamente più debole, ma anche della più popolare nei due regni erano
invece i gallicani, guidati dalla convenzione di interessi di Renata con
Francesco, duca di Guisa (cattolico), e che avevano la loro roccaforte nella
Francia centro-meridionale. Questi in particolare si rendono protagonisti delle
politiche più efficaci, rimuovendo le peggiori misure prese in sfavore del
cattolicesimo, ma senza arrivare a un clima di piena tolleranza. L'editto di
Caudéran (quartiere di Bordeaux), del resto, conferma il diritto ai protestanti
(ugonotti compresi) di praticare messa pubblicamente fuori dalle città, e di
pregare privatamente all'interno delle loro case. Però Maria la Cattolica, che
si considera la legittima regina, dimostra di non accettare nessun compromesso.
Fra il 1553 e il 1557 si combatte la prima guerra di religione, che vede i suoi
inglesi sbarcare in Normandia come più di cent'anni prima e mettere a sacco la
zona. Enrico VI e IX, consapevole della sua inferiorità numerica (i calvinisti
sono solo tre milioni tra Inghilterra e Francia), rifiuta lo scontro diretto.
Due assedi di Parigi sono tentati e respinti, mentre Jeanne Seymour muore di
parto, avendo messo al mondo la bellezza di dieci figli Orléans, tre dei quali
saliranno al trono. In ogni caso, Enrico VI e IX non può concedersi tempo per il
lutto, perché nel frattempo Renata e Francesco di Guisa conquistano posizione
dopo posizione. Fra il 1558 e il 1559 due eventi cambiano la sorte del
conflitto, finora inconcludente: dapprima muore Maria, senza aver dato figli al
principe di Spagna; con lei si chiude l'intervento degli Spagnoli nella guerra
civiile, già malvisto da Giovanni III di Spagna. Nel frattempo anche Enrico VI e
IX muore: nel testamento nomina come tutrice dei suoi figli Renata d'Orléans.
.
La reggenza di Renata d'Orléans (1559-1563), i regni di Francesco I e I (1559-1560), Carlo I e IX (1560-1574)
Il Parlamento inglese agisce immediatamente, e proclama erede al trono la
protestante Elisabetta, la quale per il momento tenta il famoso gioco della
sposa, prospettando alla reggente Renata d'Orléans di sposare il piccolo
Francesco I e I, figlio di Enrico VI e IX, ma senza procedere con l'operazione,
in maniera tale da salvaguardare l'indipendenza dell'Inghilterra. Di lì a poco,
però, ci si mettono i Guisa di mezzo, la cui influenza è tale da necessitare di
un bilanciamento; così, sotto gli auspici dei cattolici, il secondo nella linea
al trono, il delfino Carlo, viene fidanzato a Maria di Scozia, già promessa
sposa di Edoardo II e VI, per allora sotto la reggenza di Maria di Guisa.
Ciononostante, Renata d'Orléans iniziò il suo periodo al governo sotto i
migliori auspici di riconciliazione; politica della quale fu esempio luminoso
l'estensione dell'editto di Caudéran a tutto il territorio dei due regni. La
regina madre convocò anche una seconda seduta plenaria del Parlamento e degli
Stati Generali, nel tentativo di instaurare un dialogo fra le parte protestante
e quella più strettamente gallicana del Paese. Il tentativo fallì, perché il
Parlamento inglese si considerava ormai un organismo autonomo dal potere regio e
rappresentativo delle istanze della sola isola nebbiosa; però il biennio di
Francesco I e I sarebbe ugualmente stato ricordato come un felice periodo di
intermezzo tra due sanguinose guerre.
Il compromesso, comunque è fragile. Questo perché Francesco, duca di Guisa, si
era ormai reso conto che, contrariamente alle sue aspettative, la vittoria di
Renata non significava affatto un ritorno in auge del cattolicesimo, anzi.
Sebbene le misure più restrittive dei tempi di Enrico d'Orléans fossero state
abolite, i cattolici restevano sudditi di serie B in Francia e Inghilterra,
tanto da far patire una serie di importanti limitazioni politiche proprio a
quella fazione dei duchi di Guisa che aveva consentito a Renata di vincere la
guerra in partenza. Fu così che, approfittando del nuovo dominato di Carlo IX e
I, da cui chiese e ottenne la nomina a Lord Protettore del regno, il duca di
Guisa iniziò a soffiare sul fuoco delle faide religiose. Nel 1562, sfidando
apertamente l'editto di tolleranza promulgato dalla regina, i Guisa si gettarono
su di una folla calvinista che stava innocentemente predicando la messa,
menandone strage. Si tratta del tristemente famoso massacro di Vassy. Il
precario equilibrio si infrange nel momento in cui il cagionevole Francesco I e
I muore (1560), lasciando la strada aperta per il giovane e irruento Carlo IX e
I. Qui si prospetta per qualche tempo che la reggente Renata ribalti gli accordi
matrimoniali presi in precedenza, in modo tale da salvaguardare la presa della
monarchia sull'Inghilterra; però l'influenza della fazione cattolica sulla corte
è talmente forte che Renata si trova con le mani legate. Capendo che la corte è
in mano ai Guisa, e il matrimonio di Carlo e Maria rischia di pregiudicare la
sicurezza stessa dell'Inghilterra, a maggioranza protestante, il Parlamento
inglese reagisce alla morte di Francesco I e I dichiarando Elisabetta una volta
per tutte unica regina: è la secessione, agita in nome del popolo e della
Nazione (prima volta che questi lemmi entrano nel discorso politico in questo
connotato) per mezzo del proclama di Westminister. Come prima cosa, gli Inglesi
invadono la Scozia con il supporto del partito protestante e mettono a morte
Giacomo Hamilton, reggente precedente a Maria di Guisa ed apostata del
calvinismo (era stato lui stesso leader della fazione filo-inglese, prima di
convertirsi al cattolicesimo dietro la ricompensa di un ducato che aveva
costituito la dote della giovane). Il Parlamento inglese assume il potere sulla
Scozia, decretando l'imprigionamento di Maria nel castello di Edinburgo; così si
forma una Chiesa nazionale scozzese su impronta calvinista. Elisabetta I sposa
Giacomo Stuart, figlio illegittimo di Giacomo V di Scozia e fratellastro di
Maria di Scozia, nonché nuovo capo dei calvinisti: insieme avranno una sola
figlia, anch'essa Elisabetta, erede protestante ad ambo i troni.
Maria degli Scoti si salva soltanto perché il Parlamento non osa toglierla di
mezzo, temendo che un suo omicidio possa fungere da miccia per la rivolta degli
Scozzesi. Per manifestare il suo dissenso contro l'occupazione del suo Paese (ma
in realtà, si dice, in spregio al lusso dimostrato da Elisabetta I) Maria inizia
a vestirsi di una tonaca candida che ricorda quella monacale, venendo
soprannominata la Regina Bianca (nelle parole dei suoi nemici, Elisabetta I
Tudor è, ovviamente, la Regina Rossa). Nel giro di tre anni, le sue guardie di
palazzo sventano ben tredici tentativi di assassinio, con ogni probabilità
mandati da Elisabetta. Però la sua prigionia significa che la fanciulla, regina
di diritto, non può consumare il matrimonio siglato con Carlo IX e I. In
effetti, anche se gli ugonotti si stavano già riorganizzando da anni sotto la
leadership di Luigi, principe di Condé, la guerra diede pretesto alla fazione
calvinista per controbattere, oltre che il nutrito supporto finanziario
dell'Inghilterra. Un gruppo di nobili capeggiati dalla casa di Borbone dichiarò
come il loro intento fosse quello di liberare il giovane re dai cattivi
consiglieri, e a questo scopo fece divampare una grossa ribellione, che acquistò
lo stesso anno il controllo di Orléans. Il loro esempio fu seguito da diversi
gruppi di protestanti estremisti all'interno dei due regni, che presero il
controllo di Neucastle, York, Angers e Tours. In poco tempo, si era formato un
nocciolo duro di resistenza calvinista attorno alla valle della Loira. Era
proprio quello che Guisa desiderava: di fronte al rapido deterioramento della
situazione interna, la corona fu costretta a ritirare l'editto di Caudéran,
facendo il gioco dei cattolici. Il Lord Protettore dei regni venne inviato a
incontrare in battaglia i ribelli, ottenendo una serie di vittorie schiaccianti.
Però negli scontri militari si verificò un decesso eccellente: per un colpo di
pistola, il Guisa in persona trovò la morte (al tempo si vociferò di un
tentativo di assassinio). L'assenza del carismatico Lord Protettore consentì
alla corona di mediare momentaneamente la pace fra le due fazioni avverse, con
la regina che ripristinava le condizioni previgenti, solo leggermente modificate
a favore dei cattolici (editto di Amboise).
Era comunque una pace armata. Renata tentò di unire le anime opposte del Paese
nello sforzo di rioccupare Calais, che era stata ripresa dagli Inglesi nel caos
dovuto alla guerra civile, ma molti nobili si rifiutarono di reclutare
reggimenti sui propri territori, facendo risultare il tutto in una bruciante
sconfitta. Nel 1563, finalmente, il re Carlo IX e I esce dalla reggenza: egli
può condurre una politica pressoché autonoma, perché, come già detto, il duca di
Guisa è morto negli scontri che vedevano quest'ultimo opposto al principe di
Condé. Sua priorità è ovviamente liberare la promessa sposa: al comando di un
grosso esercito, Carlo IX e I sbarca in Inghilterra (notare l'inversione di
ruolo rispetto alla guerra dei cent'anni!), dove viene incontrato in battaglia
da Giacomo Stuart, che rimedia una sonora sconfitta. Carlo IX e I cattura
numerose importanti città, tra cui Londres, però egli trova un Paese composto da
contadini ostili che lo accusano di essere un fiancheggiatore del Papa e vanno a
ingrossare le fila della guerra partigiana mossagli da Elisabetta. Il conflitto
infuria per anni, senza ottenere grossi risultati, dato che gli Inglesi sbarrano
al re la via per la Scozia, e per giunta la monarchia è continuamente funestata
dalle rivolte che si accendono un po' dappertutto in Francia, animate dagli
ugonotti. Temendo che la guerra contro l'Inghilterra costituisse una prova di
forza dei gallicani, molte città si dichiararono in favore dei protestanti,
espellendone le guarnigione regie. Poco aiutava la terribile figura di Enrico,
fratello del re, che, da cattolico, si era fatto fama di sanguinario persecutore
degli eretici. In maniera piuttosto ammirevole, il re tentò di venire incontro a
queste ribellioni, dimostrando che aveva intenzione di governare alle stesse
condizioni dell'editto di Amboise. Tuttavia, la tregua fu solo temporanea,
perché sul finire del 1568 emerse nuovamente la figura del principe di Condé, il
quale ammassò un notevole esercito, attingendo proficuamente ai finanziamenti
messi a sua disposizione dall'Inghilterra (terza guerra di religione). Anche
questa volta, comunque, gli andò male: incontrato in battaglia da Enrico, Condé
perse la vita. Con lui gli ugonotti perdevano il loro più importante
condottiero; la guida della fazione passò allora a Enrico di Borbone, familiare
del Condé nonché (in iure) re di Navarra. Ancora una volta, la guerra in Francia
si concluse con un nulla di fatto, che stabiliva una tregua tra ugonotti e
gallicani.
Nel 1570 la situazione per gli Inglesi, che hanno speso un ingente ammontare di
risorse nella speranza di portare la guerra in Francia tramite il principe di
Condé, è deteriorata a tal punto da richiedere sforzi disperati. Con il tacito
supporto del Parlamento che spera così di concludere le ragioni stesse del
conflitto, i lord protestanti di Scozia prendono d'assalto il castello di
Edinburgo, rapendo Maria, che viene molto probabilmente violentata e uccisa. Al
contrario delle speranze inglesi, questo esacerba ulteriormente il conflitto,
perché la Sorbona, vicina agli ambienti cattolici, proclama questo evento un
regicidio, criminale sotto la legge di Dio e degli uomini, e per questa ragione
i sudditi inglesi svincolati da ogni dovere di obbedienza a Elisabetta. A
seguire è il turno di Giacomo Stuart, che viene ucciso da una freccia vagante
durante l'assedio di York, e con lui si spegne ogni resistenza inglese:
Elisabetta e sua figlia omonima fuggono con gli ultimi fedeli a Dublino, dove
l'ex regina morirà presto di dolore. È il 24 gennaio 1573, un mese dopo Natale,
quasi dieci anni dopo lo sbarco di Carlo IX e I in Inghilterra: si è conclusa
un'altra fase delle guerre di religione e il re dichiara pacificato l'intero suo
dominio, esteso alla Scozia. Il Parlamento inglese è disciolto, la sua
giurisdizione annessa agli Stati Generali di Francia, che ora ammettono deputati
anche dall'isola. Il fratello del re, il cattolico Enrico, è creato duca di
Vessais (HL: Wessex) e viene posto dal re come Lord Protettore d'Inghilterra e
Scozia. Egli sovraintende a una politica di brutale soppressione dell'eresia e
sistematica ritorsione dei vincitori sui vinti.
Però qualcosa iniziava a cambiare. Innanzitutto perché, eccezion fatta per il
duca di Vessais, con la disgrazia dei Guisa era finito anche lo strapotere dei
vecchi nobili cattolici sulla monarchia, e più in generale la confessione era
entrata in declino, trasformando lo scontro tripartito in una, molto più
solvibile, lotta a due. Carlo I e IX decise di utilizzare a questo fine la
diplomazia: nel 1572, egli sovraintese al matrimonio tra sua sorella Margherita
ed Enrico di Borbone, con l'intento di pacificare il regno. Solo due anni dopo,
il re veniva trovato morto nel suo letto, senza aver generato prole. Unico erede
legittimo diventava, allora, il duca di Vessais, che assunse la corona col nome
di Enrico VII e X. Con un cattolico sul trono, era chiaro che la guerra, lungi
dal finire, potesse ora solo raggiungere l'apice: Enrico VII e X, deciso a
restaurare l'ortodossia, chiamò al suo fianco tutto ciò che restava della casata
di Guisa, nonché l'alleanza del papa e del re d'Italia Cesare I Renato, tenace
difensore della fede, di cui sposò la figlia Alfonsa. Dall'altro lato, per la
prima volta gallicani e ugonotti si trovarono a combattere insieme, proclamando
Francesco (II), fratello minore del re, come re legittimo in opposizione a
Enrico.
.
Il regno di Enrico VII e X (1574-1589)
Dal 1576 al 1580 si combattono, tra
cessate il fuoco e grandi spargimenti di sangue, tre diverse guerre di
religione, che in aggiunta agli scontri finali del regno di Carlo I e IX portano
il totale delle suddette a sette (gli storiografi non sono sempre d'accordo,
comunque). I gallo-calvinisti hanno la meglio sul territorio, però Enrico VII e
X può contare sul bacino di risorse quasi inesauribile rappresentato dalle
finanze italiche, che continuano a carburare la macchina da guerra cattolica. Un
compromesso sembrò vicino a essere raggiunto sul finire dell'anno, quando Enrico
di Borbone scelse di accettare il predominio del suo omonimo qualora quest'ultimo
avesse riconosciuto il fratello minore Francesco, gallicano, come erede al
trono. Pur di ottenere la pace, Enrico VII e X accettò. Tuttavia, la guerra
riprese qualche anno dopo, quando anche Francesco morì, lasciando Enrico VII e X
come unico rappresentante dell'anticamente onnipresente clan Valois. A questo
punto, i diritti in esame sul trono erano due equivalenti: l'uno dell'esiliata
Elisabetta II Tudor, per discendenza diretta da Enrico V e VIII; l'altro proprio
di Enrico di Borbone, per matrimonio con Margherita di Valois. Entrambe le
scelte erano ugualmente spiacevoli per il re cattolico: l'una era una gallicana,
peraltro estranea alla dinastia; l'altro era uno zelota calvinista. Di fronte
all'indecisione del re, si mosse la città di Parigi (dichiarata eternamente
cattolica con l'espulsione del clero gallicano nel 1576 e la purga di tutti i
calvinisti nel 1580), che scoppiò in tumulti e invocò l'intervento della Lega
Cattolica, costituita dagli ultimi Guisa con il supporto dell'Italia. Enrico di
Guisa, che aveva ereditato dal padre Francesco il fanatismo, marciò così dentro
la città, costringendo il sovrano a un'umiliante capitolazione, nel quale
dichiarava, per via di alcuni antichi diritti, suo unico erede lo zio Carlo
Guisa (peraltro cardinale al momento), annullando le pretese sia di Enrico di
Borbone, sia di Elisabetta II Tudor. La comune ostilità della corona scaturì
l'alleanza di questi ultimi, che si legarono nello scatenare un nuovo conflitto
di religione (1585-1589, l'ottavo). La coppia visse lontano per qualche tempo: a
Enrico di Borbone serviva il matrimonio con Elisabetta II per guadagnare il
supporto dell'Inghilterra, e così acconsentì a lasciarla governare da Londres,
mentr'egli sovrintendeva allo svolgimento della guerra contro la Lega Cattolica.
Nel frattempo, re Enrico VII e X viveva segregato nel suo palazzo, ostaggio
della Lega Cattolica. Dalle sue finestre, dai suoi balconi, il sovrano poteva
vedere il suo acerrimo nemico Enrico, duca di Guisa, aver ormai pienamente
assunto il comando della fazione cattolica, a suo scapito. Gli stessi
ambasciatori stranieri, quando arrivavano a corte, non si recavano a corte,
bensì nell'ala dell'edificio riservata ai Guisa. Il re tentò di fare arrestare
il duca, però, non appena la notizia si sparse nel popolino, i parigini
iniziarono a innalzare barricate, chiedendo la fine delle ostilità fra
confratelli di fede. L'umiliazione sarebbe stata troppo grande per qualunque
monarca: fu così che, presi segreti contatti con Enrico di Borbone ed
Elisabetta, nel 1588 il sovrano fuggì dalla capitale, rifiutando i ripetuti
richiami della Lega Cattolica per il suo ritorno. Appellandosi alle ultime
briciole della sua autorità, Enrico VII e X convocò una nuova seduta degli Stati
Generali con il fine di ottenere una tregua a Blois, dove si era rifugiato.
Enrico di Borbone ed Elisabetta dichiararono di ottemperare alla chiamata, per
spirito cristiano; così, anche il duca di Guisa non poté esimersi dal prendervi
parte. In realtà, si trattava tutto di un piano del sovrano: all'incontro,
ripieno di guardie armate, si presentarono solo Enrico di Guisa e il fratello,
erede presuntivo al trono, il cardinale di Guisa. Il re ammazzò il rivale con le
sue stesse mani, e prese in custodia il cardinale Carlo, gettandolo in carcere.
L'eco delle gesta del re si sparse rapidamente in tutti e due i regni, generando
spavento. Enrico di Guisa era infatti popolarissimo (perlomeno tra i cattolici)
come un eroe della causa dell'ortodossia, e ora diveniva un martire per i
papisti. Risultato ne fu che gli Stati Generali di Francia, ormai stabilmente
riuniti su modello inglese, procedettero a lanciare sanzioni penali sul re,
osando di dare mandato alla Lega Cattolica per catturare Enrico VII e X portarlo
a giudizio. Anche la Sorbona, in una famosa udienza, dichiarò che era legittimo
e giusto per qualunque suddito dei regni di Francia e Inghilterra commettere
l'assassinio di un sovrano tirannico. Di conseguenza il re, temendo per la sua
vita, si rifugiò presso il cugino Enrico di Borbone, invocandone la protezione.
Egli abbandonava la capitale e tutta la porzione settentrionale e orientale del
Paese, che erano in mano ai cattolici, capitanati dal duca di Mayenne, fratello
del duca di Guisa. Egli fece del cardinale di Guisa il suo fantoccio sul trono,
proclamandolo re con il nome di Carlo II e X. Però la fuga di Enrico VII e X non
durò a lungo: ormai egli era troppo odiato, accusato da tutte le fazioni di
crudeltà e codardia. Nel 1589, il re venne avvicinato da un frate domenicano,
che lo ferì gravemente. Sul suo letto di morte, l'impopolare maestà cattolica
affidò il diritto di succedergli in via esclusiva a Enrico di Borbone, posto che
quest'ultimo si convertisse perlomeno al gallicanesimo. La religione fondata dai
Tudor, infatti, sembrava essere l'unica via di mezzo, capace di riunire le anime
più disparate dei due regni.
Di fronte alla possibilità di vedersi riconosciuto il trono, il Borbone accettò,
venendo riconosciuto come Enrico VIII e IX di Francia e Inghilterra (per venire
incontro agli inglesi, il re di Navarra accettò di rimuovere il numerale
risalente a Enrico d'Orléans e suo figlio, quando, giuridicamente, sovrane
elette dal Parlamento inglese erano state Maria ed Elisabetta). Elisabetta II
fece buona accoglienza a questa mediazione, finendo per acconsentire alla loro
promessa unione di Enrico di Borbone (sacrificata sull'altare della convenienza
politica fu la povera Margherita di Valois, ultima della sua casata, che venne
ripudiata in quanto sterile). Nel 1590, le forze combinate di gallicani e
ugonotti riuscirono d'impeto a conquistare Parigi, e nel biennio successivo
Enrico di Borbone riuscì a liberare l'intera Francia nord-orientale dalla
presenza cattolica. La guerra sarebbe continuata ancora per qualche tempo contro
l'Italia, che supportava le pretese indipendentiste di alcune zone dei due regni
rimaste ostinatamente cattoliche (una fra tutte, l'Irlanda, ma anche Linguadoca
e Bretagna furono attraversate da moti simmili). Tuttavia, si trattava di una
resistenza, in ultima analisi, futile. La nascita del primo bambino della coppia
Tudor-Bourbon, chiamato molto significativamente Luigi (ormai erano più di due
secoli che la Francia non aveva un sovrano con quel nome), rappresentò il
ritorno alla concordia e alla normalità per buona parte dei sudditi. Nel 1598,
appena terminata la riconquista della Bretagna, Enrico VIII e IX promulgò
l'editto di Nantes: i cattolici rimanevano nemici numero uno della monarchia
gallicana, però la pace fra protestanti (gallicani e ugonotti e altri gruppi)
era favorita in ogni modo. Di lì a poco, anche il re di'Italia, ora Carlo III il
Grande, gettò la spugna: l'unione franco-inglese era stata riconfermata, più
forte che mai, e la Controriforma aveva ricevuto il suo primo, serio smacco,
dall'apertura del Concilio di Trento in poi.
Fino a qui ci siamo soffermati sulle liti religiose in voga allora entro i
confini della duplice monarchia, è ora necessario ampliare un poco la vista sul
mondo, in modo tale da capire appieno i successivi rivolgimenti di cattolicesimo
e protestantesimo in tutto il mondo. Prima della lettura, ci tengo a
sottolineare di aver significativamente rivisto le parti precedenti in luce
delle critiche che mi erano state mosse dagli amici, che ho accolto e integrato
nel testo al meglio delle mie capacità. Anche il precedente saggio sulle
genealogie ha avuto la sua influenza, conducendomi a riscrivere per intero gli
alberi dinastici di intere famiglie (li ho salvati da qualche parte, se voleste
leggerli). Gli avvenimenti geopolitici hanno mantenuto più o meno il loro
precedente risultato, però alcuni particolari (l'indipendenza di Svizzera e
Baviera; l'area di diffusione del protestantesimo; i nomi di molti sovrani
asburgici e angioini) sono cambiati. Credo insomma di aver fatto un buon lavoro
di revisione, e vi consiglio di rileggere, anche rapidamente, le parti
precedenti, che il Comandante ha pubblicato sul sito, in maniera tale da non
restare confusi. Buona lettura
1556: Rodolfo Federico abdica dal trono imperiale, lasciando spazio a suo figlio
Federico IV, che governa con l'assistenza del fratello Massimiliano. Con lui
falliscono i tentativi di sradicare l'eresia calvinista (Lotaringia),
anabattista (Westfalia) e luterana (Hansa), così come il tentativo di
sottomettere i Savoia del regno di Bruges. Nel frattempo, a Venezia si verifica
al potere l'ascesa della famiglia emergente dei Priuli, accresciutasi grazie al
commercio con l'Oriente e vicina agli ambienti del socinianesimo. Il colto
Lorenzo Priuli, da doge, si fa mecenate di Fausto Sozzini. Con il patrocinio del
doge, egli stende il nuovo catechismo della dottrina, che rigetta i dogmi della
Trinità, dell'onniscienza divina e del peccato originale.
1557: alla battaglia di San Pietro (dal nome del patrono della città di Colonia)
la Lega Cattolica subisce una tremenda sconfitta per mano di Emanuele Filippo,
detto il Testa di Ferro (tête de fer) per la sua caparbietà nel resistere al
cattolicesimo; i lorreni avanzano fin quasi al Reno. In Aquisgrana, il Testa di
Ferro celebra la sua incoronazione solenne come Filippo V, e si dedica poi a
rifondare lo Stato all'insegna della nuova epoca, stabilendo la prima capitale
permanente a Brussels e la sede del governo all'Aja (prima la corte circolava
largamente tra Brussels, Mechelen, Dordrecht, Amsterdam e Bruges), incrementando
enormenente il commercio e la colonizzazione nelle Americhe, fondando la borsa
dell'Aja, incrementando il numero delle banche e in totale favorendo l'elemento
germanico-protestante a scapito di quello latino-cattolico, fin'ora dominante.
Intanto, i veneziani fondano il loro primo emporio a Macao.
1559: pace di Pont-à-Mousson, che sancisce una tregua generale in Europa (la
duplice monarchia, consumata dalla guerra civile, se ne chiama fuori). In
particolare, viene sancita una volta per tutta la posizione dei Savoia, cui sono
tolti i loro possedimenti in Italia ma vengono largamente ricompensati in
Germania, incorporando gli arcivescovati di Liegi, Colonia e Treviri, oltre che
le città di Amburgo e Cleves. Il re d'Italia e il re di Lotaringia si
riconoscono giuridicamente vassalli dell'imperatore, e sono ricompensati con il
titolo di elettori (in sostituzione dei sopracitati arcivescovi, ora scomparsi).
Nei fatti, però, l'autorità imperiale sui principi tedeschi è stata severamente
indebolita, e ognuno di questi conduce una politica pressoché autonoma.
1560: sotto l'influenza diretta della regina d'Inghilterra (Maria degli Scoti è
imprigionata a Edinburgo e Giacomo Stuart occupa Leith) il Parlamento scozzese
delibera l'adesione del Paese alla Riforma, adottando una propria Chiesa
nazionale dal credo prettamente ugonotto. Queste condizioni, all'epoca
sfavorevoli per la monarchia, porteranno col tempo all'esodo di molti calvinsti
francesi in Scozia, dove assumono posizioni di potere, preparando il terreno per
l'annessione. A Djerba, le forze italiane di Cesare I Renato distruggono quelle
dei pirati barbareschi, stabilendo una forte presenza su tutta la costa
tunisina; pochi mesi dopo, però, l'arrivo di rinforzi ottomani costringe il re a
sloggiare, mantenendo il possesso di poche piazzaforti costiere.
1561: Napoli supera per la prima volta Milano in quanto ad abitanti (80.000),
aggiudicandosi il titolo di terza città d'Europa per grandezza dopo
Costantinopoli e Parigi; dall'epoca della sua proclamazione come capitale
d'Italia la sua popolazione è quasi raddoppiata. L'anno successivo, gli ultimi
discendenti dei Paleologi firmano il Privilegium Italicum, con il quale il re
d'Italia si assume in perpetuo il compito di difendere la Morea (fatte salve le
città venete e la libera repubblica di Monemvassia, eretta da immigrati
sociniani) da futuribili aggressioni turche. Di fatto, la penisola entra a far
parte dell'impero coloniale angioino, conducendo a una rinnovata ostilità con la
Serenissima.
1562: viaggiando sotto copertura (la leggenda vuole, mimando la parlata veneta),
i primi mercanti italiani riescono a oltrepassare il canale di San Marco,
portando alla corte safavide la proposta di un'alleanza, sfortunatamente poco
proficua, anti-ottomana. Epoca d'ora della pirateria inglese: i bucanieri
(perlopiù figli di coloro che risentono il predominio francese) seminano il
terrore nei Caraibi, facendo la cattiva sorte di navigli angioini e Tudor.
1563: scoppio dell'inconcludente prima Guerra del Nord tra Danimarca-Norvegia da
un lato, Svezia e Polonia dall'altro, l'unico effetto pregevole della quale è la
spartizione dell'Hansa, realizzata seguendo le linee confessionali tracciate
negli anni precedenti.
1565: grande assedio di Tunisi, i cavalieri ospitalieri resistono con ogni mezzo
prima di venire soccorsi da una flotta guidata dal viceré italiano di Sicilia,
Marcantonio II Colonna, il quale verrà creato Gran Maestro dell'Ordine per
questo merito. L'anno successivo, è posta la prima pietra della città di
Colonna, nell'isola di Gerba (Djerba), opportunamente fortificata dagli italiani
e affidata ai cavalieri. Nelle Americhe, esuli francesi cattolici fondano il
forte di Saint-Augustin, colonizzando la Florida.
1566: nuova invasione turca dell'Ungheria, onde riparare alla sconfitta
incassata precedentemente a Tunisi. L'anno seguente, sfruttando l'amicizia con
la corona protestante di Inghilterra e Francia, i lorreni fondano le prime città
in Carolina (dal nome dell'erede di Filippo V), a ridosso del confine con la
Florida.
1567: dopo una serie di dogi simpatizzanti (Lorenzo e Girolamo Priuli), Pietro
Loredan è il primo doge di Venezia a convertirsi esplicitamente al socinianesimo,
scatenando le ire di Cesare I Renato, che invade il territorio della Serenissima
e per tre anni mette a ferro e fuoco il Veneto.
1568: con l'umiliante trattato di Adrianopoli i turchi impongono un tributo agli
Asburgo, estendendo la loro presa su tutta l'Ungheria: massima estensione del
sultanato ottamano sul continente.
1570: l'ascesa di Alvise I Mocenigo, già ambasciatore veneto presso la corte
regia e la Santa Sede, significa la necessità riconosciuta dall'aristocrazia
lagunare di siglare una pace in vista della riscossa ottomana. L'intervento di
Cesare I Renato dunque apparentemente ripristina la supremazia del
cattolicesimo. Non solo: Venezia deve installare guarnigioni regie a Verona,
Padova e nella patria friulana, però in cambio stringe un'alleanza con l'Italia
che le consente di fermare i turchi in mare presso Lepanto. Fondamentale, in
tale contesto, è il contributo della flotta veneta di Sebastiano Venier. Cipro
occupata militarmente dal Turco, viene liberata, e posta sotto un protettorato
congiunto italo-veneto: Cesare I se ne incorona Re, ma l'amministrazione
dell'isola torna perlopiù in mano veneziana.
1571: i cavalieri ospitalieri trasferiscono la loro capitale da Tunisi a
Colonna, intensificando l'attività di penetrazione in Africa. Un tentativo turco
sulla Morea viene frustrato presso l'istmo di Corinto, e nel contrattacco gli
italiani si spingono fino alle Termopili, liberando Atene. Nel tentativo di
avvicinarsi alla Polonia, Federico IV garantisce ai suoi nobili la libertà di
culto.
1572: Sigismondo II di Polonia muore senza lasciare prole. Essendo Enrico di
Valois già impegnato in Francia, a succedergli è direttamente la sorella Anna,
che sposa Massimiliano d'Asburgo, zio di Federico IV. È inaugurata la
dominazione asburgica sulla Polonia.
1574: prendendo atto delle sconfitte incassate in Grecia, il successore di Selim
II, Murad III, si sbarazza del potente gran visir Mehmet Sokollu, rimanendo un
burattino nelle mani della madre, Nur-Banu. A questo punto, Nur-Banu (che,
ricordiamolo, è la veneziana Cecilia Venier-Baffo, rapita in gioventù da Corfù)
cambia radicalmente la politica turca nei confronti dei veneti: temendone la
potenza nei mari e tenendo soprattutto conto del fatto che nell’Impero Ottomano
sono sempre mancati grandi operatori commerciali (a maggior ragione ora che la
Grecia era caduta in mano italiana) ella comincia ad appoggiarsi alla
Serenissima, garantendole grandi privilegi economici e commerciali, e
concedendole ufficialmente il diritto di passaggio attraverso il canale di San
Marco. Costantinopoli spera così di dividere il campo cristiano. Dal canto suo,
Mehmet III cambia la direzione dell'espansionismo turco: nel corso di dodici
lunghi anni di guerra (1578-1590) il nuovo sultano sottomette l'Iran,
spingendosi fino alle frontiere con l'India.
1576: pacificazione di Treviso. I mercanti sociniani di Venezia, ormai
maggioranza della classe dominante, dichiarano di non accettare il predominio
dell'aristocrazia cattolica, incarnata dal doge Loredan, e marciano fino alle
porte della laguna. Dopo un breve assedio in cui i Veneziani inviano disperate
richieste di aiuto al re, la contrapposizione è risolta dall'intervento dei
maggiorenti senatoriali. Infatti il nuovo Consiglio, spaventato, elegge doge
proprio il capo della rivolta, il bellicoso Sebastiano Venier, già vincitore a
Lepanto. Da questo evento sorgono le premesse per lo scontro indipendentista con
il regno d'Italia.
.
Il regno di Cesare I (1550-1577) e la rivolta veneta
Fra tutti gli scontri che separarono
cattolici e protestanti nel corso del XVI secolo, quello che vide per
protagonista la Serenissima è forse il più meritevole di un approfondimento,
sicché esso significò, al pari delle guerre di religione in Francia, la (ri)creazione
di una nazione nell'accezione comunemente intesa del termine. E questo perché,
prima dello scoppio del conflitto, agli occhi dei contemporanei il Veneto non
era una regione poi troppo diversa dal resto di quelle della penisola. Certo, re
Cesare tollerava l'esistenza di un autogoverno nella persona del Doge e del
Maggior Consiglio, però nel quadro di un regno della prima età moderna questo
stato di cose era la normalità, e specialmente in Italia, laddove quasi ogni
città aveva una lunga e dettagliata storia di animosità con il potere di uno
Stato centrale. Quasi sempre, la monarchia italiana aveva scelto la via maestra
del compromesso, tollerando l'esistenza di queste franchigie al di fuori della
base di potere dei re (il sud): la città di Genova era solo il più fortunato
esempio di questa pratica antica. Altrove governavano i feudatari locali (Este,
Medici, Gonzaga...) cui il re lasciava pressoché ogni libertà nella scelta di
come condurre i propri territori. A Milano e Torino, patrimonio regio, aveva
sede un governatore, mentre in Sicilia e Sardegna avevano sede due viceré, ai
quali facevano rispettivamente capo i possedimenti italiani in Africa (prima di
tutto, l'ordine dei Cavalieri Ospitalieri; ma poi anche Algeri, Tunisi, Orano e
altre piazzeforti, comprese le lontane colonie dello Zenega, del Marocco e della
Costa d'Avorio) e nel Mediterraneo occidentale, con le Americhe (le Baleari, i
possedimenti sulla costa andalusa, l'isola di Italica, l'Enotria, l'Esperia e
molto altro ancora).
Questo modello amministrativo, collaudato a lungo con un certo successo,
incominciò a incontrare i primi problemi con la dedizione di Costantino XII
Paleologo alla corona italiana. Infatti Cesare I Renato, preso atto
dell'acquisto della Morea, volle insediare un suo viceré a Mistrà, cui affidò
l'intesa sopra tutti i traffici italiani con l'Oriente. Inizialmente tale
provvedimento era stato diretto a salvaguardare quei pochi possedimenti,
perlopiù genovesi, che il Regno aveva ereditato nell'Egeo e nel Mar Nero. Però,
man mano che il commercio con l'Estremo Oriente cresceva, il vero affare era
diventato passare per il canale di San Marco, in modo tale da trafficare in sete
persiane e spezie indiane. I veneziani, comprensibilmente restii ad accettare
tale penetrazione nella loro sfera d'influenza, furono costretti ad aprire tutti
i loro porti all'installazione di empori italiani dalla necessità di fare fronte
comune contro la minaccia ottomana, che per la fine del secolo aveva scippato
Cipro al dominio del Serenissima. Così, il quadro politico della regione, già
complicato, si era fatto invivibile. I Greci infatti, se ortodossi mantenevano
per concessione di Cesare I il proprio diritto ("la legge dell'imperatore") e
regolavano in privato le controversie che sorgevano fra loro. I sudditi
cattolici invece, perlopiù di origine italiana ma anche convertiti locali,
adivano il tribunale generale di Mistrà perché il viceré li giudicasse in base
agli editti regi ("la legge del re"), che in via eccezionale potevano prevalere
sulle antiche disposizioni imperiali, quando la lite aveva come convenuto un
Greco, ed essere applicate anche in territorio della Serenissima. I veneti,
infine, pretendevano di essere giudicati sotto l'autorità del bailo veneziano
più vicino (Creta, Negroponte, Cipro o Corfù) o addirittura del Doge quando la
lite aveva ad oggetto una controversia sorta sul mare. Tutti questi soggetti
dovevano, ovviamente, fare applicazione delle norme della Repubblica ("la legge
del doge"). I conflitti fra le tre leggi si erano poi ulteriormente acuiti dal
momento in cui a viaggiare verso l'Oriente erano diventati in maggioranza i
sociniani, sovrarappresentati nella classe mercantile, dato che Girolamo Priuli,
sotto l'influenza di Fausto Sozzini, aveva decretato la piena libertà religiosa
all'interno dei territori della Serenissima (laddove in Italia, invece, il reato
di apostasia era passibile di morte).
Era chiaro che bisognasse fare qualcosa, perché le continue diatribe religiose,
peraltro inficiate dalla Chiesa di Roma che voleva inglobare la struttura
ecclesiastica ortodossa, sottraevano legittimità all'autorità di entrambi i
contendenti. Eppure né il re, né i dogi, timorosi di guastare i necessari
rapporti che si erano instaurati col tempo, si muovevano. In particolare fece
scalpore il martirio del rettore della fortezza di Famagosta, il sociniano
Marcantonio Bragadin, che venne catturato a conclusione dell'assedio del sultano
e crudelmente scorticato dai turchi. Fu così che la palla passò agli estremisti
di entrambi gli schieramenti, che iniziarono a darsi battaglia per le vie e
nelle piazze (le prime memorie di scaramucce sono del 1566), accusandosi
reciprocamente di essere la causa della disarmonia che attanagliava allora il
fronte cristiano. Come risposta, il viceré di Morea, l'umanista Cristoforo
Moretti, chiamò in Grecia il marchese di Pescara e del Vasto Francesco Alfonso
d'Avalos, che si mise a capo di una larga forza armata, costituita perlopiù da
mercenari reduci delle guerre che avevano contrapposto Italia, Lotaringia,
impero e Francia nei decenni precedenti. Il d'Avalos iniziò una politica di
sistematico sterminio dei ribelli, il cui culmine fu la conquista della libera
repubblica di Monemvassia, eretta dai sociniani. Gli Italiani si ritirarono, ma
la rocca della città venne distrutta con l'obbligo che non venisse ricostruita
(1572).
In tutto questo, dato che il doge, il cattolico Alvise I Mocenigo, non sembrava
avere intenzione di muoversi, gli esiliati di Monemvassia si rivolsero al
capitano generale della flotta da mar, vincitore di Lepanto e sociniano,
Sebastiano Venier, che ormeggiava per allora a Cerigo. Il focoso guerriero,
agendo di propria iniziativa, tentò una prima operazione per ricatturare
Monemvassia, ma fallì. Fu così che il capitano da mar si dedicò a una politica
di sistematica occupazione e saccheggio dei villaggi sulla costa della Morea,
minacciando il nuovo viceré, Avalos marchese del Vasto succeduto a Moretti per
premio del re, fautore della linea dura contro i protestanti. Agli ordini di
Cesare I Renato, cui egli prospettava una situazione grama, il Vasto tentò di
sterminare tutte le manifestazioni di eterodossia religiosa (che fossero di
derivazione greca o veneziana) e abolire tutti i privilegi dell'aristocrazia e
delle città locali, aumentando il peso fiscale. L'abolizione della legge
dell'imperatore rappresentò la proverbiale goccia che fece traboccare il vaso:
nel 1573, la maggior parte della Morea era entrata in aperta rivolta contro il
dominio italiano, ed andata a ingrossare le fila di Venier, al punto di spingere
il Vasto a impegnarsi in una nuova campagna di repressione su larga scala che
raccolse misti successi. L'impossibilità di venirne a capo in proprio, comunque,
convinse il re a rimuovere d'Avalos, accusato d'incompetenza, dall'incarico,
conducendo a una situazione di stallo.
Dal canto suo, Cesare I Renato cercò di snodare il groviglio di guerriglia che
era diventata la Grecia interpellando direttamente Venezia e il suo doge
Mocenigo, ch'egli credeva subdolo complice delle violenze: tra il 1573 e il 1575
arrivò per la Serenissima la punizione, nella forma di un crudele saccheggio
imposto alla Terraferma, persino nelle città di provata fede cattolica e che,
negli scontri di potere, tendevano a favorire gli Italiani. Alvise Mocenigo si
trova così in una pessima posizione, con la gran parte del Consiglio dei Dieci
favorevole a dichiarare la guerra aperta contro il Re d'Italia, anche a costo di
svuotare le casse dello Stato. La gente della laguna, sobillata dai predicatori
sociniani, voleva il sangue. Persino l'aristocrazia lagunare si spaccò a metà,
con alcune importanti famiglie (prima di tutto, i Mocenigo, che avevano ottimi
legami con la curia; ma poi anche i Morosini, Foscarini, i Giustinian) che si
dicevano "di parte italica", ma la maggior parte dei maggiorenti, in specie
quelli che si erano arricchiti nel periodo più recente grazie al commercio
oceanico, che s'erano fatti numi tutelari della libertà religiosa della
Serenissima (i Priuli, sopra a ogni altro; se ne aggiunsero in seguito altre
come i Contarini, i Corner, i Loredan, e soprattutto i Venier) ed erano
spregiamente detti dagli avversari "di parte evangelica". Nel dibattito politico
che animava la città, la parte evangelica era in maggioranza, però tutte o quasi
le leve del potere, non ultima la carica dogale, erano in mano agli italici, che
deliberarono una scelta di neutralità assoluta negli scontri del Veneto e della
Grecia. Cesare I Renato osservava con interesse questi sviluppi. Questo anche
perché il suo obiettivo era prendere la città per via diretta, in modo tale da
terminarne l'indipendenza e debellare il protestantesimo, però nel 1574 era
fallito il suo tentativo, arrestato dall'assedio della fedelissima Treviso.
Così, approfittando dal favore accordatagli dalla parte italica, il Re ne
approfittò per ritirarsi con il bottino, lasciando intatta la Città propria.
Col senno di poi, si rivelò una mossa sbagliata. Reputando i possedimenti della
Serenissima nel Levante ormai sicuri, Sebastiano Venier ne approfittò per
ritornare immediatamente da quello che era di fatto un esilio eteroimposto
nell'Egeo. Sbarcato a Venezia nel 1576, venne osannato dalla popolazione, che
gli fece adito tra due ali di folla salutandolo come il vincitore di Lepanto e
il salvatore della Città. Temendo per il suo potere, il Mocenigo ne ordinò il
repentino allontanamento dalla laguna. Però il capitano dimostrò di avere sette
vite: da Treviso, città già protagonista della resistenza all'invasore italiano,
Sebastiano Venier chiamò a raccolta le armi protestanti, proclamando la
pacificazione della Terraferma sotto il suo potestato. Dalla sua, il capitano
aveva il supporto incondizionato dei Priuli e dei Loredan, oltreché l'obbedienza
della flotta; fu così che, per poco tempo, Venezia fu messa sotto assedio dai
veneziani. Nel 1577, sono gli stessi maggiorenti cattolici a mettere da parte il
dominio del Doge, accusato di essere la ragione di tutti i conflitti che
animavano la Repubblica, e facendo rientrare il Venier in città. Nel corso
dell'anno, si celebra un processo farsa contro Alvise Mocenigo, che viene
giustiziato in pubblica piazza. Subito dopo, in una votazione quasi unanime,
Sebastiano Venier venne eletto a portare il corno ducale. Egli si proclamava
Doge, Podestà, Signore del Levante e Capitano generale del Mare, oltreché
vescovo secolare della Serenissima con effetto diretto su tutti i tuoi
territori. Inutile dire che così il socinianesimo diveniva, finalmente,
confessione di Stato.
Il nuovo ordine protestante non mancò di
usare la forza contro quelle forze che avevano sorretto il vecchio regime
cattolico. L'intero anno di regno di Sebastiano I, assurto a una specie di
dittatore militare della Repubblica, fu speso nel sistematico tentativo di
sopprimere e sradicare i fautori della parte italica. Primo provvedimento in
ordine di importanza fu quello di sloggiare le guarnigioni italiane insediate da
Mocenigo, che non mancò di attirare su Venezia le ira angioine. Vittima
eccezionale fu il patriarca del Friuli, imprigionato contro le guarentigie
riconosciutegli dal diritto canonico, sottoposto a sommario processo ed
espropriato di tutte le sue proprietà, direttamente incamerate dallo Stato
(sorte, questa, che toccò a molte larghi possedimenti ecclesiastici). Ma anche
la gente comune soffrì: larghe fette di popolazione delle campagne, perlopiù
rimaste di fede cattolica, furono deportate in Oriente, con la scusa di
fortificare le posizioni veneziane contro il Turco. Le perscuzioni decimarono
buona parte dell'antica aristocrazia lagunare, con i maggiori esponenti delle
famiglie di parte italica costretti alla fuga per scampare alla pena capitale.
Però il regno di sangue del tiranno non durò a lungo: nel 1578, forse in seguito
a un colpo apoplettico (i suoi avversari dicono, preso dall'ira del Signore),
Sebastiano Venier morì, lasciando un enorme buco nella struttura di potere
sociniana. A succedergli fu, dopo una lunga e complicata elezione che comportò
la necessità di ben 44 scrutinii (la più lunga nella storia della Serenissima)
l'ottuagenario Niccolò da Ponte, anticlericale e sociniano, ma moderato e
conservatore. La sua elezione rappresentò una vittoria ai punti della fronda
conciliatrice, che anelava a una composizione pacifica delle ostilità con
l'Italia. Purtroppo per loro, le cose non andarono così. Già sul finire
dell'anno, gli esiliati si radunarono a Peschiera, appena oltre i confini con il
Regno, eleggendo, sotto la protezione del nuovo re Carlo III, a Doge il senatore
Niccolò Mocenigo, fratello del defunto Alvise I e in evidente continuità con
quest'ultimo. Così, nella prima volta durante la sua millenaria storia, Venezia
si ritrovava ad avere due dogi, per avventura del medesimo nome, ma in realtà
tenaci rivali: la guerra civile fra cattolici e sociniani non poteva essere
evitata.
Da luglio 1577 (un mese dopo l'esecuzione di Alvise Mocenigo) a gennaio 1579,
gli esuli, coadiuvati da un ampia condotta italiana al comando di Alessandro
Farnese, duca di Parma, passarono di vittoria in vittoria, avanzando le loro
posizioni stabilmente fino alla riva sinistra dell'Adige e oltrepassando il
fiume Brenta in più punti. Verona, isolata, resisteva strenuamente, però la
cattura di San Bonifacio e Valdagno da un lato, oltreché quella di Monselice,
Bassano, e Castelfranco dall'altro comprometteva gravemente le capacità della
Serenissima di rifornire le proprie città, strette d'assedio. La battaglia di
Cittadella (1578) fu una devastante sconfitta per i veneziani, a maggior ragione
perché la morsa italica si chiudeva ora su un'altra città (Vicenza). Il morale
era basso, e molte famiglie iniziarono a considerare la possibilità di medizzare,
tanto più che il Farnese assicurava un reintegro sicuro nelle fila cattoliche.
Anche il fondamentalismo dei sociniani allontanava i veneti dal predominio dei
veneziani, sicché, nel caos generale scaturito dal conflitto, molte città
avevano sollevato il proprio provveditore inviato dalla Serenissima, e s'erano
affidate a un governo emergenziale retto perlopiù da fanatici religiosi (un
esempio a questo fine fu proprio quello della libera repubblica di Verona, dove,
intorno al centodiciottesimo giorno, un frate che si diceva discendente degli
Scaligeri rovesciò il potere costituito e diede fuoco alle case dei cattolici,
accusati di tenere per sé il cibo e collaborare con gli Italiani). Nel 1579, gli
sforzi diplomatici di Alessandro Farnese sbocciarono finalmente in un grande
successo: le città di Verona, Vicenza e Rovigo, con l'intero loro contado
accettarono di passare di parte italica, riconoscendo il doge Niccolò Mocenigo
come proprio sovrano (va senza dirlo: sotto l'alta autorità del re d'Italia).
Due anni dopo, nel 1581, scoppiò una larga rivolta dei cattolici nel Friuli, cui
Farnese cercò di connettersi forzando il Piave. La situazione, per i sociniani,
era davvero disperata.
Però, la riconquista del Farnese si arrestò nel 1585, dopo la caduta di Belluno
e l'offertà di fedeltà (diretta, questa, al re) del Friuli. Questo per due
ragioni: da un lato, perché i ripetuti tentativi di infiltrarsi nella laguna
circondando Treviso o Padova erano sempre stati frustrati dal pronto intervento
veneziano; dall'alto, perché con la scomparsa di Cesare I Renato, le priorità
del Regno erano cambiate. Suo figlio Carlo III era infatti maggiormente
preoccupato dagli sviluppi della duplice monarchia, dove ormai rischiava di
salire al trono il protestante Enrico di Borbone. Fu così che il portentoso duca
di Parma fu spedito in Provenza, a combattere una lunga e inconcludente guerra
contro gli ugonotti, in alleanza con la Lega Cattolica. I veneziani ebbero così
modo di recuperare: il nuovo doge Pasquale Cicogna strinse alleanza con Savoia e
Borbone, che arrivarono a finanziare la resistenza veneta. Re Carlo Emanuele I
di Lotaringia inviò suo figlio secondogenito, Emanuele Filippo, per guidare la
riscossa della parte evangelica. Tra il 1588 e il 1593, il duca di Lorena
riportò il fulcro della guerra in Grecia, dove riuscì quasi interamente a
conquistare la Morea, in spregio al Privilegium Italicum, e poi addirittura in
Egitto, respingendo due attacchi turchi e un ottomano. È in questo periodo che
il potentato mamelucco diviene totalmente suddito dei voleri veneziani. Nel
1591, quando Cicogna morì, al principe calvinista venne addirittura proposta la
carica di Doge, ma egli rifiutò, venendo nominato provveditore speciale da mar.
Forte del nuovo titolo (a cui molto spesso si aggiunse la potestà straordinaria
di comando sopra tutti i possedimenti di Terraferma della Serenissima), egli
procedette anche in Veneto a numerosi attacchi, che riuscirono a puntellare e
consolidare la strenua difesa della laguna e garantirono al Savoia la fama di
miglior stratega d'Europa, tanto che per molto tempo i confini della Repubblica
furono definiti nel solco delle sue campagne. Nemmeno il Farnese, richiamato
alle armi vista la malaparata in Francia, poté vincerlo in campo aperto: lo
scontro tra i due terminò in pareggio. Contro tutte le speranze dei veneti,
però, Emanuele Filippo si spense nel 1605, all'interno di una delle numerose
fortezze da lui inaugurata (per la precisione, quella di Palma). Le sue vittorie
avevano scongiurato la scomparsa di Venezia, e una tregua armata di tredici
anni. Non era ancora la fine del conflitto (la Repubblica e il Regno avrebbero
combattuto ancora nel secolo a venire), però la nazione veneta, in origine
vicina all'annichilimento, aveva finito per essere rinsaldata e confermata dalla
guerra.
Al contrario, in Italia la tregua veniva salutata come una tragedia nazionale,
inaugurando sotto i peggiori auspici il regno di Carlo III. E questo perché
sotto Cesare I Renato l'Italia aveva raggiunto l'apice della sua potenza come
egemone del Continente: in quel periodo, ovunque si combattesse, in Europa o sul
mare, non mancava il coinvolgimento italiano, fosse esso diretto o meno. La
miglior generazione di condottieri italiani (non ultimi, i citati d'Avalos,
Doria e Farnese) avevano diretto sul campo gli sforzi della Controriforma tesi a
sopprimere i protestanti sulla base di compagnie mercenarie sempre più
professionali, oltreché il primo nucleo di esercito permanente. I mercanti
italiani, eredi di una grande tradizione borghese, avevano iniziato ad espandere
le proprie reti commerciali in tutto il mondo, attraverso le nuove vie
commerciali inaugurate dagli architetti di San Marco e Santa Cecilia (anche
detta Santa Lucia) a Panamá; le loro galere riportavano in patria un enorme
fiume di merci provenienti dalle Americhe, dalla Cina, dall'India. Del resto,
Bona Sforza doveva presentire bene questi sviluppi, avendo scelto di chiamare
suo figlio con un nome profetico; in parte, perché era nato a luglio. Ma
soprattutto, perché il classicismo allora imperante, derivato dalla conquista
della Grecia, imponeva un nome che fosse di estrazione antica e suggerisse
un'immagine di grandezza.
Tuttavia, nonostante l'incrementale ammontare di benessere prodotte dalle sue
città, Cesare I non fu in grado di sopprimere il protestantesimo, di reprimere
la ribellione veneta o di restaurare il cattolicesimo in Francia. Tale politica
estera fu certamente ispirata da un forte zelo religioso, che portava il re a
considerare la difesa dell'ortodossia cattolica come uno dei suoi principali
obiettivi. Per tale motivo Cesare I adottò un approccio estremamente rigido nei
confronti dei ribelli, da lui assimilati ai turchi ottomani, riuscendo peraltro
a impedire la diffusione del protestantesimo nei suoi domini in Italia e Grecia
e a restaurarlo nel Veneto occidentale, l'odierna regione orientale della
penisola. Altrettanto importante fu la sua lotta senza quartiere per la difesa
del Mediterraneo dal dominio turco, di cui la battaglia di Lepanto del 1571 fu
il più fulgido esempio, insieme agli aiuti da lui forniti sei anni prima agli
ospitalieri nel grande assedio di Tunisi; non è un caso se gli storici dell'800
fecero risalire a Cesare I i primi germi della dominazione italiana in Africa.
In questo senso, già molti contemporanei tra i suoi devoti vassalli ebbero
ragione di credere che il fondamentalismo cattolico di Cesare I non fosse
soltanto motivato da una spinta mistica. Tramite la fede, egli cercò con ogni
mezzo di garantire l'unità del regno d'Italia, creatura di recente formazione, e
a tale scopo diede carta libera per l'operato dell'Inquisizione papalina. Egli,
sbandierando la superiorità delle università italiane, proibì agli studenti lo
studio in paesi stranieri o tramite libri vietati dalla censura, giungendo al
punto di incarcerare per 11 anni l'arcivescovo di Milano, Gaspare Visconti, per
la pubblicazione di alcuni suoi scritti giudicati dal re come eccessivamente
vicini all'eresia, e in realtà, per la difficoltà di vestire le scarpe della
successione a san Carlo Borromeo, anima della Controriforma italiana. Cesare I,
che era un grande sovrano, non riuscì ugualmente ad annichilire il potere delle
banche, delle famiglie, delle grandi corporazioni di arti e mestieri, che anzi
avevano accresciuto a dismisura il proprio potere a corte durante la sua vita,
fallendo dunque nell'obiettivo di costruire una monarchia veramente assoluta,
cioè totalmente sciolta dal perseguimento degli interessi della collettività.
Nota d'onore è che sotto il suo regno, così come sotto quello dei suoi genitori,
fiorirono le arti e la letteratura. Suo figlio Carlo avrebbe poi contribuito
alla fondazione dell'Accademia della Crusca, con il compito di raccogliere e
sistemare il canone della lingua italiana.
In ultima analisi, Cesare I Renato fu il più potente monarca europeo in un'epoca
di conflitti e guerre religiose. Alla luce di ciò, la sua figura è divenuta un
controverso argomento storico. Infatti, come fanno notare alcuni studiosi, anche
prima della sua morte i suoi sostenitori avevano cominciato a tessere
un'immagine del re gentiluomo, ricco di virtù e animato da una sincera pietà
cristiana, quanto i nemici lo avevano dipinto come un mostro fanatico e
dispotico. Tale immagine nei secoli si sviluppò ulteriormente fino a creare una
vera e propria dicotomia tra la Leggenda Nera francese e la Leggenda Bianca
italiana, di cui lo stesso Cesare fu in parte responsabile, poiché vietò ogni
racconto biografico e comandò alla sua morte di bruciare la sua corrispondenza,
impedendo qualunque investigazione nella sua vita privata. L'autore, astenendosi
da ulteriori valutazioni, vuole qui lasciare ai suoi lettori il non facile
compito di tracciare un riepilogo della figura di Cesare I, sia sul piano
pratico, sia su quello morale.
.
Il regno di Carlo
III il Grande (1577-1608) e l'Invitta Armata
Uno dei successi di Cesare I
di cui non abbiamo fin'ora avuto modo di parlare in maniera esaustiva fu la
politica matrimoniale, condotta con sagacia al fine di legarsi in alleanza con i
più tenaci oppositori della duplice monarchia. Cesare stesso aveva sposato
Cristina d'Asburgo, figlia del deposto Carlo II d'Asburgo e di Cunegonda, figlia
di Federico Rodolfo; la sorella di Cesare, Giulia (anche qui, il pararellismo
con l'antichità è voluto ed evidente) era invece stata mandata in Spagna, a
contrarre matrimonio con Giovanni III, re della casata d'Aviz. Al contrario di
quello con Cesare, però, quello di Giulia e Giovanni era stato un matrimonio
molto più triste: di dieci figli nati, solo uno, Giovanni Manuele visse
abbastanza per contrarre a sua volta un'unione con Alfonsa (in alcuni fonti
detta Alfonsina), figlia di Cesare I e Cristina. Dalla loro unione nacque un
figlio, Sebastiano, presunto erede al trono iberico; tre anni dopo, il vecchio
Giovanni III spirò, avendo mantenuto per tutto il suo regno una politica di
benevolente neutralità negli scontri religiosi che squassavano l'Europa,
eccezion fatta per l'alleanza con l'Italia e il limitato intervento nella
successione alla casata Tudor. Due terribili donne, la zia Giulia e sua nipote
Alfonsa si scontravano per la reggenza: il conflitto, che inizialmente tentò di
essere ricomposto dalle cortes del Portogallo, divenne molto rapidamente
insanabile, e il Paese inviò messi a Napoli perché con la sua autorità Cesare I
ricomponesse lo scisma. Il re decise di mediare in favore della sorella, che
aveva già dimostrato notevoli abilità al governo, richiamando la propria figlia
in Italia. Alfonsina avrebbe finito i propri giorni in un convento.
Attorno alla figura della reggente Giulia, due volte regina madre, crebbero
molto rapidamente le dicerie. Questo perché, nonostante la regina governasse con
saggezza ed equità, erano in molti a disprezzare le sue politiche di larga
apertura verso i mercanti della penisola, cui concesse numerose postazioni
commerciali, che prima erano state portoghesi, in giro per il mondo. Giulia d'Angiò
cercò di legittimarsi come una discendente degli Aragona (cosa che fattualmente
era, anche se per via illegittima), ma i tentativi in questo senso furono
sistematicamente frustrati dall'introduzione di numerosi ingombranti funzionari
e stravaganti personaggi italiani a corte. Il tutto non era reso più facile dal
suo carattere: Giulia, donna pragmatica, dalle sfaccettature complesse, ma
decise, giustificava il suo agire con l'obiettivo di preservare il nipote
Sebastiano e la discendenza d'Aviz, identificati con il benessere della Spagna.
Eppure, il fanatismo religioso da lei importato in Iberia dall'Italia, che si
tradusse nell'espulsione massiccia di migliaia di mori ed ebrei convertiti, non
riscosse molto successo. Quando i suoi oppositori, guidati dalla nobile famiglia
dei Pérez, che erano stati segretari particolari del monarca sotto gli Aviz
iniziarono a farle opposizione, ella autorizzò le attività dell'Inquisizione
italiana nel re, che prese prigioniero il padre, Gonzalo; Antonio Pérez, invece,
avvertito per tempo, riuscì a scappare in Francia, meditando vendetta.
Intendiamoci: che a metà del '500 un sovrano europeo, al pieno del processo di
formazione delle monarchie assolute, facesse arrestare e processare gli
antagonisti al suo potere non era poi così strano. Bizzarra invece venne
ritenuto a titolo universale la strana morte di Gonzalo, rinvenuto cadavere
nella sua cella poco prima che se ne cella la mattina in cui egli sarebbe stato
ammesso a parlare in sua difesa nel tribunale ecclesiastico imbastito da Giulia.
Cosa non si disse allora sui famosi veleni, sulle misteriose trappole, sugli
assassini segreti che la regina avrebbe tenuto a sua disposizione! I suoi
detrattori iniziarono a dipingerla come circondata, ad ogni ora del giorno e
della notte, da streghe e fattucchieri, spesso di origine italiana, alle prese
con pozioni e specchi magici: si tratta di insinuazioni completamente infondate.
Era pur vero che la regina stessa aveva interesse a che queste voci trovassero
spazio nell'opinione pubblica, nell'esuberante tentativo di impedire
sollevazioni contro di lei. Fu una mossa che, con il tempo, si rivelò sciocca,
rivolgendosi contro di lei, che ne era stata la prima perpetuatrice. Nel 1577, a
meno di un anno dalla morte di Cesare I che ne era stato il burattinaio occulto,
i maggiorenti di Spagna insorsero, richiamando Pérez dall'esilio e imponendo
alla regina di abbandonare la reggenza in favore del fratello del re Giovanni,
il cardinale Enrico: posta con le spalle al muro, Giulia d'Angiò cercò di
resistere, paventando il pericolo (peraltro concreto) che senza la sua figura il
fronte unito della nobiltà si sarebbe spaccato; però il segretario Pérez,
animato da vendetta, non volle sentir ragioni e la spedì via. Il re d'Italia
Carlo III, da poco succeduto al padre e che non aveva in particolar simpatia la
zia (egli a ragione la accusava di aver rovinato la vita della sorella
Alfonsina), acconsentì alla manovra, pur imponendo la figura di un suo messo a
corte onde mantenere un certo grado di influenza sulle azioni del giovane re
Sebastiano I. L'intrigante Giulia d'Angiò, machiavellica regina madre di Spagna
(o, come la ricordano gli spagnoli: la reina serpiente) venne così messa da
parte, finendo i suoi giorni in esilio nel castello di Málaga, sotto l'attenta
protezione della flotta genovese.
Il regno di Sebastiano I non fu comunque duraturo. Cresciuto all'ombra del mito
di Cesare I e della sua lotta forsennata contro i nemici della fede, il sovrano
adolescente volle da subito imitarlo, organizzando una grande spedizione in
Africa con l'obiettivo di sottomettere il sultano del Marocco. Questa
iniziativa, scoraggiata dagli spagnoli che vedevano in pericolo la vita
dell'unico esponente maschile della casata d'Aviz ancora in vita, venne invece
sostenuta ad armi spianate dagli italiani, da sempre interessati a conquistarsi
l'apertura di un punto di passaggio tra il Mediterraneo e l'Atlantico che non
fosse sotto il totale controllo dei re d'Iberia. Nella primavera del 1578,
lasciato senza troppi pensieri il governo del regno allo zio Enrico, Sebastiano
I si imbarcò da Almeria con il supporto di navigli inviati dal re d'Italia, per
sbarcare successivamente in Marocco. In estate, si combattè la battaglia
decisiva: incurante della propria inferiorità numerica, re Sebastiano lanciò i
propri cavalieri spagnoli alla carica contro i fucilieri saraceni, che ne
menarono strage. Peggio ancora, divenne subito molto chiaro che all'interno
della calca il re di Spagna era scomparso. Le ricerche durarono ore, senza
fortuna. Non aiutava il fatto che, mentre gli spagnoli cercavano di reggere
l'urto dell'ondata marocchina, molti italiani si dettero alla fuga, una volta
compreso che non c'era speranza di vincere la battaglia. Di trentamila soldati
che erano partiti, alle fortezze italo-portoghesi sotto il controllo cristiane
site sulla costa ne tornarono meno di mille, generando un grandioso tumulto di
isteria popolare in Spagna. Lo zio Enrico venne costretto in fretta e furia ad
abbandonare il berretto cardinalizio, nel tentativo di ottenere prole. Ma fu
tutto inutile, perché appena due anni dopo, nel 1580, il re-cardinale si spense,
avendo infranto a vuoto i suoi voti di castità. Le cortes di Castiglia, Léon e
Portogallo, riunite straordinariamente in una sessione comune, deliberarono di
individuare un successore nella figura dell'infanta Caterina di Aviz, figlia di
un fratello di Enrico I, e sposata con il duca di Braganza Giovanni. Quest'ultimo
venne conseguentemente incoronato re con il nome di Giovanni IV, e l'annoso
compito di difendere il regno dalle mire espansionistiche del re d'Italia. Già,
perché un altro possibile pretendente al trono era Ranuccio Farnese, figlio del
grande duca di Parma e di sua moglie Maria, sorella di Caterina. Il Farnese
venne eletto re dagli aragonesi, sotto la pesante influenza dei mercanti
napoletani, fiorentini e genovesi, che ormai in Catalogna erano di casa.
Alessandro, ottenne la protezione del re Carlo III per suo figlio, che inviò
l'Invitta Armata per prendere possesso Barcellona, ma nell'ottusità del sovrano
fu costretto a restare in Francia, da cui gestiva lo sforzo congiunto della Lega
Cattolica contro Elisabetta II ed Enrico di Borbone. In realtà, il re d'Italia
agiva secondo un preciso disegno, e cioè evitare che il duca Farnese,
installatosi in Aragona, potesse da lì sottomettere l'intera Spagna, acquisendo
così un rango paritetico rispetto a quello del suo sovrano feudale, cioè la
corona angioina. Dal canto loro, Caterina e Giovanni sapevano di non potere
accettare battaglia contro un nemico così soverchiante contro la corona
italiana, e così acconsentire a una spartizione dei territori che avevano
costituito l'impero degli Aviz. L'Africa, così come l'Atlantico venne divisa
grossomodo a metà, tra una settentrionale di pertinenza italiana a nord e una
meridionale di pertinenza spagnola a sud. Le Giovannine, opportunamente
ribattezzate Caroline, passarono all'Italia, che era interessata a guadagnare
una posizione ravvicinata all'Oriente in modo tale da poter competere con i
veneziani nel commercio con la Cina; le merce indiane, invece, restarono agli
spagnoli, anche se ormai erano lontani i tempi del monopolio, dato che
veneziani, franglesi e lorreni avevano preso a interessarsene. Notevole fu, in
questa sede, il duplice riconoscimento dell'indipendenza inca: nel corso del
secolo precedente, l'impero andino, sotto l'eminente protezione del re d'Italia,
era andato riformandosi sempre più, adottando il culto di Cristo in luogo di
quello del Sole. Nel novembre del 1588 il gesuita pugliese Michele Ruggeri,
inviato da Roma, da consigliere privato dell'imperarore Túpac Amaru divenne il
primo arcivescovo del Pirù (come lo chiamavano gli italiani), con ampio potere
di evangelizzazione del territorio. Michele Ruggeri fece venire sacerdoti
dall'Aragona e dall'Italia, imbastendo un sistema diocesale dal nulla; egli
bandì la sparuta pratica dei sacrifici umani, rivitalizzò l'attività edilizia
andina con la costruzione di numerose strade romane e chiese barocche, e
soprattutto salvaguardò la lingua piruviana, tramite la trascrizione di un
catechismo. Con la sua morte, vent'anni dopo, l'impero del Pirù stava ormai
risalendo la china, a seguito del disastroso contatto con gli europei, che era
valso agli andini due guerre civili e lo sterminio portato dalle malattie.
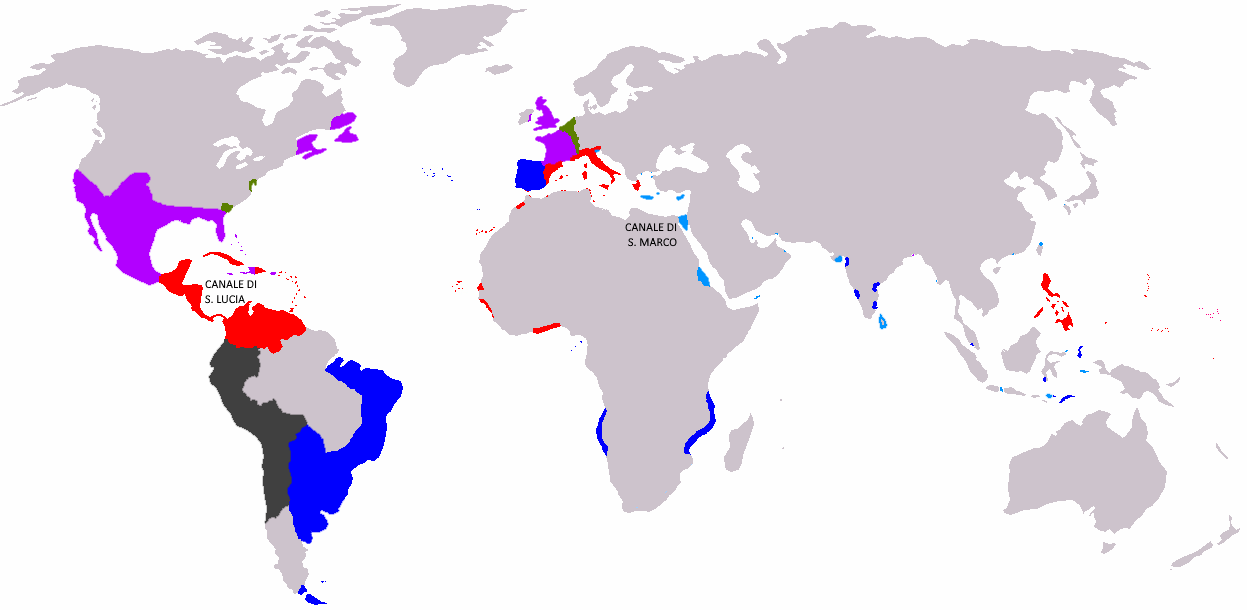
.
(cliccare per ingrandire)
.
Per farmi sapere che ne pensate, scrivetemi a questo indirizzo.
