
di Re Creso
1850: in seguito alla Rivoluzione Siciliana, Ferdinando II decide di elevare la Sicilia a regno autonomo, com'era prima del Congresso di Vienna. Stabilisce comunque che il regno di Napoli e quello di Sicilia restino uniti secondo un'unione personale. In questo modo, la popolazione siciliana diviene più mite, anche grazie alla concessione, datata 1855, di alcune lievi modifiche alla già vigente Costituzione in una direzione più liberale.
1853-1856: guerra di Crimea. Impero ottomano, Francia, Gran Bretagna e regno di Sardegna combattono contro l'impero russo, che risulta infine sconfitto, seppure non risulti quasi per nulla danneggiato dalla pace conclusa con il trattato di Parigi.
1859: il regno di Sardegna attacca la Legazione delle Romagne, territorio pontificio; la Legazione viene annessa come nuovo territorio sabaudo dopo un plebiscito, assieme alla Toscana. Durante la Seconda guerra d'indipendenza, anche la Lombardia viene annessa al neonato regno d'Italia.
1860, febbraio: venuto a sapere delle intenzioni dei Sabaudi di invadere la Sicilia, Ferdinando II si allea segretamente con il pontefice Pio IX: il papa metterà a disposizione del re, quando egli vorrà, i porti del Lazio, mentre il re si impegna ad aiutare lo Stato Pontificio a recuperare i territori sottrattigli.
1860, marzo: preoccupato per l'eventuale spedizione sabauda, della quale non conosce la data precisa, Ferdinando II decide di approfittare del patto stretto con Pio IX e posiziona alcune delle sue navi a Terracina ed a Civitavecchia, adducendo la scusa di urgenti riparazioni necessarie per non destare troppi sospetti negli ignari.
1860, 5 maggio: Giuseppe Garibaldi, con mille e più volontari, parte da Quarto, in Liguria, alla volta della Sicilia.
1860, 7 maggio: venuto a sapere della partenza dei garibaldini, Ferdinando II ordina alle nave ormeggiate in Lazio di intercettarli il prima possibile.
1860, 10 maggio: ha luogo, al largo del Lazio settentrionale, la battaglia fra le navi borboniche e quelle dei Mille. Questi ultimi infine volgono in fuga, dirigendosi verso il porto toscano di Talamone. Alcuni dei Mille, in ogni caso, vengono catturati e, prigionieri, ammettono che il preteso furto delle navi partite da Quarto non era altro che una copertura per la spedizione di conquista della Sicilia e del dominio borbonico tutto. Ferdinando II vorrebbe dichiarare guerra al regno d'Italia, ma purtroppo non può farlo, pena inimicarsi la Francia, maggiore alleata dei Sabaudi.
1861, marzo: desistendo, perlomeno temporaneamente, dall'impresa di conquista dei domini borbonici, il regno di Sardegna torna a rivolgersi verso lo Stato Pontificio, dirigendosi verso le Marche. È un grave errore: pur avendo capito che Pio IX e Ferdinando II erano alleati, i Sabaudi avevano ritenuto che le Marche fossero comunque propense ad unirsi a loro (cosa vera, in realtà). La Francia tentenna, poiché, oltre ad essere alleata del regno d'Italia, è anche la tradizionale difenditrice dello Stato Pontificio; Pio IX chiede l'aiuto di Ferdinando II di Borbone, che parte con un esercito di 6000 soldati alla volta di Ancona, nei dintorni della quale si stanno consumando le fasi più accese della guerra. Pio IX, intanto, chiede anche l'aiuto dell'Impero d'Austria, promettendo in cambio il sostegno proprio e di Ferdinando II (col suo consenso, ovviamente) per recuperare i territori lombardi perduti; l'imperatore Francesco Giuseppe accetta.
1861, aprile: i soldati sabaudi sono stretti fra borbonici-pontifici a sud e gli austriaci calati da nord, quindi vengono infine costretti alla ritirata. Le truppe dell'alleanza fra i Borbone, il pontefice e gli Asburgo proseguono alla volta della Lombardia, dove però la popolazione è alquanto recalcitrante a tornare sotto il giogo austriaco.

1861, giugno: l'asprezza della resistenza, unita alla voce dell'arrivo di truppe francesi, fa infine desistere i tre monarchi dal continuare la guerra. L'Austria risulta accresciuta dei territori di Brescia, Cremona e parte di quelli di Sondrio, ma deve rinunciare definitivamente a Milano.
1862: Ferdinando II di Borbone, ormai vecchio e stanco, associa al trono suo figlio Francesco II, il quale, anche per aver combattuto nelle azioni di guerra svolte negli ultimi anni nella penisola, è meno timido e insicuro di quanto non fosse anni prima.
1863: muore Ferdinando II di Borbone ed il trono passa a suo figlio Francesco II. Solenni funerali per il defunto, la cui bara viene accompagnata al riposo eterno dall'inno di Paisiello ("Iddio preservi il re, per lunga, lunga età [...] viva Fernando il re!").
1864: scoppia la Seconda Guerra dello Schleswig: la Prussia si annette lo Schleswig-Holstein dalla Danimarca.
1865, aprile: scoppia la guerra austro-prussiana, che vede da una parte l'Impero austriaco (e stati tedeschi alleati) e i domini borbonici, dall'altra il regno di Prussia e il regno d'Italia. A differenza di quanto accaduto nella nostra linea temporale, l'Austria non deve fronteggiare gli italiani sul fronte Lombardo-Veneto, se non marginalmente, in quanto Francesco II decide di attaccare il regno d'Italia in Toscana, compiendo così azione di disturbo. Questo "accanimento" borbonico nei confronti dei sabaudi è dovuto all'ancora fresco ricordo della tentata invasione, per non parlare dei timori che ciò si ripetesse, con l'aiuto della Francia.
1865, maggio: continuano gli attacchi borbonici in Toscana, i quali avvengono per via mare (lo Stato Pontificio, per non compromettersi, ha preferito negare il passaggio di truppe sul suo territorio; Pio IX, ad ogni modo, non fa altro per ostacolare Francesco II). I sabaudi decidono di allestire dei "porti pirateschi" che nella lontana (e sicura) Sardegna possono approvvigionarsi e trovare riparo. La Prussia e l'Austria continuano a combattere con forza sul fronte germanico, in una situazione di sostanziale stallo (l'Austria, si ricordi, non ha preoccupazioni, nel Lombardo-Veneto).
1865, agosto: stufo degli attacchi dei "pirati autorizzati", Francesco II decide di lasciare la Toscana e di portare la guerra in Sardegna: si tratta, in pratica, dell'ennesima guerra fra stati italiani. I sabaudi ristabiliscono rapidamente la pace in Toscana e, sapendo delle intenzioni borboniche, concentrano gran parte delle loro forze sull'isola, quasi ignorando il fronte con l'impero austriaco (che peraltro è impegnato altrove e dunque non attacca di certo).
1865, ottobre: battaglia di Golfo Aranci: i borbonici riescono finalmente a spezzare la resistenza sabauda ed a penetrare nell'entroterra sardo, mentre i Savoia si ritirano a loro volta verso l'interno per preparare la controffensiva. Francesco II manda un appello al "diletto popolo sardo" promettendo "grandi benefici per la Sardegna" se gli abitanti avessero aiutato le sue truppe a scacciare i sabaudi. Non che i sardi ci credano molto, ma visto il malgoverno dei Savoia delle ultime quattro decadi, decidono comunque, più o meno, di dare credito al Borbone.
1866, febbraio: con un notevole dispendio di soldati da entrambe le parti, la Sardegna è infine conquistata completamente dai Borbone, eccezion fatta per alcune piazzeforti ancora tenute dai Savoia; Austria e Prussia, intanto, si scontrano nella battaglia di Dresda, che si risolve in una vittoria pirrica per i prussiani. Non avendo dovuto occuparsi anche degli italiani, l'Austria è infatti riuscita ad ottenere risultati decisamente migliori di quanto non abbia fatto nella nostra linea temporale.

1866, marzo: trattato di Sassonia fra Austria e Prussia: la Confederazione Tedesca viene sciolta, la Prussia assume il comando della sua parte nord, l'Austria della parte sud; pochi altri stati (la Baviera, il Württemburg e dintorni) restano formalmente indipendenti, ma in realtà la loro vita politica si barcamena fra il controllo prussiano e quello austriaco. Il regno d'Italia e quelli di Napoli e Sicilia restano invece in stato di belligeranza fino a giugno, quando i Borbone riescono a far battere in ritirata anche gli ultimi sabaudi: la Sardegna è borbonica secondo il Trattato di Genova.
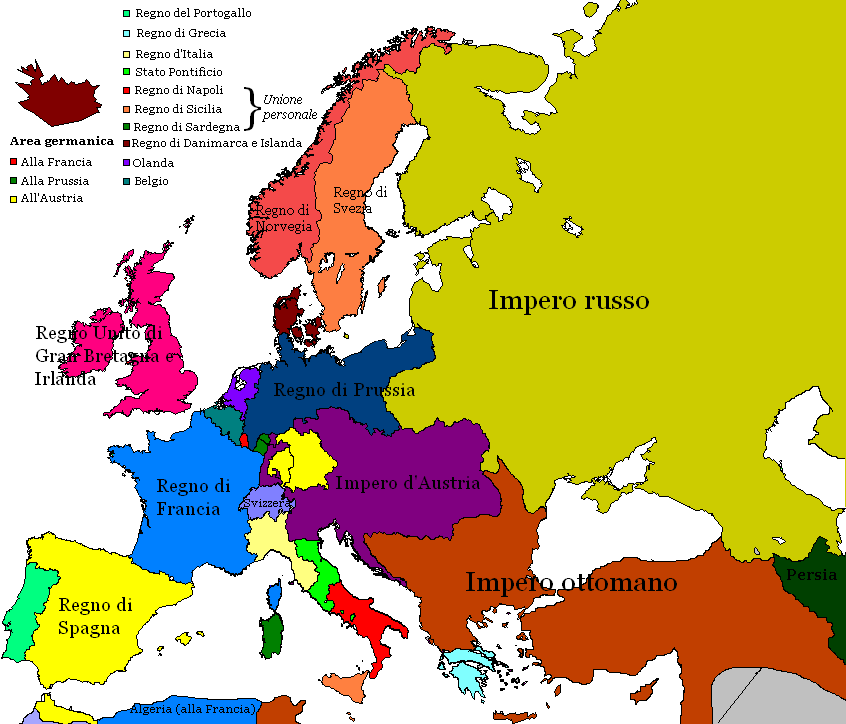
1867: i Savoia preparano il terreno per la riconquista della Sardegna; Francesco II, quindi, decide di mantenere fede alle sue promesse ed eleva la Sardegna a regno autonomo, anche se, ovviamente, in unione personale con il regno di Napoli e quello di Sicilia.
1868: in Spagna scoppia la rivoluzione: la regina Isabella II viene cacciata dal paese ed è costretta a rifugiarsi a Parigi. Le Cortes votano per la costituzione di una repubblica federale (nella nostra linea temporale divenne re di Spagna, per due anni, Amedeo di Savoia, perché i Savoia avevano acquistato una certa popolarità grazie all'unificazione italiana ed alla formazione di una monarchia costituzionale, ma in quest'ucronia i loro successi si sono fermati all'acquisizione della Toscana nel 1859). È l'inizio del periodo denominato Sessennio democratico, durante il quale la Spagna sarà afflitta da convulse e sanguinose vicende interne che porteranno infine, nel 1876, alla restaurazione della monarchia borbonica; anche in Portogallo inizia un periodo di gravi disordini che coprirà più o meno lo stesso arco di tempo del Sessennio.
1869: la repubblica spagnola tenta di trovare una soluzione ai propri problemi interni, ma senza costrutto. Iniziano alcune sollevazioni popolari, ma vengono soffocate.

1870: tentativo francese di annettersi il Lussemburgo, come "premio" promesso (e poi ritrattato) dalla Prussia in cambio della neutralità di Napoleone III nella guerra austro-prussiana. Prussia e Francia si dichiarano guerra a vicenda, ma l'impero austriaco si allea con quest'ultima, approfittando dei problemi prussiani per conquistare definitivamente la Baviera ed il Württemberg, giacché la Prussia è impegnata altrove. Napoleone III resiste egregiamente in Lussemburgo, quindi Guglielmo primo, vedendo che non riesce a piegare la resistenza francese, decide di conquistare gli ultimi due staterelli germanici ancora formalmente indipendenti, con la scusa di un presunto attacco laterale alle forze di Francia. L'intero mondo germanico è quindi diviso fra regno di Prussia e impero d'Austria, il prestigio di Napoleone III è accresciuto (e quindi niente Comune di Parigi, anche perché non c'è stato alcun assedio), come pure quello della stessa Prussia e soprattutto dell'Austria.
1871: forte dell'acquisizione di nuove terre germaniche, Bismarck, il primo ministro prussiano, promuove la creazione dell'impero tedesco, una monarchia federale costituzionale.
1872: veloce sviluppo industriale in senso capitalistico nella penisola italiana, in Francia, in Scandinavia, nell'impero russo, nel neonato impero tedesco e nell'impero austriaco.
1873: ha inizio un periodo di decadenza economica chiamato Grande Depressione a causa di una sovrapproduzione alla quale non corrisponde un aumento della domanda. Gli stati innalzano barriere doganali per favorire la propria economia.
1875: i Balcani si rivoltano contro il dominio turco.
1876: ha termine il Sessennio democratico, costato fiumi di sangue, e torna la monarchia in Spagna e in Portogallo.
1877: scoppia l'ennesima guerra fra la Russia (che ha come alleate le popolazioni balcaniche) e l'impero ottomano, ma si risolve velocemente a favore della Russia il 3 marzo 1878, poiché stavolta non ha dovuto fronteggiare le altre potenze europee, essendosi con esse già accordata, prevedendo la vittoria. La pace di Santo Stefano sancisce:
• la creazione di una grande Bulgaria, tributaria dell'impero ottomano e tuttavia ampiamente sotto il controllo russo, che si estende dal Danubio fino all'Egeo;
• l'indipendenza di Serbia, Montenegro e Romania;
• la cessione della Bessarabia alla Russia.
La disposizione delle cose, però, dà troppo vantaggio alla Russia, che la Gran Bretagna vede affacciarsi sul Mediterraneo tramite la Bulgaria, mentre l'Impero austriaco vede pregiudicata la sua penetrazione nei Balcani, in quanto la Bosnia-Erzegovina non gli è stata assegnata, come precedentemente pattuito.
Tutto ciò scontentò le grandi potenze partecipanti (beh, Russia esclusa); a giugno, quindi, si tenne il Congresso di Berlino, prima del quale, però, si erano già stabilite alcune alleanze fra la Gran Bretagna e:
• la Russia, con la quale si impegnò a restare neutrale in un eventuale conflitto russo-austriaco in cambio della divisione della Grande Bulgaria;
• l'impero ottomano, a cui promise di difendere i suoi possedimenti in Asia Minore in caso la Russia avesse ottenuto delle acquisizioni in Anatolia, in cambio dell'isola di Cipro;
• l'Austria, che ottenne dalla Gran Bretagna un appoggio economico in caso di guerra contro la Russia e l'approvazione di qualsiasi proposta nei riguardi nella Bosnia-Erzegovina, in cambio del sostegno a favore della divisione della Grande Bulgaria.
Durante il Congresso, dunque, vengono stabilite le seguenti risoluzioni:
• la Grande Bulgaria viene scissa in due parti, una settentrionale (la Bulgaria, indipendente) ed una meridionale (la Rumelia orientale, tributaria dell'impero ottomano);
• la Grecia ottiene la Tessaglia;
• Serbia e Montenegro, che si sono rivolti all'Austria per preservare la propria indipendenza dalla Russia, stringono accordi commerciali con Vienna;
• la Bosnia-Erzegovina non viene formalmente incorporata nell'impero austriaco (gli Asburgo avevano finalmente visto la popolazione tedesca aumentare notevolmente in proporzione rispetto alle altre etnie dei loro domini grazie all'acquisizione degli stati tedeschi durante la guerra franco-prussiana, per cui non ci tenevano a far affluire altri slavi nei propri territori), ma diviene indipendente dall'impero ottomano e stringe accordi economici con Vienna, così come hanno fatto Serbia e Montenegro; questi tre stati, di fatto, si trovano ad essere economicamente satelliti dell'impero austriaco;
• l'Austria, inoltre, ottiene di poter presidiare una zona dell'impero ottomano posta fra Serbia e Montenegro, il Sangiaccato;
• la Russia conferma le sue acquisizioni nell'Anatolia al confine con l'area caucasica, quindi, come da accordi, la Gran Bretagna ottiene Cipro dall'impero ottomano.
Grande trionfatrice del Congresso è, come si può intuire, l'Austria, sebbene questo trionfo le costi l'acuirsi dei contrasti con la Russia; anche i rapporti anglo-russi peggiorano a causa delle rispettive acquisizioni territoriali (che inseriscono nel cosiddetto Grande Gioco, una specie di guerra fredda fra Russia e Regno Unito per il predominio sull'Asia centrale).
1879: l'Impero austriaco, la Serbia, il Montenegro e la Bosnia-Erzegovina stringono un accordo commerciale ufficiale a Trieste, che comporta la caduta delle dogane fra i quattro paesi e anche la fondazione di un Fondo Monetario Austro-Balcanico comune, al quale contribuiscono tutte le nazioni partecipanti secondo proporzioni definite. Ovviamente, l'onere maggiore va all'Impero d'Austria, ma quest'ultimo ne ricava, in cambio, oltre ai vantaggi economici, anche una forte amicizia con i tre paesi slavi, la quale le potrà tornare utile in caso di scontro con la Russia.
1877-1885: gli interessi europei verso il continente africano si intensificano, in particolare a causa dell'acquisizione, più o meno dichiarata, del territorio congolese da parte di Leopoldo II del Belgio. Inoltre, anche i Borbone di Napoli e i Savoia cominciano a mostrare qualche interesse per l'Africa, se non altro per le sue aree settentrionali, per non parlare dei mai cancellati disegni della Francia, dei sogni di grandezza dell'Impero germanico e così via.
Per questo, nel 1885 viene convocata la Conferenza di Berlino, principalmente per volere dell'Impero germanico e della Francia, la quale stabilisce fondamentalmente le modalità di sviluppo del commercio, anche se sancisce il possesso belga del Congo e la libera navigabilità di tutti i fiumi. Non essendo però riuscito alcun accordo per quanto riguarda le modalità di colonizzazione dell'Africa, dichiarata res nullius, inizia una "corsa" per la conquista del continente alla quale parteciperanno l'Impero germanico, la Francia, il regno sabaudo d'Italia, i Borbone, l'Impero austriaco, la Gran Bretagna, il Portogallo e la Spagna.

1886: viene inaugurata la Statua della Libertà; il pontefice Leone XIII, con l'enciclica Dei filii, esorta tutta la cristianità a trattare più umanamente le popolazioni delle proprie colonie. I Savoia e i Borbone di Napoli sono i possessori di colonie più toccati dall'accorato appello papale e sono i primi a concedere qualche diritto agli indigeni, come il diritto di essere assistiti in caso di malattia e di essere difesi dalla polizia in caso di soprusi. La Spagna e il Portogallo non concedono diritti, ma invitano i propri compatrioti nelle colonie a trattare un pochino meglio gli abitanti del luogo.
1888: l'imperatore d'Austria approfitta del colonialismo per deportare in Africa un gran numero di abitanti dell'impero non germanici, allo scopo di affermare ancora una volta la predominanza tedesca nei territori dell'impero. Fra tutti, solo gli ungheresi riescono ad opporre una resistenza degna di questo nome alla politica imperiale: iniziano a scoppiare i primi tumulti, ma l'imperatore Francesco Giuseppe, consigliato dalla moglie Elisabetta di Baviera (la celeberrima "Sissi"), risolve la questione concedendo un parlamento proporzionale con il potere di rifiutare leggi proposte dall'imperatore ed eventualmente di modificare quelle esistenti, però solo con il consenso dell'imperatore. I seggi, in proporzione, appartengono: per il 42% alle genti germaniche di varie nazionalità (austriaci, bavaresi, eccetera); per il 27% alle genti ungheresi; per il 20% alle genti boeme; per l'11% a genti delle altre nazioni presenti nell'impero (italiani, sloveni, croati, eccetera). Francesco Giuseppe, inoltre, promette di far cessare le deportazioni in terra d'Africa.
1889: l'impero d'Austria stringe accordi commerciali più stretti con l'impero di Prussia, con particolare attenzione sui possedimenti extra-europei. Si iniziano a pianificare grandi opere nelle colonie dei due paesi da compiersi in comune: sarà questo uno dei motivi scatenanti della prima guerra euro-africana; viene inaugurata la Torre Eiffel.
1889-1898: un lungo periodo di pace, in Europa, fa spazio al Novecento. Il Vecchio Continente ha goduto di tale pace in virtù degli impegni coloniali che hanno tenuto occupati molti dei suoi stati e nel 1898 l'occupazione dell'Africa è ormai completa e organizzata (mappa dell'Africa 1898). Proprio a causa dell'Africa, nascono dei contrasti: come si può notare dalla mappa, in Africa Orientale un sottile lembo di territorio savoiardo impedisce alle colonie prussiane e austriache della zona di toccarsi, ciò che è causa di tensioni diplomatiche fra i due imperi ed il piccolo regno d'Italia; questi tre possedimenti, poi, impediscono alle terre inglesi di toccarsi, attraversando così l'intero continente senza interruzioni; la Francia possiede un'enorme zona dell'Africa centro-settentrionale (nonché il Madagascar), ma è più fumo che sostanza, perché gran parte del territorio incluso in tale zona è del tutto desertico. Ad ogni modo, la Francia vorrebbe eliminare tutte le altre potenze coloniali dal golfo di Guinea, ovvero Gran Bretagna, Austria, Borbone di Napoli e Savoia; anche il Portogallo è in tensione con la Gran Bretagna, perché in tal caso sono i possedimenti inglesi che impediscono a quelli portoghesi di toccarsi, in Africa Meridionale; infine, la Spagna desidererebbe espandere i propri domini africani a scapito di quelli francesi.
Ma i problemi non ci sono solo nel Continente Nero: ci sono contrasti anche riguardo questioni europee, poiché nessuno vede di buon occhio le sempre migliori relazioni fra Impero d'Austria e Impero germanico, le due compagini statali più forti dell'Europa centrale; peraltro, la Russia non riesce neppure a tessere relazioni abbastanza forti e vantaggiose con i Balcani, a causa degli accordi commerciali fra l'Austria, la Bosnia, la Serbia e il Montenegro.
Prevedendo una guerra e avendo ormai più interessi in Africa che altrove, la Spagna vende Porto Rico e Guam agli Stati Uniti per la somma di 18 milioni di dollari, ai quali se ne aggiungono altri cinque, dati dagli Stati Uniti per avere mano libera a Cuba, la quale ottiene formale indipendenza, ma in realtà è tenuta in pugno dagli USA.
1899: iniziano a formarsi delle alleanze in previsione di una guerra. Nella penisola italiana, i Savoia, il papa e i Borbone di Napoli stringono il Patto Difensivo Italiano, allo scopo di tutelarsi in caso di invasione straniera. I rapporti franco-savoiardi, infatti, si sono alquanto raffreddati per via dei possedimenti dei Savoia nel golfo di Guinea, ma anche i Borbone non sono in amicizia con l'imperatore Napoleone IV, sempre per via dei propri possedimenti nel golfo di Guinea. Il Patto Difensivo Italiano prevede poche, ma tassative clausole per i membri:
• mutuo soccorso in caso di invasione straniera nella penisola (possono ancora farsi la guerra fra di loro);
• elezione di un comandante generale delle truppe del Patto Difensivo Italiano una volta ogni cinque anni;
• creazione di un Fondo Comune Italiano per sovvenzionare le azioni del Patto Difensivo Italiano. La scelta per la sede di questo fondo è complicata, ma alla fine viene fissata a Firenze.
Il primo comandante generale del Patto Difensivo Italiano è Cesare Porto, pontificio di Perugia.
In Europa vengono a formarsi due gruppi di alleanze che comprendono quasi tutti gli stati del continente.
Da una parte c'è l'alleanza di Sebastopoli, che all'inizio viene stipulata fra Impero russo e Impero ottomano per contrastare la potenza germanica nei Balcani; a questi due si aggiunge poi la Francia, che vuole combattere l'influenza germanica nel centro Europa. Infine ci sono la Romania, che partecipa in quanto stato satellite della Russia, e il Portogallo, che fa parte dell'alleanza sperando di riuscire a strappare alla Gran Bretagna abbastanza terre africane da fare in modo che i propri possedimenti nel Continente Nero si tocchino.
Dall'altra parte c'è l'alleanza di Baviera, stipulata all'inizio fra Impero germanico e Impero d'Austria, ai quali poi si aggiungono: la Gran Bretagna, per spirito di contraddizione verso la Francia e per i cattivi rapporti con la Russia; la Spagna, che in seguito alla rottura delle contrattazioni per l'acquisto di terre francesi in Africa spera così di ottenerle con la forza; la Grecia, che spera di strappare ulteriori terre agli ottomani, cosa che non riuscirebbe a fare da sola; più i vari staterelli balcanici nell'orbita austriaca.
1900, marzo: l'intera Europa è alla ricerca di un casus belli ed è l'Impero ottomano a fornirlo, cercando di togliere all'Austria il diritto di presidiare il Sangiaccato (la sottile striscia di territorio ottomano che separa la Serbia dal Montenegro), ottenuto nel 1878. In pochi giorni, Vienna dichiara guerra a Costantinopoli e si attiva tutto il meccanismo di alleanze del continente: per farla breve, ogni membro dell'alleanza di Sebastopoli dichiara guerra a ogni membro dell'alleanza di Baviera.
La Francia è il paese che da subito appare più in difficoltà, essendo impegnato su tre fronti: al confine con la Spagna, al confine con gli imperi della nazione germanica e a nord, con la Gran Bretagna. Riesce a cavarsela bene fino a quando la Spagna, dopo la battaglia di Valverde (17 maggio 1902) non ha ragione dell'ingombrante vicino, il Portogallo. Mentre le forze portoghesi si riorganizzano nell'interno del paese, la Spagna attacca i possedimenti francesi nel nord dell'Africa, con l'aiuto di alcune navi inglesi. La madrepatria non può inviare rinforzi e quindi con la battaglia di Tenez (6 giugno 1902) le forze francesi in Africa sono costrette a ripiegare su Algeri; intanto, la Francia riesce ad ottenere una vittoria sugli inglesi nella battaglia della Manica (7 giugno 1902), ma la pressione germanica è sempre più forte.
L'Impero austriaco, con gli stati balcanici satelliti e la Grecia, sconfigge ripetutamente l'Impero ottomano, respingendone l'esercito fin quasi a Costantinopoli, ma, prima di sferrare l'attacco finale, le forze russe stanziate in Romania e quel che rimane delle forze ottomane infliggono alla fazione austriaca una sonora sconfitta nella battaglia di Adrianopoli (2 luglio 1901), per cui gli austriaci tornano indietro fino in Macedonia, dove preparano il contrattacco; la Grecia occupa il territorio ottomano europeo fin quasi alla penisola
Calcidica.
Il fronte russo-germanico è più ribollente che mai. L'esercito dello zar tiene duro e riesce a impedire che prussiani e austriaci penetrino seriamente nel territorio. Nelle battaglie di Vilnius prima e di Lublino dopo, infligge pesanti sconfitte a Vienna e a Berlino, costringendole a ordinare la ritirata. Questo dà un po' di respiro sia all'Impero ottomano che soprattutto alla Francia, e per quanto sussista il blocco dei porti settentrionali francesi da parte della Gran Bretagna sembra che la guerra volga a favore dell'alleanza di Sebastopoli, sennonché la già citata sconfitta portoghese ed il conseguente attacco spagnolo alle terre francesi d'Africa vibrano un colpo molto duro alla Francia, che, dopo la altresì già citata battaglia della Manica, non ottiene più risultati degni di nota.
A causa della sostanziale inerzia francese, i due imperi della nazione germanica possono tornare a rivolgere il pieno delle loro forze contro l'Impero russo e il debole Impero ottomano. Quest'ultimo capitola in pochi giorni, dopo che le truppe austro-greche sono arrivate a ridosso di
Costantinopoli; l'Impero russo, trovandosi solo, dopo una situazione di stallo durata un paio di mesi, si dichiara disponibile a trattare per la pace.
In tutto questo, i membri del Patto Difensivo Italiano non vengono quasi coinvolti, a parte la richiesta austriaca fatta ai Savoia di attaccare la Francia e la richiesta francese fatta ai Borbone di aiutare gli ottomani contro gli austriaci nella penisola balcanica, entrambe
rifiutate perché gli stati italiani non volevano imbarcarsi in un'impresa così grande, e per di più confidavano nel Patto Difensivo Italiano per scongiurare ogni minaccia di invasione. Per quanto riguarda il papato, Leone XIII chiese all'Europa di porre fine alle ostilità, cosa che non ottenne alcun risultato. Pur tuttavia, il papa visse abbastanza per vedere la firma dell'armistizio di
Königsberg (15 aprile 1903), il quale stabilisce:

• la limitazione delle terre ottomane in Europa all'area circostante Costantinopoli. Le terre perdute si dividono fra le acquisizioni greche, montenegrine e serbe, oltre alle piccole repubbliche di Albania e di Macedonia del Nord, appena nate;
• la cessione dell'Africa mediterranea francese alla Spagna, area che poi è stata "scambiata" per la zona marocchina;
• l'ingrandimento dei domini inglesi sul golfo di Guinea a scapito della Francia;
• l'ingrandimento deii domini austriaci sul golfo di Guinea, sempre a scapito della Francia. Tali domini giungono a circondare completamente quelli borbonici nella medesima zona;
• la cessione di alcune aree dell'Africa portoghese all'Impero germanico.

1904: mentre gli stati scandinavi accarezzano l'idea di un patto difensivo tipo quello italiano, scoppia la rivoluzione in Francia e nell'Impero ottomano. Dopo convulse vicende, in Francia Napoleone IV viene deposto e viene proclamata la repubblica il 24 febbraio, mentre la rivolta ottomana si trascina fino al 4 novembre, quando, esiliato l'ultimo sultano, l'impero si divide: la parte europea, per quanto piccola, costituisce la Repubblica di Rumelia, mentre la parte asiatica è divisa fra la Repubblica anatolica, che comprende il Vicino Oriente e aree contingue, e vari staterelli retti da principi locali.
Questi due avvenimenti alimentano i focolai di rivolta che si erano già formati nell'Impero russo e una moltitudine di popolani russi marcia pacificamente verso il Palazzo d'Inverno a San Pietroburgo il 19 dicembre, chiedendo di vedere lo zar. Questi, impressionato, acconsente di ascoltare le richieste di un delegato del suo popolo, il quale viene trattenuto presso l'autocrate per tre ore, dopo le quali viene licenziato dallo zar con promesse che vengono prontamente mantenute: l'imperatore forma un parlamento (consultivo), toglie alcuni diritti ai nobili (tra i quali lo ius vitae necisque sui propri coloni), impone a questi nuove tasse e dà inizio ad un periodo di pugno di ferro contro la corruzione e la violenza della polizia.
La Grecia, già che c'è, compra Creta dalla neonata Repubblica anatolica.
1905: l'unione personale fra il regno di Norvegia e il regno di Svezia ha termine.
1906: anno che in seguito verrà detto "delle unioni". Le repubbliche di Macedonia del Nord e d'Albania chiedono e ottengono di essere ammesse nel Fondo Monetario Austro-Balcanico; iniziano i lavori per una rete
ferroviaria che colleghi fra loro tutti i membri. Il piano austriaco sarebbe stato di arrivare fino all'Egeo, ma purtroppo niente da fare, per ora.
L'Impero austriaco stringe con l'Impero germanico il Patto di Francoforte, che impegna entrambe le parti a sostenersi a vicenda in caso di guerra (in pratica è un'alleanza perpetua), e inoltre afferma gli accordi economici già raggiunti.
Il regno di Grecia e le repubbliche anatolica e di Rumelia siglano a loro volta un accordo commerciale cui verrà dato il nome di Accordo Egeo.
I tre regni scandinavi stringono il Concordato Scandinavo, con il quale si impegnano ad aiutare un membro in caso di invasione straniera, sul modello del Patto Difensivo Italiano.
Infine, gli stati italiani siglano l'Accordo Commerciale di Roma, con il quale si impegnano a cooperare economicamente per il benessere di tutti.
Sia l'Impero austriaco e quello germanico che i Savoia e i Borbone di Napoli progettano grandi opere in comune nei possedimenti africani.

1908: dopo le dovute trattative, il regno d'Italia e il regno di Napoli siglano con il regno del Belgio l'atto di compravendita della sottile striscia di litorale del Congo belga che separa le colonie savoiarde e borboniche di quella zona. Questa sottile striscia e un pezzetto del territorio borbonico si aggiunge alla colonia dei Savoia, per compensarla della zona perduta in favore del Belgio, che certo non poteva rinunciare allo sbocco sul mare, per quanto lo pagassero.
1908-1909: guerra russo-giapponese. In seguito ad una crisi diplomatica, scoppia la guerra fra Impero giapponese e Impero russo. Dopo sanguinose battaglie, la vittoria arride alla Russia, che può occupare la Manciuria, parte della Corea del Nord e la penisola di Liaodong. Rasputin perde gran parte del suo favore presso la famiglia imperiale a causa dei suoi commenti negativi sulla la decisione dello zar di prendere le armi e, soprattutto, di una velata derisione dei risultati ottenuti.
1910: la Persia invade una parte dell'ex-territorio ottomano, approfittando dell'intrinseca debolezza degli staterelli della zona, incapaci di coalizzarsi contro il nemico.

1911-1916: anni molto intensi in campo diplomatico. I rapporti fra Impero Germanico e Gran Bretagna si sono alquanto raffreddati a causa dello sviluppo della potenza navale tedesca, sicché Francia e Regno Unito giungono a fare l'impensabile: si alleano. La Francia, dal canto suo, è molto ostile ai due imperi germanici a causa della sconfitta subita agli inizi del secolo e vorrebbe dar loro pan per focaccia. Aspira inoltre a liberarsi dell'influenza austriaca sul golfo di Guinea (anche di quella inglese, ma tanto per cominciare...). Memore delle grane che le ha dato la Spagna durante la prima guerra euro-africana (1900-1903), ne cerca l'alleanza, ma la Spagna preferisce la neutralità, che assicura in cambio di modestissime acquisizioni territoriali in Africa; il Portogallo, invece, è ben felice di allearsi contro l'Impero germanico nella speranza di ottenere nuove terre nel Sud dell'Africa. L'alleanza prende il nome di alleanza del Lussemburgo e vi entrano sia il regno d'Italia che i regni di Napoli, Sicilia e Sardegna, perché i domini savoiardi nell'Africa orientale sono sotto la pressione dei possedimenti tedeschi e austriaci in quella zona, mentre i domini borbonici sul golfo di Guinea sono accerchiati e angustiati da quelli austriaci, che li circondano.
L'Impero austriaco e l'Impero germanico, oltre a riconfermare la propria alleanza sancita dal Patto di Francoforte e ad allargarlo agli stati satellite dell'Austria (Bosnia, Montenegro, eccetera), cercano e ottengono l'assicurazione di neutralità da parte della Russia in cambio dell'impegno, da parte degli Asburgo, di non avanzare mai pretese di alcun genere su Romania e Bulgaria e di non prendere le armi contro lo zar in caso di interventi armati in questi due paesi.
1916, 24 aprile: il casus belli è fornito dall'Impero austriaco, che sorpassa il confine dei possedimenti borbonici sul golfo di Guinea e in breve tempo causa la rottura dei rapporti diplomatici con il regno di Napoli; le alleanze si attivano e tutti si schierano come prestabilito.
L'Impero germanico attacca la Francia sul fronte lussemburghese, riuscendo facilmente a penetrare all'interno del territorio francese per parecchi chilometri, ma viene fermato a Thionville (9 maggio 1916) e i due eserciti si trovano in sostanziale stallo per parecchio tempo.
La Gran Bretagna, intanto, ingaggia una feroce lotta navale contro i tedeschi e le viene inflitta una sonora sconfitta al largo dell'Olanda (16 maggio 1916), quindi la Royal Navy è costretta a ripiegare.
L'Impero austriaco attacca il regno d'Italia, mentre gli stati balcanici satelliti compioni incursioni piratesche nel regno di Napoli approfittando della loro posizione. I Borbone, fedeli al Patto Difensivo Italiano, inviano il grosso delle proprie truppe a combattere al fianco dei Savoia; anche il papa Benedetto XV dà il proprio contributo, per quanto abbia cercato in tutti i modi di mantenere la pace con accorati appelli a tutta l'Europa; infine, un piccolo contingente francese si aggiunge alle truppe della penisola. L'esercito austriaco si ritrova quindi, poco dopo il confine del proprio paese, alle prese con un confronto militare piuttosto aspro.
In Africa, intanto, i domini dell'Impero tedesco nel Sud del continente sono invasi sia dal Portogallo, che può impegnarsi a fondo nel Continente Nero non potendo essere colpito in madrepatria, così lontano dalle nazioni delle genti germaniche, che dalla Gran Bretagna, ben affermata in quelle zone.
Francesi e inglesi aiutano i Borbone sul golfo di Guinea, riuscendo a respingere gli austriaci all'interno dei loro territori.
Nel 1917, la Gran Bretagna sferra un nuovo attacco navale all'Impero germanico e stavolta ha la meglio, riuscendo a respingere i nemici fin dentro i porti, che poi occupa nei mesi seguenti.
L'esercito francese, guidato da un diretto discendente dei re di Francia, Luigi XXI, al grido di "Vive Paris, vive la France!" attacca i tedeschi riuscendo a cacciarli dal paese (29 marzo 1917). A questo punto l'Austria si vede costretta a portare aiuto all'alleato, diminuendo l'impegno sul fronte italiano e attaccando in Lorena. La Francia sposta quindi il grosso delle sue truppe sul fronte austriaco e perciò l'Impero germanico tenta di invadere la Danimarca, ciò che sembra l'unica possibilità per continuare ad attaccare via mare il Regno Unito, a causa del blocco dei porti. Purtroppo per i tedeschi, in base al Concordato Scandinavo le forze militari di Norvegia e Svezia si mobilitano per portare aiuto alla Danimarca, per cui le truppe tedesche vengono ancora una volta respinte nella battaglia dello Jutland (14 ottobre 1917).
Nel 1918, la situazione volge nettamente a favore dell'alleanza del Lussemburgo: l'Impero germanico viene invaso da truppe inglesi, i francesi tengono sotto scacco gli austriaci e il regno d'Italia e di Napoli attaccano a più riprese nell'Italia austriaca; in Africa orientale, Savoia e inglesi si mantengono saldi nelle zone delle genti germaniche, mentre la Francia compie brevi incursioni dalle basi del Madagascar; sul golfo di Guinea, gli austriaci sono ormai ridotti all'impotenza; in Africa meridionale, inglesi e portoghesi hanno il controllo di una buona parte dei possedimenti dell'Impero tedesco.
La svolta avviene con la battaglia di Ribe (17 settembre 1918), quando i tedeschi riescono a sfondare le difense scandinave e ad occupare quasi tutto lo Jutland: la popolazione danese della zona si trasferisce nelle isole vicine. A questo punto l'Impero germanico può attaccare nuovamente il Regno Unito con la propria marina e il 3 dicembre 1918 metà delle forze di occupazione inglesi nei porti tedeschi viene distrutta, complice una tempesta; ciò che ne resta riepiega in una zona dello Jutland ancora sotto il controllo danese, per poi tornare in madrepatria.
Gli austriaci, nella battaglia di Sondrio (25 settembre 1918) infliggono una sonora sconfitta alle forze italo-francesi. I membri dell'alleanza del Lussemburgo, allarmati, sospendono le operazioni in Africa e dopo poco prendono la stessa risoluzione anche l'Impero austriaco e quello germanico, per raccogliere le forze e sferrare l'attacco finale.
L'anno 1919 è d'importanza cruciale: le truppe d'Africa sono tornate quasi tutte in Europa e tutti si preparano a porre fine alla guerra.
L'Impero germanico ritira le truppe dallo Jutland per concentrarle sul fronte francese, mentre l'Impero d'Austria convince i paesi balcanici a creare un diversivo sulle coste adriatiche della penisola italiana, cosicché le truppe del Patto Difensivo Italiano sono occupate a difendere quelle zone dai contingenti illirici e gli austriaci possono spostare gran parte dei soldati impegnati sul fronte italiano al confine con la Francia. A Metz (6 aprile 1919) i francesi volgono in fuga dinanzi agli eserciti nemici, cosicché gli austro-germanici arrivano sino alle porte di Parigi. Per la Francia sembra la fine, ma l'orgoglio parigino è risvegliato dal grido di Luigi XXI (ancora lui!) "Vive Paris, vive la France!", al quale fu risposto "Et vive le roi!". A pochi chilometri da Parigi, il 10 aprile 1919, l'esercito francese e una nutrita guarnigione inglese attaccano e sconfiggono gli eserciti delle genti germaniche, i quali, dopo essere stati battuti, vengono inseguiti e scacciati nuovamente nell'Impero germanico e in quello austriaco.
Nei territori pontifici, precisamente presso Rimini (21 aprile 1919), l'esercito del Patto Difensivo Italiano sconfigge gli eserciti balcanici, demoralizzati dalla notizia della batosta subita dal loro patrono, l'Impero d'Austria.
La guerra termina il 2 maggio 1919 con l'armistizio di Londra, dopo che Berlino è stata quasi raggiunta e attaccata dalle truppe franco-inglesi e che la Danimarca ha mobilitato il suo piccolo esercito per compiere azioni diversive nello Schleswig-Holstein, mentre l'Austria era stata attaccata dai Savoia e dai Borbone.
Le clausole della pace stabiliscono:
• il pagamento di un'indennità di guerra alla Danimarca da parte dell'Impero germanico (la Danimarca chiedeva la restituzione dello Schleswig-Holstein, ma le potenze europee rifiutano per evitare di dare a Berlino un altro motivo di vendetta);
• la spartizione dell'Africa sudoccidentale tedesca fra Portogallo e Gran Bretagna;
• acquisizioni territoriali inglesi e portoghesi in Africa sudorientale a scapito dell'Impero germanico;
• acquisizioni territoriali inglesi e savoiarde nell'Africa orientale a spese di Austria e Prussia;
• riduzione dei domini austriaci sul golfo di Guinea a favore di Francia e regno di Napoli.
Il Regno Unito, in seguito, compra dal regno d'Italia una parte delle sue proprietà coloniali in Africa orientale, sicché le aree inglesi si toccano, mentre la Francia tiene fede ai propri impegni con la Spagna e le dà le aree africane promesse. Inoltre, com'era prevedibile, Luigi XXI viene acclamato re di Francia.

1919-1932: i motivi di conflitto europei si estinguono e il Vecchio Continente prospera più che mai. Gli anni Venti sono un decennio d'oro per l'Impero russo, dove Nicola II cede il trono al figlio Alessandro III nel 1922, perché lo zar è un po' attempato e sempre più debole. Il nuovo autocrate russo promuove una politica di pacificazione fra nobiltà e popolo, riuscendo a dominare la prima con determinazione e con l'aiuto di truppe scelte fra borghesi e, soprattutto, contadini. C'è qualche disordine, ma niente di grave.
I rapporti fra gli stati italiani, l'Impero d'Austria e quello germanico migliorano notevolmente. Una volta smaltito il rancore per la sconfitta, le relazioni hanno potuto ristabilirsi, e, se da una parte i Savoia hanno venduto una parte dei loro territori in Africa Orientale ai due imperi tedeschi perché si tocchino, mentre l'Impero austriaco e i Borbone di Napoli compiono opere importanti nei loro domini africani sul golfo di Guinea.
La Francia e il Regno Unito hanno inaugurato con l'alleanza della Seconda guerra euro-africana un'amicizia che nessuno si sarebbe mai aspettato, unendo le loro incredibili forze economiche e coloniali in un organismo potente e prospero.
1934: in seguito ad una crisi diplomatica, la Russia invade e annette la Romania, nel sostanziale disinteresse di tutte le potenze europee (solo l'Austria avrebbe avuto qualcosa da dire, ma si era impegnata a restare neutrale e non aveva voglia di inimicarsi Mosca).
1935-1938: proteste in Polonia, Finlandia, Romania e Caucaso. Alessandro III, convocati i capi delle fazioni avverse al potere centrale dei rispettivi paesi, vi parlamenta per una settimana intera, e infine decide di creare, all'interno dell'Impero russo, le regioni autonome di Polonia, Finlandia, Georgia e Armenia. Solo la Romania è esclusa da tutto questo perché conquistata di fresco: ulteriori proteste si spengono nel nulla, non essendo più supportate da altre zone dell'impero.
1939: papa Pio XII esorta ancora una volta i possessori di colonie ad essere più umani nei confronti degli abitanti dei propri domini, mentre i missionari si fanno in quattro per aiutarli. Il regno di Napoli, il regno d'Italia, la Spagna, il Portogallo e l'Impero austriaco recepiscono meglio degli altri il messaggio, dando inizio ad una politica di "umanizzazione" dell'amministrazione coloniale.
1942: viene fondata a Roma l'Associazione Internazionale per i Diritti dell'Umanità, che si propone come primo obiettivo un equo trattamento dei popoli colonizzati.
1942-1960: l'azione dell'Associazione Internazionale per i Diritti dell'Umanità culmina nel settembre 1960, quando tutti gli stati possessori di colonie ratificano un accordo che prevede la concessione agli abitanti della zona dei medesimi diritti di cui godono i colonizzatori europei, meno quello di voto.
(tratta da questo sito)
.
Per farci sapere che ne pensate, scriveteci a questo indirizzo.
