
Entriamo nel giardino botanico...
storia e simbologia delle
specie vegetali a noi più (o meno) note
acacia − agar-agar − agrifoglio − albero di Giuda − albicocca − aloe − amaranto − ananas − anguria − arachide − asparagi − avocado − banana − baobab − cacao − caffé − canapa − carciofo − cardo − carota − carrubo − castagna − cavolo − cedro − chia − ciliegia − cipresso − coriandolo − crisantemo − digitale − edera − fico − finocchio − frassino − frutto della passione − giglio − ginestra − goji − gombo − henné − incenso − issopo − jicama − karkadè − kiwi − litchi − lino − loglio − mais − mandarino − mandorlo − mandragora − mango − manioca − mela − melanzana − melograno − mirto − nespola − noce − nontiscordardimè − origano − palma − papaia − papavero − papiro − patata − pepe − peperone − pesca − pioppo − pomodoro − prugna − quercia − rosmarino − salice − seitan − sequoia − sicomoro − tabacco − tè − tiglio − tofu − ulivo − vischio − vite − wasabi − ximenia − yucca − zucca

Il tubero nemico del sole
Cominciamo con la patata, nome scientifico Solanum
tuberosum, appartenente alla famiglia delle Solanaceae. Non si conoscono varietà
spontanee, né si sa da quale specie originaria di Solanum si sia originata la
patata odierna. Coltivata in tutto il mondo dalle zone temperate a quelle
subtropicali, in condizioni climatiche molto differenti, riveste particolare
importanza nei climi temperati, tanto da rappresentare una delle più importanti
colture non cerealicole. I suoi tuberi possono essere utilizzati come alimento
base, come raccolto da reddito, come mangime per animali e come fonte di amido
per molti usi industriali. Oggi è coltivata in oltre 150 paesi, che hanno
prodotto 75 milioni di tonnellate su 360 miliardi di ettari: Cina, India,
Ucraina, Russia e Stati Uniti d'America rappresentano il 53% della produzione.
Quando arrivò dalle Americhe (pare già con il primo viaggio di Colombo),
tuttavia, fu catalogata come pianta
velenosa e sconsigliata, nonostante i nativi americani la consumassero senza
problemi di sorta, e tale rimase fino al '700. Come mai? Il fatto è che il suo
tubero contiene la solanina (infatti la patata appartiene alla famiglia delle Solanacee) che, se esposta al sole, si decompone in sostanze tossiche, che
possono dare gravi disturbi. Evidentemente i primi contadini spagnoli tenevano i
mucchi di patate al sole, sbagliando. Nel '700 però ci si rese conto
dell'errore, le patate cominciarono ad essere conservate al buio e al fresco dei
sottoscala o delle cantine, e tutto cambiò. La patata divenne la base
dell'alimentazione di molti popoli, tanto che, quando nell'800 una malattia
delle patate distrusse i raccolti in Irlanda, mezzo milione di irlandesi morirono
di fame, e un milione furono costretti ad emigrare negli USA, tra cui gli
antenati del futuro Presidente Kennedy (la regina Vittoria donò di tasca sua
5.000 sterline alla popolazione bisognosa, nonostante non fosse particolarmente
amata dagli irlandesi).

Le radici viola
La carota è una pianta erbacea dal
fusto di colore verde appartenente alla famiglia delle Apiaceae (un tempo note
come Ombrellifere), il suo nome scientifico è Daucus carota ed è diffusa in
Europa, in Asia e nel Nord Africa. Le carote moderne vennero domesticate e
coltivate per la prima volta in Afghanistan circa 5000 anni fa. Non è certo che
i Romani la conoscessero: in un affresco su un muro di una taverna ad Ostia
Antica tornata di recente alla luce è visibile una radice (più precisamente si
parla di "fittone") con la forma di una carota, ma è più probabile che si tratti
di una pastinaca, chiamata anche carota bianca, una varietà meno pregiata. Il
famoso gastronomo Apicio infatti ci ha tramandato diversi modi per cuocere la
pastinaca. Di certo sappiamo che le carote odierne, dolci e croccanti, furono
introdotte nel bacino del Mediterraneo dagli Arabi: arrivarono in Spagna nel XII
secolo, in Italia nel XIII, in Francia nel XIV e in Inghilterra nel XV. Oggi è
possibile trovare al supermercato delle carote viola, le ho trovate anch'io al Tigros non lontano da casa; molti le schifano, credendole opera di ingegneria
genetica, e quindi catalogandole tra i tanto demonizzati OGM (ed invece sono
stati prodotti per il bene dell'umanità, come i vaccini). Chissà cosa direbbero
se sapessero che quello era il colore originario delle carote vere e proprie.
Come racconta Dario Bressanini in uno dei suoi libri, nei quadri dei pittori
fiamminghi del '400 si vedono già le carote sui banchi del mercato, ma sono
tutte carote viola, tendenti al nero! Nessuna ingegneria genetica, magari
orchestrata dagli alieni per conto di Bill Gates: un giorno dal suo orto un
contadino estrasse per puro caso delle carote gialle, nate così per una casuale
mutazione genetica che aveva prodotto un'abbondanza di carotenoidi, ed ebbe il
buon senso di non buttarle via, ma di assaggiarle. Trovatele ottime, cominciò a
trapiantarle, a riprodurle, ad incrociarle, fino a che il viola sparì o quasi,
soppiantato dal giallo delle carote moderne, che si impose rapidamente sul
mercato. Le carote viola oggi hanno ancora scarso mercato, guardate con sospetto
per i motivi che ti ho elencati sopra. Ma forse, un giorno...

La drupa di Cerasunte
Tecnicamente la ciliegia è una drupa,
un frutto con una parte carnosa che circonda un nocciolo coriaceo. Il termine
inglese (cherry), quello tedesco (kirsche), il francese (cerise), il portoghese
(cereja), lo spagnolo (cereza), il lombardo (scirées), il piemontese (ciresa),
il veneto (saresa), il friulano (cjariese), il siciliano (cirasa) derivano tutti
dall'antico francese o lingua d'oil cherise, a sua volta disceso dal greco κέρασος (kérasos), che s riferisce all'antica città di Cerasunte nel Ponto, oggi Giresun in Turchia, da cui,
secondo Plinio il Vecchio, Lucullo (quello dei
famosi pranzi) importò a Roma nel 72 a.C. i primi alberi di ciliegio. L'areale
indigeno della ciliegia si estende attraverso la maggior parte dell'Europa,
dell'Asia occidentale e parti dell'Africa settentrionale, e il frutto è stato
consumato sin dalla preistoria, come testimoniano i reperti archeologici. Le
ciliegie sono arrivate in Nord America fin dal primo insediamento dell'attuale
New York, ancora chiamata Nieeuw Amsterdam, quando ancora era sotto la sovranità
olandese: il primo contratto d'acquisto di varie piante da frutto, tra cui 73
ciliegi, a opera di un certo Cornelius van Tienhoven, è datato 18 giugno 1639!
Il frutto può nascere da due diverse specie di alberi: il ciliegio dolce (Prunus
avium), che produce le ciliegie che siamo abituati a consumare come frutta
fresca, e il ciliegio acido (Prunus cerasus), che produce amarene, visciole o
marasche, da usare in gastronomia (leggi gelato alla panna variegato amarena, o
il famoso liquore chiamato maraschino). Distillando il succo di ciliegie si
ottiene un noto liquore, lo cherry; e nel preludio della famosa opera di Pietro
Mascagni "Cavalleria Rusticana" si sente Compare Turiddu intonare: « O Lola
ch'ai di latti la cammisa / si bianca e russa comu la cirasa... » Oggi il primo
produttore mondiale è la Turchia, seguita dagli USA. In Italia sono diffuse due
categorie di ciliegie: i duroni, più grandi e scuri, e le tenerine, più chiare e
piccole. La ciliegia ha addirittura un suo santo protettore: San Gerardo dei
Tintori, copatrono di Monza, che si festeggia il 6 giugno! Secondo uno studio
della Michigan State University, le antocianine contenute in elevate quantità
nelle ciliegie inibiscono la cicloossigenasi, enzima che risponde ai processi
infiammatori segnalando la sensazione di dolore; insomma, esse agiscono in modo
simile all'aspirina, ma senza però effetti collaterali. Le antocianine hanno
inoltre un'azione antiossidante. Secondo un altro studio della stessa
università, una dieta ricca di ciliegie avrebbe dimostrato di poter ridurre i
fattori di rischio associati a malattie cardiache e diabete di tipo due nei
ratti; che abbiano tali effetti benefici anche sull'Homo sapiens non è
dimostrato, ma non ci sarebbe da stupirsene, a patto naturalmente di non farne
indigestione perchè, come dice il proverbio, una ciliegia tira l'altra...

La pesca del lupo
Il pomodoro tecnicamente è una bacca,
nativa dell'America Meridionale tra Ecuador e Perù, anche se i più lo ritengono
di origine messicana, perchè i primi a coltivarlo in maniera intensiva furono
gli Aztechi, che lo chiamavano xitomatl. Ad introdurlo in Europa sarebbero
stati i reduci del famigerato sterminatore seriale Hernán Cortés, verso il 1540,
mentre in Italia arrivò per la prima volta non a Napoli ma a Pisa, il 31 ottobre
1548, quando Cosimo de' Medici ricevette in regalo un cesto dei pomodori nati da
semi a loro volta donati alla moglie, Eleonora di Toledo, dal padre, Viceré del
Regno di Napoli. Il termine pomodoro risale al botanico senese Pietro Andrea
Mattioli che nel 1544 lo definì "mala aurea", e da qui in italiano "pomo d'oro",
perchè le bacche all'epoca erano piccole e di color oro; solo in seguito,
tramite incroci, i frutti divennero rossi e sugosi. Invece i francesi lo
chiamarono pomme d'amour, "pomo d'amore", perchè si riteneva avesse proprietà
afrodisiache (ma io non me ne sono mai accorto). Nel 1640 la nobiltà di Tolone
regalò al famoso cardinale Richelieu quattro piante di pomodoro come atto di
ossequio, e sempre in Francia era usanza per gli uomini offrire piantine di
pomodoro alle dame, come atto d'amor cortese. Inizialmente si pensò che fosse
una pianta velenosa, come molte altre portate dall'America, tuttavia venne
coltivata come pianta puramente decorativa, e così nel seicento potevi vedere
tanti pomodori ciliegini che adornavano i giardini dei nobili, e marcivano senza
che nessuno li assaggiasse. Da qui anche il nome latino Lycopersicum, "pesca del
lupo", cioè buono da mangiare solo per chi è abituato a mangiare di tutto in
mancanza di meglio. In seguito a poco a poco ci si rese conto che, come nel caso
della patata, era ottimo da usare in cucina, anche se inizialmente solo nelle
salse per condire la carne, e il suo nome scientifico divenne Lycopersicum
esculentum, cioè "squisito" (ancora oggi però l'esatta classificazione del
pomodoro è ancora oggetto di dibattito, alcuni lo comprendono nello stesso
genere della patata, altri in un genere diverso). Antonio Latini, nel suo "Lo
scalco alla moderna", trattato di cucina del 1692 (lo scalco era il capocuoco),
descrive la ricetta della salsa di pomodoro alla spagnola, diffusa nella cucina
napoletana. Non si sa quando si cominciò ad usarlo per condire la pasta o la
pizza, ma siccome il pomodoro trovò l'ambiente soleggiato ideale per la sua
coltivazione su tutte le rive del Mediterraneo, ci è lecito ipotizzare che ciò
avvenne proprio a Napoli. Di sicuro quando nel 1889 il pizzaiolo napoletano
Raffaele Esposito ideò la pizza Margherita (pomodoro, mozzarella e basilico) in
onore della regina d'Italia Margherita di Savoia, oggi nota solo per questa
pizza e per le innumerevoli corna che il marito e cugino Umberto I le mise, il
pomodoro era già diventato uno dei simboli stessi del capoluogo partenopeo.

La bacca ricca di nicotina
E veniamo alla melanzana o, per
meglio dire, alla Solanum melongena. Dal punto di vista botanico, anche se
nessuno lo direbbe, è una bacca e fa parte delle Solanacee, per cui è
imparentata con il pomodoro, il peperoncino e la patata, anche se questi ultimi
vengono dal Nuovo Mondo, mentre la melanzana è originaria del Vecchio Mondo.
Come il pomodoro se ne possono mangiare buccia e semi, ma, come la patata, si
mangia solitamente cotta. Il frutto contiene numerosi semi piccoli e morbidi,
che hanno un sapore amaro perché contengono o sono ricoperti di alcaloidi
nicotinoidi, proprio come il tabacco! E la melanzana ha la più alta
concentrazione di nicotina di qualsiasi altra pianta, tabacco a parte. La
melanzana è nutrizionalmente povera di macronutrienti e micronutrienti, ma la
capacità del frutto di assorbire oli e sapori nella sua polpa attraverso la
cottura ne ha diffuso a dismisura l'uso nelle arti culinarie di tutto il
mondo. In Italia venne inizialmente chiamata petronciana o petronciano. Per
evitare fraintendimenti sulle sue proprietà, la prima parte del nome venne
mutata in mela, dando così origine al termine melangiana e poi melanzana. Esiste
anche una paraetimologia in cui il nome melanzana veniva popolarmente
interpretata come "mela insana", proprio perché non è commestibile da
cruda. Dalla forma araba con l'articolo (al-bādhingiān) derivano invece le forme
catalana (albergínia), francese, tedesca e inglese britannica (aubergine),
mentre, da quella senza articolo derivano la forma spagnola (berenjena) e quelle
portoghesi (bringella, bringiela, anticamente beringela). I nomi in uso nei
paesi di lingua inglese ("eggplant", cioè "pianta delle uova") furono
originariamente applicati a cultivar bianche, che assomigliano molto alle uova
di gallina!
Non c'è consenso sul luogo di origine della melanzana: la specie
vegetale è stata descritta come originaria dell'India, dove continua a crescere
spontaneamente, dell'Africa oppure dell'Asia meridionale. È stata sicuramente
coltivata in Asia sin dalla preistoria. La prima testimonianza scritta
conosciuta della pianta si trova nel Qimin Yaoshu, un antico trattato agricolo
cinese completato nel 544 d.C. I numerosi nomi arabi e nordafricani, unitamente
alla mancanza degli antichi nomi greco e romano, indicano che fu coltivata in
tutta l' area mediterranea dagli Arabi nell'Alto Medioevo; essi poi lo
introdusse in Spagna nell'VIII secolo. Un saggio sull'agricoltura di Ibn
Al-Awwam scritto in al-Andalus, la Spagna araba del XII secolo, descrive come
coltivare le melanzane. La prima citazione nel mondo cristiano è nel tardo
catalano medievale. La melanzana non è registrata in Inghilterra fino al XVI
secolo; un test di botanica inglese del 1597 descriveva la "mela madde": «
Questa pianta cresce in Egitto quasi ovunque, producendo frutti delle grandi
dimensioni di un grande cetriolo... E' cresciuta anche nei nostri giardini di
Londra, dove ha prodotto fiori, ma l'inverno si avvicina prima del tempo della
maturazione, e i frutti simili ad uova di anatra sono marciti nonostante fosse
un anno straordinariamente temperato... » A causa del colore violaceo e del
sapore amaro dei semi, un tempo si credeva che il frutto fosse estremamente
velenoso, proprio come accaduto alla patata. In effetti fiori e foglie possono
essere velenosi se consumati in grandi quantità per la presenza di solanina. La
melanzana ha un posto speciale nel folclore: secondo la tradizione italiana del
XIII secolo, la melanzana poteva causare addirittura la pazzia. Nell'Egitto del
XIX secolo, si diceva che la follia fosse "più comune e più violenta" quando le
melanzane sono di stagione in estate. In alcune culture popolari, invece,
sognare melanzane è considerato un segno di buon auspicio.

La scatola dei semi
Il peperone è il frutto della
Capsicum annuum, originaria come patate, pomodori e tabacco del Centro America,
dei Caraibi e del Sud America; per la precisione è la più comune e ampiamente
coltivata dei cinque peperoni domestici. Il genere capsicum prende il nome dal
latino "capsa", cioè "scatola", a causa della sua somiglianza con un contenitore
che ne racchiude i semi; secondo altri però viene dalla voce verbale greca "capto" ("mordo"), a causa del sapore pungente. Invece
"peperone" deriva dal
latino "piper", cioè "pepe". La specie comprende un'ampia varietà di forme e
dimensioni di peperoni, compresi i peperoni dolci e alcune varietà di
peperoncino come il peperoncino e il pepe di cayenna; cultivar discendenti dal
peperone selvatico americano si trovano ancora nelle regioni più calde delle
Americhe. Per spezzare il monopolio delle repubbliche marinare nel commercio del
pepe gli esploratori portoghesi, nel XV secolo, si impegnarono a circumnavigare
l'Africa in cerca di una via marittima alternativa per le Indie, mentre
Cristoforo Colombo scelse di "buscar el Levante por el Poniente", scoprendo
casualmente l'America, dove non cresceva il pepe bensì il peperoncino, che gli
indigeni chiamavano "ají" o "chile". Colombo capì subito che quegli strani
baccelli erano diversi dal pepe, a cui li accomunava solo la piccantezza.
Tuttavia, forse per consolarsi di essere arrivati nel posto sbagliato, in
America anzichè nelle isole delle pregiate spezie, gli spagnoli diedero ai
frutti del Capsicum annuum il medesimo nome che usavano per il pepe, "pimienta",
e la confusione si estese alle altre lingue europee, dall'inglese pepper al
francese piment o poivron, fino al serbo pȁpar, da cui deriva il tedesco
Paprika. In Italia questa novità proveniente dal continente americano fu detta
inizialmente pepe d'India, poi, dal XVIII secolo, peperone; infine, dalla
seconda metà dell'Ottocento, solo le varietà più grandi e non piccanti furono
chiamate "peperoni", mentre per le più piccole e piccanti fu coniato il termine
peperoncino.
Sebbene il nome della specie, "annuum", significhi "annuale", in
realtà la pianta non è annuale ma in assenza di gelate invernali può
sopravvivere per diversi anni e crescere fino a diventare una grande erba
perenne arbustiva. Capsicum annuum comunque è particolarmente produttivo nei
climi caldi e secchi. I singoli fiori sono di colore bianco sporco, a volte
violaceo, mentre lo stelo è densamente ramificato e alto fino a 60 cm. Sebbene
sia generalmente autoimpollinante, gli insetti impollinatori aumentano le
dimensioni dei frutti e la velocità di maturazione, oltre a garantire uno
sviluppo simmetrico. Le varietà di peperoni producono frutti di differenti
forme: allungata, conica, a prisma e persino a globo, superfici lisce o
costolute, e un sapore che può essere sia acre sia dolce. I colori più comuni
dei peperoni sono verde, giallo, arancione e rosso, ma se ne trovano anche
marrone, bianco, lavanda e viola scuro, a seconda della varietà. I frutti acerbi
sono verdi o, meno comunemente, giallo pallido o viola, benché la varietà
Permagreen mantenga il suo colore verde anche a piena maturazione. Nel 2020, la
produzione mondiale di peperoni è stata di 36 milioni di tonnellate, guidata
dalla Cina con il 46% del totale e seguita da Messico, Indonesia e Turchia. Un
peperone rosso crudo contiene il 94% di acqua, il 5% di carboidrati, l'1% di
proteine e una quantità trascurabile di grassi; 100 grammi di peperoni
forniscono 26 calorie e sono una ricca fonte di vitamina C, contenendo il 158%
del valore giornaliero. Un peperone rosso fornisce il doppio della vitamina C e
otto volte il contenuto di vitamina A di un peperone verde. I peperoni vengono
consumati sia freschi (crudi o cotti) sia essiccati: ad esempio il peperone crusco, tipico della cucina lucana. I peperoni maturi possono essere verdi,
gialli, arancioni o rossi. Mille sono le possibili ricette, a partire dalla
squisita peperonata o i peperoni ripieni, ma è apprezzabile anche la pizza ai
peperoni. Viene anche utilizzato come antipasto, condito con olio e sale,
eventualmente rosolato su una superficie molto calda (una volta si usava la
parte superiore della stufa) fino a renderlo morbido e poi privato della buccia.
In Piemonte è servito anche come antipasto in grosse fette, ricoperte sulla
superficie interna di bagna càuda. Vi sono anche delle varietà ornamentali che
tendono ad avere frutta e fogliame con colori insoliti come il nero e il viola.
Il peperone è infestato dalla tignola del tubero della patata (Phthorimaea
operculella), un insetto le cui femmine usano le foglie per deporre le uova.
Sono i composti chimici chiamati capsinoidi a fornire i sapori distintivi nelle
varianti di peperone; in particolare, la capsaicina crea una sensazione di
bruciore in bocca, che in casi estremi può durare anche diverse ore dopo
l'ingestione. Per descrivere la piccantezza dei peperoni e dei peperoncini (e di
altri alimenti) si usa la cosiddetta Scala Scoville, ideata nel 1912 dal
farmacista statunitense Wilbur Scoville (1865-1942). In pratica, il peperone si
differenzia dal peperoncino perché non contiene la capsaicina: un peperone ha
pertanto valore zero nella Scala Scoville. Ultima curiosità. In una delle
strisce del capolavoro di Bill Watterson, "Calvin & Hobbes", il pestifero
bambino protagonista del fumetto viene mandato a letto senza cena, e nell'ultima
vignetta telefona in pizzeria: "...and extra pepperoni!" Un bambino che
ordina pizza con aggiunta di verdure? Implausibile, e infatti in inglese
"pepperoni" non sono i peperoni, che come detto si chiamano "peppers", bensì il
salame piccante, per via della suddetta confusione tra peperoni e pepe!

L'ortaggio
sotto cui nascono i bambini
Il cavolo (Brassica oleracea) è un
ortaggio appartenente alla famiglia delle brassicacee, che comprende molte cultivar molto comuni utilizzate come verdure, come cavoli, broccoli,
cavolfiori, cavoli, cavoletti di Bruxelles, verze: tutti utilizzati per le loro
grandi riserve di cibo, che vengono immagazzinate durante l'inverno nelle sue
foglie. La sua forma spontanea, il cavolo selvatico, originario dell'Europa
meridionale e occidentale, è una pianta rustica con un'elevata tolleranza al
sale e alla calce. Tuttavia la sua intolleranza alla concorrenza di altre piante
in genere limita la sua presenza in natura alle scogliere calcaree, come le
scogliere di gesso su entrambi i lati del Canale della Manica. La Brassica
oleracea selvatica è una pianta biennale che nel primo anno di vita forma una
robusta rosetta di grandi foglie. Le foglie sono più carnose e più spesse di
altre brassicacee, un adattamento che lo aiuta a immagazzinare acqua e sostanze
nutritive nel suo difficile ambiente di crescita. Nel suo secondo anno, utilizza
i nutrienti immagazzinati per produrre una spiga floreale alta da uno a due
metri, con numerosi fiori gialli. Uno studio del 2021 ha suggerito che la
Brassica cretica diffusa in Grecia e nelle isole dell'Egeo sia all'origine della
Brassica oleracea domestica, supportando così l'opinione che la sua coltivazione
abbia avuto origine nella regione del Mediterraneo orientale, con successiva
mescolanza con altre specie di Brassica. Invece l'analisi genetica di nove
popolazioni selvatiche sulla costa atlantica francese ha indicato la loro comune
origine selvatica, derivante da piante domestiche fuggite da campi e giardini.
Le tante cultivar oggi note sono suddivise nei seguenti gruppi:
gruppo acephala, al quale appartengono il cavolo nero toscano, il cavolo gallego
e il cavolo riccio;
gruppo alboglabra, a cui appartiene il broccolo cinese;
gruppo capitata, di cui fanno parte il cavolo cappuccio e il cavolo rosso;
gruppo gemmifera, a cui appartiene il cavoletto di Bruxelles;
gruppo gongylodes, a cui appartiene il cavolo rapa;
gruppo tronchuda, di cui fa parte il cavolo portoghese. Invece le varietà botrytis (il cavolfiore e il broccolo romanesco) e
italica (il cavolo broccolo) sono considerate parte della specie Brassica
cretica.
Il cavolo cinese e il cavolo di Pechino sono in realtà cultivar della specie
Brassica rapa, mentre i broccolini sono un ibrido creato in Giappone.
Il nome "cavolo" (in provenzale "cauls", in tedesco "kohl", in gallese "cawl")
deriva dal latino "caulus", a sua volta dal proto-indoeuropeo *keh₂u-li-, da cui
anche il sanscrito कुल्या ("kulyā"), il greco antico καυλός ("kaulós", "radice")
e il lettone "kauls" ("osso"), visto che alcune specie della famiglia sono
legnose alla base. Invece "Brassica" era il nome che Plinio il Vecchio dava a
piante simili ai cavoli; si discute se il gallese "bresych", il greco medioevale
"βράσκη" e il tipo slavo "broskva" siano mutuati dal latino o di diretta
ascendenza indoeuropea. Invece "oleracea" viene dal latino antico "helus", a sua
volta, dal proto-italico "*helos", dal proto-indoeuropeo "*ǵʰélh₃-s", da "*ǵʰelh₃-"
("fiorire; giallo"), affine al proto-germanico *gulaz ("giallo"), da cui
l'odierno "gelb" in tedesco, "geel" in olandese, "gul" in danese e "yellow" in
inglese.
Gli storici ritengono che sia coltivato da migliaia di anni, ma la sua storia
come pianta domesticata non è chiara prima dell'epoca greca e romana, quando era
già un ortaggio da giardino ben consolidato. Il botanico greco Teofrasto
(371-287 a.C.) menziona tre tipi di rhaphanos (ῤάφανος): uno a foglia riccia,
uno a foglia liscia e uno selvatico. Riferisce anche la leggenda dell'antipatia
tra cavolo e vite, poiché gli antichi credevano che i cavoli coltivati vicino
all'uva avrebbero conferito il loro sapore al vino, cosa che ovviamente non ha
riscontri scientifici. Attraverso la selezione artificiale per vari tratti
fenotipici, nel corso dei secoli si sono ottenute varietà della pianta con
drastiche differenze nell'aspetto. La preferenza per foglie, gemma terminale,
gemma laterale, gambo e infiorescenza ha portato alla selezione di varietà di
cavolo selvatico nelle molte forme conosciute oggi. In particolare la preferenza
per il consumo delle foglie ha portato alla selezione di piante con foglie più
grandi da raccogliere. Si pensa che quello che oggi chiamiamo "cavolo" sia
comparso intorno al V secolo a.C., ma secondo alcuni la varietà di cavolo con
foglie più fitte e gemme terminali non comparve prima del I secolo d.C. Marco Porcio
Catone (234-149 a.C.) nel De re rustica" scrisse:
«Brassica est quae omnibus oleribus antistat; eam esto vel coctam vel crudam » (« È il cavolo quello che supera ogni altro vegetale; si può mangiare sia cotto,
sia crudo ») Le preferenze di selezione del fenotipo in Germania hanno portato a
una nuova variazione dalla cultivar: selezionando steli più grassi, nell'alto
Medioevo comparve la variante nota come cavolo rapa. Alcuni documenti del XV
secolo d.C. indicano le prime attestazioni di cavolfiore e broccoli in tutta
l'Italia meridionale e in Sicilia, ma secondo alcuni questi tipi potrebbero non
essere diventati cultivar se non circa 100 anni dopo. Un'ulteriore selezione in
Belgio nel XVIII secolo ha portato ai cavoletti di Bruxelles.
Il tipico sapore delle brassicacee lo dobbiamo al gene TAS2R38, che codifica un
recettore accoppiato con le proteine G, mediato da molecole come
propiltiouracile e feniltiocarbamide che si legano al recettore del gusto e
avviano la segnalazione che conferisce vari gradi di percezione del tipico
sapore. Tutte le verdure della famiglia delle brassicacee contengono
glucosinolati e isotiocianati, che assomigliano al propiltiouracile, e quindi
gran parte dell'amarezza tipica di queste verdure è mediata da TAS2R38. I
recettori del gusto amaro della famiglia TS2R si trovano anche nelle cellule
della mucosa intestinale e del pancreas sia nell'uomo che nei roditori. Questi
recettori influenzano il rilascio di ormoni coinvolti nella regolazione
dell'appetito, come il peptide YY e il peptide-1 simile al glucagone, e quindi
possono influenzare l'apporto calorico e lo sviluppo dell'obesità. Pertanto la
percezione del gusto amaro può influenzare i comportamenti alimentari
influenzando sia il sapore che la regolazione ormonale metabolica. Gli individui
con almeno una copia dell'allele PAV percepiscono le molecole nelle verdure che
assomigliano al propiltiouracile con un sapore amaro, e di conseguenza possono
sviluppare un'avversione per queste verdure; al contrario, gli individui con due
aplotipi AVI amano anche il sapore amaro. Gli aplotipi PAV e AVI sono i più
comuni, sebbene esistano altri aplotipi che conferiscono una sensibilità al
gusto amaro intermedia. Questa avversione al gusto del cavolo può applicarsi
alle verdure in generale, e da qui il tipico rifiuto di molti bambini di
nutrirsi di verdure (e di cavoli in particolare).
Il cavolo ha un modesto contenuto nutrizionale, con piccole quantità di glucidi e
ancor meno di proteine. Per i composti minerali e i microelementi presenti in
ampia varietà, è invece molto utile per ricostituire le riserve minerali
dell'organismo. Per l'elevato contenuto in fibre e per la presenza di parte
cellulare vegetale ha elevato potere saziante se unito, come è tradizione a legumi o carboidrati.
I più importanti composti minerali contenuti sono zolfo, calcio, fosforo, rame,
iodio, selenio, magnesio. Tutti i cavoli (soprattutto se freschi) sono ricchi di
vitamine, soprattutto di vitamina C.
Per i suoi effetti di ricostruzione vitaminica, rimineralizzante e soprattutto
promotrice del movimento intestinale, svolge azione preventiva di molti tumori
e, costituendo massa diluente e tampone chimico,
combatte le ulcere gastro-duodenali. Per la forte azione osmotica delle foglie
fresche, queste sono usate per disinfiammare le contusioni.
Quasi tutte le brassicacee hanno mostrato una straordinaria
capacità di raccogliere e fissare nei propri tessuti i minerali contenuti nel
suolo, no solo quelli essenziali per l'alimentazione umana, ma anche metalli pesanti,
che spesso sono tossici, quali cromo, piombo, arsenico, cadmio.
Coltivando piante di cavolo a scopo alimentare è bene assicurarsi che i suoli
non siano inquinati da tali metalli.
Le diverse varietà di cavoli hanno numerosi impieghi in cucina: sono molto usati
nella cucina italiana, europea e asiatica, sia crudi sia
cotti. Per ciascuna varietà esistono mille ricette anche molto particolari, come
la famosa cassoeula milanese, tipico piatto invernale a base di verze e di
cotiche di maiale, chiamata in italiano bottaggio (probabilmente derivato dal
termine francese "potage"), che mia nonna era abilissima a preparare. Il nome
deriva probabilmente dal cucchiaio con cui si mescola ("cassœu") o dalla pentola
con cui la si prepara (casseruola). Esiste un'altra spiegazione per il nome: per
tradizione il piatto veniva preparato dagli operai dei cantieri edili una volta
che l'edificio era giunto al tetto, e perciò il nome potrebbe derivare
dall'attrezzo utilizzato per mescolarla durante la cottura, per l'appunto la
"cazzuola". Esiste un piatto, La cassoeula, così come viene preparata
oggi, nasce tardi, all'inizio del XX secolo, ma le sue varianti più antiche sono
di origine incerta e controversa. Probabilmente il piatto deriva ed è legato
alla ritualità del culto popolare di Sant'Antonio abate, festeggiato il 17
gennaio, data che segnava la fine del periodo delle macellazioni dei maiali. I
tagli di carne utilizzati per la cassœula erano quelli più economici e avevano
lo scopo di insaporire la verza, elemento invernale basilare della cucina
contadina lombarda nei secoli scorsi. La leggenda vuole che la cassœula nasca da
un soldato spagnolo che, invaghitosi di una giovane donna milanese, cuoca di una
famiglia nobile, le abbia insegnato la ricetta e che in seguito la donna abbia
proposto con successo il piatto ai suoi datori di lavoro. Nella tradizione
culinaria popolare europea vi sono altri piatti con ingredienti simili, come le
diverse forme di "potée" francesi (minestre a base di cavolo e maiale) o il "Kasseler"
("càssola" nella pronuncia italiana) della tradizione tedesca, consistente in
tagli di maiale affumicato servito con un contorno di cavolo verza. Il piatto
nazionale della Polonia è il bigos, anch'esso a base di verza.
Non dimentichiamo poi i crauti (in tedesco "Sauerkraut", letteralmente "erba
acida"), uno dei prodotti più frequenti nella dieta germanica, al punto da
formare all'estero, insieme a patate e salsicce, il cliché culinario
generalmente attribuito ai tedeschi (come pasta e pizza per gli italiani). La
loro preparazione è a base di cavolo cappuccio, le cui foglie sono tagliate a
piccole strisce e sottoposte a fermentazione naturale controllata, per circa due
mesi, con aggiunte di sale da cucina, pepe e aromi. Il procedimento, usato
principalmente come metodo di conservazione, modifica il profilo organolettico
del vegetale e conferisce ai crauti il tipico sapore deciso e leggermente aspro.
Il risultato è un alimento ricco di vitamine e sali minerali. I crauti
favoriscono la digestione, poiché rinforzano la flora intestinale, allontanando
così batteri e virus patogeni. Questo risultato si ha solo se mangiati crudi,
perchè nella cottura tutti i fermenti vivi e le vitamine termolabili, così
importanti per la nostra flora intestinale e non solo, vengono compromessi
irrimediabilmente. In realtà i crauti appartengono alla tradizione gastronomica
non solo di aree di lingua tedesca come Germania, Austria, alcuni cantoni
svizzeri e Alto Adige, ma anche di Paesi come Slovenia ("kislo zelje"),
Ungheria, Croazia, Polonia ("kapusta kiszona"), Ucraina, Russia (Квашеная
капуста, "kvašenaja kapusta"), Repubblica Ceca ("kysané zelí"), Bosnia ed
Erzegovina e Serbia ("kiseli kupus"). I crauti vengono usati nei piatti
tradizionali anche in Romania, chiamati "varză murată". In Italia sono diffusi
nei territori un tempo asburgici come il Friuli-Venezia Giulia (con il nome di "capuzi")
e nell'Emilia occidentale (con il nome di "sacrao"). In Trentino, e in
particolare nella zona del Tesino, e nella parte di Veneto che confina con esso,
sono consumate le verde o verdòle, con una preparazione pressoché identica, se
non nel taglio delle foglie (tagliate in piccoli quadretti) e per la durata
della fermentazione (40-50 giorni).
Una curiosità: quando vengono cotti, tutti i cavoli emanano un cattivo odore perché sono ricchi
di composti di zolfo, che vengono liberati dalla cottura.
I solfuri, in gran parte isotiocianato di metile, svaniscono al 90% dopo 8
minuti di cottura, e l'estrazione è totale dopo 16 minuti.
Una tra le storie più celebri che un tempo venivano raccontate ai bambini che
chiedevano come sono nati, oltre a quella della cicogna, afferma che essi
sarebbero stati raccolti proprio sotto le foglie di questi ortaggi. Ma perchè
proprio sotto i cavoli? Per molti secoli nelle regioni dell'Europa centrale il
cavolo era l'alimento che durante l'inverno garantiva vitamine e minerali. Da
sempre simbolo di fecondità e di vita, veniva raccolto dopo nove mesi dalla
semina, ovvero da marzo a settembre, proprio quanto dura la gestazione dei
bambini. La piantagione e la raccolta dei cavoli erano affidati a donne che
venivano chiamate levatrici, proprio come quelle che aiutavano la futura mamma
durante il parto, perché le contadine avevano il compito di recidere il “cordone
ombelicale” che legava il cavolo alla terra; da qui la leggenda che i bambini
fossero trovati sotto ai cavoli.
Un altro modo di dire assai celebre alle nostre latitudini è senza dubbio «
salvare capra e cavoli », detto di chi vuole raggiungere due obiettivi
apparentemente inconciliabili tra di loro. Il detto nasce da un famoso esercizio
di logica che, secondo la tradizione, sarebbe stato inventato da Alcuino di York
(735-804), teologo e pedagogo inglese, che nel 782 fu chiamato da Carlo Magno a
dirigere la Schola Palatina di Aquisgrana, una delle prime scuole pubbliche al
mondo, destinata ai futuri funzionari del Sacro Romano Impero. Un contadino deve
trasportare da una riva all'altra di un fiume un lupo, una capra e dei cavoli,
ma ha a disposizione solo una barchetta che oltre al contadino non può
trasportare più di una cosa per volta, e naturalmente bisogna impedire che il
lupo mangi la capra o la capra mangi i cavoli. Qual è l'esatto ordine di azioni
necessario per raggiungere l'obiettivo? Assumendo che il lupo, in quanto
carnivoro, a differenza della capra non mangi i cavoli, ecco la soluzione. Il
contadino deve traghettare per prima la capra; poi tornare indietro e traghetta
i cavoli; riporta indietro la capra (per non lasciarla con i cavoli) e
traghettare il lupo (che può restare con i cavoli); infine tornare indietro a
prendere la capra. Tra andata e ritorno, sono sette viaggi in tutto!
Molte altre espressioni legate a "cavolo" fanno oggi parte del linguaggio comune:
testa di cavolo, non fare un cavolo, commettere una cavolata, incavolarsi.
Nessuna di questa è però legata alle molte proprietà delle brassicacee,
derivando piuttosto da un eufemismo scherzoso, laddove si vuole evitare di usare
uno dei tanti termini popolari con cui si indica l'organo genitale maschile
(pare che derivi da "ocazzo", antica denominazione del maschio dell'oca, oppure
dal greco κύαθος, "kýathos", cioè "mestolo"). Ma l'odore sulfureo del cavolo
cotto può aver contribuito in larga misura alla sostituzione.
Chiudiamo con una nota storica dal tono agrodolce.
Con la scoperta dell'America cominciò l'epoca dei viaggi navali su lunghe
distanze, e tale fatto pose una questione drammatica: come contrastare
l'insorgenza dello
scorbuto, una malattia terribile e spesso letale, che oggi sappiamo dovuta a
carenza di acido ascorbico (vitamina C) presente in agrumi, pomodori, peperoni e
kiwi. Con la navigazione costiera, l'assenza da terra durava solo per
pochi giorni, e il cibo fresco durava abbastanza bene per tale periodo, per cui
nel passato non si
erano mai verificati casi di malattia particolari.
Invece, navigando per lunghi periodi senza toccare terra e senza cibi freschi,
insorsero subito nei marinai gravissimi inclusi perdita di denti, emorragie
gengivali e sottoungueali, apatia, irritabilità, perdita di peso, dolori
muscolari e articolari. Nel 1747 il medico scozzese James Lind (1716-1794),
imbarcato sulla HMS Salisbury della marina da guerra britannica, condusse il
primo studio clinico accurato su questa malattia, annotando scrupolosamente i
sintomi dei marinai affetti dallo scorbuto e scoprendo che tali sintomi, che portavano alla morte certa, erano
scongiurati se nella dieta erano presenti agrumi, non facili allora da reperire,
oppure cavoli,
reperibili con facilità anche nei paesi nordici.
Ben presto tutte le navi oceaniche ebbero a bordo una grossa scorta di cavoli
freschi, che permetteva, grazie alla vitamina C in essi contenuta, di poter fare viaggi di molte settimane
senza toccare terra. Nella soste a terra, in qualsiasi posto del mondo, erano
molto ricercati i cavoli (o gli agrumi, secondo la latitudine) per ricostruire
le scorte. Grazie ai cavoli e agli agrumi la colonizzazione giunse rapidamente
in ogni angolo del mondo e divennero possibili nel 1700 e 1800 le
campagne di pesca di mesi in mare aperto delle navi baleniere, che in poche
decine di anni provocarono lo sterminio di cetacei e di foche raggiungendo tutti
gli oceani del pianeta. Involontariamente, dunque, i cavoli condussero a due
delle piaghe del mondo moderno: il colonialismo, specie in Africa e in Asia, e
la caccia ai mammiferi marini, che li ha portati sull'orlo dell'estinzione.
Quando si dice: teste di cavolo...

L'ortaggio di Maratona
Tocca al finocchio. Il suo nome
latino è Foeniculum vulgare (è un diminutivo di "faenum", che significa "fieno",
forse perchè era usato nell'alimentazione animale) ed è una angiosperma della
famiglia delle carote. È un'erba perenne resistente, con fiori gialli e foglie
piumate. È originario delle coste del Mediterraneo, ma si è ampiamente diffuso
in mezzo mondo, specialmente sui suoli asciutti vicino alle coste e sulle rive
dei fiumi. Il nome greco del finocchio è marathos (μάραθος), e il luogo della
famosa battaglia di Maratona significa letteralmente "pianura dei finocchi".
Pensate che questa parola è attestata per la prima volta nella forma micenea
lineare B, come ma-ra-tu-wo! Nella "Teogonia" di Esiodo, Prometeo ruba agli dei
la brace ardente nascondendola in un gambo cavo di finocchio. Il finocchio è una
delle nove piante invocate nel canone pagano anglosassone delle nove erbe
magiche, messo per iscritto nel X secolo. Nel XV secolo, i coloni portoghesi di
Madeira notarono l'abbondanza di finocchi selvatici e vi fondarono una città
chiamata Funchal, dal portoghese "funcho" ("finocchio"), oggi capoluogo
dell'isola. La poesia "Il calice della vita" di Henry Wadsworth Longfellow
(1842) si riferisce ripetutamente alla pianta e menziona la sua presunta
capacità di rafforzare la vista: « Sopra le piante inferiori, torreggia / il
Finocchio dai fiori gialli; / e in un'epoca precedente alla nostra / era dotato
di poteri meravigliosi / visione perduta da ripristinare. »
È un'erba molto
saporita e, insieme all'anice, dal sapore simile, è uno degli ingredienti
primari dell'assenzio. I fiori sono prodotti in ombrelle composte con 20–50
minuscoli fiori gialli ciascuna su pedicelli corti. Poiché il seme nel frutto è
attaccato al pericarpo, l'intero frutto viene spesso erroneamente chiamato
"seme". Si consuma la grossa guaina bianca di forma bulbosa, detta grumolo, che
si sviluppa alla base, messa in vendita con un breve ciuffo di fusti e
foglie. Il suo colore bianco è dato dalla tecnica dell'imbianchimento, una rincalzatura che si effettua a cadenza regolare nel corso dello sviluppo del
grumolo, o almeno due settimane prima della raccolta. La raccolta dei grumoli
avviene in tutte le stagioni, secondo le zone di produzione, dopo circa 90
giorni dalla semina. Richiede frequenti e abbondanti irrigazioni e preferisce un
clima temperato di tipo mediterraneo. Il Foeniculum vulgare 'Purpureum' o
"finocchio a foglia di bronzo", è invece ampiamente diffuso come pianta
decorativa da giardino. La comune distinzione tra "finocchio femmina" e
"finocchio maschio" è solo formale: il primo è di forma allungata e il secondo
di forma tondeggiante; il finocchio maschio è più apprezzato sotto l'aspetto
merceologico perché meno fibroso e più carnoso. Oggi il maggior produttore
mondiale è l'India, seguita a ruota da Cina e Bulgaria. Il bulbo, il fogliame e
i frutti della pianta del finocchio sono utilizzati in molte delle tradizioni
culinarie del mondo. Il frutto essiccato del finocchio è una spezia aromatica al
gusto di anice, marrone o verde quando è fresco, che diventa lentamente grigio
opaco man mano che il frutto invecchia; con il finocchio si fanno anche ottime
tisane diuretiche, disintossicanti e carminative.
Chiudiamo con qualche
curiosità. L'espressione "lasciarsi infinocchiare" deriva dall'abitudine dei
commercianti di vino di offrire spicchi di finocchio a chi si
presentava per acquistare il vino contenuto nelle botti, perchè il grumolo
contiene sostanze aromatiche che modificano leggermente la percezione dei
sapori, rendendo saporito il successivo assaggio di un vino di qualità scadente
o prossimo a diventare aceto. Purtroppo in tante culture "finocchio" è diventato
sinonimo spregiativo di gay (lo usa anche Monica Vitti ne "La ragazza con la
pistola"). Secondo una leggenda popolare, ai tempi dell'Inquisizione i semi di
finocchio sarebbero stati gettati sugli omosessuali che venivano bruciati sul
rogo, al fine di mitigare la puzza di carne bruciata, ma non vi è alcuna prova
oggettivamente documentata che questo sia ma stato fatto (e il rogo era
riservato agli eretici, non ai gay). Una spiegazione più probabile ritiene
che il finocchio selvatico venisse usato come ripiego per aromatizzare i cibi
quando non si avevano i soldi per comprare le pregiate e costose spezie
provenienti dall'Oriente (ancor oggi in Toscana col finocchio si dà l'aroma al
salame, producendo la famosa "finocchiona"), e quindi "finocchio", se riferito a
una persona, sarebbe qualcuno che vale davvero poco, un uomo che non è neppure
un uomo. Secondo altri invece "finocchio" in quest'accezione sarebbe
un'allusione metaforica alla forma arrotondata del grùmolo, che ricorda
vagamente quella delle natiche umane. Una metafora, in ogni caso, che è meglio
non usare mai!

La
lanterna del peccatore
E veniamo alla
zucca. Con questo termine vengono identificati i
frutti di diverse cultivar appartenenti alla famiglia
delle Cucurbitaceae, in particolare alcune specie del genere Cucurbita: Cucurbita maxima, Cucurbita pepo e Cucurbita moschata
(ma anche specie
appartenenti ad altri generi come ad esempio la Lagenaria vulgaris o zucca
ornamentale). Le specie del genere cucurbita variano di numero da 13 a 40 a
seconda degli autori: la grande diversità delle varietà coltivate e la facilità con cui le specie di
Cucurbita si ibridano tra loro portano infatti a molta confusione nella loro nomenclatura.
Il termine "zucca" deriva probabilmente dal latino "cucutia", con caduta della
cu- iniziale e con la metatesi tra c e z, ed infatti nei dialetti dell'Italia
meridionale è sopravvissuto il termine "cocuzza". Secondo la professoressa Rosa
Ronzitti dell'università di Genova, "cucutia" deriverebbe dal latino classico "cutis",
"pelle, involucro, guscio di frutto" (da cui anche "cute"), forse
dall'indoeuropeo *(s)keu-t-, "coprire, avvolgere" o da *keu-, "rigonfiamento,
per la sua forma. Altri invece propongono una derivazione dal latino sūc(c)us,-i,
a sua volta dall'indoeuropeo *seu(H)-, "succo, umido", ad indicare il suo uso
dopo l'essiccazione come contenitore di liquidi vari, ma anche la sua caratteristica
succosità.
Dal punto di vista evolutivo, il genere Cucurbita è di origine relativamente
recente: risale infatti solo all'Olocene (iniziato 10.000 anni fa), mentre la famiglia delle Cucurbitacee
risale al Paleocene: sono stati ritrovati dei semi di una specie simile alla
attuale Bryonia, rinvenuti a Shirley Canal, nel Montana, e risalenti a 50
milioni di anni fa. Abbiamo sufficienti testimonianze archeologiche per affermare che le Cucurbitacee,
alcune specie delle quali (quelle "a fiaschetta") erano diffuse anche nel
Vecchio Mondo, cominciarono a essere coltivate per la prima volta in maniera
sistematica nel Centro e Sud America, e in particolare negli stati messicani di Puebla, Oaxaca, e Mexico.
La coltivazione era già praticata in epoca precolombiana praticamente in tutta
l'America centrale, e le zucche nei loro paesi di origine sono conosciute con il
nome di ayotes, dal Náhuatl ayotli. Di solito le zucche erano coltivate in una triplice
combinazione detta milpera, con il mais e i fagioli. In Perù è stata trovata ceramica Mochica con rappresentazione della pianta
dell zucche. Sull'onda dei Conquistadores furono trapiantate in Europa, Asia e
Africa, però tardarono a diffondersi; la facilità e lo scarso impegno nella sua
coltivazione portarono a utilizzarla molto come alimento per animali.
Le specie del genere Cucurbita sono piante erbacee annuali e dioiche. In generale
striscianti o rampicanti, nella varietà silvestre raggiungono vari metri di
lunghezza, lanciando dei viticci con i quali si aggrappano alla
vegetazione adiacente.
Le foglie sono in genere palmate.
I frutti presentano una
grande varietà di dimensioni a seconda della specie, arrivando a vari
chilogrammi di peso, con notevoli variazioni anche nella forma: se ne producono di larghi, cilindrici, sferici, con colori che vanno dal giallo pallido
al verde intenso. La parte esterna del frutto si indurisce e ingrossa con
l'avanzare della maturazione. La zucca è comunemente usata nella cucina di
diversi popoli: la polpa di zucca si consuma cotta, i semi si mangiano
abbrustoliti e salati, mentre se crudi sono utilizzati per le lori proprietà
vermifughe. Inoltre da essi viene estratto un olio commestibile dal gusto
delicato. La zucca è un frutto che si presta a numerose ricette: si consuma
cucinata al forno, al vapore, nel risotto o nelle minestre, fritta nella
pastella, alcune si conservano tagliate a fette ed essiccate. Particolarmente
famosi sono i tortelli alla mantovana, ripieni dell'omonima varietà di zucca. Le
specie più usate in cucina in Italia sono la Cucurbita maxima, come la Zucca
Marina di Chioggia, e la Cucurbita moschata, come la Zucca di Napoli. Della
zucca si consumano anche i fiori, solamente quelli maschili, quelli cioè con il
gambo sottile, che dopo l'impollinazione sono destinati ad appassire: vengono
fritti dopo essere stati impanati. Primo produttore al mondo ancora una volta è
la Cina, seguita da India, Ucraina e Russia. In particolare la specie Cucurbita
pepo è quella che noi chiamiamo comunemente "zucchina",
i cui frutti cilindrici e di colore verde scuro sono colti e consumati immaturi
(io ne sono ghiotto).
Anche la zucca, nella sua apparente banalità, ha una simbologia molto complessa.
In Occidente essa ha spesso connotazioni dispregiative: l'iniziale ignoranza
delle sue qualità nutritive e la minore fertilità dovuta alle condizioni
climatiche dell'Europa rispetto al clima più caldo dell'America ha probabilmente
contribuito in maniera determinante a questa svalorizzazione. Già per i Romani
(che ne coltivavano le varietà del Vecchio Mondo) la zucca era simbolo di
stupidità e di follia: "sei uno zuccone!" è ancor oggi epiteto tipico degli
studenti teste di legno. Seneca portò questa svalutazione al massimo grado con
la sua opera satirica "Divi Claudii Apokolokyntosis", cioè "Inzuccatura del Divo
Claudio", evidente parodia dell'Apotheosis (divinizzazione) degli imperatori
romani: il povero Claudio, dopo la morte probabilmente per mano della seconda
moglie Agrippina, anzichè deificato si ritrova trasformato in una zucca! (Κολοκύνθη)
Del resto Seneca aveva i suoi motivi per avercela con Claudio, che dietro
istigazione della prima moglie Messalina lo aveva esiliato da Roma. Nel Medioevo
la zucca venne riabilitata e la sua ricchezza di semi la portò a diventare
simbolo di resurrezione dei morti. Come tale appare in alcune opere d'arte ai
piedi di Cristo. Inoltre le zucche essiccate e svuotate erano usate come
borracce dai pellegrini che si recavano a visitare i tradizionali Luoghi Santi
(Roma, Monte Sant'Angelo, Santiago de Compostela, la Terrasanta), e come tale la
troviamo nelle rappresentazioni di Giacomo Maggiore, di Cristo sulla via di
Emmaus e dell'Arcangelo Raffaele. Lo storico dell'arte Cesare Ripa (1555-1622)
torna a considerarla simbolo di stupidità e speranza fallace, perché in
pochissimo tempo cresce e in altrettanto breve tempo avvizzisce e cade a terra.
Con lo stesso significato la rintracciamo nella Satira VII di Ludovico Ariosto
(1474-1533): « Fu già una zucca che montò sublime / in pochi giorni tanto, che
coperse / a un pero suo vicin l'ultime cime. [...] / "Ma tu che a un volger
d'occhi arrivi in cielo, / renditi certa che, non meno in fretta / che sia
cresciuto, mancherà il tuo stelo." » Secondo Anton Francesco Doni (1513-1574)
l'espressione "avere sale in zucca" deriva « dall'usanza antica di portare il
sale nelle zucche vuotate ed essiccate, per cui avere la zucca vuota o essere
senza sale in zucca erano le definizioni popolari per persone senza cervello o
con limitata intelligenza. » Ma ormai, sulla scia dell'arrivo dalle Americhe di
migliori qualità di zucche, era tempo per la sua definitiva riabilitazione:
Borso d'Este (1413-1471), Duca di Ferrara, pose la zucca nel proprio stemma:
essa era coltivata nei terreni sabbiosi lungo il fiume Po, che proprio Borso
aveva bonificato restituendoli all'agricoltura; e giusto in questo periodo
comparve a Ferrara la celebre ricetta dei "cappellacci" di zucca. Le nuove
cultivar di zucche provenienti dall'America furono subito identificate, per la
grandezza, la bellezza e la ricchezza di semi, come portatrici di denaro e
prosperità. A partire dalla metà del Cinquecento la zucca americana, nelle sue
numerosi varianti, apparve con sempre maggior frequenza nei quadri che
mostravano scene di natura morta o di mercato, ma che, in realtà, nascondevano
sottotraccia finalità grottesche legate alla sessualità, potendo alludere alle
rotondità femminili e alla gravidanza, come possiamo osservare in un quadro di
Joachim Beuckelaer (1530-1573) intitolato "Mercato di Campagna": l'uomo
ritratto, un venditore di selvaggina, cinge le spalle e tocca il seno di
un'ortolana che appoggia la mano sinistra, allusivamente, su alcune zucche,
quasi a promettere un futuro rapporto sessuale. Nel quadro di Vincenzo Campi
(1536-1591) intitolato "Pescivendola" si vede in primo piano un polpo che
avviluppa una zucca (fuori contesto merceologico) con i suoi tentacoli: i pesci
erano rappresentazioni della sessualità maschile, mentre la zucca lo era di
quella femminile. Il polipo che abbraccia la feconda zucca è immagine traslata
dell'accoppiamento umano.
Infine, nei paesi anglosassoni (ma si va sempre più diffondendo anche nel
nostro) la zucca è da sempre simbolo della festa di Halloween (dall'inglese All
Hallows' Eve, letteralmente "vigilia di Ognissanti"): una grossa zucca gialla
della varietà Aspen, la quale produce grossi frutti globosi che possono arrivare
a pesare anche dieci chili, viene scavata per ricavarne una rudimentale lanterna
mediante l'apertura di finestre che simulano bocca e occhi. Secondo il mito,
nella notte del 31 ottobre la zucca esposta fuori casa cattura gli spiriti
maligni, imprigionandoli per sempre. Ma perché è stata scelta proprio la zucca?
Secondo un lugubre mito, Jack O'Lantern era un fabbro irlandese con il vizio
dell'alcol, ma particolarmente astuto. La sera del 31 ottobre Jack si recò alla
sua locanda preferita per bere, ma lungo la strada si imbatté nel diavolo in
persona, pronto ad impossessarsi della sua anima. Jack prese tempo e chiese al
demonio di poter almeno bere il suo ultimo bicchiere e, non avendo soldi con cui
pagarlo, l'uomo convinse il diavolo a trasformarsi in una moneta con cui avrebbe
potuto comprare il suo amato liquore. Quando Belzebù lo ebbe fatto, tuttavia,
Jack infilò la moneta in tasca accanto ad una corona del rosario, la quale
impedì al demonio di riprendere la sua forma originaria. Quando però egli morì
come tutti si muore, non vene ammesso in Paradiso perché era stato un peccatore,
e neppure il diavolo lo volle all'inferno, memore dello scherzo che gli aveva
combinato. E così, il povero Jack fu condannato a vagare per il mondo per
l'eternità; il diavolo gli concesse solo un po' di fuoco che gli illuminasse la
strada nel buio. Per mantenere la fiamma accesa il più a lungo possibile, Jack
ripose il fuoco in una rapa svuotata, che divenne così una lanterna. Da allora,
secondo i superstiziosi, nelle notti di Halloween sarebbe possibile scorgere nel
buio la fiammella di Jack, in viaggio senza una meta. Infatti, un tempo nella
tradizione inglese si utilizzavano le rape intagliate per scacciare gli spiriti.
Come si è arrivati alla zucca? Nel 1845 l'Irlanda fu colpita da una grave
carestia che portò alla migrazione di massa di tanti irlandesi che si
trasferirono in America. La comunità irlandese stanziata negli Stati Uniti e in
Canada continuò a rispettare le proprie tradizioni popolari di origine celtica
ma, non avendo a disposizione le rape nella nuova terra, le sostituì con le
zucche, più facili da reperire e di dimensioni più grandi. Da qui nacque negli
Stati Uniti la tradizione delle zucche di Halloween, che divenne il simbolo
definitivo di Halloween a metà Novecento. Alcuni storici hanno collegato la
festa di Halloween a quella pagana e celtica di Samhain, o addirittura a
presunti culti satanisti, ma in realtà Halloween era una festa tipicamente
cristiana accolta dal popolo irlandese dopo la conversione. I primi cristiani ricordavano
tutti i Santi Martiri il 13 maggio, festa dei Lemuralia nell'antica Roma, ma il
papa siriano Gregorio III (che nulla aveva a che fare con il mondo celtico) il
1° novembre 732 consacrò un oratorio a San Pietro dedicato alla memoria di tutti
i martiri, e non ci sarebbe alcuna prova che Gregorio III sia stato influenzato
da festività pagane nella scelta di questa data (altri storici attribuiscono il
cambio di data della festa a Papa Gregorio IV). Ciò che va rigettato di
Halloween non è dunque la sua connessione con i Santi e con i defunti, ma il
carattere di "Carnevale horror" che ha assunto negli Stati Uniti d'America per
motivi puramente commerciali, così come altre feste in origine cattoliche, da
San Valentino allo stesso Natale, sono state stravolte per diventare unicamente
culti del dio denaro. Meglio dunque omaggiare la zucca come simbolo di una donna
in gravidanza, che di un'anima in pena condannata a non trovare requie per
l'eternità!

Il profumo del pitale
Ora, sperando di farvi cosa gradita, vi dirò qualcosa sugli
asparagi. Quelli che noi chiamiamo così sono in
effetti i turioni, ovvero i giovani getti commestibili che si ramificano dai
rizomi, cioè fusti modificati che crescono sotto terra formando un reticolo,
della pianta nota come Asparagus officinalis, una angiosperma monocotiledone
oggi diffusa in tutti i continenti, Antartide esclusa. Essa cresce fino a un
metro e mezzo di altezza, ed è una specie dioica, cioè porta fiori maschili e
femminili su piante diverse, come i kiwi (dei quali ti parlerò in un altro
messaggio). Solo raramente si trovano piante ermafrodite. Il frutto è una
piccola bacca rossa di alcuni millimetri di diametro, tossica per l'uomo. Il
nome deriva dal greco "aspharagos", che è a sua volta derivato dal persiano "asparag",
ossia germoglio. Alcuni lo credono originario delle Americhe come patate e
pomodori, e invece abbiamo le prove che fu coltivato e utilizzato nel
Mediterraneo dagli Egizi e in Asia Minore migliaia di anni fa: una pianta di
asparagi sembra essere raffigurata come offerta votiva su un fregio egizio
risalente al 3000 a.C.! Greci e Romani lo mangiavano fresco quando era di
stagione e lo essiccavano per l'uso invernale. L'imperatore Augusto coniò
l'espressione "più veloce della cottura degli asparagi" per un'azione rapida e
incisiva, come racconta Svetonio nelle sue Vite dei Cesari. Una ricetta per
cucinare gli asparagi è riportata in una delle più antiche raccolte di ricette
sopravvissute, il "De re coquinaria" di Apicio (I secolo d.C.). Catone e Plinio
descrissero accuratamente non solo il metodo di coltivazione, ma anche quello di
preparazione degli asparagi. Agli imperatori romani gli asparagi piacevano così
tanto, che sembra che abbiano fatto costruire delle navi apposite per andarli a
raccogliere! Nel II secolo d.C. il medico greco Galeno menzionò gli asparagi
come un'erba benefica, ma con il declino dell'impero romano il loro valore
medicinale cominciò a passare in secondo piano. Nel XVI l'opera "Il giardino
profumato" dell'arabo al-Nafzawi celebrava il presunto potere afrodisiaco degli
asparagi. Gli asparagi furono portati in Nord America dai coloni europei già nel
1655: Adriaen van der Donck, un immigrato olandese, menzionava gli asparagi
nella sua descrizione delle pratiche agricole olandesi nel Nuovo Mondo, e nel
1685 una delle pubblicità di William Penn per attirare i compatrioti in
Pennsylvania includeva pure gli asparagi in un lungo elenco di colture che
crescevano bene nel clima americano! Anche i nativi americani essiccavano gli
asparagi per successivi usi officinali. Il consumo frequente di asparagi porta
ad un tipico odore dell'urina per via dei composti a base di zolfo che
contengono, ed infatti Proust scriveva: « L'asparago trasforma il mio vaso da
notte in un flacone di profumo! » Il raccolto di asparagi è così popolare in
California che la città di Stockton organizza ogni anno un festival per
celebrarlo, mentre la contea di Oceana, nel Michigan, si è autoproclamata
"capitale mondiale degli asparagi" ed ospita un festival annuale con tanto di
parata e di elezione di "regina degli asparagi". Tale titolo però le è conteso
dalla città tedesca di Schwetzingen. Molte altre città tedesche, tra cui
Norimberga, organizzano uno Spargelfest annuale, che celebra il raccolto degli
asparagi bianchi, e si tiene persino un campionato di rapidità nella sbucciatura
degli asparagi! In Germania gli asparagi vengono spesso consumati con
prosciutto, uova sode, patate e una salsa al burro fuso che anch'io da giovane
ho potuto apprezzare. Consiglio anche a voi di assaggiarla appena possibile!

Cuore di articiòc
Vi ricordate il Cynar, del liquore creato nel 1948
dall'imprenditore veneziano Angelo Dalle Molle e reso popolarissimo negli anni
sessanta e settanta da un celeberrimo Carosello con il grande Ernesto Calindri,
che lo sorseggiava nel bel mezzo di una strada trafficatissima di auto e
motocicli tipica del Miracolo Economico? "Cynar: contro il logorio della vita
moderna..." Gli
estimatori del Cynar, peraltro a gradazione alcolica relativamente bassa (16%),
sapevano che esso era a base di carciofo perchè questo pungente ortaggio era
raffigurato sull'etichetta sotto il suo nome, ma ben pochi erano al corrente che
il liquore veneto è debitore al carciofo anche del nome. Infatti il nome
scientifico del carciofo, una angiosperma dicotiledone della famiglia delle
Asteracee, è Cynara scolymus. La parola italiana "carciofo" deriva
dalla diffusione nel Mediterraneo dell'arabo "ḵuršūf". Nei dialetti dell'Italia
settentrionale viene chiamato "articiòc", termine simile ad altre lingue
europee: in francese è artichaut, in inglese artichoke, in tedesco Artischocke.
Probabilmente tale termine è stato preso in prestito dallo spagnolo alcachofa, a
sua volta discesa dall'arabo andaluso medievale "al-kharshūfa" (incluso
l'articolo determinativo arabo al). La forma araba kharshūfa è ancora usata oggi
nell'arabo maghrebino, probabilmente dalla parola "hardafa", che significa
"squama".
Documentazioni storiche e linguistiche sembrano indicare che la domesticazione
del carciofo dal suo progenitore selvatico, Cynara cardunculus, una delle tante
specie che porta il nome generico di cardo (vedi più sotto), sia avvenuta in Sicilia, a partire dal I secolo dopo
Cristo; ed infatti in alcuni orti casalinghi della Sicilia centro-occidentale
ancora oggi si conserva un'antica cultivar che, sotto il profilo biologico e
molecolare, sembrerebbe una forma di transizione tra il cardo selvatico ed
alcune delle varietà di carciofo oggi diffuse. La pianta chiamata Cynara
era già conosciuta dai greci e dai romani, ma sicuramente era una
varietà selvatica, e pare che le si attribuissero poteri afrodisiaci. Il cardo è
citato come pianta da giardino già da Omero ed Esiodo, e Plinio il
Vecchio menzionò la coltivazione del "carduus" a Cartagine e a Cordova. Nella mitologia greca si narra che Zeus
(vecchio maiale) si innamorò della bellissima ninfa Cynara, di carattere ritroso
e solitario. La ninfa lo respinse e Zeus, colmo di rabbia, la trasformò nel
carciofo, come lei spinoso, ma dolce e saporito, verde e viola come gli occhi
della ninfa. Nel XII secolo fu menzionato nel compendio agricolo composto da Ibn
al-'Awwam a Siviglia, e in Germania da Santa Ildegarda di Bingen, nominata Dottore
della Chiesa da Papa Benedetto XVI. Nel XV secolo il carciofo era già consumato
in Italia: apparve in Toscana verso il 1466. La tradizione dice che fu
introdotto in Francia da Caterina de' Medici, la quale adorava i cuori di
carciofo, quando si sposò con il re Enrico II di Francia. Gli olandesi
introdussero i carciofi in Inghilterra: abbiamo notizie che nel 1530 venivano
coltivati nell'orto di Enrico VIII. I colonizzatori spagnoli e francesi
dell'America lo portarono in quel continente nel secolo XVIII, rispettivamente
in California e in Louisiana. Paradossalmente, oggi in California i cardi sono
diventati un'autentica piaga, esempio tipico di specie aliena invasiva in un
habitat in cui non si trovava precedentemente. Anche Luigi XIV era un
grande consumatore di carciofi. A Vittorio Amedeo II di Savoia
(1666-1732), primo Re di questa casata, si attribuisce l'aforisma: « l'Italia è come un carciofo, va
mangiata foglia per foglia » (e così infatti fece il suo discendente Vittorio
Emanuele II).
L'Italia è il primo produttore di carciofi al mondo, seguita da
Egitto e Spagna. Da qualche anno in qua, a causa di un'epidemia che ha
colpito gli asparagi, in Perù si è cominciato a coltivare i carciofi al fine di
esportarli nei paesi europei, facendo del Perù il quarto produttore mondiale. Il
carciofo cotto non salato contiene l'82% di acqua, il 12% di carboidrati, il 3%
di proteine e il 3% di grassi; una porzione da 100 grammi
di carciofi cotti fornisce 74 calorie, è una ricca fonte di acido folico ed una
fonte moderata di vitamina K, magnesio, sodio e fosforo. Inoltre il carciofo
contiene la cinarina, un polifenolo derivato dell'acido caffeico che apporta
benefici alle funzionalità epatiche. Il basso contenuto calorico del carciofo fa
sì che sia indicato nelle diete dimagranti. Oltre che in mille gustose ricette,
come i celeberrimi carciofi alla giudia della tradizione romana, il carciofo può essere
utilizzato per realizzare tisane (il tè l carciofo è molto apprezzato in
Vietnam) e anche per composizioni floreali ornamentali. Infine, il decotto di
carciofo può stimolare la crescita dei capelli. E scusate se è poco!

Il cereale che ha bisogno della calce
Il mais
(Zea mays) è un cereale domesticato per la prima volta dalle popolazioni
indigene nel sud del Messico circa 10.000 anni fa. Il fusto frondoso della
pianta produce infiorescenze pollinifere (dette "fiocchi") e ovulifere
("pannocchie") separate; le seconde, una volta fecondate, producono i cosiddetti
grani di mais, che in realtà sono frutti e non semi. Infatti il pericarpo
del frutto è fuso con il tegumento detto "cariosside", tratto tipico delle
graminacee. La pianta di mais è spesso alta 3 m, sebbene alcuni steli possano
crescere fino a 13 m di altezza. Una pannocchia contiene comunemente 600
chicchi. Sono di vari colori: nerastri, grigio-bluastri, porpora, verdi, rossi,
bianchi e gialli. Quando viene macinato, il mais produce più farina con molta
meno crusca rispetto al grano. Manca il glutine proteico del frumento e, quindi,
produce prodotti da forno con scarsa capacità di lievitazione. Una variante
genetica che accumula più zucchero e meno amido nella pannocchia viene consumata
come verdura e si chiama mais dolce. Le spighe giovani possono essere consumate
crude, ma man mano che la pianta matura (di solito durante i mesi estivi), la
pannocchia diventa più dura e si secca fino a diventare immangiabile. Entro la
fine della stagione di crescita, i chicchi si seccano e diventano difficili da
masticare senza cottura. Mentre i mais gialli derivano il loro colore dalla
luteina e dalla zeaxantina, nei mais di colore rosso la colorazione del chicco è
dovuta agli antociani e ai flobafeni.
Il mais è diventato un alimento base in molte parti del mondo, con la produzione
totale di mais che oggi supera quella del grano o del riso. Nel 2021 la
produzione mondiale totale è stata di 1,2 miliardi di tonnellate. Solo negli
Stati Uniti nel 2021 ne sono stati coltivati 384 milioni di tonnellate; seguono
a ruota Cina, Brasile, Argentina, Ucraina e India. Oltre ad essere consumato
direttamente dall'uomo, il mais viene utilizzato anche per l'etanolo da mais
(uno dei più importanti biocarburanti), l'alimentazione animale e altri prodotti
come l'amido di mais e lo sciroppo di mais. La sua fermentazione e la sua
distillazione danno origine a bevande alcoliche come il whisky (il nome deriva
dal gaelico "uisce beatha", "acqua di vita"). L'amido di mais può anche essere
trasformato in plastica, tessuti, adesivi e molti altri prodotti chimici.
La parola mais deriva dalla forma spagnola della parola indigena Taíno "mahiz"
che indicava questo cereale. Il mais come oggi lo coosciamo è stato selezionato
dall'uomo, ed è necessario l'intervento umano per la sua propagazione. Il fatto
che i chicchi cadano o meno dalla pannocchia da soli è una chiave utilizzata in
archeologia per distinguere il mais adomesticato dal suo antenato che si propaga
naturalmente, il cosiddetto teosinte. La maggior parte degli storici ritiene che
il mais sia stato domesticato nella valle di Tehuacán oppure nell'adiacente
valle del fiume Balsas del Messico centro-meridionale. Uno studio del 2002 ha
dimostrato che tutto il mais odierno è nato da un singolo domesticamento nel
Messico meridionale circa 9.000 anni fa. Lo studio ha anche dimostrato che i più
antichi tipi di mais sopravvissuti sono quelli degli altopiani messicani.
Successivamente, il mais si è diffuso da questa regione nelle Americhe lungo due
percorsi principali, coerentemente con un modello basato sulla documentazione
archeologica che suggerisce che il mais si sia diversificato negli altopiani del
Messico prima di diffondersi nelle pianure; avrebbe raggiunto le valli andine
della Colombia tra il 7000 e il 6000 a.C. Sono state trovate prove della
coltivazione di mais in Perù risalenti a circa 6700 anni fa. Gli Olmechi e i
Maya coltivavano numerose varietà di mais in tutta la Mesoamerica; a partire da
questa regione si è sviluppata una rete commerciale basata su eccedenze e nuove
varietà di colture di mais. Verso il 1000 a.C. gli Olmechi avevano organizzato
il loro calendario, i lori miti e la loro visione del mondo con il mais al
centro del loro simbolismo. I Mapuche del Cile centro-meridionale coltivavano
mais insieme a quinoa e patate in epoca precolombiana, tuttavia la patata era il
loro alimento base. L'espansione dell'Impero Inca fece sì che il mais venisse
commerciato e trasportato in tutto il Sudamerica.
Per i Maya, che lo chiamavano ixim, il mais era la divinità principale,
protagonista di un ciclo mitologico che narrava la sua morte per decapitazione e
la sua successiva rinascita all'inizio dell'attuale era del mondo come pianta
alimentare, ma non solo: come grande albero cosmico al centro dell'universo e
sovrano primordiale. Con il mais gli deì avevano impastato il corpo dell'uomo,
istituendo così una fondamentale analogia tra il ciclo vitale della pianta e
quello umano. Come alimento per i popoli precolombiani il mais aveva un ruolo
così centrale che la parola "waaj", il nome della pagnotta di mais cotta al
vapore dentro le foglie che avvolgono la pannocchia, era utilizzato come termine
generico per "alimento", come avviene con l'italiano "pane". Lo stesso valeva
per gli Aztechi che a quella pagnotta ("tamalli" in lingua náhuatl) aggiunsero
un diverso sistema di preparazione, il quale prevedeva la cottura alla piastra
di una sorta di frittella detta "tlaxcalli" e oggi nota come tortilla (uno dei
cibi simboli del Messico). Con una particolare varietà di mais gli Aztechi
facevano anche una specie di popcorn detto "momochtli". Le zuppe erano la
principale forma di preparazione del mais anche nel mondo andino, dove gli Incas
lo chiamavano sara. Tra l'altro, il famoso "astronauta di Palenque", una
raffigurazione sulla pietra tombale del re-sacerdote Pakal, risalente al 692 d.C.,
che secondo gli ufologi rappresenta una vera e propria astronave con tanto di
pilota alieno, in realtà (come riconosciuto da tempo dagli archeologi)
rappresenta la discesa agli Inferi di Pakal lungo il fusto dell'albero cosmico
di mais!!
Dopo l'arrivo degli europei nel 1492, i coloni spagnoli scoprirono il mais, lo
portarono in Europa e lo introdussero in altri paesi, ed esso si diffuse nel
resto del mondo grazie alla sua capacità di crescere in climi diversi. La
coltivazione intensiva iniziò molto probabilmente nel sud della Spagna nel 1525,
dopodichè si diffuse rapidamente nel resto dell'Impero Spagnolo compresi i suoi
territori in Italia e, da lì, in altri stati italiani. Il mais aveva molti
vantaggi rispetto al grano e all'orzo: produce due volte e mezzo la loro energia
alimentare per unità di superficie coltivata e può crescere ad altitudini e
climi estremamente variabili, da regioni relativamente secche con solo 250 mm di
pioggia annuale a regioni umide con oltre 5.000 mm. Per l'errata credenza che
venisse dall'Asia fu chiamato granoturco, e così è conosciuto ancor oggi. Nel
XVII secolo era un alimento comune per i contadini dell'Europa sudoccidentale,
in Italia specialmente sotto forma di polenta, anche se, nel capitolo VI dei
"Promessi Sposi" di Alessandro Manzoni, Renzo trova il cugino Tonio intento a
preparare « una piccola polenta bigia, di grano saraceno », evidentemente ancora
il cereale più diffuso nel milanese nel novembre 1628. Da notare che il mais
conobbe un destino simile a quello della patata: esso infatti provocò epidemie di pellagra, una malattia terribile
che conduce alla pazzia e che uccise migliaia di persone. Ai
tempi si credeva che fosse dovuta, come per la patata, a qualche tossina
contenuta nel mais, ma le ricerche non diedero esito e si continuò a morire di
pellagra, sino a che non ci si accorse che in Messico si consumavano vagonate di
mais, eppure la pellagra era sconosciuta. Solo nel 1935 ci si rese conto che la
pellagra era dovuta a carenza di vitamina D, abbondante in tutti i cereali.
Abbonda anche nel mais, ma la cuticola esterna impedisce al chicco di
rilasciarla. Gli Aztechi e gli altri popoli precolombiani avevano imparato a
mettere a bagno il mais in acqua e calce, così da sciogliere la cuticola e
liberare la vitamina D (un processo chiamato nixtamalizzazione); gli spagnoli
però non avevano esportato questo processo in Europa, probabilmente nell'errata
convinzione che si trattasse solo di un rito pagano. Quando fu introdotto anche
in Europa, usando procedimenti chimici anche più efficaci del bagno nella calce,
la pellagra a poco a poco sparì, e oggi è ridotta a pochi casi facilmente
curabili. Come vedete, anche gli erboristi del passato sbagliavano, e di grosso!

Il
pane dei tropici
La
manioca (Manihot esculenta, chiamata anche "yuca" in lingua Arawak e "kappa"
o "maricheeni" in lingua Malayalam, è un arbusto legnoso della famiglia delle
Euforbiacee, originario del Sud America. Sebbene sia una pianta perenne, la
manioca è ampiamente coltivata come coltura annuale nelle regioni tropicali e
subtropicali per il suo tubero commestibile e ricco di amido, una delle
principali fonti di carboidrati per le popolazioni andine. La manioca viene
consumata prevalentemente bollita, ma grandi quantità vengono utilizzate per
estrarre l'amido di manioca, chiamato tapioca o cassava, che viene utilizzato
per alimenti, mangimi e scopi industriali.
Pianta arbustiva, perenne, dicotiledone, alta da uno a cinque metri, ha rami
fragili a scorza liscia. Le foglie sono semplici, alterne e caduche, costituite
da lembi multilobati lunghi da 10 a 20 cm e attaccati allo stelo da piccioli
lunghi fino a 30 cm. I fiori unisessuali sono raggruppati in infiorescenze con
fiori maschili in alto e femminili alla base. Il frutto è una capsula contenente
tre semi. Poiché i semi germinano con difficoltà, per la riproduzione si usano
le talee prelevate dalla coltura precedente. La radice tuberizzata della manioca
è lunga e affusolata, con una polpa soda e omogenea racchiusa in una scorza
staccabile, spessa circa 1 millimetro, ruvida e marrone all'esterno. Le cultivar
commerciali possono avere un diametro da 5 a 10 centimetri, una lunghezza
compresa tra 15 e 30 cm e un peso tra i 900 e i 2.300 grammi. Lungo l'asse della
radice corre un fascio vascolare legnoso, e la polpa può essere bianca o
giallastra. Ogni pianta produce normalmente 5-10 tuberi. Le radici di manioca
sono molto ricche di amido e contengono piccole quantità di calcio (16
milligrammi per 100 grammi), fosforo (27 mg per 100 g) e vitamina C (20,6 mg
per100 g), ma sono poveri di proteine e altri nutrienti. Al contrario, le
foglie di manioca sono una buona fonte di proteine per l'alimentazione animale
e umana, ma sono carenti dell'aminoacido metionina.
La manioca è la terza più grande fonte di carboidrati alimentari nei tropici,
dopo riso e mais, un alimento di base così importante che almeno 800 milioni di
persone in tutto il mondo dipendono dalla manioca come alimento principale. La
manioca svolge un ruolo particolarmente importante nell'agricoltura nei paesi in
via di sviluppo, in particolare nell'Africa subsahariana, perché è una delle
colture più resistenti alla siccità, in grado di crescere su terreni poveri e
con scarse precipitazioni, e perché è una pianta perenne che può essere raccolta
all'occorrenza. La sua ampia finestra di raccolta leconsente di agire come
riserva di carestia ed offre flessibilità agli agricoltori poveri di risorse
perché serve come coltura di sussistenza o da reddito. Le condizioni ottimali
per la coltivazione della manioca sono temperature medie annue comprese tra 20°
e 29°C, precipitazioni annue comprese tra 1.000 e 2.500 mm e un periodo di
crescita annuale non inferiore a 240 giorni. La manioca è ben adattata entro
latitudini 30° nord e 30° sud, ad altitudini comprese tra il livello del mare e
2.000 m sul livello del mare. La manioca viene raccolta a mano sollevando la
parte inferiore del fusto, estraendo le radici dal terreno e rimuovendole dalla
base della pianta. Essa viene propagata tagliando lo stelo in sezioni di circa
15 cm, piantate prima della stagione delle piogge. La manioca è una coltura
altamente produttiva se si considera l'energia alimentare prodotta per unità di
superficie terrestre al giorno: 250.000 kcal/ha, rispetto a 156.000 kcal/ha per
il riso, 110.000 kcal/ha per il frumento e 200.000 kcal/ha per il mais. La
manioca cruda contiene il 60% di acqua, il 38% di carboidrati, l'1% di proteine
e ha un contenuto di grassi trascurabile. Una confezione da 100 grammi di
manioca cruda fornisce 160 kilocalorie di energia alimentare e il 25% del valore
giornaliero di vitamina C,. L'amido di manioca cotto ha una digeribilità
superiore al 75%. Con 60 milioni di tonnellate annue (il 20% del totale), la
Nigeria è il più grande produttore mondiale di manioca, seguita dalla Repubblica
Democratica del Congo con 41 milioni, dalla Thailandia con 29, dal Ghana con
21,8 e dall'Indonesia con 18,3. Nel 2020 la produzione globale di radice di
manioca è stata di 303 milioni di tonnellate. La Thailandia è il più grande
esportatore di amido di manioca.
Ma attenzione! Le radici, le bucce e le foglie di manioca non devono essere
consumate crude perché contengono due glucosidi cianogenici, la linamarina e la
lotaustralina. Questi vengono decomposti dalla linamarasi, un enzima presente in
natura nella manioca, liberando acido cianidrico. La manioca è classificata come
dolce o amara, con le varietà amare che ne contengono quantità molto maggiori di
glucosidi cianogenici. Deve dunque essere adeguatamente preparata prima del
consumo, poiché una preparazione impropria della manioca può lasciare abbastanza
cianuro residuo da causare intossicazione acuta, paralisi parziale, atassia (un
disturbo neurologico che colpisce la capacità di camminare, noto come konzo) e
anche la morte. Gli agricoltori spesso preferiscono le varietà amare perché
scoraggiano parassiti, animali e ladri (una dose di 25 mg di glucoside
cianogenico di manioca puro, che contiene 2,5 mg di cianuro, è sufficiente per
uccidere un topo! Durante la crisi in Venezuela alla fine degli anni 2010, sono
state segnalate dozzine di morti a causa del fatto che i venezuelani ricorrevano
al consumo di manioca amara per arginare la fame. Casi di avvelenamento da
manioca sono stati documentati anche durante la carestia che accompagnò il
"Grande balzo in avanti" in Cina (1958-1962). Le società che tradizionalmente
mangiano manioca generalmente sanno che un breve ammollo della manioca non è
sufficiente, ma l'ammollo per 18-24 ore può rimuovere fino a metà del livello di
cianuro. Per alcune varietà dolci con radici più piccole, la cottura è
sufficiente per eliminare ogni tossicità. Il cianuro viene portato via
nell'acqua di lavorazione e le quantità prodotte nel consumo domestico sono
troppo piccole per avere un impatto ambientale. Invece la produzione industriale
di farina di manioca può generare abbastanza cianuro e glicosidi cianogenici
negli effluenti da avere un grave impatto ambientale.
Passiamo alla storia. Manioca deriva da un termine in lingua Guarani attraverso
il francese "manioc". La parola tapioca viene invece dalla lingua Tupi (Brasile)
"tipioca" "succo di manioca pressata", da "tipi", "residuo", e "og", "spremere";
la parola cassava discende invece dal francese "cassave" attraverso lo spagnolo
"casabe", dalla parola "caçabi" in lingua Taino. É stato dimostrato che le
popolazioni selvatiche di Manihot esculenta sottospecie flabellifolia sono le
progenitrici della manioca domesticata. Esse sono concentrate nel Brasile
centro-occidentale, dove probabilmente la manioca fu domesticata per la prima
volta 10.000 anni fa. Si possono trovare anche varietà delle moderne specie
domestiche che crescono allo stato selvatico nel sud del Brasile. Del polline
fossile di manioca è stato rinvenuto nel sito archeologico di San Andrés, nelle
pianure del Golfo del Messico, risalente al 4600 a.C. La più antica prova
diretta della coltivazione della manioca proviene invece da un sito Maya di
1.400 anni fa, Joya de Cerén in El Salvador. Con il suo alto potenziale
alimentare, essa divenne ben presto un alimento base per le popolazioni native
del Sud America settentrionale, della Mesoamerica e del popolo Taino nelle isole
caraibiche, che la chiamavano yuca e la coltivavano utilizzando una forma di
agricoltura ad alto rendimento; non a caso, essa è spesso raffigurata nell'arte
nativa. Il popolo Moche ad esempio raffigurava spesso la yuca nelle sue
ceramiche. Nei primi anni della loro occupazione dell'America, gli spagnoli non
volevano mangiare manioca o mais, che consideravano velenosi e poco nutrienti,
perchè legati a culti pagani. La coltivazione e il consumo di manioca
continuarono tuttavia sia nell'America portoghese che in quella spagnola, ed
anzi la produzione in serie di pane di manioca divenne la prima industria cubana
fondata dagli spagnoli, perché il clima tropicale cubano non era adatto alla
semina del grano. La manioca dal Brasile fu introdotta in Africa dai
commercianti portoghesi nel XVI secolo. Nello stesso periodo fu anche introdotta
in Asia attraverso commercianti portoghesi e spagnoli, e piantata nelle loro
colonie a Goa, Malacca, Indonesia orientale, Timor e Filippine. Ecco perchè oggi
il mais e la manioca sono importanti alimenti di base, sostituendo le colture
africane native, in paesi come la Tanzania. La manioca è diventata una coltura
importante anche in Asia: viene coltivato principalmente per l'estrazione di
amido e la produzione di biocarburanti in Thailandia, Cambogia e Vietnam.
Secondo una leggenda la manioca sarebbe stata introdotta nel 1880 nello stato
del Kerala, nell'India meridionale, dal re di Travancore, il Maragià Vishakham
Thirunal, come sostituto del riso dopo che una grande carestia aveva colpito il
suo regno, ma vi sono casi documentati di coltivazione di manioca in quello
stato prima del suo regno. La manioca è talvolta chiamata "il pane dei tropici",
ma non va confuso con l'albero del pane asiatico (Artocarpus altilis) o africano
(Treculia africana).
Il genoma completo dell'aplotipo della manioca africana è stato completamente
sequenziato e reso disponibile utilizzando la tecnologia Hi-C. La diversità
genetica è vitale quando la produttività è diminuita a causa di parassiti e
malattie e i piccoli proprietari tendono a conservare pool genetici meno
produttivi ma più diversificati.
Purtroppo grandi quantità di manioca immagazzinata vanno sovente perdute a causa
dell'infestazione da insetti, con perdite tra il 19% e il 30% del prodotto
raccolto. In Africa i problemi maggiori li davano la cocciniglia della manioca (Phenacoccus
manihoti) e l'acaro verde della manioca (Mononychellus tanajoa), che potevano
causare perdite di raccolto fino all'80%. Questi parassiti dilagarono negli anni
'70 e '80, ma sono stati messi sotto controllo in seguito all'istituzione del
Centro di Controllo Biologico per l'Africa dell'Istituto Internazionale di
Agricoltura Tropicale (IITA), il quale ha scoperto che due nemici naturali
sudamericani, Anagyrus lopezi (una vespa parassitoide) e Typhlodromalus aripo
(un acaro predatore), controllano efficacemente rispettivamente la cocciniglia
della manioca e l'acaro verde della manioca. Invece il batterio Xanthomonas
axonopodis provoca la peronospora della manioca. Questa malattia ha avuto
origine in Sud America e ha seguito la manioca in tutto il mondo, rendendosi
responsabile di perdite e carestie quasi catastrofiche negli ultimi decenni. Il
virus del mosaico della manioca africana fa appassire le foglie della pianta
della manioca, limitando la crescita della radice; la diffusione di questo virus
in Africa negli anni '20 dovuta alla mosca bianca e al trapianto di piante
malate in nuovi campi portò a una gravissima carestia. Verso la fine degli anni
'80 in Uganda si è verificata una mutazione che ha reso il virus ancora più
dannoso, causando la completa perdita delle foglie. Questo virus mutato si è
diffuso a una velocità di 80 chilometri all'anno, e dal 2005 è stato trovato in
Uganda, Ruanda, Burundi, Repubblica Democratica del Congo e Repubblica del
Congo. Un'altra delle principali minacce alla coltivazione in tutto il mondo è
rappresentata dalla vasta gamma di nematodi parassiti della manioca in tutto il
mondo: essi includono Pratylenchus brachyurus, Rotylenchulus reniformis,
Meloidogyne incognita e Meloidogyne javanica. Purtroppo la ricerca sui parassiti
nematodi della manioca è ancora agli inizi: poiché i nematodi hanno una
distribuzione apparentemente irregolare nei campi agricoli di manioca, non è
facile definire chiaramente il livello di danno diretto attribuito ai nematodi e
successivamente quantificare il successo di una contromisura. Visto che i
nematocidi si sono rivelati poco efficienti, l'uso di cultivar resistenti è il
metodo di gestione più pratico di questa infezione.
La manioca subisce un deterioramento fisiologico post-raccolta una volta che i
tuberi vengono separati dalla pianta principale, e questo rappresenta uno dei
principali ostacoli che impediscono agli agricoltori di esportare manioca
all'estero e di generare reddito. La manioca fresca può essere conservata come
la patata, usando il tiabendazolo o la candeggina come fungicida, quindi
avvolgendola nella plastica, ricoprendola di cera o congelandola, ma tali
strategie si sono rivelate economicamente o tecnicamente impraticabili.
L'ingegneria genetica (il progetto chiamato "BioCassava Plus") ha portato alla
nascita di varietà di manioca con una migliore durata dopo il raccolto, ma si sa
bene la diffidenza del grande pubblico verso gli OGM.
I piatti a base di manioca sono ampiamente consumati dovunque venga coltivata la
pianta (ovviamente deve essere cotta correttamente per disintossicarla prima di
essere mangiata). Un metodo di lavorazione sicuro noto come "metodo di
bagnatura" consiste nel mescolare la farina di manioca con acqua in una pasta
densa, stenderla in uno strato sottile su un cesto e poi lasciarla riposare per
cinque ore a 30 °C all'ombra. In questo lasso di tempo, circa l'83% dei
glicosidi cianogenici viene scomposto dalla linamarasi. La radice della varietà
dolce ha un sapore delicato e può sostituire le patate; può essere trasformata
in una farina che viene utilizzata in pane, torte e biscotti.
In diversi paesi dei Caraibi con la tapioca si produce un alimento simile al
pane, chiamato "casabe" in Repubblica Dominicana e Porto Rico; ad Haiti lo si
mangia con burro di arachidi o latte, a Porto Rico con olio e aceto. La farina
di manioca viene usata anche per fare alcune varianti locali della "empanada":
due esempi sono la "catibía" dominicana e le "pasteles" portoricane, ripiene di
manzo, pollo o maiale, un piatto tipicamente natalizio. In Giamaica con la
tapioca si realizza il tradizionale "bammy", un pane basso originariamente
tipico dell'etnia Arawak. Altre ricette caraibiche a base di tapioca sono la "moussa"
haitiana fatta con tapioca bollita, il "sancocho" dominicano, un bollito misto
di verdure, e le "arepitas de yuca" dominicane, fettine di radice di manioca
fritte.
In El Salvador, Costa Rica e altri paesi dell'America centrale la "yuca" viene
bollita, fritta o usata per preparare zuppe. Fra i piatti tipici salvadoregni a
base di manioca si possono citare la "yuca frita con chicharrón", manioca fritta
nell'olio servita con una salsa chiamata "curtido" e carne di maiale o sardine,
e il "pan con pavo", un panino fatto con farina di manioca, di forma simile a
una baguette, farcito con carne di tacchino marinata. In Costa Rica sono molto
diffusi panini di manioca con carne di maiale e lime. A Panama si mangia un
panzerotto fritto di farina di manioca ripieno di carne speziata, che prende il
nome di "carimanola".
In Bolivia la manioca si mangia in moltissimi modi. Fritta, viene spesso
accompagnata con una salsa piccante nota come "llajwa", formaggio, o "choclo"
(mais essiccato). Sono moltissimi anche i piatti tipici brasiliani in cui si
impiega la manioca, qui chiamata "mandioca", "macaxeira" o "aipim" a seconda
delle zone: dalla "vaca atolada", un bollito di carne e manioca, al "pirão",
pezzetti di pesce cotti nella farina di manioca, al "pão de queijo", un pane al
formaggio; cotta da sola, la farina di manioca viene chiamata "farofa", e
costituisce uno degli elementi principali dell'alimentazione quotidiana del
brasiliano medio. Sempre in Brasile la manioca bollita viene usata per fare un
budino dolce molto popolare. In Colombia con la manioca si fa un tipo di pane
chiamato "pandebono", un panzerotto chiamato "bollo de yuca", servito con burro
e formaggio, e un dessert a base di manioca, anice, zucchero e marmellata di
guava detto "enyucado". In Ecuador la manioca viene mangiata bollita o affettata
e fritta ("yuquitos"), e diversi tipi di pane e panzerotto come i "bolitos de
yuca", in genere ripieni di formaggio. In Paraguay la manioca si mangia in tutti
i pasti, in genere bollita o nella forma di "chipa", un pane al formaggio che si
prepara nelle festività. Nella Guyana il succo della manioca amara viene bollito
fino a fargli raggiungere la viscosità di uno sciroppo e poi insaporito con
spezie; la salsa che se ne ottiene, nota come "cassareep", serve come base per
la preparazione di diverse salse e condimenti, ed è alla base di uno dei piatti
nazionali della Guyana, il "pepperpot guyanese". La "casa de farinha" è il luogo
dove in Brasile è effettuata tradizionalmente la lavorazione della radice di
manioca per ottenere la farina di tapioca, in particolare nelle regioni Nord e
Nordest, usando metodi tradizionali ereditati dalle popolazioni indigene, che
furono le prime a coltivare la manioca; oggi però la trasformazione industriale
è in aumento.
In Nigeria e in molti altri paesi dell'Africa occidentale, tra cui Ghana,
Camerun, Benin, Togo, Costa d'Avorio e Burkina Faso, vengono solitamente
grattugiate e fritte in olio di palma per conservarle. Il risultato è un
alimento chiamato "gari". Il processo di fermentazione riduce anche il livello
di antinutrienti, rendendo la manioca un alimento più nutriente. In Sierra Leone
vengono usate come alimento anche le foglie della pianta; vengono lavate
ripetutamente per renderle meno amare, e poi pestate insieme con l'olio di palma
per realizzare una salsa. In Africa centrale la manioca viene generalmente
bollita e poi pestata in una sorta di purè o porridge chiamato "fufu" o
"cuscus", che viene talvolta mischiato a spezie e poi cotto; viene anche
cucinata alla griglia dopo essere stata marinata per alcuni giorni in acqua
salata. In Africa orientale, dove la manioca è nota come "mihogo", la si fa
soprattutto fritta a pezzetti, talvolta con una salsa chiamata "pilipili",
ottenuta dalla cottura di peperoncini piccanti in olio di palma. Nelle campagne
si prepara un porridge di manioca, che viene chiamato "ugali" in Tanzania, "nshima"
in Zambia e "mwanga" dai Kikuyu del Kenya. In Repubblica Centrafricana esiste
una grande varietà di ricette basate sulla manioca, che viene usata anche per
fare pane e biscotti. Un piatto tipico della Costa d'Avorio è l'"attiéké", a
base di polpa fermentata di manioca grattugiata o fatta a granelli, spesso
servito come accompagnamento di carni stufate.
In India la manioca si mangia spesso con piatti al curry, insieme con pesce o
carne; due esempi sono il "kappayum meenum" (letteralmente "manioca con pesce")
e il "kappa biriyani" ("manioca con carne"), molto popolari nello stato di
Kerala. In Indonesia la manioca si chiama "singkong" e viene bollita, fritta o
cotta al forno. A Giava si mangia un piatto a base di radice di manioca
essiccata chiamato "gaplek", ma anche le foglie della pianta sono usate in molte
ricette: per esempio nel "gulai daun singkong" (foglie di manioca in latte di
cocco), nell'"urap" (un'insalata mista) e nel "buntil" (un involtino
vegetariano). Nelle Filippine la manioca viene bollita con lo zucchero e usata
per fare torte e altri dolci.
Possono essere prodotte anche numerose bevande alcoliche a base di manioca: "cauim"
e "tiquira" (Brasile), "kasiri", "parakari" o "kari" (Venezuela, Guyana,
Suriname), "impala" (Mozambico), "masato" (Amazzonia peruviana) e "tarul ko" (Darjeeling
e Sikkim, India).
I tuberi di manioca e il suo fieno sono utilizzati in tutto il mondo anche come
mangime per animali. Il fieno di manioca viene raccolto in una fase di crescita
giovane, da tre a quattro mesi, quando raggiunge il mezzo metro di altezza;
viene quindi essiccato al sole per uno o due giorni fino a quando il suo
contenuto finale di sostanza secca si avvicina all'85%. Il fieno di manioca
contiene un alto contenuto proteico (20-27% di proteine grezze) e tannini
condensati. La manioca viene anche utilizzata in numerosi prodotti per il bucato
disponibili in commercio, in particolare come amido per camicie e altri
indumenti: usare l'amido di manioca diluito in acqua e spruzzarlo sui tessuti
prima della stiratura aiuta a irrigidire i colletti. In Repubblica Centrafricana
la manioca viene persino utilizzata per realizzare una sorta di vernice
utilizzata per imbiancare le pareti esterne degli edifici.
In tempi recenti è iniziata una ricerca a tappeto per valutare l'uso della
manioca come materia prima per biocarburanti a base di etanolo. Nell'ambito del
piano di sviluppo per l'energia rinnovabile nell'undicesimo piano quinquennale
nella Repubblica Popolare Cinese, l'obiettivo era aumentare la produzione di
etanolo da materie prime non cerealicole a 2 milioni di tonnellate; il 22
dicembre 2007 a Beihai è stato completato il più grande impianto di produzione
di etanolo da manioca, con una produzione annua di 200mila tonnellate. Inutile
dire però che questa pratica sottrarrebbe un'importante fonde di amido a molte
popolazioni già afflitte da malnutrizione cronica.
La manioca ha applicazioni nella medicina tradizionale di alcuni dei paesi in
cui è coltivata. Le radici delle varianti amare sono usate per trattare la
diarrea e la malaria; le foglie possono essere impiegate come analgesici e per
ridurre l'ipertensione. I cubani impiegano la manioca nel trattamento dei
sintomi della sindrome del colon irritabile.
Un tubero così utile e diffuso fin a tempi immemorabili non poteva non entrare
nel mito dei popoli per i quali è indispensabile; riportiamone uno tratto dalla
mitologia dei Tupí, uno dei più grandi gruppi di popolazioni indigene del
Brasile prima della sua colonizzazione, che si stabilirono per la prima volta
nella foresta pluviale amazzonica circa 2.900 anni fa, per poi migrare verso sud
e occupare gradualmente la costa atlantica del sud-est del Brasile. Secondo il
mito, la figlia di un capo Tupí rimase incinta nonostante lei asserisse di non
aver giaciuto con alcun uomo. Suo padre non le credette, volle vendicarsi
dell'uomo che aveva portato la vergogna nella sua famiglia e insistette perché
lei le rivelasse il suo nome. Poiché si rifiutava di farlo, suo padre la tenne
prigioniera all'interno di una capanna e decise di ucciderla per evitare il
disonore. Con questo pensiero in mente il capo della tribù si addormentò, e
sognò un uomo dalla pelle bianca vestito da guerriero. Questi gli disse che sua
figlia gli stava dicendo la verità e che non aveva avuto alcun contatto con un
uomo, quindi gli ingiunse di prendersi cura di sua figlia perché un giorno
avrebbe portato un grande dono a tutta la sua tribù. Il padre decide di dare
retta al sogno, e dopo nove lune piene sua figlia diede alla luce una bambina la
cui pelle era bianca come la luna e i suoi occhi scuri come la notte. Ciò
provocò la sorpresa non solo dell'intera tribù, ma anche delle tribù vicine che
erano venute a visitare la neonata perché non potevano credere che fosse bianca.
Maní crebbe forte e bella fino al suo primo compleanno, quando morì
improvvisamente senza segni di malattia o dolore. Il capotribù era così
disperato che seppellì la bambina nella sua stessa capanna. Sua madre annaffiava
la sua tomba ogni singolo giorno, come era usanza nella sua tribù. Un giorno uno
strano tipo di pianta spuntò dalla tomba di Maní, e poiché nessuno ne aveva mai
visto una uguale, la lasciarono crescere e nessuno nella tribù osava toccarla.
Notarono anche che quando gli uccelli mangiavano i frutti della pianta,
mostravano strani sintomi, come se fossero ubriachi. Qualche tempo dopo si aprì
una crepa nella terra e la gente della tribù vi trovò un tubero che aveva lo
stesso colore della pelle del corpo della bambina defunta. Raccolsero il tubero
da terra, lo sbucciarono e lo cucinarono, e scoprirono con sorpresa che aveva un
sapore delizioso e aumentava la loro forza; con esso prepararono anche una
bevanda che poteva far addormentare facilmente. Così, da quel giorno in poi,
iniziarono ad utilizzare la radice come alimento base e la chiamarono "mandioca",
che in lingua Tupí significa "casa" ("oca") di Maní.
Esistono versioni alternative di questa legenda. Padre Carlos Teschauer
(1851-1930), missionario gesuita in Amazzonia, ne ha riportata una nei suoi
scritti. In essa si racconta come il capo della tribù stesse per uccidere sua
figlia quando un guerriero bianco gli apparve in sogno e gli disse di non farlo
perché sua figlia gli stava dicendo la verità, e che lei davvero non aveva avuto
rapporti con nessun uomo. In questa versione il bambino nato dalla fanciulla era
un maschietto che si chiamava Maní. Stavolta il figlio non solo visse a lungo,
ma insegnò anche alla sua tribù molte cose. Disse loro anche che dopo un anno
dalla sua morte avrebbero dovuto aprire la sua tomba affinché fosse rivelato
loro il tesoro più grande di tutti, una radice che produce pane, e così fu.
Un'altra leggenda diceva che uno spirito buono era sceso sulla Terra e aveva
mostrato ai nativi le proprietà della manioca, insegnando loro a estrarre lo
spirito maligno che vi abitava (cioè il cianuro), ma non insegnò loro a farla
riprodurre. Successivamente una delle donne della tribù, mentre vagava per la
foresta, incontrò un bellissimo giovane cacciatore che non era altro che la
manioca personificata. Egli la sedusse e da questa unione nacque una figlia.
Quest'ultima condusse la tribù alla piantagione dell'arbusto e insegnò loro come
riprodurlo dalle sottili porzioni del fusto.
Chiudiamo con un antico proverbio del Congo: « Un pezzetto di manioca non è mai
troppo caldo per chi è affamato! »

Le
palline d'oro di San Nicola
Il mandarino (Citrus reticulata)
è un agrume dolcissimo di
forma sferoidale, un po' appiattito all'attaccatura, che si lascia cogliere
facilmente. L'albero è un arbusto alto poco più di due metri, che in alcune
varietà raggiunge i quattro metri e le cui foglie sono piccole e profumatissime.
Il tronco dell'albero e i rami principali sono spinosi. I fiori sono portati
singolarmente o in piccoli gruppi all'ascella delle foglie. Gli agrumi sono
solitamente autofertili, cioè possono essere impollinati all'interno dello
stesso fiore, oppure sono senza semi, e quindi non richiedono impollinazione. La polpa del frutto è di
colore arancio chiaro, costituita da spicchi facilmente separabili, molto
succosa e dolce, entro la quale si trovano numerosi semi. La buccia è di colore
arancione, sottile e profumata, e consente una facile pelatura del frutto, in
quanto scarsamente attaccata alla polpa: spesso la buccia addirittura si
distacca dalla polpa ancora prima che il frutto venga colto dal ramo, il che gli
conferisce un aspetto "ammaccato". Il mandarino si separa anche
facilmente in spicchi. I frutti possono essere senza semi o contenerne un
piccolo numero; sono dolci da gustare e possono essere consumati interi o
spremuti per ricavarne il succo, avendo un profumo agrodolce e aromatico come la
clementina. Un albero adulto può forniare da 400 a 600 frutti all'anno. Può
essere coltivato in aree tropicali e subtropicali, e si rovina facilmente con il
freddo. I mandarini sono normalmente consumati come frutta fresca o lavorati
nella produzione di marmellate e frutta candita. Dalla buccia si estrae un olio
essenziale che è un liquido di colore giallo oro leggermente fluorescente,
utilizzato come aromatizzante per caramelle, gelatine, gelati, gomme da
masticare e prodotti da forno. Viene utilizzato anche come aromatizzante nei
liquori.
Chimicamente si tratta perlopiù di d-limonene, che spesso viene sofisticato con
l'olio ricavato dal frutto intero non maturo. La buccia, chiamata chenpi, viene
utilizzata fresca o essiccata come spezia per insaporire piatti dolci e salse.
Gli spicchi di mandarino in scatola vengono sbucciati per rimuovere il midollo
bianco prima dell'inscatolamento; altrimenti diventano amari. I segmenti vengono
pelati utilizzando un processo chimico: innanzitutto vengono
scottati in acqua calda per allentare la pelle; quindi vengono immersi in una
soluzione di lisciva, che elimina la parte bianca e immangiabile. Infine gli spicchi
vengono sciacquati più volte in semplice acqua. Una volta preparati
adeguatamente, i mandarini vengono sottoposti a un
trattamento termico per rimuovere i batteri che possono causare deterioramento,
per poi venire confezionate in contenitori ermetici. È possibile aggiungere
anche acido ascorbico.
Nella medicina tradizionale cinese, la buccia essiccata del frutto viene
utilizzata per migliorare la digestione.
Il nome mandarino si può riferire tanto alla pianta quanto al suo frutto. Tale
nome era dato agli antichi funzionari politici imperiali cinesi, ed è passato al
frutto in quanto quei funzionari erano vestiti con un mantello arancione. Il
nome latino Cĭtrŭs (f., II. declinazione) è giustificabile come formazione
primaria indoeuropea *(s)khₐĭ-t-rŏ́-s, "chiaro, luminoso", mentre "reticulata" deriva dall'aspetto retato della buccia.
Gli agrumi sono coltivati da almeno 4.000 anni, e una serie di incroci
successivi ha generato almeno 25 specie diverse. Di solito associamo le arance e
i limoni al sole delle regioni mediterranee, ma in realtà la domesticazione
degli agrumi è iniziatain Estremo Oriente. I primi documenti scritti che citano
gli agrumi sono il testo cinese "Tributo a Yu", del XXII secolo a.C., dove
vengono menzionate alcune specie di agrumi, probabilmente mandarini e pomelo, e
l’indiano "Vajaseneyi sambita" (800 a.C.) che cita i cedri e i limoni. Come
racconta il chimico e divilgatore scientifico Dario Bressanini nei suoi saggi
(ad esempio "Contro natura", scritto nel 2015 con Beatrice Mautino), l'albero
genealogico degli agrumi è rimasto a lungo misterioso, fino a quando il
sequenziamento del genoma di alcuni agrumi ha permesso di ricostruirne
parzialmente i complessi rapporti di parentela. La scoperta più sorprendente è
il fatto che quasi tutti gli agrumi coltivati al mondo sono il risultato di
incroci di sole tre specie: il cedro (Citrus medica), il pomelo (Citrus maxima)
e, a sorpresa, proprio il nostro mandarino. Il cedro
è stato il primo agrume a raggiungere l’Europa: probabilmente originario
dell'India, è coltivato nel Sudest asiatico da migliaia di anni e fu introdotto
nel Mediterraneo dalla Persia da Alessandro Magno. Usato per il suo aroma, era
l’unico agrume diffuso in epoca romana, e fu Plinio il Vecchio a battezzarlo
citrus, nome poi esteso a tutti gli agrumi. Invece il
pomelo sembra un grande pompelmo, largo fino a 30 cm di diametro, ma con
una forma un po’ a pera e con molta parte spugnosa bianca non commestibile (il
cosiddetto albedo); è nativo del Sudest asiatico ed è stato introdotto in Spagna
dagli Arabi, insieme ad altri agrumi, attorno all’anno 1000. È arrivato in
Italia nel XVII secolo grazie al capitano inglese Philip Chaddock, che lo
esportò anche in Giamaica, e per questo in Liguria questo agrume è chiamato
sciaddocco.
La coltivazione del Citrus reticulata invece ebbe inizio in Cina ed arrivò in Europa
a partire da Portogallo e Spagna, dove cominciò a diffondersi intorno al XV secolo.
Negli Stati Uniti d'America la varietà più coltivata è la satsuma o mikan,
importata nel 1876 dal Giappone; da notare che Satsuma, oltre al nome di una
regione dell'isola di Kyūshū, è anche una città dell'Alabama cresciuta con i
mandarineti. Questa varietà viene coltivata anche in Sicilia, assieme all'avana
e al paternò. Da non dimenticare il mandarino tardivo di Ciaculli, dal sapore
zuccherino, che viene coltivato nell'omonima frazione di Palermo, nel cuore
della pianura Conca d'oro. Viene denominato "tardivo" per via di una maturazione
prolungata fino ai primi giorni del mese di marzo. Nel Regno Unito e negli USA
il mandarino viene chiamato anche tangerine, perchè venne importato pel la prima
dal porto marocchino di Tangeri. Si tratta in realtà di due distinte varietà: il
vero mandarino è di colore arancio chiaro e leggermente appiattito; il peduncolo
si trova in una piccola infossatura. Il tangerino invece è un ibrido del
mandarino con l'arancio, perciò la buccia è di clementine arancio acceso; il
peduncolo esce da una piccola protuberanza (come in certi limoni); le foglie
sono più larghe. Sebbene il mandarino ancestrale fosse amaro, la maggior parte
delle varietà di mandarini commerciati oggi derivano dall'ibridazione con il
pomelo, che conferisce loro un sapore molto dolce. Sempre più importanza hanno
oggi le varietà senza semi, il cui genoma è stato modificato per ottenere dei
triploidi (sono presenti tre cromosomi di ogni tipo) invece dei normali diploidi
con i semi.
I dieci maggiori produttori di mandarino nel 2018 sono stati la Repubblica Popolare
Cinese con 19.035.444 tonnellate, la Spagna con 1.978.581, la Turchia con
1.650.000, il Marocco con 1.208.789, l'Egitto con 1.068.351, il Brasile con
996.872, gli Stati Uniti d'America con 804.670, il Giappone con 773.700,
l'Italia con 699.832 e la Corea del Sud con 646.218 tonnellate.
Citrus japonica è invece il cosiddetto mandarino cinese o
kumquat (il nome deriva dalla pronuncia cantonese dei caratteri 金橘,
letteralmente "tangerino d'oro"); è originario della Cina (in letteratura le
prime descrizioni risalgono al XII secolo), ed è stato a lungo coltivato in
Giappone. Furono introdotte in Europa nel 1846 da Robert Fortune (1812-1880),
collezionista della London Horticultural Society. Il frutto sembra una piccola
arancia ovale lunga 3–4 cm e larga 2–4 cm; a seconda della varietà la buccia si
presenta dal giallo al rosso e viene prodotto generalmente dal tardo novembre
fino a febbraio. Differisce dalle altre specie di Citrus per il fatto che
durante l'inverno entra in un periodo di letargo in cui non mette più nuove
gemme o getti.
Tutti gli altri agrumi coltivati sono risultati di incroci. Come spiega sempre
Bressanini, quello più importante, dal punto di vista economico, è l’arancia
dolce (Citrus sinensis), prodotta soprattutto in Brasile, nel
Mediterraneo, in Cina e negli USA, anche se negli ultimi anni si è osservata una
riduzione del mercato proprio a favore del mandarino. Non esiste allo stato
selvatico perché è il risultato di un incrocio, probabilmente avvenuto 4000 anni
fa, tra il mandarino e il pomelo. Non sappiamo se l’incrocio sia avvenuto
casualmente o se sia stato operato dall’uomo, ma quel nuovo frutto dolce e
succoso fu immediatamente apprezzato e coltivato e, forse, ulteriormente
reincrociato con il mandarino. Poiché è il risultato di uno o pochissimi incroci
originari, la sua biodiversità è estremamente bassa. Il bacino del Mediterraneo,
nonostante vi sia stato introdotto dagli Arabi solo nel Basso Medioevo, ne
costituisce il principale centro di diversificazione genetica, con varie
mutazioni, in tre regioni distinte. La principale è la penisola Iberica,
caratterizzata da arance bionde e dolci. Le popolari Washington Nave sono le più
diffuse al mondo, e sono state inizialmente coltivate in Spagna e Portogallo. La
seconda area di diversificazione comprende la Tunisia, Malta e la Sicilia. Le
arance Tarocco sono oggi le più coltivate in quel gruppo, ora. La terza area di
diversificazione delle arance è il Vicino Oriente. L’arancia
amara (Citrus aurantium), detta anche arancia di Siviglia, non è
l’antenata dell’arancia dolce come alcuni credono, ma è anch’essa un incrocio
tra il mandarino e il pomelo. Introdotta in Italia nel Medioevo con il nome di
melangolo, la si usava per aromatizzare carne o pesce. Ora il suo uso è limitato
a bevande e marmellate. L’arancio amaro si è incrociato con il cedro,
probabilmente tra il Nordvest dell’India e il Sud della Cina, e ha generato il
limone (Citrus limon). Mosaici romani del I secolo
della nostra era dimostrano che il limone era già conosciuto, forse portato dai
mercanti, ma non vi sono prove di una sua coltivazione nell'Impero Romano.
Portato dagli Arabi in Sicilia, le prime coltivazioni risalgono al Basso
Medioevo. Cristoforo Colombo lo portò a Haiti nel suo secondo viaggio del 1493,
e da lì si diffuse nel continente americano. E il pompelmo
(Citrus paradisi)? Incredibilmente, esso nacque solo nel XVIII secolo sull’isola
di Barbados grazie ad un incrocio tra l’arancio dolce e il pomelo. Ancora più
recente (le prime menzioni scritte sono datate 1902) è l’incrocio casuale tra un
mandarino mediterraneo e un arancio dolce, che ha generato la
clementina (Citrus clementina): il primo frutto fu
scoperto da Fra Clément Rodier (1839-1904), da cui prese il nome, nel giardino
del suo orfanotrofio a Misserghin, in Algeria. Nel 1925 è stata importata in
Spagna, dove sono state trovate alcune mutazioni genetiche interessanti, ed ora
è l'agrume più coltivato nel bacino del Mediterraneo. Infine il
lime (Citrus aurantifolia) arrivò nel 1500 nei
Caraibi e in Messico grazie agli esploratori spagnoli, dando il via nel Nuovo
Mondo a una coltivazione importante ancora oggi. È il risultato di un incrocio
tra il cedro e il Citrus micrantha, un agrume
selvatico originario delle Filippine, descritto per la prima volta nel 1915 da
Peter Jansen Wester (1877-1931), che lavorava per l'Ufficio Filippino
dell'Agricoltura. Poiché gli agrumi sono generati da incroci, si potrà forse in
futuro creare nuovi incroci con le caratteristiche desiderate di aroma, sapore,
forma, colore eccetera, ma anche e soprattutto resistenti alle malattie come il
"citrus greening", provocato dal batterio Huanglongbing (HLB), che sta danneggiando le
piantagioni di tutto il mondo.
Torniamo ora al nostro mandarino. 100 g di polpa di mandarino crudo forniscono
53 kcal di energia,
13,34 g di carboidrati, 1,8 g di fibra,
0,81 g di proteine e
0,31 g di grassi. Contengono altresì vitamina A,
beta carotene, tiamina (B1), niacina (B3) e ben 26,7 mg di vitamina C (32% del
valore giornaliero), oltre a calcio, magnesio, fosforo e potassio. Essendo
ricchissimi di vitamina C, gli agrumi come il mandarino hanno contribuito a
debellare una malattia terribile, lo scorbuto, che provoca emorragie gengivali e
sottoungueali, apatia, irritabilità, perdita di peso, dolori muscolari e
articolari. Esso colpiva in particolare i marinai durante i lunghi viaggi per
mare lontano dalla costa; la celebre circumnavigazione del globo effettuata da
Ferdinando Magellano tra il 1519 e il 1522 si concluse con più dell'80%
dell'equipaggio morto a causa di questa malattia, le cui motivazioni (e dunque
le cui possibili cure) restarono a lungo ignote. Solo nel 1747 un medico
scozzese della marina da guerra britannica di nome James Lind condusse il primo
studio clinico accurato riportato sino a oggi a bordo della HMS Salisbury,
dimostrando l'efficacia del succo di limone e di lime per combatterla (oggi
sappiamo che la vitamina C è essenziale per la formazione del collagene e aiuta
a mantenere l'integrità del tessuto connettivo).
Tradizionalmente i mandarini sono frutti associati al Natale: l'usanza di
consumarli durante le festività natalizie risale al 1880, quando gli immigrati giapponesi
in Canada e negli Stati Uniti iniziarono a ricevere mandarini dalle
loro famiglie in patria come regali per il nuovo anno (da qui l'iniziale nome di
"japanese oranges"). La tradizione si diffuse
tra la popolazione non giapponese e verso est in tutto il paese: ogni raccolto
di novembre era rapidamente spedito verso est
tramite ferrovia, sui cosiddetti "treni arancioni", con vagoni merci dipinti di
questo colore, così da avvisare tutti lungo il percorso che gli irresistibili agrumi
venuti dal
Giappone erano arrivate in tempo per le feste, tanto che, per molti americani, l'arrivo dei mandarini
giapponesi segnava l'inizio delle vacanze natalizie. Questa tradizione
giapponese si fuse con le tradizioni europee legate alla Calza di Natale e, in
Italia, della Befana. Secondo una ben nota leggenda medioevale, infatti, San Nicola,
vescovo di Mira in Abatolia nel IV secolo, avrebbe nascosto delle monete d'oro nelle calze di tre ragazze povere in
modo che potessero sposarsi (il loro padre avrebbe invece voluto avviarle alla
prostituzione per pagarsi la dote). A volte la storia viene
raccontata con palline d'oro al posto delle monete d'oro, e siccome nei paesi
anglosassoni San Nicola ha dato vita alla leggenda di Santa Claus (poi diffusa
in ogni dove dalla grancassa pubblicitaria della Coca Cola), i mandarini sono
diventati la metafora di queste palline d'oro. Per questo vengono messi nelle
calze di Natale o della Befana, insieme a monete di cioccolato avvolte in
carta dorata.
I mandarini a partire dall'inizio del 1900 vennero coltivati anche negli Stati Uniti,
ma il Giappone rimase un importante fornitore. Le importazioni
statunitensi di questi agrumi giapponesi furono sospese a causa delle ostilità
con il Giappone durante la seconda guerra mondiale. Sebbene fossero una
delle prime merci giapponesi autorizzate nuovamente all'esportazione dopo la fine della
guerra, l'ostilità residua portò al rebranding di queste arance come "mandarini"
al posto del vecchio nome di "arance giapponesi". La tradizione del mandarino
natalizia era ed è molto viva in Canada, grazie all'importazione dal Giappone
attraverso il porto di Vancouver. Ritroviamo infatti questo frutto anche nella
letteratura canadese, in particolare nel romanzo "Il Flauto di Latta" di
Gabrielle Roy (1909-1983). una delle maggiori scrittrici canadesi francofone, in
cui un mandarino rappresenta un regalo di lusso per il figlio moribondo della
povera famiglia Lacasse, intorno di cui è intessuto il romanzo. I mandarini sono
citati anche nel romanzo "As for me and for my house" (1942) di Sinclair Ross
(1908-1996). Ma il mandarino era già al centro di una poesia di Liu Hsun
(462-521 d.C.): « Al mattino del primo gelo / il giardiniere lo stacca e ne fa
dono: / il profumo si espande; appena schiusa, / la sua fragranza si riversa /
sugli invitati. » Nulla da stupirsi se questi piccoli, dolcissimi agrumi sono
oggi annoverati tra le principali tradizioni culinarie del Natale cristiano.

Il
frutto del Paradiso
Il melo domestico (Malus
domestica) è una pianta da frutto appartenente alla
famiglia delle Rosacee; si tratta di una delle più diffuse piante da frutto coltivate
dall'uomo.
L'etimologia della parola "melo" è incerta, e sono state avanzate molte teorie
in proposito. Secondo quella che va per la maggiore, essa deriverebbe dal latino tardo
"melum" e
questo dal latino classico "malum", dal greco antico μῆλον,
"mèlon", a sua volta derivante dal dorico
μᾶλον, "màlon". Tale termine potrebbe essere messo in relazione con la
radice indoeuropea *mal - dal significato di "essere molle", "dolce", ed avere
forse un legame con le parole "malva", "miele" e "molle".
Elizabeth Fenwich nel 2016 ha invece messo in relazione il latino malum e il
greco μᾶλον con l'ittita māḫlaš, ("vite"), il lidio μῶλαξ ("vino") e l'armeno մոլ
(mol, "stolone") da un termine indoeuropeo *móh₂l- ("pianta culturalmente
importante”). L'inglese "apple", il tedesco "apfel", lo scozzese "aipple",
il bretone "aval", l'olandese "appel", lo svedese "äpple" e il danese "æble" deriverebbero poi dal
germanico proto-occidentale *applu , dal proto-germanico *aplaz" e dal
proto-indoeuropeo *h₂ébōl o *h₂ébl̥, "frutto", da cui anche il gallese "afal",
l'irlandese "úll", il lituano "óbuolỹs", il russo я́блоко ("jábloko") e forse il
greco antico ἄμπελος, ("ámpelos"), "vite". Infine, l'italiano "pomo"
discenderebbe dal proto-italico "poomos" e dal proto-indoeuropeo *h₂po-h₁ém-os
("tolto") , da *h₂epo ("fuori", da cui l'inglese "off"), da cui *po-, più *h₁em-
("prendere"), da cui *emō; dalla stessa radice deriverebbero il greco "poìa",
"erba" e "poiëo", "produco, genero".
Per quanto oggi ne sappiamo,
il centro di origine del melo selvatico, progenitore del melo coltivato Malus
domestica, pare sia il Kazakistan nella zona di Almaty. Questa specie è la progenitrice di tutte le
specie attualmente esistenti, e quindi la madre di tutte le mele. Questa pianta ha origini che si perdono nella
notte dei tempi;
nel 1929 il biologo sovietico Nikolai Vavilov (1887-1943), noto per essere
rimasto vittima delle paranoiche purghe staliniane, ne ha rintracciato dei fossili in
Kazakistan, ai piedi delle Montagne Celesti del Tian Shan, ai confini con la
Cina. L'evoluzione
di Malus domestica sarebbe iniziata nel Neolitico. Le prime notizie sulle
piantagioni di melo risalgono al XIII secolo a.C., epoca in cui era certamente
coltivato in Egitto e in Asia Minore. Furono gli Arabi che, mediante avanzati
sistemi agricoli, ampliarono le varietà di mele e le tecniche per produrne in
tutto il mondo. Oggi questo frutto è così popolar che "mela/o" e "pomo" sono
diventati persino la radice di altri termini per indicare alberi da frutto o
ortaggi, come "melograno", "melocoton" e "pomme de terre"!
Il melo è un piccolo albero deciduo di altezza tra 3 e 10 metri, con una chioma
densa ed espansa e un apparato radicale superficiale.
Le foglie sono alterne e semplici, a lamina ovale, leggermente seghettate, con
apice acuto e base arrotondata, di 5-12 centimetri di lunghezza e 3–6 cm di
larghezza, glabre superiormente e con una certa peluria sulla pagina
inferiore. Il picciolo è lungo 2–5 cm.
I fiori sono ermafroditi di colore bianco-rosato esternamente e bianco
internamente, hanno una corolla composta da 5 petali,
e sono riuniti in infiorescenze, in numero di 3-7. La fioritura avviene in primavera, simultaneamente al germogliamento
delle foglie. L'impollinazione è affidata ad insetti pronubi.
Si può ricavare miele dai fiori, ma essendo questi poco appetiti dalle api, la
produzione si concentra quasi esclusivamente nelle zone di estesa coltivazione
come la Campania, l'Emilia-Romagna e il Trentino-Alto Adige.
Il frutto si forma per accrescimento del
ricettacolo fiorale insieme all'ovario, ed è perciò in realtà un falso frutto
(anche se quasi tutti lo ignorano); ha forma una globosa, generalmente di 5–9 cm di diametro, prima verde e a maturazione,
tra estate e autunno, con colore variabile dal giallo-verde al rosso. Non ci
crederete, ma il vero frutto, derivato dall'accrescimento dell'ovario, è in realtà costituito da
quello che noi chiamiamo
torsolo, di consistenza più coriacea rispetto alla polpa.
Il pericarpo contiene cinque carpelli, ciascuno dei quali contiene da uno a tre semi.
Il melo è una pianta che tollera benissimo il freddo e, con l'eccezione di
qualche varietà, può sopportare temperature fino a −25 °C, ma le gelate tardive
possono procurare seri danni alla coltivazione; la sensibilità alle gelate
dipende dal periodo di fioritura delle diverse coltivazioni. Può essere coltivato ovunque, ma preferisce un clima fresco, un terreno
ricco di humus e le zone che si trovano tra i 600 e i 1.000 metri sopra il
livello del mare. La pianta teme la siccità e i ristagni idrici.
Il melo è caratterizzato da autoincompatibilità. Di conseguenza i semi
generati sono sempre figli di due genitori differenti, e ciò limita la
selezione artificiale delle caratteristiche interessanti per la coltivazione.
Pertanto si ricorre largamente all'innesto per moltiplicare gli esemplari che
esprimono meglio le caratteristiche di una certa varietà, in modo da passare tali
caratteristiche alle nuove piante. Tale pratica tuttavia abbassa la varietà
genetica tra gli esemplari e rende le coltivazioni più sensibili alle malattie
ed ai parassiti.
Il melo è colpito da varie malattie causate da funghi, tra cui la ticchiolatura
del melo, l'oidio, la moniliosi, il cancro delle pomacee e il marciume radicale
lanoso.
Tra gli insetti pericolosi per quest'albero, i più importanti sono la
cocciniglia di San Josè (Quadraspidiotus
perniciosus), l'afide grigio (Dysaphis plantaginea) e i lepidotteri Cydia
pomonella, Orgyia antiqua e Cossus cossus. Inutile dire che vengono coltivati
anche molti OGM.
Gli obiettivi del miglioramento genetico riguardano l'ottenimento di piante
resistenti agli insetti, in particolare ai rodilegno, difficilmente
contrastabili, al colpo di fuoco batterico, alla ticchiolatura, oidio e afidi.
Si punta anche all'ottenimento, per le varietà commerciali più note, di cloni
autofertili.
La produzione mondiale di mele nel 2018 è stata di 86,1 milioni di tonnellate; la
Cina da sola ha contribuito per il 46% del totale con 39,2 milioni di tonnellate, seguita a grande distanza da
Stati Uniti (4,7 milioni), Polonia (4,0 milioni), Turchia (3,6 milioni), Iran
(2,5 milioni) e Italia (2,4 milioni).
Esistono circa 7.000 varietà di mele, differenti per colore, consistenza, sapore
e contenuti nutrizionali. Alcune di queste varietà sono tradizionali, altre sono
note per la loro denominazione commerciale. Tra queste ricordiamo l'Annurca (di piccole dimensioni rispetto alle altre mele, di forma tondeggiante
con epidermide rossa striata, polpa bianco giallastra, croccante,
dolce, gradevolmente acidula), la
Braeburn (con buccia di colore rosso scuro o scarlatto, polpa compatta e
croccante, sapore dolce-acidulo), l'Elstar (di colore rosso e giallo, saporita,
succosa), la
Fuji (di forma tondeggiante, con buccia di colore rosso-rosato, polpa croccante e succosa,
ricca di fruttosio), la
Golden Delicious (di origine americana, di forma tondeggiante, con buccia di
colore giallo, polpa croccante e compatta, sapore dolce leggermente acidulo), la
Granny Smith (con buccia verde intenso, polpa croccante, particolarmente ricca
di magnesio), la
Jonagold (incrocio fra Golden Delicius e Jonathan ottenuto nel 1953, di sapore
succoso, agrodolce, molto aromatico), la
Pink lady (incrocio di Lady Williams e Golden Delicious, con buccia avente
sfumature di colore rosa), la
Red Delicious (con buccia di colore rosso), la
Renetta (di forma irregolare, con buccia rossa e verde), la
Renetta Grigia (tipica della zona di Barge, con forma schiacciata, buccia
ruvida e rugginosa, polpa grossolana dal colore bianco-crema, sapore
acidulo), la
Royal Gala (dalla buccia rosso intenso con venature giallo chiaro, polpa soda e
croccante, sapore dolce leggermente aspro), la
Seuka (autoctona della provincia di Udine e molto diffusa nelle Valli del Natisone),
la
Stark Delicious (con buccia rossa, sapore aromatico,
particolarmente ricca di carotene e retinolo, ma con Iron Man non c'entra nulla)
e la
Stayman Winesap (con buccia ruvida di colore giallo-verde punteggiata di rosso,
polpa soda e croccante, sapore agrodolce). La mela è presente in Italia con
circa 2.000 varietà, ma una definizione precisa è difficile data la
sovrapposizione storica di innumerevoli denominazioni, e le grande quantità di
specie estinte o ormai irreperibili. Dal 1990 in tutto il Regno Unito il 21
ottobre si celebra l'Apple Day, un festival voluto dall'ente di beneficenza
"Common Ground" per sostenere la biodiversità con canti popolari e giochi per
bambini nei frutteti.
La mela è senz'altro il frutto più destagionalizzato del mondo, dato che ormai lo si trova tutto l'anno,
ma ciò
richiede la presenza di impianti che provvedano alla sua conservazione e ne
prmettano la disponibilità su di un ampio arco di tempo. La maturazione
naturale varia da fine agosto a metà ottobre, mentre la disponibilità alla
conservazione naturale dei frutti è drasticamente diversa nelle differenti
varietà; dati gli elevati contenuti in acidi organici, di norma la conservazione
va da uno a quattro mesi; nella conservazione industriale sono importanti le
condizioni fisiche in cui questa avviene. Dopo il raccolto, i frutti sono
conservati a temperature da 1,0° a 3,5°C con umidità relativa del 60-70%. Per
conservazioni prolungate si ricorre a celle frigorifere con atmosfera
controllata, più ricca di azoto. Le mele coltivate sono spesso piene di
antiestetici puntini neri provocati dagli insetti; per renderne l'aspetto più
appetibile le mele sono continuamente irrorate con antiparassitari, e sottoposte
a ceratura prima di essere messe in vendita, per renderle così lucide (per
questo oggi si sconsiglia di mangiarle senza sbucciarle, nonostante la buccia
sia ricchissima di fibra).
La mela ha un potere antiossidante molto elevato, con notevoli variazioni in funzione del tipo di mela considerata, in
quanto contiene provitamina A, vitamine B1, B2, B6, E e C, acido citrico, acido
malico, niacina e acido folico, insieme a flavonoidi e carotenoidi. Un noto
proverbio afferma che « una mela al giorno toglie il medico di torno », in
riferimento alle proprietà benefiche sulla salute dell'organismo possedute dal
nostro falso frutto. Le mele sono destinate prevalentemente al consumo
casalingo, sia immediato (vengono consumate anche fette di mela essiccate)
che in cucina per la preparazione di primi, secondi, marmellate, gelatine e
soprattutto diversi dolci. Ricorderò qui solo lo
strudel di mele, oggi considerato un dolce tipicamente tedesco ("strudel" in
tedesco significa "vortice", essendo fatto di pasta arrotolata), ma in realtà è
un dolce antichissimo, risalente addirittura all'VIII secolo a.C., ovvero al
tempo degli Assiri; un dolce simile si serviva anche nell'Antica Grecia del III
secolo a.C. Una delle ricette all'origine dell'odierno strudel è probabilmente
l'antico dolce baklava che seguì fedelmente le conquiste territoriali ottomane;
dal 1526 il sultano Solimano il Magnifico ne diffuse la ricetta nei territori da
lui conquistati, ovvero fino all'Ungheria. I continui contatti tra l'impero
ottomano e quello austriaco fecero sì che anche la ricetta dello strudel
passasse ai domini di casa d'Austria, di cui l'Ungheria entrò a far parte nel
1699, e da qui arrivò in Trentino, Sudtirol, Veneto e Friuli-Venezia Giulia,
dove oggi viene tradizionalmente preparato.
La mela si presta anche ad essere utilizzata per preparare in casa maschere di
bellezza antietá e impacchi nutrienti per capelli secchi.
Molte mele sono
destinate alla produzione di succhi, di olio di semi di mela
(molto utilizzato nei paesi del nord Europa, ottenuto come sottoprodotto dalla
produzione del succo), di creme di bellezza e di produzione
di alcol da distillazione da fermentati.
Dalla fermentazione alcolica delle mele (ma a volte anche delle pere) è
possibile ricavare una bevanda alcolica chiamata sidro. La parola "sidro" nacque
nella lingua d'oïl attorno al 1130, precedentemente veniva chiamato auppegard; i
marinai baschi lo chiamavano sagarnoa o sagardoa (in basco letteralmente "vino
di mela"). In Grecia il sidro era conosciuto con i nomi semitici di σικερίτης "sikerítēs"
o σίκερα "síkera", dall'ebraico שֵׁכָר "šēkār", passato poi al latino sīcera, da
cui deriva la parola moderna sidro. La parola "šēkār" è legata ad ad una radice
semitica che significa "ubriacarsi": la incontriamo in Genesi, 9,20, quando Noè
si ubriaca e Cam pecca guardandone le nudità, e in Deuteronomio 32,42, quando
nel Cantico di Mosè al Faraone viene fatto dire: « Inebrierò di sangue le mie
frecce, si pascerà di sangue la mia spada! » Da "šēkār" deriverebbe anche
l'arabo "sukkar", da cui l'italiano "zucchero". La documentazione archeologica
ha evidenziato il più antico sidro sinora noto in Spagna, nella Valle Ambrona,
risalente alla metà del III millennio a.C.; l'analisi del residuo di un coccio
di ceramica ha dimostrato la presenza di un sidro di pera selvatica. Il sidro fu
menzionato da Plinio di Vecchio, il quale ci dice che era tipico dell'attuale
Austria, dovr rta utilizzato per fini curativi. Anche l'aceto di sidro di mele
veniva utilizzato dai romani per dissetare e dagli Egizi per curare. Questo
liquore è documentato nei trattati medici del 1588 del medico normanno Julien Le
Paulmier, studioso dell'università di Caen e medico personale dei Re di Francia
Carlo IX e di Enrico III, che ne esaltò le proprietà terapeutiche, digestive,
diuretiche e antinfluenzali. Fu introdotto in Inghilterra nel 1066 da Guglielmo
il Conquistatore, e i primi documenti noti scrivono di produzione di sidro nelle
campagne dello Herefordshire. Questa bevanda infatti è oggi molto diffusa nel
Regno Unito, maggior consumatore e produttore al mondo, in Francia (specie in
Bretagna e Normandia) e Spagna (dove la produzione è particolarmente concentrata
nelle Asturie e nei Paesi Baschi). In Italia è meno popolare, ma la si può
trovare nei pub in stile anglosassone. La gradazione alcolica varia da 2 a 7%;
il tipico sapore acidulo le è conferito dalla presenza di acido malico. Ne è
molto diffusa anche la preparazione casalinga. "Il sidro" ("The Cyder") è il
titolo di un poemetto in due canti del 1709, opera del poeta inglese John
Philips (1676-1709), ispirato alle "Georgiche" di Virgilio, nel quale si
descrivono le tecniche necessarie per produrre il sidro. Nel celebre romanzo
"Madame Bovary" (1856) di Gustave Flaubert (1821-1880) si racconta come a Papà
Rouault piacesse avere sempre il sidro forte in tavola, per mostrare come l'uomo
non badasse a spese quando si trattava del suo tenore di vita.
E ora, qualche cenno allo sterminato mondo di leggende e tradizioni che
riguardano il nostro frutto che, per le sue caratteristiche, ha colpito
l'immaginazione umana di ogni tempo, entrando nel folklore e nella mitologia di
quasi tutti i popoli. Spesso ha assunto una valenza erotica: nell'antichità la
mela era simbolo di fertilità e in particolare quella rossa dell'amore.
Nell'antica Grecia, lanciare una mela a qualcuno equivaleva a una dichiarazione
d'amore o era un chiaro invito per un convegno amoroso. Testimonianze di tale
uso si trovano nelle "Nuvole" di Aristofane (450-385 a.C.), in cui si consiglia
ai giovani di non frequentare i bordelli perché « mentre, a bocca aperta,
guardano una qualche bella prostituta, lei potrebbe coinvolgerli gettando loro
una mela », e nei "Dialoghi delle cortigiane" di Luciano di Samosata (circa
120-190 d.C.), nei quali una cortigiana si lamenta perché il suo amante « getta
la mela ad altre » piuttosto che pensare a lei. Callimaco (310-245 a.C.) negli "Aitia"
e Publio Ovidio Nasone (43 a.C.-18 d.C.) nelle sue "Heroides" narrano il mito di
Aconzio e Cidippe: il giovane Aconzio, non sapendo come conquistare la bella
Cidippe, di cui si è innamorato, fa in modo che rotoli nelle sue vicinanze una
mela su cui lui ha inciso la frase « Giuro per il santuario di Artemide che
sposerò Aconzio ». Quando la ragazza raccoglie la mela e legge l'iscrizione ad
alta voce, il suo diviene un vero e proprio giuramento e, nonostante sia
promessa a un altro uomo, dopo varie peripezie suo padre non può fare altro che
concederne la mano al giovane. Nel mondo occidentale il "frutto proibito" di
Adamo ed Eva (Gen 2,16) è stato identificato con una mela, mentre in oriente
prevalgono altre identificazioni (dal fico al melograno); secondo alcuni tale
identificazione è dovuta, oltre al fatto che il frutto dell'albero « era buono
da mangiare e gradito agli occhi » (Ge 3,16) proprio come la mela, anche al suo
antico significato erotico, lasciando intendere che il peccato dei due
progenitori aveva anche una valenza sessuale. Tale valenza può essere
rintracciata anche nel famoso "pomo della discordia" che avrebbe dato origine
alla guerra di Troia. Zeus desiderava unirsi a sua cugina Teti, ma la dea Temi
(la Giustizia) lo aveva avvertito che Teti avrebbe partorito un figlio più forte
di suo padre, e così, per non correre il rischio di essere spodestato dalla
carica di re degli déi, diede in sposa Teti al mortale Peleo, uno degli
Argonauti, da cui ebbe il figlio Achille. Alle nozze tra Teti e Peleo erano
stati invitati tutti gli déi tranne Eris, la Discordia, che per vendicarsi gettò
sulla tavola del banchetto una mela d'oro con la scritta Στην πιο όμορφη (Stin
pio ómorfi). "Per la più bella". Siccome Era, Athena e Afrodite si disputarono
quel dono, Zeus decise di affidare il giudizio al più bello tra i mortali,
Paride, figlio di Priamo. Questi consegnò il pomo ad Afrodite che gli aveva
promesso l'amore della donna più bella del mondo: Elena, moglie di Menelao, Re
di Sparta. Paride rapì Elena e scatenò la guerra di Troia, nella quale Era ed
Athena parteggiarono per vendetta per gli Achei (la storicità dell'evento è
oggetto di dibattito: probabilmente Omero unificò in un'unica, grandiosa epopea
duecento e più anni di scontri tra i Micenei e la Confederazione Assuwa, di cui
Wilusa, cioè Ilio, faceva parte). Da notare che nel libretto "Il pomo d'oro"
scritto nel 1667 da Francesco Sbarra (1611-1668), la "mela della Discordia",
inizialmente assegnata da Paride ad Afrodite come nel mito classico, viene
infine donata da Zeus a Margherita Teresa di Spagna, il cui matrimonio con
l'imperatore Leopoldo I d'Asburgo è celebrato nel poemetto. In tal modo, non
solo il nostro falso frutto diventa una "mela della Concordia", ma anche simbolo
stesso dell'Impero ("Reichsapfel") in nome di una nuova "pax romana"!
La mela però può presentarsi anche come elemento di inganno e di divisione, ad
esempio nel mito di Atalanta. L'eroina annunciò che solo chi la avesse battuta
in una gara di corsa la avrebbe sposata, i concorrenti sconfitti sarebbero stati
uccisi. Melanione, follemente innamorato di lei, chiese aiuto ad Afrodite, la
quale gli consegnò tre mele d'oro da utilizzare durante la corsa. Egli, seguendo
il consiglio della dea, le lasciò cadere una a una sul terreno: Atalanta si
fermò a raccoglierle e perse la gara. Del resto, anche il pomo della discordia
divide, poiché crea contrasto tra le tre dee che lo desiderano. Viene dal mondo
germanico la mela avvelenata offerta dalla matrigna a Biancaneve, che la fa
cadere in coma ma non la uccide, poi resa famosa in tutto il mondo dal
lungometraggio animato di Walt Disney del 1939. Il grande scienziato britannico
Alan Turing (1912-1954), uno dei padri del'informatica, fu arrestato perchè gay
(all'epoca l'omosessualità era un reato nel "civilissimo" Regno Unito) e
condannato alla castrazione chimica; caduto in depressione a causa degli ormoni
che era costretto ad assumere, il grande matematico morì in circostanze poco
chiare il 7 giugno 1954, ma verosimilmente si suicidò addentando una mela da lui
intrisa di cianuro di potassio, perchè era un grande fan dei cartoni animati di
Walt Disney. In suo onore, Steve Jobs (1955-2011) scelse come logo della
multinazionale da lui fondata proprio una mela morsicata, come quella di
Biancaneve, e la chiamò "Apple"! (la mela morsa su un lato è anche il simbolo
dell'azienda olandese "Mentadent", ma in tal caso si riferisce solo agli effetti
benefici del suo dentifricio sui denti, resi in grado di morsicare anche la mela
più dura). Chi rovina la reputazione di un ambiente stimato è definito
comunemente una "mela marcia", e negli USA un nativo che ha perso i
contatti con la propria identità culturale è chiamato da altri nativi americani
"mela", tipico insulto che indica un individuo che è « rosso fuori, bianco
dentro »!
Talvolta la mela per il suo aspetto e la sua dolcezza è legata al tema delle
gioie ultraterrene. Tali sono i "pomi delle Esperidi" custoditi da un drago in
un giardino incantato ai confini del mondo, che Eracle dovette rubare nella sua
undicesima fatiche, ma anche le mele mistiche che danno il nome ad Avalon
("Isola delle Mele", perche "aval" in gallese significa "mela"). Nei miti
celtici quest'isola viene descritta come il luogo dove dimorano le anime dei
morti; essa é ricoperta da grandi foreste lussureggianti, è attraversata da
lunghi fiumi e in essa regna l'eterna primavera. Di solito viene identificata
con il colle su cui sorgeva l'abbazia di Glastonsbury perchè d'inverno esso
emerge dalle nebbie come un'isola; da qui il fortunatissimo bestseller "Le
nebbie di Avalon" di Marion Zimmer Bradley (1930-1999). Dopo la
cristianizzazione della Britannia si disse che ad Avalon sarebbe arrivato
Giuseppe d'Arimatea, in fuga dalla Palestina insieme ad alcuni compagni,
portando con sé il Sacro Graal, il calice nel quale aveva raccolto il sangue di
Gesù dopo la crocifissione, e lo avrebbe nascosto in un pozzo. Questa leggenda
potrebbe derivare dal fatto che in alcuni pozzi del luogo si raccoglie
naturalmente acqua rossastra per via di alcune alghe, che ricorda il sangue di
Gesù. Nel ciclo arturiano si afferma che ad Avalon fu sepolto re Artù, il quale
vi riposa nell'attesa di ritornare quando il mondo necessiterà ancora di lui.
Per inciso, anche la ex capitale kazaka Almaty deve il suo nome ai meleti: in lingua kazaka
significa infatti "posto delle mele"!
Ritroviamo la mela dell'Aldilà anche nell'antica ballata inglese "Thomays the
Rymour" ("Thomas il rimatore"), inoltre, la Regina delle Fate avverte il
protagonista di non mangiare alcuna mela o pera che cresca nel suo giardino,
perché mangiare il cibo dei morti gli impedirebbe di tornare nel mondo dei vivi.
Una nota superstizione dei costruttori di barche sosteneva che portasse sfortuna
costruire una barca con il legno di un melo, perché questo legno un tempo era
utilizzato per fabbricare bare, e quindi fosse una porta verso l'altro mondo.
Anche nel manga e anime "Death Note" il dio della morte Ryuk adora le mele e
mangia praticamente solo quelle, mentre nella saga cinematografica dei "Pirati dei Caraibi"
targata Disney il capitano Hector Barbossa, interpretato dall'attore Geoffrey
Rush, è particolarmente ghiotto di mele verdi, frutto che ricorderebbe a Rush
l'infanzia trascorsa nelle campagne inglesi.
Il tema del meleto incantato ai confini del mondo torna anche in un mito delle
popolazioni del Caucaso, in cui si narra che sul melo nel giardino dei Narti,
dai fiori azzurri splendenti, crescesse una mela d'oro, una sola alla volta,
magica, brillante e capace di guarire ferite e malattie. Nonostante la guardia
che i Narti facevano all'albero, di notte qualcuno riusciva sempre a rubare la
mela, che poi durante il giorno ricresceva. Quando toccò a Uaerhaeg fare la
guardia, egli mandò nel giardino i due figli Aeshaertaeg e Aeshar, che
riuscirono a scoprire chi rubava la mela: al tramonto, tre colombe giungevano
sui rami dell'albero e prendevano il pomo. I due fratelli Narti ne ferirono una
e, seguendo le tracce di sangue, arrivarono al regno del genio delle acque,
Donbettyr, posto sotto le acque del mare. Lì Aeshaertaeg prese in sposa la
figlia del dio Dzerasse, che si trasformava in colomba insieme alle sue sorelle
per rubare la mela.
Da qui alla mela come simbolo di immortalità, il passo fu breve. Ne consegue la
già citata identificazione del frutto proibito di Adamo con una mela, ma anche
il mito celtico in cui Lug, dio supremo del pantheon irlandese, portò in dono al
re Cormac un ramo di un albero dell'isola di Avalon, adorno di tre mele, che
rappresentava la regalità eterna. Nella mitologia scandinava, Idun è la dea che
nutre gli Asi con le sue miracolose mele d'oro, le quali donano loro l'eterna
giovinezza. Un giorno giorno la dea Idun venne attirata dal dio Loki in un
bosco, dove le disse che vi erano delle mele con proprietà particolari. Il
gigante Pjazi, messosi d'accordo con Loki e trasformatosi in aquila, rapì la dea
con tutte le sue mele d'oro. L'assenza di Idun causò l'invecchiamento degli dei
e questi, furibondi, diedero la colpa di tutto ciò a Loki. Quesi, per
riscattarsi, sotto forma di falco volò a liberare la dea trasformata in noce, ma
il gigante in forma di aquila lo inseguì. Giunti alla barriera di fuoco che
protegge Asgard, il gigante prese fuoco e morì, così finalmente Idun tornò dagli
dei con le sue mele magiche che continuarono a conferire ad essi l'eterna
giovinezza. Nel folclore americano invece è ben nota la leggenda di Johnny
Semedimela, originata da una figura storica, John Chapman (1774-1845), pioniere
che introdusse coltivazioni di mele in gran parte della Pennsylvania, Ohio,
Indiana, Illinois, Ontario e dell'attuale West Virginia. Secondo la leggenda,
quando era ormai vecchio non ci vedeva più bene ma continuava a piantare semi di
mela, finché non salì su una collina occupata da una nuvola; continuò a piantare
semi anche nella nuvola, che lo portò direttamente in Paradiso (anche nella
patria dell'industria moderna, le leggende millenarie sono dure a morire!!)
Durante il capodanno ebraico ("Rosh Hashanah") è consuetudine mangiare mele
immerse nel miele per evocare un "dolce anno nuovo", e negli Stati Uniti, ma
anche in Danimarca, Finlandia e Svezia, una mela fresca era un regalo
tradizionale da parte dei bambini per la loro maestra fin dal XIX secolo. Il
simbolismo della mela negli USA è ancor oggi fortemente associato agli
insegnanti, e le mele restano un tema popolare per regali e premi assegnati ad
insegnanti esemplari.
Siccome la mela può conferire l'immortalità o l'eterna giovinezza, sovente
diventa oggetto di una prova di coraggio. Il caso più noto è quello della mela
posta sulla testa del figlio di Guglielmo Tell, che l'eroe dovette centrare con
la sua balestra. Questo racconto fondativo della moderna Confederazione Elvetica
è da molti ancor oggi ritenuto storico, ma la maggior parte dei medievalisti lo
ritiene leggendario per l'assenza di testimonianze coeve che citino il
leggendario balestriere di Uri che avrebbe sconfitto e ucciso il balivo
austriaco Gessler, anch'egli personaggio sconosciuto alla storia: il primo
riferimento all'eroe svizzero appare in un manoscritto del 1470, il "Libro
bianco di Sarnen", compilato da Hans Schriber (morto nel 1479) per raccontare le
origini della Confederazione Elvetica. Il racconto di Schriber però è
sospettosamente simile ad alcuni miti scandinavi. Ad esempio, nel "Gesta Danorum"
scritto nel XII secolo dal monaco danese Saxo Grammaticus (1150-1220), si
racconta di Toko, un abile cacciatore che si vantava troppo delle sue abilità di
arciere. Il Re di Danimarca Harald Dente Azzurro (933-986) lo costrinse allora a
colpire una mela posta sulla testa del figlio. Toko aveva deciso che, se avesse
fallito il bersaglio, con una seconda freccia avrebbe ucciso il re, e per questo
finì imprigionato dal sovrano. Scappò poi dalla prigione e uccise il tiranno in
un agguato. Troppe somiglianze per non pensare che il mito di Guglielmo Tell sia
stato ispirato da queste saghe nordiche. Ma non è tutto: secondo la leggenda fu
una mela caduta in testa a Isaac Newton (1642-1727) ad ispirargli la scoperta
della legge di gravitazione universale: in effetti suo padre era morto prima
della sua nascita e la madre si risposò con un altro uomo, da Isaac mai amato,
che possedeva ampi frutteti in campagna, nei quali Isaac trascorse la
giovinezza. La caduta della mela in testa potrebbe configurarsi in tal caso come
la moderna versione della prova (intellettuale) da superare per giungere alla
comprensione dei misteri della scienza.
Detto tutto questo, sarà solo un caso se la casa discografica inglese fondata
dai Beatles nel 1968 si chiama Apple Records? O se una delle più note
trasmissioni televisive per bambini si chiamava "Melevisione"? Ma, anche se non
ci crederete, c'è anche una versione odierna del mito del giardino delle
esperidi e di quello della dea Idun! Infatti la mela è il simbolo della città di New York, appunto soprannominata "Big Apple"
("Grande mela"). Per la prima volta quest'espressione compare nel 1909, nel
libro "The Wayfarer in New York" di Edward Sandford Martin (1856-1939), in cui
si dice: « Lo stato di New York è un melo, con le radici nella valle del
Mississippi ». Negli anni venti il termine fu riproposto sul quotidiano "The
Morning Telegraph" dal cronista sportivo John J. Fitzgerald (1893-1963), che si
riferiva all'ippodromo di New York, volendolo intendere come « il sogno di
qualunque giovanotto che abbia gettato una gamba in groppa ad un purosangue e la
meta di ogni fantino ». Negli anni settanta il soprannome fu reso ulteriormente
popolare da una campagna di promozione turistica della città. Nel 1997 il
sindaco Rudolph Giuliani, per rendere omaggio al giornalista che aveva reso
famoso il soprannome, battezzò "Big Apple Corner" l'angolo tra la West 54th
Street e Broadway, dove John J. Fitzgerald aveva abitato dal 1934 al 1963.
Ebbene sì: New York è il moderno Giardino delle Esperidi dell'attuale Cultura
Pop!!

New York, la Grande Mela!
I
dolci frutti che non piacciono ai Marines
L'albicocco (Prunus armeniaca)
è un albero appartenente come il melo alla famiglia delle Rosacee. È una pianta
latifoglia e caducifoglia alta 8–12 m, con un tronco fino a 40 cm di diametro e
una chioma densa e ampia. Le foglie sono cuoriformi, lunghe 5–9 cm e larghe 4–8
cm, con una base arrotondata, una punta e un margine finemente seghettato. I
fiori hanno un diametro di 2–4,5 cm, con cinque petali da bianchi a rosati;
vengono prodotti singolarmente o in coppia all'inizio della primavera. La
fioritura avviene, come in tutti gli alberi del genere Prunus, prima della
comparsa delle foglie. Il frutto è una drupa, di diametro pari a 1,5–2,5 cm (più
grande in alcune cultivar moderne), con colore dal giallo all'arancione, spesso
sfumato di rosso sul lato più esposto al sole; la sua superficie può essere
liscia o vellutata con peli molto corti (in termini botanici è definita
"pubescente"). Come per tutte le piante da frutto, questi ultimi sono verdi,
duri e difficili da staccare dall'albero quando sono ancora acerbi. La polpa è
solitamente succulenta, e il suo gusto può variare dal dolce all'aspro. Il
singolo seme o "nocciolo" è racchiuso in un guscio duro, con una consistenza
granulosa e liscia ad eccezione di tre creste che scendono lungo un lato.
Quanto all'etimologia, la parola "albicocca" e l'antico inglese abrecock (da cui
l'inglese moderno) derivano dal medio francese aubercot o abricot, a sua volta
dallo spagnolo albaricoque e dal catalano a(l)bercoc. Questo viene dall'arabo
الْبَرْقُوق (al-barqūq, "le prugne"), la cui origine è incerta. Forse proviene
dal greco bizantino βερικοκκίᾱ (berikokkíā), e questo dal greco tardo πραικόκιον
(praikókion), che a sua volta potrebbe essere un calco del latino "persica
praecoquus", cioè "pesca di maturazione precoce".
L'albicocca oggi più comunemente coltivata era conosciuta in Armenia fin da
tempi molto antichi, ed è stata coltivata lì per così tanto tempo che in Grecia
e a Roma si pensava avesse avuto origine lì: nel "De re rustica", trattato di
agraria romana di Lucio Giunio Moderato Columella (4-70 d.C.), questa piante è
infatti detta "armeniacum", da cui il suo nome "armeniaca" della specie.
Tuttavia ciò è contraddetto da studi genetici, che confermano invece l'ipotesi
proposta da Nikolaj Ivanovič Vavilov (1887-1943) che l'addomesticamento di
Prunus armeniaca sia avvenuto in Cina. L'albicocco domestico si sarebbe poi
diffuso a sud verso l'Asia meridionale e ad ovest verso l'Asia occidentale
(compresa l'Armenia). L'albicocca giapponese (Prunus mume) è un'altra specie di
albicocca ampiamente coltivata, solitamente per usi ornamentali; nonostante il
nome, anch'essa è originaria della Cina ed è stata introdotta in Giappone in
tempi antichi.
Un clima secco è ottimo per la maturazione dei frutti; l'albicocco preferisce
terreni ben drenati con un pH compreso tra 6,0 e 7,0. Esso è leggermente più
resistente al freddo del pesco, tollerando temperature invernali fino a -30°C ,
ma un fattore limitante nella cultura dell'albicocca è rappresentato dalle
gelate primaverili: tendono a fiorire molto presto (all'inizio di marzo
nell'Europa occidentale), il che significa che il gelo primaverile può far
cadere i fiori. Inoltre gli albicocchi sono sensibili agli sbalzi di temperatura
durante la stagione invernale: i Cina gli inverni possono essere molto freddi,
ma le temperature tendono ad essere più stabili che in Europa e soprattutto in
Nord America, dove in inverno possono verificarsi grandi sbalzi di temperatura.
L'ibridazione con il Prunus sibirica o albicocca siberiana, resistente a -50°C
ma con frutti non succulenti e quindi meno appetibili, offre opzioni per
l'allevamento di piante più resistenti al freddo. Le cultivar di albicocca
vengono solitamente innestate su portainnesti di prugne o pesche. Il rampollo
della cultivar fornisce le caratteristiche del frutto, come il sapore e le
dimensioni, ma il portainnesto fornisce le caratteristiche di crescita della
pianta. Alcune cultivar di albicocco sono autocompatibili, quindi non
necessitano di alberi impollinatori; altri no: le varietà Moongold e Sunggold,
ad esempio, devono essere piantate in coppia in modo che possano impollinarsi a
vicenda. Quella che è nota come "albicocca nera" o "albicocca viola" (Prunus
dasycarpa), è in realtà un ibrido di albicocca e prugna ciliegia (Prunus
cerasifera); invece la cosiddetta "percocca" è un varietà di pesca con polpa
compatta, gialla o bianca, coltivata in diverse regioni italiane ("percochi" o "pr'quech"
a Bari, "pricuechi" a Otranto, "pescoche" in Italia settentrionale). Nel 2020 la
produzione mondiale di albicocche è stata di 3,72 milioni di tonnellate; i
maggiori produttori di albicocche sono state la Turchia con 750.000 tonnellate,
l'Uzbekistan con 493.842, l'Iran con 342.479, l'Algeria con 242.243 e l'Italia
con 229.020. La città di Malatya è il centro dell'industria turca delle
albicocche per antonomasia.
Tra i funghi patogeni che colpiscono l'albicocco i più pericolosi il corineo, la
moniliosi, l'oidio (Podosphaera oxyacanthae), il mal del piombo parassitario, il
fusicocco e i marciumi radicali da Armillaria mellea e Rosellinia necatrix. Tra
gli insetti, i più importanti sono la mosca mediterranea della frutta (Ceratitis
capitata), la tignola orientale (Cydia molesta), l'anarsia (Anarsia liniatella),
il rodilegno rosso (Cossus cossus), la cocciniglia bianca (Diaspis pentagona) e
l'aspidioto (Quadraspidiotus perniciosus). Tra i batteri ricordiamo il tumore
batterico (Agrobacterium tumefaciens), la scabbia (Pseudomonas syringae) ed il
cancro batterico delle drupacee (Xantomonas campestris). Danni ingenti alle
coltivazioni di albicocchi sono provocati anche dal virus della Sharka (Plum Pox
Virus). A differenza delle pesche, invece, le albicocche non sono colpite
dall'arricciamento delle foglie.
100 grammi di albicocche crude forniscono 48 calorie e sono composte per l'11%
da carboidrati, l'1% da proteine, per meno dell'1% da grassi e per l'86% da
acqua. Le albicocche crude sono una fonte moderata di vitamina A e vitamina C
(12% del valore giornaliero ciascuna). Altre sostanze fitochimiche in esse
contenute sono i polifenoli, comprese le catechine e l'acido clorogenico. I
composti del gusto e dell'aroma includono saccarosio, glucosio, acidi organici,
terpeni, aldeidi e lattoni. Molto consumate sono le albicocche secche: quando le
albicocche vengono essiccate, la concentrazione relativa di nutrienti aumenta,
con vitamina A, vitamina E , potassio e ferro con valori giornalieri superiori
al 25%.
I semi di albicocca contengono amigdalina, un composto velenoso. In media i semi
di albicocca amari contengono circa il 5% di amigdalina e i semhi dolci circa lo
0,9%; questi valori corrispondono allo 0,3% e allo 0,05% di cianuro. A causa del
loro contenuto naturale di amigdalina, gli usi culinari del nocciolo sono
limitati. L'olio ricavato dai semi di albicocca è sicuro per il consumo umano
senza trattamento perché l'amigdalina non è solubile in olio. I gusci macinati
sono usati nei cosmetici come esfoliante, offrendo un'alternativa ecologica alle
microsfere di plastica. Dai noccioli di albicocca può essere ricavato un latte
vegetale.
E ora, l'albicocca nella cultura. I cinesi associano l'albicocca all'istruzione
e alla medicina: ad esempio, la parola 杏壇 (letteralmente "altare
dell'albicocca") è ancora ampiamente usata nella lingua scritta nel senso di
"circolo scientifico". Zhuang Zhou, filosofo cinese vissuto nel IV secolo a.C.
al tempo degli "Stati Combattenti", raccontò una storia intitolata "Il Vecchio
Pescatore" che Confucio (Kǒng Fūzǐ, 551-479 a.C.) avrebbe insegnato ai suoi
studenti in una piazza circondata, guarda caso, da un bosco di albicocchi.
L'origine dell'associazione cinese dell'albicocca con la medicina non è chiara:
secondo i più deriverebbe dall'uso comune dei semi di albicocca come componente
nella medicina tradizionale cinese, e in particolare dalla storia di Dong Feng
(董奉, circa 200-260 d.C.), un medico vissuto durante il cosiddetto Periodo dei
Tre Regni, che non richiedeva alcun compenso ai suoi pazienti tranne che
piantassero alberi di albicocche nel suo frutteto dopo essersi ripresi dalle
loro malattie. In tal modo egli avrebbe avuto a disposizione un grande giardino
di albicocchi, che gli avrebbero garantito un rifornimento costante di
ingredienti per le sue medicine. Pensate che il termine "esperto dell'albicocco"
(杏林高手, Xìnglín gāoshǒu) è ancor oggi usato in Cina come riferimento poetico ai
medici!
Il fatto che la stagione delle albicocche sia assai breve ha dato origine
all'espressione comune in arabo egiziano e palestinese "fel meshmesh" (في
المشمش) per riferirsi a qualcosa che non accadrà mai o ad una promessa
avventata. Nelle cucine del Medio Oriente e del Nord Africa ,e albicocche sono
usate per preparare la Qamar al-Din (قمر الدين, letteralmente "Luna della
religione"), una densa bevanda all'albicocca che è un appuntamento fisso durante
l'ifṭār, il pasto serale consumato dai musulmani che interrompe il loro digiuno
quotidiano durante il mese di Ramadan. Si ritiene che la Qamar al-Din abbia
avuto origine a Damasco, dove fu coltivata per la prima volta la varietà di
albicocche più adatta a preparare tale bevanda.
L'espressione idiomatica turca "bundan iyisi Şam'da kayısı" (letteralmente
"l'unica cosa migliore di questa è un'albicocca a Damasco") significa "non c'è
niente di meglio di questo".
Da segnalare come l'allora giovane, in futuro grandissimo storico, Jacques Le
Goff (1924-2014) scherzò sul bilancio fallimentare delle crociate, concludendo,
nel suo noto volume "La civiltà dell'Occidente medievale" (1964), che l'unico
frutto ricavato in Europa dalle spedizioni militari in Medio Oriente era...
l'albicocca!
Nella cultura ebraica, le albicocche sono comunemente mangiate come parte del Tu
Bishvat seder, piatto tradizionale di frutta secca e semi consumato nella festa
del Capodanno degli Alberi, che cade il 15 del mese di Shevat.
Naturalmente, l'albicocca è il frutto nazionale dell'Armenia, che cresce
principalmente nella pianura dell'Ararat ed è spesso raffigurata nelle opere
d'arte di
quel paese. Ritroviamo l'albicocca anche in numerosi dipinti occidentali, in
particolare nature morte: tra le altre, la "Natura morta con albicocche,
ciliegie, conchiglie e insetti" di Balthasar van der Ast (1594-1657), il "Ramo
di albicocche" di Georg Flegel (1566-1638), le "Albicocche in una ciotola di
ceramica, con prugne su una mensola di pietra" (1631) di Louise Moillon
(1610-1696), la "Natura morta con cinque albicocche" (1704) di Adriaen
Coorte (circa 1665-1707), la "Natura morta con albicocche e ciliegie" (1740
circa) di Luis Meléndez (1716-1780), le "Albicocche su un piatto, (1877) del
grande Paul Cézanne (1839-1906), le "Albicocche, mandorle e vaso bianco" (1943)
di Henri Charles Manguin (1874-1949) e le "Albicocche" di Andy Warhol
(1928-1987).
Al contrario di quanto avviene nelle culture orientali, tuttavia, presso i Marines
statunitensi è considerato eccezionalmente sfortunato mangiare o possedere
albicocche, specialmente vicino ai carri armati. Anche solo chiamarle per nome
chiamerebbe la malasorte, per cui vengono invece chiamati "cots" ("culle", ma in
realtà diminutivo di "apricots"), "frutto proibito" o "A-fruit". Questa
superstizione è stata documentata almeno a partire dalla guerra del Vietnam, ed
è spesso considerata originaria della seconda guerra mondiale: molti degli AAV
("Assault Amphibious Vehicle", ovvero "Veicolo Anfibio d'Assalto") mandati a
conquistare le isole del Pacifico portavano con sé questi frutta, poiché spesso
facevano parte delle razioni alimentari d'ordinanza, e così i militari
cominciarono a sussurrarsi l'un l'altro che tutti gli AAV distrutti con i membri
dell'equipaggio all'interno avessero un solo carico in comune: le albicocche.
Naturalmente non ci sono molte prove a sostegno di questa affermazione, poiché
molti veicoli che non trasportavano il "frutto proibito" hanno incontrato la
stessa sorte; ma la guerra è così orrenda ("Si sta come d'autunno sugli alberi
le foglie", scrisse Ungaretti) e così priva di razionalità, che nel corso di
essa ci si aggrappa a qualunque superstizione irrazionale, pur di esorcizzare la
morte. E, in questo caso, a farne le spese sono state proprio le dolci
albicocche.

I
fiori rosa di Lucio Battisti
Il pesco (Prunus persica) è un
albero a foglie decidue del genere Prunus, che come abbiamo visto comprende il
ciliegio, l'albicocco, il mandorlo e il susino, ed alla famiglia delle Rosacee.
Il pesco è classificato con il mandorlo nel sottogenere Amygdalus, distinto
dagli altri sottogeneri per il guscio del seme ondulato. A causa della loro
stretta parentela, i noccioli di pesca hanno un sapore molto simile a quello
delle mandorle, e sono spesso usati per realizzare una versione economica del
marzapane, nota come "persipan". Il pesco cresce fino a 7 m di altezza e
larghezza, ma se potati correttamente i peschi sono generalmente alti e larghi
3-4 m. I peschi hanno una vita relativamente breve rispetto ad altri alberi da
frutto: in alcune regioni i frutteti vengono ripiantati dopo 8-10 anni, mentre
in altre gli alberi possono produrre in modo soddisfacente per 20-25 anni o più,
a seconda della loro resistenza a malattie, parassiti e danni invernali. Le
foglie sono lanceolate, misurano 7–16 cm in lunghezza e 2–3 cm in larghezza. I
fiori vengono prodotti all'inizio della primavera, prima delle foglie; sono
solitari o appaiati, con diametro di 2,5–3 cm, di colore rosa, con cinque
petali. Il nostro albero produce frutti succosi commestibili chiamati pesche e
nettarine, che appartengono alla stessa specie, anche se commercialmente sono
considerate frutti diversi. La buccia delle nettarine (in Italia dette anche
"pesche noci") è priva della peluria tipica della buccia della pesca; si ritiene
che responsabile della differenza tra i due frutti sia una mutazione in un
singolo gene (MYB25). Le nettarine sono addirittura erroneamente ritenute un
incrocio tra pesche e prugne, poiché la mancanza di peluria sulla buccia può
farla apparire più rossastra di quella delle pesche, contribuendo al loro
aspetto simile a quello di una prugna. Le pesche e le nettarine, come le
ciliegie, le prugne e le albicocche, sono drupe, hanno polpa gialla o biancastra
e profumo intenso; la polpa è molto delicata e si ammacca facilmente, ma è più
consistente in alcune varietà commerciali, soprattutto quando è verde. Il
singolo, grande seme è rosso-marrone, di forma ovale, lungo circa 1,3–2 cm e
circondato da un guscio simile al legno. Le pesche a polpa bianca sono
tipicamente molto dolci con poca acidità , mentre le pesche a polpa gialla hanno
tipicamente un sapore acidulo, sebbene anche questa caratteristica vari
notevolmente da cultivar a cultivar. Entrambi i colori hanno spesso del colore
rosso sulla buccia. Le pesche a polpa bianca a bassa acidità sono le varietà più
popolari in Cina, Giappone e nei paesi asiatici limitrofi, mentre europei e
nordamericani hanno storicamente favorito le cultivar acide a polpa gialla. La
varietà nota come "pesca indiana" matura nell'ultima parte dell'estate e può
avere un colore che va dal rosso e bianco al viola.
Il nome della specie, "persica", da cui deriva la stessa parola "pesca" e i suoi
corrispondenti in molte lingue europee (francese "pêche", inglese "peach",
tedesco "Pfirsich", olandese "perzik", catalano "préssec", portoghese "pêssego",
danese "fersken", finlandese "persikka"), deriva dall'antica credenza europea
che il pesco fosse originario della Persia: gli antichi romani infatti si
riferivano alla pesca come "malum persicum" ("mela persiana"), ma in realtà
l'albero fu domesticato e coltivato per la prima volta nella Cina orientale.
Endocarpi fossili con caratteristiche indistinguibili da quelle delle moderne
pesche sono stati recuperati da depositi del tardo Pliocene a Kunming, risalenti
a 2,6 milioni di anni fa. In assenza di prove che le piante fossero per altri
versi identiche al pesco moderno, a questi fossili è stato assegnato il nome
Prunus kunmingensis. Fino a poco tempo fa si credeva che la coltivazione fosse
iniziata intorno al 2000 a.C., ma prove più recenti indicano che la
domesticazione avvenne già nel 6000 a.C. nella provincia cinese di Zhejiang. I
noccioli di pesca più antichi provengono dal sito di Kuahuqiao, vicino a
Hangzhou. Gli archeologi indicano la valle del fiume Yangtze come il luogo in
cui probabilmente ebbe luogo la prima selezione di varietà di pesche favorevoli
al consumo umano. Le pesche sono state menzionate negli scritti e nella
letteratura cinese a partire dall'inizio del primo millennio a.C. Una pesca
addomesticata apparve in Giappone già nel 4700-4400 a.C., durante il periodo
Jōmon. Era già simile alle moderne forme coltivate, dove i noccioli di pesca
sono significativamente più grandi e più compressi dei noccioli precedenti;
questa cultivar di pesca è stata certamente portata in Giappone dalla Cina,
anche se, paradossalmente, nella stessa Cina questa varietà è attualmente
attestata solo in date successive al 3300 a.C. In India la pesca apparve per la
prima volta intorno al 1700 a.C., durante il periodo della cosiddetta (e per
molti versi ancora misteriosa) civiltà Vallinda.
La coltivazione del pesco raggiunse la Grecia nel 300 a.C. Comunemente si
ritiene che Alessandro Magno li abbia introdotti in Grecia dopo aver conquistato
la Persia ed essere giunto sino in India, ma non è stata trovata alcuna prova
storica di questa affermazione. Le pesche erano ben note ai Romani già nel I
secolo d.C.; le più antiche rappresentazioni artistiche conosciute del nostro
frutto si trovano in due frammenti di pitture parietali ad Ercolano,
conservatesi a causa dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., e ora conservate al
Museo Archeologico Nazionale di Napoli. I reperti archeologici mostrano che le
pesche erano ampiamente coltivate nell'Europa continentale romana, ma la
produzione crollò intorno al VI secolo; qualche ripresa della produzione si ebbe
con il cosiddetto Rinascimento Carolingio del IX secolo. Si parla della
coltivazione del pesco in Spagna nel trattato agricolo di Ibn al-'Awwam, scritto
nel XII secolo. La pesca fu portata nelle Americhe dagli esploratori spagnoli
nel XVI secolo e alla fine arrivò in Inghilterra e in Francia nel XVII secolo,
dove era un regalo pregiato e costoso. L'orticoltore George Minifie (1597-1646)
avrebbe portato le prime pesche dall'Inghilterra nelle colonie nordamericane
nella prima metà del XVII secolo, piantandole nella sua tenuta di Buckland in
Virginia. Sebbene Thomas Jefferson coltivasse alberi di pesco a Monticello, gli
agricoltori americani non iniziarono la produzione commerciale fino al XIX
secolo nel Maryland, nel Delaware, in Georgia, nella Carolina del Sud e infine
in Virginia.
Invece la storia della nettarina non è chiara; la prima menzione registrata in
inglese è del 1616, ma probabilmente erano state coltivate molto prima
all'interno dell'areale nativo del pesco nell'Asia centrale e orientale. Sebbene
alcune fonte affermino che le nettarine furono introdotte negli Stati Uniti da
David Fairchild del Dipartimento dell'Agricoltura nel 1906, in realtà già
l'edizione del 28 marzo 1768 della "New York Gazette" menziona una fattoria di
Long Island, nello stato di New York, dove si coltivavano nettarine.
La "pesca del nettare di miele" di Shanghai era una componente chiave sia della
cultura nutrizionale che dell'economia agraria dell'area in cui sorge la moderna
megalopoli di Shanghai, la città più popolosa del mondo., e i peschi non
mancavano mai nei giardini di tale città. Quando la modernizzazione e
l'occidentalizzazione ne hanno sconvolto l'aspetto, la "pesca del nettare di
miele" di Shanghai si è quasi estinta del tutto: gran parte della Shanghai
moderna è purtroppo costruita su quelli che erano vasti frutteti di pesche.
Nell'aprile 2010 un consorzio internazionale, l'International Peach Genome
Initiative, che comprendeva ricercatori provenienti da Stati Uniti, Italia,
Cile, Spagna e Francia, ha annunciato di aver sequenziato il genoma del pesco.
La sequenza è composta da 227 milioni di nucleotidi disposti in otto
pseudomolecole che rappresentano gli otto cromosomi della pesca. Inoltre sono
stati previsti 27.852 geni codificanti proteine e 28.689 trascritti
codificanti proteine. Particolare enfasi in questo studio è stata riservata
all'analisi della diversità genetica nel genoma del pesco e al modo in cui è
stato plasmato da attività umane come la domesticazione e la selezione. Sono
stati riscontrati importanti "colli di bottiglia" storici, uno legato alla
presunta domesticazione originaria che si suppone sia avvenuta in Cina circa
4.000-5.000 anni fa, il secondo dovuto alla precoce diffusione del pesco in
Europa. Questi "colli di bottiglia" hanno evidenziato la sostanziale riduzione
della diversità genetica associata alle attività di domesticazione.
Il pesco cresce in un areale abbastanza limitato nei climi secchi, continentali
o temperati, poiché gli alberi hanno un fabbisogno di freddo che le zone
tropicali o subtropicali generalmente non soddisfano se non ad altitudini
elevate (ad esempio in alcune aree di Ecuador, Colombia, Etiopia, India e
Nepal). La maggior parte delle cultivar richiede 500 ore di raffreddamento da 0°
a 10°C, perchè durante il periodo di raffreddamento si verificano reazioni
chimiche chiave, anche se la pianta appare dormiente. Una volta completato il
periodo di raffreddamento, la pianta entra in un secondo tipo di dormienza, il
periodo di quiescenza, durante il quale le gemme si rompono e crescono quando si
raggiunge un clima caldo sufficientemente favorevole alla crescita. Gli alberi
possono solitamente tollerare temperature comprese tra -26° e -30°C, sebbene i
boccioli dei fiori della stagione successiva vengano solitamente compromessi a
queste temperature, impedendo un raccolto per quell'estate. Un altro vincolo
climatico è il gelo primaverile: gli alberi fioriscono abbastanza presto (a
marzo nell'Europa occidentale) e il fiore viene danneggiato o cmpromesso se le
temperature scendono al di sotto di -4°C. Se i fiori non sono completamente
aperti, però, possono tollerare qualche grado in meno di freddo. Anche i climi
con precipitazioni invernali significative a temperature inferiori a 16°C non
sono adatti alla coltivazione del pesco, poiché la pioggia favorisce
l'arricciamento delle foglie, che è la più grave malattia fungina per questi
alberi da frutto. Per questo i fungicidi sono ampiamente utilizzati per la
coltivazione delle pesche in tali climi, con oltre l'1% delle pesche europee che
superavano i limiti legali di pesticidi nel 2013! Infine, per la maturazione del
raccolto è necessario il caldo estivo, con temperature medie del mese più caldo
comprese tra 20° e 30°C.
I peschi hanno bisogno di pieno sole e di una disposizione che consenta un buon
flusso d'aria naturale per favorire l'ambiente termico per l'albero; vengono
piantati all'inizio dell'inverno, e durante la stagione di crescita necessitano
di un approvvigionamento idrico regolare e affidabile, con quantità maggiori
appena prima del raccolto. Inoltre i peschi hanno bisogno di fertilizzanti
ricchi di azoto più di altri alberi da frutto. Senza una fornitura regolare di
fertilizzanti, le foglie del pesco iniziano a ingiallire o mostrano una crescita
stentata. I fiori su un pesco sono tipicamente diradati perché se tutte le
pesche su di un ramo giungessero a maturazione, sarebbero sottodimensionate e
mancherebbero di sapore: i frutti vengono diradati a metà stagione. Le pesche
fresche si ammaccano facilmente, quindi non è bene conservarle a lungo: sono più
saporite quando maturano sull'albero e si mangiano il giorno stesso del
raccolto. Nei giardini recintati costruiti in pietra o mattoni, che assorbono e
trattengono il calore solare e poi lo rilasciano lentamente, aumentando la
temperatura contro il muro, le pesche possono essere coltivate a spalliera
addirittura fino alle isole britaniche. Le tipiche cultivar di pesco iniziano a
dare i loro frutti nel loro terzo anno.
Sono note centinaia di cultivar di pesche e nettarine, classificati in due
categorie: "freestone" e "clingstone". Le prime sono quelle la cui polpa si
separa facilmente dal nocciolo, le seconde sono quelle la cui polpa vi si
aggrappa saldamente. Alcune cultivar sono parzialmente freestone e clingstone,
quindi sono chiamate "semifree". I tipi freestone sono preferiti per essere
consumati freschi, mentre i tipi clingstone servono per l'inscatolamento. La
selezione artificiale ha favorito cultivar con maggiore compattezza, colore più
rosso e peluria più corta sulla superficie del frutto: queste caratteristiche
facilitano le spedizioni e le vendite nei supermercati, migliorando l'attrattiva
visiva. Tuttavia, questo processo di selezione non ha necessariamente portato a
un aumento del sapore. Le pesche hanno una durata di conservazione breve, quindi
i coltivatori commerciali in genere piantano un mix di diverse cultivar per
avere frutta da spedire per tutta la stagione. Tra le cultivar italiane di
pesche vi sono Springcrest, Springbelle, Royal Gem, Royal Glory, Flavorcrest,
Redhaven; tra quelle di nettarine vi sono Sbergia, Big Top, Stark Redgold, Venus,
Rita star, Maria Laura, Adriana, Independence, Caldesi. La "merendella" è una
pesca dalla pelle liscia e colore bianco-verde, con polpa aderente al nocciolo,
diffusa in Sicilia e soprattutto in Calabria, in particolare nella fascia ionica
catanzarese. La "pesca saturnina" o "pesca tabacchiera" o "platicarpa" ha forma
schiacciata (le comuni pesche sono per lo più sferiche) e sapore intenso. Un
pesco è anche una buona fonte di polline per le api mellifere.
Il primo parassita ad attaccare l'albero all'inizio dell'anno, quando scarseggia
altro cibo, è la forbicina (Forficula auricularia), che si nutre di fiori e
foglie giovani durante la notte, impedendo la fruttificazione e indebolendo gli
alberi appena piantati. Infestano i peschi anche le larve di alcune specie di
falene come la piralide del pesco (Synanthedon exitiosa), la tignola gialla del
pesco (Conogethes punctiferalis), Abagrotis orbis, Lyonetia prunifoliella,
Phyllonorycter hostis, la piralide degli alberi da frutto (Maroga melanostigma),
la falena a macchie bianche (Orgyia thyellina) e l' avvolgifoglie del melo (Archips
termias). Il pesco viene attaccato anche dall'acaro rosso europeo (Panonychus
ulmi) e dal famigerato coleottero giapponese (Popillia japonica). I peschi sono
purtroppo soggetti a una diffusissima malattia chiamata arricciamento delle
foglie, che di solito non colpisce direttamente il frutto, ma riduce la resa del
raccolto defogliando parzialmente l'albero. Diversi fungicidi a base di rame
possono essere utilizzati per combattere tale malattia. Il frutto è suscettibile
anche al marciume bruno.
Nel 2020 il primo produttore mondiale di pesche e nettrine era naturalmente la
superpotenza cinese con 15,00 milioni di tonnellate (il 61% del totale
mondiale), seguita dalla Spagna con 1,31, dall'Italia con 1,02, dalla Turchia e
dalla Grecia con 0,89, a fronte di una produzione mondiale di 24,57 milioni di
tonnellate. Lo stato americano della Georgia è noto come "Stato delle pesche"
per la sua significativa produzione di pesche iniziata già nel 1858. Il fiore
simbolo dello stato del Delaware è il fiore di pesco dal 1995, e la torta di
pesche è diventata nel 2009 il suo dolce ufficiale.
La polpa di pesca cruda è composta per l'89% da acqua, per il 10% da
carboidrati, per l'1% da proteine e contiene una quantità trascurabile di
grassi. Una pesca cruda di medie dimensioni, del peso di 100 grammi, fornisce 39
kilocalorie, 9,54 g di carboidrati, 8,39 g di zuccheri, 1,5 g di fibre e
contiene piccole quantità di nutrienti essenziali, ma nessuno è una percentuale
significativa del valore giornaliero. Comunque le pesche fresche sono una fonte
moderata di antiossidanti e vitamina C, necessaria per la costruzione del
tessuto connettivo all'interno del corpo umano. I polifenoli totali in 100 g di
peso fresco sono 14-102 mg nelle nettarine a polpa bianca, 18-54 mg nelle
nettarine a polpa gialla, 28-111 mg nelle pesche a polpa bianca e 21-61 mg nelle
pesche a polpa gialla. I principali composti fenolici identificati nella pesca
sono l'acido clorogenico, le catechine, l'acido gallico e l'acido ellagico.
Circa 110 composti chimici contribuiscono all'aroma della pesca, inclusi alcoli,
chetoni, aldeidi, esteri, polifenoli e terpenoidi. Contenendo amigdalina, anche
se in dosi minori che in altre specie del genere Prunus, i semi delle pesche
sono tossici se consumati in grandi quantità.
L'intolleranza alla pesca è una forma relativamente comune di ipersensibilità
alle proteine contenute nelle pesche e nei relativi frutti, così come nelle
mandorle. I sintomi variano da effetti locali (sindrome orale allergica,
orticaria da contatto) a reazioni sistemiche più gravi, tra cui anafilassi
(orticaria, angioedema, sintomi gastrointestinali e respiratori). Le reazioni
avverse sono legate alla "freschezza" del frutto: la frutta sbucciata o in
scatola può essere tollerata.
Chiudiamo come sempre con il significato della pesca nella cultura. Le pesche
non sono solo un frutto molto popolare, ma sono anche rivestite di simbolismo in
molte tradizioni culturali. Com'è noto, i fiori di pesco sono molto apprezzati
nella cultura cinese. Gli antichi cinesi credevano che il pesco possedesse più
vitalità di qualsiasi altro albero perché i loro fiori compaiono prima che
spuntino le foglie. Quando i primi imperatori della Cina visitavano i loro
territori, si dice che fossero preceduti da stregoni armati di bastoni di legno
di pesca per proteggerli dai ogni sorta di malefizio. Alla vigilia di Capodanno,
i magistrati locali tagliavano rami di legno di pesco e li mettevano sopra le
porte delle loro case per proteggersi dalle influenze malvagie. Durante il
periodo Han (202 a.C. - 220 d.C.) gli archi di legno di pesco venivano usati per
scagliare frecce in ogni direzione nel tentativo di dissipare il male, mentre
sigilli o figurine di legno di pesco custodivano cancelli e porte. I semi di
pesca (桃仁, "táo rén") sono un ingrediente comune della medicina tradizionale
cinese per dissipare i ristagni di sangue, contrastare l'infiammazione e ridurre
le allergie. In un frutteto di peschi in fiore, Liu Bei, Guan Yu e Zhang Fei
prestano giuramento reciproco di fratellanza nel capitolo iniziale del classico
romanzo cinese "Il Libro dei Tre Regni" (XIII secolo). Un pesco che cresceva su
un precipizio era il luogo in cui il maestro taoista Zhang Daoling metteva alla
prova i suoi discepoli. In Cina il termine "pesca morsicata" divenne sinonimo di
"omosessuale" (come "finocchio" in Europa); tale termine fu usato per la prima
volta dal filosofo Han Fei (280-233 a.C.), raccontando un aneddoto in cui il
cortigiano Mizi Xia addentò una pesca particolarmente deliziosa e diede il resto
al suo amante, il duca Ling di Wei, in modo che anche lui potesse assaggiarlo.
In Corea la pesca è considerata il frutto della felicità, della ricchezza, degli
onori e della longevità. La rara pesca con semi doppi è considerata un auspicio
propizio di un inverno mite. È una delle dieci piante e animali immortali,
quindi le pesche compaiono in molti minhwa (dipinti popolari coreani). I coreani
ritengono ancor oggi che pesche e alberi di pesco scaccino gli spiriti, quindi
le pesche non vengono poste sui tavoli per la venerazione degli antenati, a
differenza di altri frutti.
Per quanto riguarda il Giappone, basti dire che secondo il Guinness dei Primati
la pesca più dolce conosciuta è stata coltivata a Kanechika, in Giappone, con un
contenuto zuccherino del 22,2%. Momotarō (桃太郎, "il ragazzo della pesca") è il
personaggio di una fortunata fiaba giapponese, che prende il nome dalla pesca
gigante da cui è nato: essa fu pescata mentre andava alla deriva in un fiume da
un'anziana donna che non aveva avuto figli e che si era recata al fiume per
lavare i panni. La donna e suo marito scoprirono il bambino mentre cercavano di
aprire la pesca per mangiarla, ed egli spiegò loro di essere stato inviato dal
cielo per essere loro figlio. Secondo un'altra versione, invece, la donna mangiò
un pezzo della pesca e tornò giovane e bella, e quando il marito tornò a casa
convinse anche lui a cibarsene; la coppia, rinvigorita dai poteri della pesca,
quella sera stessa concepì un figlio. Infatti la pesca è considerata in Giappone
un simbolo di fertilità, per la sua forma che ricorda il fondoschiena di una
donna. Comunque, una volta cresciuto, il ragazzo lasciò la famiglia per andare
ad affrontare gli "oni", orchi che vivevano nell'isola di Onigashima; lungo la
strada incontrò un cane, una scimmia e un fagiano, che accettarono di aiutarlo
nella sua missione. Insieme ai suoi amici animali, Momotarō penetrò nel forte di
Ura, sconfisse il capo degli oni e sottrasse alle creature un prezioso bottino,
grazie al quale la sua famiglia e i suoi nuovi amici poterono vivere per sempre
negli agi. Aggiungiamo che due parole giapponesi tradizionali per il colore rosa
corrispondono agli alberi in fiore: una per i fiori di pesco (momo-iro) e una
per i fiori di ciliegio (sakura-iro).
I protagonisti di The Tale of Kieu si sono innamorati di un pesco, e In Vietnam
il fiore di pesco che sboccia è il segnale della primavera, e i bonsai di pesco
sono usati come decorazione nel nord del Vietnam durante il capodanno vietnamita
(Tết), che diede il nome a un episodio della Guerra del Vietnam ("Offensiva del
Tết"). Una leggenda vietnamita racconta che nella primavera del 1789, dopo aver
marciato verso Ngọc Hồi e aver ottenuto una grande vittoria contro gli invasori
della dinastia Qing cinese, l'imperatore del Vietnam Quang Trung (1753-1792)
ordinò a un messaggero di galoppare fino alla cittadella di Phú Xuân (ora Huế) e
consegnare un ramo di pesco in fiore all'imperatrice Ngọc Hân; ciò sarebbe
avvenuto il quinto giorno del primo mese lunare, due giorni prima della prevista
fine della battaglia. Il ramo di fiori di pesco inviato dal nord al centro del
Vietnam non fu solo un presagio di vittoria dell'Imperatore alla sua consorte,
ma anche l'inizio di una nuova primavera di pace e felicità per tutto il popolo
vietnamita. Inoltre, poiché la terra di Nhật Tân aveva donato gratuitamente
proprio quel ramo di fiori di pesco all'Imperatore, esso divenne il fedele
giardino della sua dinastia.
Nell'Egitto ellenistico la pesca era il frutto sacro di Arpocrate (Hor pa khred,
ossia Horus il fanciullo), dio protettor dell'infanzia: per questo ancora oggi
le guance dei bambini sono paragonate alla buccia della pesca.
Quanto all'Europa, a Marsiglia si diceva che bastava addormentarsi con la
schiena appoggiata a un pesco e restarci per due o tre ore, per far passare la
febbre che si sarebbe trasmessa all'albero, le cui foglie sarebbero ingiallite e
cadute. Molti artisti famosi hanno dipinto nature morte con frutti di pesco in
risalto o alberi di pesco in varie ambientazioni: Caravaggio, Vicenzo Campi,
Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet, Édouard Manet, Henri Fantin-Latour, Severin
Roesen, Peter Paul Rubens e Vincent Van Gogh. Gli studiosi dell'arte
suggeriscono che molte composizioni siano simboliche: ad esempio, Jack Tresidder
sostiene che gli artisti del Rinascimento usavano la pesca per rappresentare il
cuore e una foglia attaccata al frutto come simbolo della lingua, implicando
così che stavano dicendo la verità che usciva loro dal cuore; una pesca matura
era anche un simbolo per indicare uno stato di buona salute. I dipinti di
Michelangelo Merisi detto il Caravaggio (1571-1610) introducono un notevole
realismo dipingendo foglie di pesco che sono appassite, scolorite o, in alcuni
casi, sono rose dai vermi, condizioni comuni nella moderna coltivazione della
pesca. In letteratura, Roald Dahl (1916-1990) intitolò il romanzo fantasy dei
suoi figli "James and the Giant Peach" perché una pesca è "più bella, più grande
e più morbida di una ciliegia". E poi, come non ricordare Lucio Battisti e la
sua “Fiori rosa, fiori di pesco”?

La
drupa che ispirò Pablo Neruda
Anche la prugna (Prunus
domestica) è una pianta da fiore del genere Prunus e della famiglia delle
Rosacee. Comprende molte varietà di alberi da frutto conosciuti come prugne,
anche se non tutti quelli che noi chiamiamo "alberi di prugne" appartengono a
questa specie. L'albero ha la tipica forma ad ombrello o ad alberello, di medie
dimensioni: da 3-4 fino a 6-8 metri d'altezza, a seconda della varietà. Talvolta
nodoso, presenta fiori solitamente bianchi che sorgono già all'inizio della
primavera. Il frutto ovale o sferico varia in dimensioni, ma può raggiungere un
diametro massimo di 8 centimetri. La polpa è generalmente dolce, però esistono
anche varietà acide che necessitano di essere cotte con zucchero per essere
commestibili. Come tutti i frutti degli alberi del genere Prunus, la prugna
contiene un unico grande seme, solitamente chiamato nocciolo, che non è
commestibile e viene scartato durante il consumo. I frutti si raccolgono a più
riprese da giugno a ottobre, con la possibilità di ottenere fino a cinque
raccolte. Per stabilire il grado di maturazione si valuta la resistenza della
polpa (misurata con uno strumento chiamato penetrometro), il rapporto solidi
solubili/acidità totale e la variazione del colore di fondo della buccia. La
prima raccolta è generalmente la migliore, fino ad arrivare poi alle ultime che
presentano frutti di seconda qualità. Data la natura organolettica della polpa,
conservare in frigo questo frutto si rivela quasi inutile, in quanto la polpa
tende ad imbrunire.
La parola "prugna" viene dal latino "prunum" attraverso il latino volgare "prunĕa",
a sua volta dal greco "proynon". Alcuni lo fanno derivare dalla radice indoeuropea "brhux-mnĕi-ŏ-", "scuro",
attraverso l'anatolico "*prumnĕiă" probabilmente per il colore del frutto. Siccome il pruno
selvatico è pieno di spine, la parola "pruno" è passata in italiano ad indicare
ogni genere di arbusto spinoso, come il biancospino e il rovo, usati per le
siepi (che certamente non producono prugne commestibili!). Il termine in questo
senso è usato anche da Dante nella selva dei suicidi: « Allor porsi la mano un
poco avante, / e colsi un ramicel da un gran pruno; / e 'l tronco suo gridò:
"Perché mi schiante?" » (Inf. XIII,31-33) Da qui viene il senso figurato di
"fastidio, dolore" assunto da questa parola, come il famoso letto
dell'Innominato, che secondo Manzoni era diventato "un covile di pruni" a causa
dei rimorsi che lo perseguitavano, e che lo avrebbero condotto all'improvvisa
conversione. Il frutto, per distinguerlo dall'albero, viene chiamato anche
susina, ed anche l'etimologia di questa parola è discussa. Secondo alcuni viene
da Susa, una delle capitali della Persia achemenide, presunta città d'origine
della pianta; secondo altri viene da "succiare" ("succhiare") attraverso una
voce dialettale, come il toscano "sucina". Secondo alcuni, però, il
termine susina andrebbe riferito alla sola specie Prunus salicina, originaria di
Cina e Vietnam.
Originario dell'Asia, e in particolare della zona del Caucaso, in seguito il
prugno cominciò ad essere coltivato anche in Siria, principalmente a Damasco. I
Romani, verso il 150 a.C., lo introdussero nel bacino del Mediterraneo, ma
furono i combattenti della Prima Crociata a portarlo in tutta l'Europa intorno
al 1100 d.C., dapprima in Francia e poi nelle altre nazioni. Forse
rinselvatichita, si diffuse nell'Europa centrale, giungendo con la variante
Juliana fino alla Danimarca e alla Scandinavia meridionale.
Grazie ai coloni europei, oggi il prugno è coltivato in tutto il mondo: i maggiori produttori di prugne nel
2018 sono stati la Cina (6,8 milioni di tonnellate), la Romania e la Serbia
(842.000 tonnellate), gli Stati Uniti (368.000 tonnellate) e l'Iran (313.000
tonnellate), a fronte di una produzione complessiva mondiale di 12.608.678
tonnellate. L'irrigazione si dimostra fondamentale durante il periodo di
fioritura. La potatura è diversa in base alla specie: per il susino europeo è
importante lasciare una buona quantità di gemme. Le sottospecie si incrociano
facilmente, tanto che si possono trovare numerose forme intermedie: la loro
dolcezza e acidità possono variare molto, i colori variano dal viola-bluastro al
rosso, arancio, giallo o verde chiaro.
Le varie specie di prunus sono raggruppate in tre principali categorie: il
gruppo asiatico-europeo (Prunus domestica, Prunus insititia, Prunus. cerasifera);
il gruppo sino-giapponese (Prunus salicina); e il gruppo americano (Prunus
americana). Tra i pruni europei ricordiamo: la
Agostana, varietà di origine italiana caratterizzata da frutti piccoli di colore
rosso con polpa gialla e gusto gradevole, utilizzati anche per realizzare
liquori e confetture; la
Anna Späth, originaria dell'Ungheria ma commercializzata in Germania per la prima
volta dal vivaista Ludwig Späth (1793-1883) da cui il nome, con frutti medio-grandi,
una buccia che varia dal rosso porpora al blu violetto ed una polpa
giallo-verdastra, soda e zuccherina, non particolarmente succosa; la
Bianca di Milano, che, produce frutti di forma rotonda con buccia verde chiaro e
polpa gialla e zuccherina; la
Stanley, la varietà più coltivata, più produttiva e di qualità
superiore, i cui frutti di grandi dimensioni sono
eccezionali per l'essiccazione, data la maturazione tardiva; la San Pietro, con
frutti di forma ovoidale e una buccia inizialmente verde che tende a colorarsi
di giallo a maturazione completa (è tra le prime varietà di prugne a maturare);
e la Verdacchia, varietà italiana di origini molto antiche, che ha frutti succosi e
dolci dalla forma allungata con buccia e polpa di colore giallo-verdastro. Tra i
pruni sino-giapponesi, ricordiamo la
Burbank, con frutti grandi caratterizzati da una buccia rossa scura ed una polpa
gialla, molto produttiva; la
Goccia d'oro, detta anche Shiro, che come suggerisce il nome è contraddistinta
da frutti di colore giallo dorato; la
Sangue di Drago, con buccia rosso-viola e polpa gialla molto dolce; e la Santa Rosa, caratterizzata da frutti piuttosto grandi e di forma sferica, la
cui buccia è color rosso scuro, mentre la polpa è gialla o sfumata di rosa. Non
dimentichiamo poi la
California Blu, ovviamente originaria della California, che è contraddistinta dai
caratteristici frutti color blu-violaceo e dalla forma per lo più tonda.
Infine, "Pluot" è il nome commerciale attribuito ad un gruppo di cultivar di un
ibrido realizzato alla fine del XX secolo da Floyd Zaiger (1926-2020). Questa
drupacea fu ottenuta da una ibridazione multipla ed è composta per tre quarti
dal susino e per un quarto dall'albicocco. Il nome dell'ibrido deriva infatti
dalla crasi fra "plum" (in inglese, "prugna"), e "apricot" ("albicocca"). Molto
commercializzata nei mercati ortofrutticoli statunitensi, in Italia è nota come
prugnocca, anche se la legge imporrebbe di non tradurre o modificare i nomi
imposti da chi ha creato l'ibrido. L'aspetto esteriore del frutto, chiamato
anche "uovo di dinosauro", è quello di una susina, ha un sapore molto dolce ed è
ricco di provitamina A.
Le prugne vengono coltivate a scopo commerciale nei frutteti, ma i moderni
portainnesti
consentono di coltivare singole prugne in spazi relativamente piccoli. La loro
fioritura e fruttificazione precoci fa sì che richiedano un luogo riparato dal
gelo e dai venti freddi. Purtroppo è una pianta molto delicata, che subisce le
aggressioni di molti parassiti. Tra di essi si annoverano l'eriofide del susino
(Aculus fockeui), l'afide verde del susino (Brachycaudus helychrysi), l'afide
farinoso del susino (Hyalopterus pruni), la cocciniglia del susino (Sphaerolecanium
prunastri), la mosca mediterranea della frutta (Ceratitis capitata), la
carpocapsa delle susine (Grapholita funebrana), l'oplocampa delle susine (Hoplocampa
minuta) e il buprestide dei fruttiferi (Capnodis tenebrionis). Un'altra grave
avversità è rappresentata dalle gazze ladre. Una menzione a parte la merita
Taphrina pruni, un fungo ascomicete che attacca il susino, di cui colpisce i
frutti provocando la loro degenerazione nei cosiddetti "bozzacchioni del
susino", immangiabili: i frutti vengono colpiti quando hanno raggiunto un certo
grado di sviluppo e si deformano assumendo una forma allungata e ricurva; la
loro superficie diventa grinzosa e rugosa e poi suberosa. Il frutto assume un
colore giallastro e quindi grigiastro e poi dissecca, trasformandosi in una
"mummia" ricoperta da una muffa biancastra. A rendere universalmente nota questa
patologia è stato Dante Alighieri, che nel suo "Paradiso" scrive: « Ben fiorisce
ne li uomini il volere; / ma la pioggia continüa converte / in bozzacchioni le
sosine vere » (Par. XXVII, 124-126) Con questa metafora tratta (come molte altre
dantesche) dal mondo agricolo, Beatrice intende rimarcare il fatto che l'uomo
nasce naturalmente inclinato al bene, ma poi crescendo perde la sua innocenza e
si corrompe, come le prugne che la pioggia trasforma in bozzacchioni, guasti e
privi di ogni sapore, a causa della mancanza di una guida spirituale e politica
nel mondo (i funghi parassiti non erano noti ai tempi del Ghibellin Fuggiasco, e
la malattia era attribuita al maltempo, che in effetti può favorire la crescita
dei funghi). All'epoca non restava che eliminare i rami colpiti dalla malattia,
ma oggi Taphrina pruni è efficacemente combattuta mediante trattamenti
preventivi con anticrittogamici a base rameica alla caduta delle foglie e alla
ripresa vegetativa.
Le prugne forniscono 42 kcal per 100 grammi, contengono acqua per l'80% e
apportano sali minerali, potassio e vitamine, in particolare la vitamina C. La
buccia è ricca di potenti antiossidanti. Il potere calorico delle prugne secche
è ancora più elevato, 220 kcal per 100 grammi, perché gli zuccheri sono più
concentrati. Le prugne secche si possono ottenere così: si lavano e si asciugano
le prugne, si eliminate il nocciolo con l'apposito strumento, si mettono le
prugne in una pentola piena di acqua bollente, ed appena la buccia inizia a
gonfiarsi (dopo circa 2 minuti) si scolano, si asciugano, le si dispone in una
teglia coperta con carta da forno e le si cuoce in forno ventilato a 80°C per
due ore. Si può anche disporle su un vassoio metallico, coprirle con un velo e
lasciarle essiccare al sole per una settimana.
E ora, un po' di poesia. Oltre alla suddetta citazione dantesca, il poeta cileno
Pablo Neruda (pseudonimo di Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, 1904-1973)
nelle sue Odi Elementari, scritte nel 1954, ha dedicato alcune poesie a diversi
alimenti, tra cui ortaggi e frutta: limoni, cipolle, cocomeri, arance, carciofi.
Anche alla prugna è dedicata una poesia, dove viene rappresentata come il frutto
della memoria, perché il poeta, tenendone una tra le mani, rivive momenti della
sua infanzia, ricordando le emozioni e le scoperte di quando era "un ragazzino
silvestre". Ecco una strofa della poesia: « Da allora / la terra, il sole, la
neve / le raffiche / della pioggia in ottobre / per le strade, / tutto, / la
luce, l'acqua, / lasciarono / nella mia memoria / odore / e trasparenza / di
prugna. / La vita / ovalizzò in un calice / il suo splendore, la sua ombra, / la
sua freschezza. / Oh bacio / della bocca / nella prugna, / denti / e labbra /
pieni / dell'ambra odorosa / della liquida / luce della prugna. »
Chiudiamo con una curiosità storica davvero insolita. A Bra, in provincia di
Cuneo, c'è un esemplare di Prunus spinosa che fiorisce in pieno inverno. Secondo
la tradizione, la sera del 29 dicembre 1336 la giovane Egidia Mathis, prossima
al parto, stava rientrando a casa. Si fermò, come suo solito, per una preghiera
davanti a un'edicola dedicata alla Vergine. Qui venne raggiunta con cattive
intenzioni da alcuni soldati di ventura che stazionavano nelle vicinanze. La
povera Egidia invocò la Madonna e all'improvviso arrivò dal bosco una dignitosa
matrona, sfolgorante di luce, tanto che i soldati pensarono bene di tagliare la
corda. Per lo spavento Egidia venne colta dalle doglie e partorì di lì a poco,
confortata da quella misteriosa presenza che infine scomparve senza rivelare la
propria identità. La giovane corse in paese col neonato, raccontò i fatti e
tornò sul posto insieme ad alcuni parenti. Essi si accorsero con stupore che gli
alberi di prugne, attorno all'edicola, erano coperti di fiori. Da allora il
luogo diventò meta di pellegrinaggi; nel 1626 venne eretto il primo Santuario
della Madonna dei Fiori, detto anche Santuario Antico, uno dei più visitati del
Piemonte. Si rese poi necessaria la costruzione di un ulteriore santuario, più
grande, la cui prima pietra fu posta nel 1933. La fioritura si ripete ogni anno
alla fine di dicembre, preceduta qualche volta da un'ulteriore fioritura per
l'Immacolata. In genere dura una ventina di giorni, ma può protrarsi anche più a
lungo. A ogni mancata fioritura hanno fatto seguito eventi drammatici, come
negli inverni del 1914 e del 1939, vigilie della prima e della seconda guerra
mondiale, quando il "miracolo" non si verificò. Non accadde neppure nel 1877, e
poco dopo morì Papa Pio IX, che aveva promulgato il dogma dell'Immacolata
Concezione. Si dice che i fiori apparvero però il 20 febbraio del 1878, in
concomitanza con l'elezione del successore, Leone XIII. Fin dal ‘700 sono stati
compiuti studi scientifici volti a comprendere le ragioni della fioritura fuori
stagione, e se ne è occupato anche il CICAP, l'organizzazione italiana degli
scettici per antonomasia, ma finora non è stata trovata alcuna particolarità nel
terreno o nel microclima, per cui l'unica spiegazione scientifica è un'insolita
(ma non impossibile) mutazione genetica della pianta. Ma le leggende sono belle
indipendentemente da qualsiasi debunking, e così ringraziamo il Cielo per aver
fatto nascere una pianta di susine che fiorisce persino sotto la neve!

I
grandi frutti che Piero Chiara voleva rubare
L'anguria
(Citrullus lanatus) è una pianta da fiore della famiglia delle
Cucurbitacee che prende il nome dal suo frutto commestibile: è molto coltivata
in tutto il mondo, con più di 1.200 varietà. Si tratta di una pianta annuale che
può strisciare per terra o essere rampicante. Gli
steli sono lunghi fino a 3 metri, e quelli di nuova crescita hanno peli gialli o
marroni che scompaiono con l'invecchiamento della pianta. Le foglie misurano da
60 a 200 millimetri di lunghezza e da 40 a 150 mm di larghezza, e di solito sono trilobate. Come
quasi tutte le specie del genere Citrullus, l'anguria ha
viticci ramificati. Le piante sono monoiche, cioè hanno fiori unisessuali maschili o femminili,
bianchi o gialli, portati su fiori lunghi 40 millimetri e dotati di gambi
pelosi che crescono all'ascella delle foglie. I fiori maschili predominano all'inizio della stagione; i
fiori femminili si sviluppano successivamente.
Il grande, iconico frutto è una specie di bacca modificata chiamata "peponide" con una scorza
spessa detta esocarpo e un centro carnoso detto endocarpo. Le piante
selvatiche producono frutti fino a 20 cm di diametro, mentre le varietà
coltivate possono superare i 60 cm! La buccia del frutto è di
colore verde scuro e solitamente screziato o striato, e la polpa,
contenente numerosi semi sparsi all'interno, può essere rossa o rosa, ma in
certe varietà arancione, gialla, verde o bianca. Esiste anche un'anguria amara, Citrullus amarus, che si è naturalizzata nelle regioni semiaride di
diversi continenti ed è designata come "pianta infestante" in alcune parti
dell'Australia occidentale, dove viene chiamata "melone maiale".
L'anguria dolce fu descritta per la prima volta da Carlo Linneo nel 1753 e le
venne dato il nome Cucurbita citrullus. Fu riassegnata al genere Citrullus nel
1836, con il nome Citrullus vulgaris, dal botanico tedesco Heinrich
Adolf Schrader (1767-1836). Il nome attuale Citrullus lanatus fu assegnato nel
1916 dai botanici giapponesi Jinzō Matsumura (1856-1928) e Takenoshin Nakai
(1882-1952). Il latino Cĭtrŭllŭs viene dall'indoeuropeo *kĭ-tr-ŏn-(ĕ)lŏ-s,
"piccolo cranio per antonomasia", mentre l'epiteto "lanatus" si riferisce alle parti lanose della pianta
giovane.
Il nome anguria, comune in Italia Settentrionale, deriva dal greco tardo
ἀγγούριον,ʼăggŏ́u̯rĭŏn (dove -gg-
si pronuncia -ng-), diminutivo di ʼắggŏu̯rŏn ("cetriolo selvatico"),
dal composto indoeuropeo *hₐăṅg-ŏ-u̯r-(i̯)ŏ-m, "che ha una protezione a vaso". ed entra nel lessico della lingua
italiana in epoca bizantina attraverso l'Esarcato di Ravenna. Oggi in greco
moderno αγγούρι (angúri) significa "cetriolo". Il nome "cocomero", prevalente
invece in Italia Centrale deriva dal latino cucumis, "cetriolo"; da qui deriva
anche "cucumbra", termine usato nelle Marche. Il nome "pateca", comune in
Liguria, deriva dal francese "pastèque", a sua volta dal portoghese "pateca",
dall'arabo بطيخه "baṭīḫa", "cocomero". In Abruzzo il nome "citrone" o "cetrone"
deriva dal latino "citrium", "cetriolo". Il nome "melone d'acqua", diffuso in
Italia meridionale, deriva dal francese melon d'eau, a sua volta dal latino
mēlōne(m). In Sardegna viene usato il nome "síndria" o "sandia", vocaboli
derivanti rispettivamente dal catalano síndria e dallo spagnolo sandía, a loro
volta provenienti dall'arabo سِنْدِيَّة sindiyya, dal sanscrito सिंधु "sindhu",
"fiume" (nome sanscrito del fiume Indo, da cui l'attuale regione pakistana del
Sindh). In Calabria è conosciuto come "zipangolo" ("zuparacu", "pizzitangulu"),
termine la cui etimologia è incerta. Il nome Zipangolo potrebbe provenire da
Cipango o Zipangu, nome dato da Marco Polo al Giappone, area di notevole
diffusione del frutto, dal cinese 日本國 "Rìběnguó", ossia "Paese della Radice del
Sole". "Zuparacu", usato specialmente della provincia di Catanzaro, viene da
alcuni spiegato come "lo zio parroco", con riferimento alle lunghe file ordinate
e rettilinee dei semini neri, che ricordano i bottoni delle tuniche sacerdotali.
Prima del 2015 si presumeva che la specie selvatica più vicina a Citrullus
lanatus fosse il melone senza viticci Citrullus ecirrhosus delle regioni
aride del Sudafrica, sulla base di un esemplare erroneamente identificato nel XVIII secolo. Tuttavia, dopo l'analisi filogenetica, si ritiene ora che il
parente più stretto di Citrullus lanatus sia Citrullus mucosospermus
dell'Africa occidentale (coltivato dal Senegal alla Nigeria), che talvolta è anche
considerato una sottospecie di Citrullus lanatus. Secondo altri il progenitore del moderno cocomero domestico
potrebbe essere un melone della regione del Kordofan dell'attuale Sudan, il
quale
condivide con l'anguria domestica la perdita del gene dell'amarezza, pur
mantenendo un sapore dolce, a differenza di altre varietà selvatiche africane
provenienti da altre regioni: forse il melone di Kordofan era già coltivato
nella Valle del Nilo nel 2000 a.C. Il
melone lanoso amaro fu formalmente descritto nel 1794 da Carl Peter Thunberg
(1743-1828) e
gli venne dato il nome Momordica lanata, ma fu riassegnato al genere Citrullus
nel 1916 dai già citati Matsumura e Nakai.
Le angurie venivano originariamente coltivate per il loro alto contenuto di
acqua e venivano conservate per essere consumate durante le stagioni secche, non
solo come fonte di cibo, ma come metodo per immagazzinare l'acqua. Il famoso
esploratore David Livingstone (1813-1873) scrisse che la pianta del cocomero
cresceva nel deserto del Kalahari, e ritenne che essa avesse avuto origine lì,
dove è conosciuta come "tsamma" ed è famosa per l'elevato numero di frutti che
produce, fino a cento per ogni esemplare: per questa ragione è una fonte di
acqua abituale per gli abitanti della zona, oltre a fungere da cibo sia per gli
uomini sia per gli animali. In Botswana la pianta è conosciuta con il nome di "lerotse"
ed è considerata sacra, con foglie purificanti. Come scrisse il famoso
antropologo Sir James George Frazer (1854-1941) nel suo celebre saggio "Il ramo
d'oro" (1915), fra i beciuani è d'obbligo purificarsi prima di consumare i nuovi
raccolti. La purificazione avviene in gennaio, all'inizio del nuovo anno, in un
giorno stabilito dal capo tribù: tutti i maschi adulti tengono le foglie del
lerotse in mano e le schiacciano, ottenendone un succo che applicano agli alluci
e all'ombelico; poi ciascuno di essi si reca alla propria abitazione e spalma
tutti i membri della propria famiglia con questo succo. Solo dopo che questa
purificazione è stata completata, la gente è libera di mangiare i nuovi
raccolti.
Alcuni semi
di anguria sono stati trovati nella regione del Mar Morto negli antichi
insediamenti di Bab edh-Dhra e Tel Arad. Molti semi di anguria selvatica risalenti a 5000 anni fa sono
stati scoperti a Uan Muhuggiag, un sito preistorico della
Libia sudoccidentale che risale al 3500 a.C. circa. Non è dato sapere quando
l'anguria sia stata coltivata per la prima volta, ma il primo raccolto a essere
stato registrato è documentato in alcuni geroglifici nell'Antico Egitto e
avvenne quasi 5000 anni fa. Il frutto veniva spesso deposto nelle tombe dei
faraoni come mezzo di sostentamento per l'aldilà, e nella mitologia egizia
l'anguria aveva origine dal seme del dio Seth.
Nel VII secolo i cocomeri venivano coltivati in India e nel X secolo
raggiunsero la Cina. I Mori introdussero il frutto nella penisola iberica, e ci
sono prove che venisse coltivato a Cordova nel 961 e a Siviglia nel 1158.
Si diffuse verso nord attraverso l'Europa meridionale, forse limitato nella sua
avanzata dalle temperature estive insufficienti per buoni raccolti. Il frutto
cominciò ad apparire negli erbari europei nel 1600 e fu ampiamente piantato in
Europa nel XVII secolo in poi, ma senza troppa fortuna, poiché le prime angurie non erano dolci ma amare, con polpa bianco-giallastra,
ed erano
anche difficili da aprire. Attraverso la selezione, le angurie in seguito
acquisirono un sapore migliore e divennero più facili da aprire.
I Conquistadores e gli schiavi africani introdussero l'anguria nel Nuovo Mondo:
i coloni spagnoli la coltivavano in Florida nel 1576. Veniva coltivata in
Massachusetts nel 1629 e nel 1650 in Perù, Brasile e Panama . Nello stesso
periodo i nativi americani lo coltivavano nella valle del Mississippi e in
Florida. Durante la guerra di secessione americana, le angurie erano
comunemente coltivate dagli ex schiavi neri liberati e divennero uno dei simboli dell'abolizione
della schiavitù. Dopo la fine della guerra civile, nel Sud l'associazione dei
neri con l'anguria diede vita a un brutto stereotipo razzista secondo cui i neri
condividevano un presunto appetito vorace per l'anguria, un frutto a lungo
associato alla pigrizia e alla sporcizia.
Le angurie senza semi furono sviluppate nel 1939 da scienziati
giapponesi che furono in grado di creare ibridi triploidi senza semi che
inizialmente rimasero rari perché non avevano sufficiente resistenza alle
malattie. Le angurie senza semi sono diventate più popolari a partire dal 2000,
raggiungendo quasi l'85% delle vendite totali di angurie negli Stati Uniti nel
2014. Nel 1954
Charles Fredrick Andrus, un orticoltore del Laboratorio Agronomico
dell'USDA a Charleston, nella Carolina del Sud, è riuscito a produrre un'anguria
resistente alle malattie e all'avvizzimento, il cosiddetto "melone grigio di Charleston". La sua forma oblunga e la crosta dura lo
rendevano facile da impilare e spedire; la sua adattabilità permetteva di coltivarlo su un'ampia area geografica,
produceva raccolti abbondanti ed era resistente alle più gravi malattie
dell'anguria, come antracnosi e
fusarium. Nel 1963 J.M. Crall
dell'Università della Florida produsse "Jubilee" e l'anno successivo C.V. Hall della Kansas
State University produsse "Crimson Sweet". Queste non vengono
più coltivate in larga misura, ma il loro lignaggio è stato ulteriormente
sviluppato in varietà ibride con rese più elevate, migliore qualità della polpa
e aspetto attraente. Per capire se un'anguria è matura al punto giusto, bisogna
avvicinare il frutto all'orecchio e percuoterne la superficie esterna con il
pugno: si dovrebbero udire rintocchi armoniosi e profondi che gli esperti
paragonano a quelli di un violoncello.
Le angurie sono piante coltivate nei climi tropicali a temperati, che
necessitano di temperature superiori a 25°C per prosperare. Le angurie hanno un
periodo di crescita più lungo rispetto agli altri meloni, e possono impiegare 85
giorni o più dal momento del trapianto affinché il frutto maturi. Negli orti
domestici i semi vengono solitamente seminati in vasi coperti e
trapiantati nel terreno. Le condizioni ideali sono un terriccio sabbioso ben
drenato con un pH compreso tra 5,7 e 7,2. La qualità più diffusa è la "Crimson
Sweet", che si presenta rotonda e per lo più allungata, di colore verde chiaro
alternato a strisce verde scure. Altra qualità famosa è la "Sugar Baby",
inconfondibile in quanto è piccola, tonda e di colore verde scuro. I maggiori
produttori di angurie nel 2018 sono stati la Cina con 62.803.768 tonnellate,
l'Iran con 4.113.711, l'India India con 2.520.000, il Brasile con 2.240.796 e
l'Algeria con 2.095.757. La produzione italiana nel 2020 è stata di 677.727
tonnellate, di cui 568.326 da coltivazioni all'aperto e 109.401 da coltivazioni
in serra.
Il frutto dell'anguria è composto per il 91% da acqua e contiene il 6% di
zuccheri. Un ettogrammo di polpa d'anguria cruda produce 30 kcal e contiene
7,55 g di carboidrati,
0,61 g di proteine, 0,4 g di fibre,
0,15 g di grassi e basse quantità di nutrienti essenziali: solo la vitamina C è
presente in un contenuto apprezzabile, pari al 10% del valore giornaliero. Nella
scorza dell'anguria è abbondante l'amminoacido citrullina. E' possibile ottenere
anche un olio di semi di anguria.
Gli agricoltori della regione giapponese di Zentsuji hanno trovato il modo di
coltivare angurie... cubiche, coltivando i frutti in scatole di metallo e vetro e
facendo loro assumere la forma del contenitore La forma cubica è stata
originariamente pensata per rendere i meloni più facili da impilare e
conservare, ma queste "angurie cubiche" possono costare anche il
triplo di quelle normali, quindi si rivolgono principalmente ai ricchi
consumatori urbani. Sono state sviluppate anche stravaganti angurie a forma di
piramide.
Tra gli insetti il più importante parassita dell'anguria è l'afide Aphis
gossypii. Tra le malattie da funghi vi sono l'oidio (causato da Erysiphe
cichoracearum e da Sphaerotheca fuliginea), la peronospora (causata da
Pseudoperonospora cubensis), la muffa grigia (causata da Botrytis cinerea) e il
nerume (causato da Alternaria alternata). Tra le micotossine vi è la patulina. Alcune varietà
coltivate in Giappone e in altre zone dell'Estremo Oriente sono
suscettibili all'appassimento dovuto al fusarium. L'innesto di tali varietà su portainnesti resistenti alle malattie
garantisce una certa protezione.
L'anguria è un frutto dolce, comunemente consumato in estate, solitamente a
fette, tagliato a dadini nelle macedonie o bevuto come succo: il succo di
anguria può essere miscelato con altri succhi di frutta o trasformato in vino.
Scarso è invece il suo impiego per la trasformazione industriale a causa della
bassa conservabilità del frutto, dovuta all'elevato contenuto di zuccheri
fermentescibili. La polpa del frutto presenta un elevato potere diuretico e
depurativo, mentre i semi hanno effetto lassativo.
Un famoso proverbio afferma che "con l'anguria si mangia, si beve e ci si lava
la faccia" per via del suo altissimo contenuto idrico, che sfugge quando lo si
taglia e lo si morde. Ancora oggi a Roma, il giorno di Ferragosto, ci si può
imbattere nei "cocomerari" che vendono le fette al grido di "Taja ch'è rosso!"
Nei paesi tropicali l'anguria si mangia spesso servita su un vassoio assieme ad
altri tipi di frutta, come ananas, mango o papaya.
I semi hanno il sapore di nocciola e possono essere essiccati e tostati o
macinati per dar vita a una farina. Le bucce dell'anguria possono essere mangiate,
perché il
loro sapore sgradevole può essere superato con la marinatura: a volte
sono consumate come verdura, saltate in padella o in umido.
Questo frutto, re del colore e della forma, uno dei più usati anche nell'arte
dell'intaglio, è celebrato in famosi quadri di grandi maestri come Caravaggío o
Matisse. L'anguria è da sempre sinonimo di allegra convivialità. Secondo una
leggenda, per la sua forma a palla, è stato uno dei primi strumenti di gioco
degli dei. Secondo la religione egizia l'anguria nasceva dal seme del dio Seth,
divinità del deserto e dei morti, e perciò il nostro frutto veniva spesso
deposto nelle tombe dei faraoni come per il sostentamento nell'aldilà. I nobili
egiziani lo offrivano agli ospiti in visita quale ristoro dalle fatiche e dalla
sete. Del resto, non è un caso se l'anguria rientra tra i rimpianti degli
Ebrei in fuga dalla schiavitù. Insieme all'abbondanza di pesci, di cetrioli, di
porri, di cipolle e di aglio, pare che, nonostante la manna, anche l'anguria
mancasse ai figli di Israele: quella di Numeri 11,5-6 è l'unica citazione nella
Bibbia riconducibile con buona approssimazione agli "avatichim", ma essi
compaiono in altre fonti ebraiche: le angurie sono infatti citate nella Mishnah
e nel Talmud di Gerusalemme.
Ricordiamo anche l'anguria nera Densuke, una varietà molto singolare coltivata
nella città di Toma, nell'isola settentrionale di Hokkaido, che rappresenta
un'eccellenza giapponese: raggiunge al massimo gli 8 kg ed ha pochi semi; a
causa della sua costante necessità di cure, si ottiene solo una modesta quantità
di frutti l'anno dalla forma sferica (si stima poco meno di 100 esemplari) ma
con un sapore molto dolce e con una polpa croccante di un colore rosso vivido.
Il suo confezionamento richiede una cura particolare: viene infatti inserita in
un'elegante scatola di cartone, insieme ad altre protezioni, per fare in modo
che non subisca ammaccature, e insieme viene incluso il suo certificato di
origine. L'anguria Densuke è considerata un dono per occasioni speciali, e viene
portata come omaggio durante i matrimoni, come augurio buon auspicio in
occasione delle festività, ed è regalata come gesto di riconoscimento per un
favore ricevuto. In passato infatti, la frutta in Giappone assumeva spesso una
connotazione spirituale, e veniva scelta come offerta agli dei. Da qui, la
tradizione di portare un frutto pregiato come ringraziamento a una persona che
ci ha aiutato, o a cui vogliamo bene.
Chiudiamo con la letteratura. In occasione dell'ottantesimo compleanno dello
scrittore russo Lev Tolstoj (1828-1910), il corrispondente del giornale "Kazanskij
telegraf" nel 1908 scrisse parole divenute famose: « Peccato che con Tolstoj non
si possa fare come con un cocomero e tagliarlo a metà, per tenere solo quello
che ci piace e buttare il resto dalla finestra », cioè tenere la metà che ci fa
comodo (l'artista e il romanziere) e buttare via invece lo scomodo pubblicista,
filosofo e teologo: parole ancor oggi attuali in Russia nella recezione della
figura e dell'eredità di Tolstoj, che continua a essere un polo di attrazione e
repulsione, un idolo e un eretico, insomma un forte segno di contraddizione.
Pablo Neruda (1904-1973) scrisse tra l'altro un'"Ode all'Anguria": « L'albero dell'estate /
intenso, / invulnerabile, / è tutto il cielo azzurro, / sole giallo, /
stanchezza a goccioloni... » "Zucchero di cocomero" è un romanzo di Richard
Brautigan (1935-1984) pubblicato nel 1968, che parla di una comunità di tipo
hippy (l'autore lascia intendere che si tratti di una comunità di sopravvissuti
a qualche cataclisma atomico) in cui le cose sono fatte quasi tutte di zucchero
di cocomero. "Dove crescono i cocomeri" è un romanzo di Cindy Baldwin pubblicato
nel 2018, che affronta il tema molto delicato della malattia mentale della madre
della protagonista (il cui padre coltiva per l'appunto angurie in North
Carolina). Infine, nel suo superclassico "Le avventure di Pierino al mercato di
Luino", pubblicato nel 1980, lo scrittore Piero Chiara (1913-1986) racconta le
peripezie di se stesso bambino nel mercato della sua città natale, nelle felici
giornate d'estate sul Lago Maggiore, ed una di queste avventure riguarda proprio
il furto di golosi poponi dalla bancarella di un fruttivendolo!
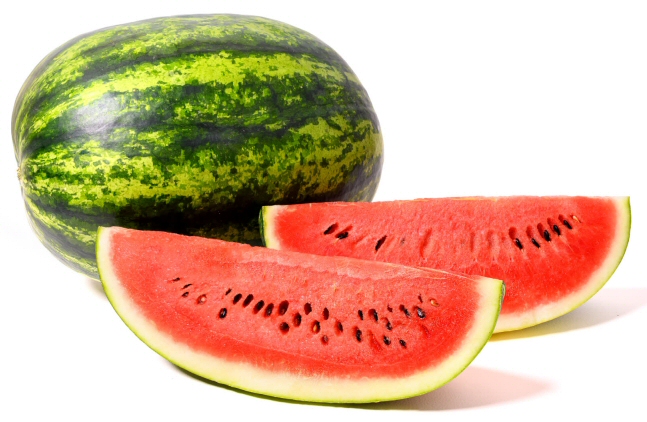
I
legumi dei fumetti
L'arachide
(Arachis hypogaea) è una leguminosa, quindi parente di piselli e fagioli,
coltivata principalmente per i suoi semi commestibili. È ampiamente
coltivata nei tropici e, come la maggior parte degli altri legumi,
ospita batteri simbiotici che fissano l'azoto nei noduli radicali. Ciò implica
che essa richiede meno fertilizzanti contenenti azoto e migliora la fertilità
del suolo, rendendola preziosa nelle rotazioni delle colture, oltre ad
essere importante sia per i piccoli che per i grandi produttori a scopo
commerciale. Le arachidi sono simili per gusto e profilo nutrizionale alle noci
e alle mandorle; ma siccome la definizione botanica di una noce è "un frutto la
cui parete ovarica diventa dura a maturità", l'arachide non è classificata come
una noce, anche se sono spesso considerate come tali per scopi culinari. Inoltre sono adatte alla produzione di
olio. A
differenza della maggior parte delle altre leguminose, i baccelli di arachidi si
sviluppano sottoterra (si parla di "geocarpia") piuttosto che al di sopra del
suolo, e per questo la specie ha ricevuto da Carlo Linneo il nome hypogaea, che
significa "sotto terra". Invece "arachide" deriva dal greco "rhákhis", "spina
dorsale", con il prefisso a- privativo, perché i fiori sono privi di
rachide, l'asse principale di ogni infiorescenza.
E ora, un po' di storia. Il genere Arachis è originario del Sudamerica, a est
delle Ande. Le arachidi coltivate sono nate da un ibrido tra due specie
selvatiche di arachidi, Arachis duranensis e Arachis ipaensis. L'ibrido iniziale
sarebbe stato sterile, ma il raddoppio cromosomico spontaneo ne ha ripristinato
la fertilità, formando quello che in genetica viene definito anfidiploide o
allotetraploide. L'analisi genetica suggerisce che l'ibridazione potrebbe
essersi verificata solo una volta e avrebbe dato origine ad Arachis monticola,
una forma selvatica di arachide che si trova in poche località limitate nel
nordovest dell'Argentina e nel sudest della Bolivia, e poi per selezione
artificiale ad Arachis hypogaea. Il processo di domesticazione attraverso la
selezione artificiale ha reso Arachis hypogaea radicalmente diversa dai suoi
parenti selvatici: le piante domestiche sono più cespugliose, più
compatte, hanno una diversa struttura del baccello e semi più grandi. Dal suo
centro primario di origine la coltivazione si è diffusa in Perù, Ecuador,
Brasile, Paraguay e Uruguay. A poco a poco si sono evolute migliaia di varietà
autoctone di arachidi, classificate in sei varietà botaniche e due
sottospecie. I più antichi resti archeologici conosciuti di baccelli di arachidi
sono stati datati a circa 7.600 anni fa (forse si trattava di una specie
selvatica o di Arachis hypogaea nella prima fase della domesticazione) e sono
stati trovati in Perù, dove le condizioni climatiche secche sono favorevoli alla
conservazione del materiale organico. Quasi certamente la coltivazione
dell'arachide è anteriore a questa data nel centro di origine, dove il clima è
più umido. Molte culture precolombiane, come i Moche, raffiguravano le
arachidi nelle loro opere d'arte. All'arrivo degli spagnoli i conquistadores
trovarono in vendita nel mercato della capitale azteca Tenochtitlan il tlalcacahuatl (il nome nahuatl della pianta, da cui il nome in
spagnolo "cacahuete" e il primo nome italiano, "cacaoetti", oggi non più in uso). I commercianti
spagnoli hanno successivamente diffuso le arachidi in tutto il mondo
(ecco perchè in Italia erano chiamate anche "spagnolette"!) e la
coltivazione è ora diffusa in tutte le regioni tropicali e subtropicali. In
Africa occidentale ha sostanzialmente sostituito una pianta coltivata della
stessa famiglia, l'Arachis bambara; in Asia è diventato un pilastro agricolo, e
quel continente è ora il più grande produttore al mondo di arachidi. La
produzione annuale mondiale di arachidi sgusciate nel 2016 è stata di 44 milioni
di tonnellate; il primo
produttore oggi è la Cina (con il 38% del totale mondiale!), seguita da India, Nigeria, Stati Uniti e Sudan. La
coltivazione delle arachidi ha assunto particolare importanza negli Stati Uniti,
passando da pianta da giardino a foraggio per animali fino a quando il consumo
umano non è esploso negli anni '30; il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati
Uniti ha avviato un programma per incoraggiarne la produzione agricola tra la
fine del XIX e l'inizio del XX secolo, tanto che in italiano sono note anche
come "noccioline americane" per antonomasia. Il burro di arachidi è stato inventato
negli anni 1880 e 1890 proprio negli Stati Uniti e in Canada.
Le arachidi possono essere tostate con il guscio o sgusciate, anche in un forno
domestico se stese in una padella e cotte a una temperatura di 177 °C per 15-20
minuti (sgusciate) e 20-25 minuti (nel guscio). Le arachidi bollite sono uno
spuntino popolare in India, Cina, Africa occidentale e Stati Uniti meridionali.
L'olio di arachidi è spesso usato in cucina perché ha un sapore delicato e un
punto di fumo relativamente alto. A causa del suo alto contenuto di grassi
monoinsaturi, è considerato più salutare degli oli saturi ed è resistente
all'irrancidimento. Invece il burro di arachidi è una crema spalmabile a base di
arachidi tostate a secco e macinate; spesso contiene ingredienti aggiuntivi che
modificano il gusto o la consistenza, come sale, dolcificanti o emulsionanti.
Esso viene servito spalmato su pane o toast e utilizzato per preparare panini,
ma anche in una serie di dolciumi, come le barrette di cereali. Gli
statunitensi spendono la bellezza di 800 milioni di dollari in burro di arachidi
all'anno, e il suo abuso nella dieta è uno dei responsabili della piaga
dell'obesità in America (da un rapporto medico del 2021 risulta che il 31,1%
degli adulti statunitensi è sovrappeso, il 42,5% è obeso e il 9% ha un'obesità
grave). Alcuni (lo 0,6% della
popolazione degli Stati Uniti, per esempio) riferiscono di avere avuto reazioni
allergiche in seguito al consumo di arachidi; i sintomi possono essere
particolarmente gravi e possono andare dalla forte lacrimazione allo shock
anafilattico, che è generalmente fatale se non trattato tempestivamente.
Peraltro, a causa del loro uso diffuso negli alimenti preparati e confezionati,
evitare le arachidi può essere difficile, ed è importante leggere con cura gli
ingredienti e le avvertenze sulle etichette dei vari prodotti. E non è tutto. Se
le piante di arachidi sono soggette a grave siccità durante la formazione dei
baccelli, o se i baccelli non vengono conservati correttamente, possono essere
contaminati dalla muffa Aspergillus flavus, che può produrre sostanze
cancerogene chiamate aflatossine. Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati
Uniti testa ogni camion carico di arachidi crude per l'aflatossina; quelli
contenenti livelli di aflatossina superiori a 15 parti per miliardo vengono
distrutti.
Ma attenzione a mettere le noccioline americane sul banco degli imputati perché,
se consumate con la debita moderazione, le arachidi possiedono diverse proprietà
benefiche per la salute: abbassano il rischio cardiovascolare, riducono il
rischio di cancro, contrastano l'ipercolesterolemia, promuovono la salute del
sistema nervoso e della pelle e promuovono la salute del feto e della donna in
gravidanza. Inoltre, possono aiutare a combattere efficacemente la malnutrizione
nei paesi poveri, essendo la base di farine e bevande ad alto contenuto
proteico, energetico e di nutrienti, sviluppate per essere utilizzate come
alimento terapeutico per alleviare le carestie nei paesi del Quarto Mondo.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'UNICEF, il Progetto Peanut Butter e Medici Senza Frontiere hanno utilizzato e
raccomandato questi prodotti per aiutare a salvare i bambini malnutriti nei
paesi in via di sviluppo; e ciò dimostra una volta per tutte che non vi sono alimenti buoni o
cattivi. Buono o cattivo è l'uso che l'Homo sapiens ne fa!
Com'è noto a chi bazzica il mondo dei fumetti, è proprio ingoiando intere delle
speciali spagnolette dal guscio indistruttibile che l'imbranato e giuggiolone
Pippo (Goofy nell'originale inglese), spalla comica di Topolino, diventa
l'invincibile Super Pippo (Super Goof negli USA), creato come evidente parodia
di Superman da Del Connell, Bob Ogle e Paul Murry e comparso per la prima volta
nell'ottobre 1965 (in Italia su "Topolino" n° 540 del 3 aprile 1966): il goffo
supereroe indossa un pigiama come costuma, conserva le arachidi miracolose
dentro il cappello, e per attivare la supervista a raggi X manovra una delle sue
lunghe orecchie come se fosse una manopola.
Infine, chi non conosce i Peanuts? I famosi bambini terribili guidati dal saggio
e timidissimo Charlie Brown, creati nel 1950 dal grande Charles M. Schultz
(1922-2000), vennero chiamati "Peanuts" ("Arachidi", letteralmente
"noci-piselli") dal loro editore perché tale termine indicava a teatro la
sezione con i posti più economici, e a volte era usato per indicare un pubblico
composto da bambini; in realtà il loro autore avrebbe voluto chiamarli "Li'l
Folks" (letteralmente "personcine" in slang americano), ma tale nome fu bocciato
per eccessiva assonanza con altre strisce quotidiane a fumetti ("Li'l Abner" di
Al Capp e "Little Folks" di Tack Knight). Schulz ha disegnato ininterrottamente
le loro strisce per 50 anni, senza avvalersi di assistenti, nemmeno per i testi
e la colorazione; praticamente smise solo pochi giorni prima di morire, e chiese
nel suo testamento che la serie non venisse continuata da altri disegnatori.
Grazie, Charles, per averci regalato delle "Arachidi" così sagge!

Il
regalo di Athena
Il nome dell'ulivo deriva dal latino
olīvum, e quindi da oleum, a sua volta dal greco arcaico ἔλαιϝον (élaiwon) e dal
greco classico ἔλαιον (élaion). La forma "ulivo", come anche "uliva", è più
frequente in Toscana; la forma "olivo", del tutto prevalente nella letteratura
scientifica, è tipica del Veneto, di parte della Sardegna, dell'Emilia-Romagna e
del Lazio settentrionale; nel Sud prevalgono termini dialettali. L'ulivo è un
albero sempreverde la cui attività vegetativa è pressoché continua, ha crescita
lenta ed è molto longevo: in condizioni climatiche favorevoli può diventare
millenario e arrivare ad altezze di 15-20 metri. Un ulivo a Mouriscas, in
Portogallo, ha un'età stimata di 3.350 anni, e quindi fu piantato
approssimativamente all'inizio dell'Età del bronzo! La pianta comincia a
fruttificare dopo 3-4 anni dall'impianto, inizia la piena produttività dopo 9-10
anni e la senescenza è raggiunta dopo i 40-50 anni; a differenza della maggior
parte degli altri alberi da frutta, la produzione non diminuisce negli alberi
molto anziani. Il fusto è cilindrico e contorto, con corteccia di colore grigio
o grigio scuro e legno duro e pesante. Le foglie sono opposte, coriacee,
ellittico-lanceolate, con picciolo corto e margine intero, spesso ripiegato. La
pagina inferiore è di colore bianco-argenteo per la presenza di peli
squamiformi; la parte superiore invece è di colore verde scuro. Il fiore
ermafrodito è piccolo, con calice di quattro sepali e una corolla di petali
bianchi. I fiori sono raggruppati in infiorescenze a grappolo, chiamate
"mignole", e crescono nell'ascella delle foglie dei rametti dell'anno
precedente. La fioritura avviene, secondo le cultivar e le zone, da maggio alla
prima metà di giugno. Il frutto è propriamente una drupa globosa, a volte
asimmetrica, formata da una parte "carnosa" (polpa) che contiene l'olio e dal
nocciolo legnoso e rugoso. Il peso del frutto varia tra 1 e 6 grammi a seconda
della specie. Ottobre-dicembre è il periodo della raccolta, da olio o da mensa.
I cinque Paesi con la maggiore superficie olivicola sono la Spagna (2,24 milioni
di ettari), la Tunisia (1,62 milioni), l'Italia (1,15 milioni), la Turchia (0,9
milioni), la Grecia (0,73 milioni). I primi cinque Paesi produttori di olio di
oliva sono la Spagna, l'Italia, la Grecia, la Tunisia e la Turchia, ma le
tendenze attuali vedono una forte espansione dell'olivicoltura in Marocco,
Sudafrica e Australia.
E ora, un po' di storia. Le prove fossili indicano che
l'olivo ha avuto origine 30 milioni di anni fa nell'Oligocene, in quello che
oggi corrisponde all'Italia e al bacino del Mediterraneo orientale. Già 100.000
anni fa le olive venivano consumate dagli esseri umani in Africa, sulla costa
atlantica del Marocco; gli ulivi selvatici, o oleastri, erano presenti e
raccolti nel Mediterraneo orientale fin da 19.000 anni fa. Foglie fossilizzate
di ulivo sono state trovate nei paleosuoli dell'isola vulcanica di Santorini
(Mar Egeo) e datate a circa 37.000 anni fa. Sulle foglie sono state trovate
impronte di larve di mosca bianca dell'olivo; lo stesso insetto si trova
comunemente oggi sulle foglie di ulivo, a dimostrazione del fatto che le
relazioni coevolutive pianta-insetto non sono cambiate da allora. Il genoma
delle olive coltivate riflette la loro origine dalle popolazioni di oleastri nel
Mediterraneo orientale. Si pensa che la pianta dell'ulivo sia stata coltivata
per la prima volta circa 7.000 anni fa nelle regioni mediterranee. Per migliaia
di anni gli ulivi sono stati coltivati principalmente per l'olio delle lampade,
con scarso interesse per il sapore e l'uso culinario. Già nel 3.000 a.C. le
olive venivano coltivate a Creta, come dimostrano noccioli di olive e frammenti
di legno trovati in antiche tombe: potrebbero essere stati una delle fonti di
ricchezza della civiltà minoica.In Egitto questi rami di ulivo importati da
Creta assunsero significati rituali, infatti sono raffigurati come offerte sul
muro del tempio di Aton e vennero usati per realizzare le ghirlande trovate
nella tomba di Tutankhamon. L'ulivo era una delle poche coltivazioni che
prosperavano nei suoli sassosi e montagnosi della Grecia, dove il grano non
attecchiva; per questo i Greci iniziarono una serie di ondate migratorie che li
portarono in Asia Minore, in Magna Grecia e in tutto il bacino del Mediterraneo,
alla ricerca di terre coltivabili a grano, dove esportarono anche la
coltivazione degli ulivi. Per questo l'ulivo è una pianta centrale nella storia
delle civiltà che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, e d conseguenza di
tutto l'Occidente. Nell'antica Grecia l'ulivo era considerato un albero sacro, a
tal punto che Aristotele, nella "Costituzione degli Ateniesi", affermava che
chiunque veniva sorpreso a maltrattare un ulivo, veniva punito con l'esilio.
Secondo Plinio il Vecchio, al centro del Foro Romano crescevano una vite, un
fico e un ulivo (l'orto è stato ricreato nel XX secolo. Il poeta romano Orazio
lo menziona in riferimento alla propria dieta, che descrive come molto semplice:
"Quanto a me, le olive, le indivie e le malva liscia forniscono sostentamento".
Vitruvio nel suo "De Architectura" descrive l'uso del legno di ulivo
carbonizzato per legare insieme muri e fondamenta. Gli antichi Romani non
usavano il sapone, considerato un costoso cosmetico: nelle loro terme, sorte
come funghi in tutto l'Impero, si ungevano il corpo d'olio e poi lo raschiavano
via insieme allo sporco. La cultura dell'olio di oliva è giunta sino a noi,
attraverso il Medioevo, per opera di alcuni ordini religiosi, fra cui in
particolare i Benedettini ed i Cistercensi. I Benedettini, devoti alla regola
della preghiera e del lavoro, persuadevano contadini ed operai agricoli a non
abbandonare le terre ma a dedicarsi a colture redditizie quali l'olivo. Il
grande animatore dei Cistercensi fu Bernardo Chiaravalle, detto "l'ultimo dei
padri della Chiesa", i cui monaci insegnarono ai contadini, provati dallo stato
di semischiavitù in cui si trovavano, a dissodare i campi, a piantare colture da
reddito, a rendersi indipendenti come fattori di produzione. Non si videro mai
tanti oliveti e vigne come dal Mille al Quattrocento, gli anni d'oro dei monaci
Benedettini e Cistercensi. I coloni spagnoli portarono l'ulivo nel Nuovo Mondo,
dove la sua coltivazione prosperò in Perù, Cile e Argentina; le prime piantine
dalla Spagna furono piantate a Lima da Antonio de Rivera nel 1560. La
coltivazione dell'ulivo si diffuse rapidamente lungo le valli dell'arida costa
del Pacifico del Sud America, dove il clima era simile a quello mediterraneo,
poi i missionari spagnoli del XVIII secolo portarono l'albero in California,
dove parimenti trovò il clima ideale: fu coltivato per la prima volta nella
Missione San Diego de Alcalá nel 1769, e l'ulivicoltura divenne gradualmente
un'impresa commerciale di grande successo dal 1860 in poi. In Giappone, la prima
piantagione riuscita di ulivi avvenne nel 1908 sull'isola di Shodo, che divenne
la culla della coltivazione dell'olivo in Giappone. Nel 2016 è iniziata la
produzione di olio d'oliva in India, con alberelli di ulivo piantati nel deserto
del Thar nel Rajasthan. A causa del riscaldamento climatico in corso, nel 21°
secolo sono state stabilite con successo numerose aziende agricole di produzione
di olive su piccola scala a latitudini piuttosto elevate in Europa e Nord
America. Si stima che nel 2005 nel mondo ci fossero circa 865 milioni di ulivi,
la stragrande maggioranza dei quali nei paesi del Mediterraneo!
La
simbologia connessa all'ulivo è ricchissima e antichissima. L'olio d'oliva è
stato a lungo considerato sacro, e tutti i popoli hanno sempre considerato
questa pianta un simbolo della pace, di gloria e di abbondanza. Le fronde
dell'ulivo venivano offerte ritualmente alle divinità e ai potenti come emblemi
di benedizione e purificazione, e venivano utilizzate per incoronare i vincitori
di gare atletiche e di guerre sanguinose. Sull'ulivo si narrano numerose
leggende. Set, terzo figlio di Adamo, avrebbe piantato sulla tomba del padre tre
semi provenienti dal Giardino di Eden, da cui sarebbero germinati un albero di
ulivo, uno di cedro e uno di cipresso. La colomba, per annunciare a Noè la fine
del diluvio universale, gli portò un ramoscello d'ulivo che teneva stretto nel
becco, e da quel momento l'ulivo assunse un duplice significato: diventò il
simbolo della rinascita, perché, dopo la distruzione operata dal Diluvio, la
terra tornava a fiorire; ma diventò anche simbolo di pace perché attestava la fine
del castigo e la riconciliazione di Dio con il genere umano. Omero cita l'ulivo
varie volte nell'Iliade e nell'Odissea. I ciclopi avevano bastoni e clave fatti
col legno d'ulivo. Anche Odisseo ricavò, dal tronco di un grosso ulivo, il palo
che conficcò nell'occhio di Polifemo, e Penelope ottiene la prova definitiva che
lo sterminatore dei Proci era in effetti suo marito perchè sapeva che il loro
letto nuziale non si poteva spostare da una stanza all'altra, essendo stato
ricavato dallo stesso Odisseo da un enorme ceppo d'ulivo. Quando Cecrope, metà
uomo e metà serpente, fondò una nuova città nell'Attica, si proposero come
patroni della nuova città sia Poseidone che Athena. Il primo offrì in dono a
Cecrope il cavallo, la seconda l'ulivo. L'antico re scelse la seconda, e per
questo la città si chiamò Atene; fino al 2001 sulle monete italiane da 100 lire
(ricordate?) era infatti raffigurata la dea Athena vicino ad un alberello
d'ulivo, suo albero sacro. Secondo Teofrasto, il padre della botanica (IV
secolo a.C.), lo stesso ulivo di Atena cresceva ancora sull'Acropoli, e vi si
trovava ancora nel II secolo d.C. (del resto gli ulivi sono assai longevi).
Secondo la tradizione i gemelli Romolo e Remo vennero allattati dalla lupa sotto
un ulivo. Per i Giudei l'ulivo era simbolo della giustizia e della sapienza: nel
Primo Libro dei Re, Salomone, durante la costruzione del Tempio di Gerusalemme,
« fece due cherubini di legno d'olivo, alti dieci cubiti… fece costruire la
porta della cella con battenti di legno d'olivo… lo stesso procedimento adottò
per la porta della navata, che aveva stipiti di legno d'olivo » (1Re 6,31-33).
Gli antichi re di Israele (ma anche della Mesopotamia e della Siria) venivano
"unti" con l'olio santo, da cui il titolo di Messia ("Unto"), in greco reso con
la parola "Cristo" (da cui Cristiani). L'oliva è elencata in Deuteronomio 8,8
come una delle sette specie prodotte in abbondanza dalla Terra d'Israele, e
secondo l'Halakha, la legge rabbinica obbligatoria per tutti gli ebrei, l'olio
d'oliva è l'olio più consigliato e migliore possibile per l'accensione delle
candele dello Shabbat. Nel libro del profeta Osea il Dio di Israele è
addirittura paragonato alla magnificenza dell'ulivo. Nella Domenica delle Palme
Gesù fu ricevuto calorosamente dalla folla che agitava foglie di palma e
ramoscelli d'ulivo; nell'Orto degli Ulivi egli trascorse le ultime ore prima
della Passione. L'olio d'oliva usato nelle liturgie cristiane prende il nome di
Crisma; viene utilizzato nei sacramenti del battesimo, dell'estrema unzione,
della confermazione e dell'ordinazione dei nuovi sacerdoti. Molti di noi hanno
in casa un ramoscello di ulivo benedetto la Domenica delle Palme. L'allegoria
dell'Ulivo nella Lettera di San Paolo ai Romani si riferisce alla dispersione e
al raduno di Israele, paragonando gli Israeliti a un ulivo domestico e i Gentili
a un ramoscello di ulivo selvatico. L'olivo e l'olio d'oliva sono menzionati
sette volte nel Corano, e l'oliva è lodata come un frutto prezioso. Si dice che
Maometto abbia detto: "Prendi olio d'oliva e massaggialo, è un albero
benedetto". Le olive sostituiscono i datteri (se non disponibili) durante il
digiuno del Ramadan, e le foglie di ulivo sono usate come incenso in alcuni
paesi musulmani del Mediterraneo. A Creta, il giorno del loro matrimonio, gli
sposi piantano un albero di ulivo poiché si crede che, in tal modo, il loro
amore crescerà vigoroso e immarcescibile e darà molti frutti. Quando i coniugi
muoiono, i figli legano attorno al suo tronco un drappo bianco in segno di
lutto. "L'Ulivo" era il nome della coalizione con cui Romano Prodi sconfisse
Silvio Berlusconi alle elezioni politiche del 1996, permettendo poi l'ingresso
dell'Italia nell'euro fin dal 1999, e un ramo di ulivo è presente nello stemma
della nostra Repubblica Italiana. Anche il celebre stemma degli Stati Uniti,
utilizzato per la prima volta nel 1782, raffigura un'aquila che stringe un
ramoscello d'ulivo in uno dei suoi artigli, a indicare il potere della pace. Due
ramoscelli d'ulivo compaiono parimenti nella bandiera bianca di Cipro greca,
sotto il profilo dell'isola color del rame. La bandiera delle Nazioni Unite
adottata il 30 ottobre 1947 rappresenta una mappa del mondo in proiezione
azimutale centrata sul Polo Nord, circondata da due rami di ulivo; gli odierni
terrapiattisti credono erroneamente che essa sia una prova del fatto che i
fondatori dell'ONU ritenessero la terra piatta (che grulli!) Anche
nell'immaginaria bandiera della Federazione Unita dei Pianeti nel franchise di
"Star Trek" appare un globo stellato compreso tra due rami di ulivo, simbolo di
pace e di armonia. Io ho un bell'ulivo
nel mezzo del mio giardino, ma non è mai stato innestato e produce olive amare;
io comunque lo tengo come albero ornamentale, circondato dalla nuvola del suo
ricco apparato simbolico!

In
quest'eccezionale pareidolia le nodosità di un tronco
di ulivo ricordano le mani di Dio, protese verso la Terra!
Il
frutto che in realtà è
un'infiorescenza
Dopo l'ulivo, restando in tema di citazioni evangeliche, passiamo
al fico, oggetto di una famosa maledizione da parte
di Gesù. Si tratta del frutto commestibile del Ficus carica, un piccolo albero
della famiglia delle Moraceae, originaria della regione mediterranea. Viene
coltivato fin dall'antichità ed è oggi ampiamente diffuso in tutto il mondo, sia
per i suoi frutti che come pianta ornamentale. Il genere Ficus contiene oltre
800 specie di piante tropicali e subtropicali! La pianta di fico può crescere
fino a 7 metri di altezza, con corteccia bianca liscia e grandi foglie che
presentano da tre a cinque grandi lobi. Quello che noi consideriamo il suo
frutto è in realtà un'infiorescenza molto particolare, tanto da ricevere un nome
scientifico apposito: siconio. Ha forma di lacrima, lunga da 3 a 5 cm, di
colore variabile dal verde al rossiccio fino al bluastro-violaceo; è cava, e al
suo interno sono racchiusi i fiori unisessuali, piccolissimi; una piccola
apertura apicale, detta ostiolo, consente l'entrata degli insetti pronubi. I
veri frutti, che si sviluppano all'interno dell'infiorescenza (che diventa
perciò un'infruttescenza), sono numerosissimi piccoli acheni. La polpa che
circonda i piccoli acheni è succulenta e dolce, e costituisce la parte
commestibile. La linfa lattiginosa delle parti verdi è irritante per la pelle
umana. Nell'emisfero settentrionale i fichi freschi sono di stagione dalla fine
dell'estate all'inizio dell'autunno; tollerano il gelo stagionale moderato e
possono essere coltivate anche nei climi continentali dalle estati caldi. I
fichi possono essere consumati freschi o essiccati, oppure trasformati in
marmellate, panini, biscotti e mille altri tipi di dolci. Poiché la frutta
matura non si conserva a lungo e deperisce i fretta, la maggior parte della
produzione commerciale viene essiccata o trasformata. I fichi crudi contengono
circa l'80% di acqua e il 20% di carboidrati, e sono una fonte moderata di
fibre alimentari. Nel 2018 la produzione mondiale di fichi crudi è stata di 1,14
milioni di tonnellate, guidata da Turchia, Egitto, Marocco e Algeria. In alcune
antiche medicine popolari mediterranee, la linfa lattiginosa della pianta del
fico veniva utilizzata per ammorbidire i calli, rimuovere le verruche e
scoraggiare i parassiti. Il cosiddetto "prurito del droghiere" è una irritazione
cutanea caratterizzata da una dermatite pruriginosa che si verifica entrando in
contatto con acari come Carpoglyphus passularum (un acaro della frutta), di
solito maneggiando datteri, prugne e, appunto, fichi.
L'etimologia della parola
"fico" è discussa. Secondo alcuni il latino "ficus" deriva dal greco "sykon",
termine usato dagli antichi Elleni per indicare il frutto, dal fenicio "pequ", e
questo dal precedente accadico "pīqu" o "sīqu", "fessura", termine attestato fin
dal 2300 a.C. per indicare l'organo sessuale femminile, evidentemente per
somiglianza di aspetto (da qui deriverebbe anche il termine volgare "fica" o "figa").
Secondo altri invece "ficus" deriva dal greco "Phiyo", "produco", per via della
sua fecondità, o dall'ebraico "phag", più o meno con lo stesso significato; ma
anche in questo caso il verbo "produco" potrebbe invece riferirsi ai figli. In
ogni caso, i riferimenti letterari alla connotazione sessuale del frutto del
fico sono numerosissimi: ad esempio la dea mesopotamica Ishtar secondo il mito
assunse la forma del fico divino Xikum, "la madre primordiale al centro della
terra", protettrice del dio Dumuzi o Tammuz, anch'esso divinità della fertilità
maschile; e il termine indicante il fico è usato come sinonimo dell'attributo
genitale femminile già da Aristotele. Alcuni frutti fossili di Ficus
potentilloides, una specie estinta del Miocene inferiore, sono stati trovati
nella miniera di Kristina a Hrádek nad Nisou, nella Boemia settentrionale, e
questi fossili sono in tutti simili ai frutti di Ficus carica. Il fico è stata
una delle prime piante coltivate dall'uomo: nove fichi fossili risalenti al 9200
a.C. sono stati trovati nel villaggio neolitico di Gilgal nella Valle del
Giordano, 13 km a nord di Gerico. Questa datazione precede di mille anni la
domesticazione del grano, dell'orzo e dei legumi, e potrebbe quindi essere il
primo esempio noto di agricoltura! Secondo una leggenda induista il dio Visnù
sarebbe nato sotto un fico. I fichi erano molto diffusi nell'antica Grecia, e la
loro coltivazione è stata descritta sia da Aristotele che da Teofrasto, il padre
della botanica. Aristotele notò che, come nei sessi degli animali, i fichi hanno
individui di due tipi, il fico coltivato che porta frutti, e il caprifico
selvatico che permette all'altro di portarli. I fichi erano anche un cibo comune
per i Romani. Catone il Censore nel suo "De Agri Cultura" (160.C.), prima opera
della letteratura latina giunta integralmente a noi, elenca diversi ceppi di
fichi coltivati all'epoca in cui scrisse il suo manuale: il Marisco, l'Africano,
l'Ercolano, il Saguntino e il Tellanio nero. I fichi lavorati con il miele erano
considerati una leccornia sulle tavole dei ricchi. I frutti venivano utilizzati
inoltre per ingrassare le oche per la produzione di un precursore del patè. Si
diceva che il primo imperatore romano, Augusto, fosse stato avvelenato dalla
moglie Livia Drusilla con i fichi del suo giardino nei quali era stato iniettato
del veleno quando erano ancora acerbi, onde agevolare la salita al trono di suo
figlio Tiberio. Il fico nel Medioevo veniva coltivato dall'Afghanistan al
Portogallo; nel 1769 i missionari spagnoli guidati da Junipero Serra
(1713-1784), canonizzato nel 2015 da Papa Francesco, portarono i primi fichi in
California dove la varietà Mission, da loro coltivata, è ancora oggi
popolare. La cultivar Kadota è la più antica ancora coltivata, citata dal
naturalista romano Plinio il Vecchio che nella "Naturalis Historia" registra
trenta varietà di fichi.
Anche il fico è uno degli alberi con la simbologia più
ricca, risalente addirittura all'era dei cacciatori-raccoglitori del Paleolitico
ed al culto dell'antica Dea Madre. Nella Genesi, dopo aver disobbedito ed
essersi accorti di essere nudi, Adamo ed Eva si coprirono intrecciando foglie di
fico (Genesi 3,7): un'evidente allusione al fatto di aver scoperto la sessualità
e le sue deviazioni peccaminose dopo aver mangiato il frutto dell'albero della
conoscenza del bene e del male. Allo stesso modo, le foglie di fico sono state a
lungo utilizzate per coprire i genitali di figure nude in pittura e scultura, ad
esempio nella "Cacciata dal giardino dell'Eden" di Masaccio. Inoltre, secondo l'Aggadah
(raccolta di testi omiletici del Talmud), lo stesso frutto proibito dell'Albero
della Conoscenza nel Giardino dell'Eden non era una mela, ma un fico, lasciando
intendere che il peccato di Adamo e di Eva non fosse legato alla gola, ma alla
lussuria. Il libro del Deuteronomio (8,7-8) dice che il fico era una delle sette
specie di piante citate per illustrare la fertilità della terra di Canaan: si
tratta di sette piante originarie del Medio Oriente che possono fornire cibo
tutto l'anno, e l'elenco è organizzato per data di raccolta, con il fico al
quarto posto a causa della maturazione del suo raccolto principale durante
l'estate. La citazione biblica "ciascuno sotto la sua vite e il suo fico" (Michea
4,4) è stata usata per denotare pace e prosperità, tanto che era comunemente
usata per riferirsi alla vita che sarebbe stata condotta dai coloni nel West
americano, ma anche da Theodor Herzl, il fondatore del sionismo, nella sua
rappresentazione della futura patria ebraica: « Il nostro scopo è menzionato nel
Primo Libro dei Re: "Giuda e Israele abiteranno al sicuro, ciascuno sotto la
propria vite e il proprio fico, da Dan a Beersheva". » Il presidente degli Stati
Uniti George Washington, scrivendo nel 1790 alla sinagoga di Newport, nel Rhode
Island, usò la medesima metafora per assicurare l'uguaglianza di tutti i
cittadini americani di fronte alla legge, indipendentemente dalla loro fede. La
Sura 95 del Corano è chiamata al-Tīn (in arabo "Il fico"), poiché si apre con il
giuramento "Per il fico e l'oliva". Si dice che il Profeta Maometto andasse
matto per i fichi, e la raccolta di massime "Sahih al-Bukhari" (IX secolo) mette
in bocca a Maometto quest'affermazione: « Se dovessi menzionare un frutto che è
disceso dal paradiso, direi che il fico è uno di essi perché i frutti
paradisiaci non hanno noccioli [...] Mangia da questi frutti perché prevengono
le emorroidi e combattono la gotta. »
Il celebre racconto della maledizione del
fico si trova nel Vangelo di Marco 11,12-25 e in quello di Matteo 21,18-22,
mentre Luca lo sostituisce con la parabola del fico sterile (Lc 13,6-9) e
Giovanni lo omette completamente. Nell'apocrifo Vangelo dell'Infanzia di Tommaso
(3,2) Gesù dice: «...ecco, anche tu ora sarai seccato come un albero, e non
porterai foglie, né radici, né frutti ». La maggior parte degli esegeti ritiene
che Marco (il primo vangelo messo per iscritto e utilizzato come fonte da Matteo
e Luca) usi la maledizione del fico sterile come metafora del Tempio di
Gerusalemme: Gesù e i suoi discepoli sono in cammino verso Gerusalemme quando
Gesù maledice un fico perché non dà frutti; a Gerusalemme il Redentore scaccia
dal tempio i cambiavalute; e la mattina dopo i discepoli scoprono che il fico è
appassito ed è morto, con il messaggio implicito che il tempio è maledetto e
appassirà perché, come il fico, non è riuscito a produrre il frutto della
giustizia. Infatti in 13,28 Marco fa usare di nuovo a Gesù l'immagine del fico
per rendere chiaro che Gerusalemme cadrà e la nazione giudaica sarà dispersa
prima che la generazione allora vivente sia estinta. Invece secondo Matteo il
fico appassisce subito dopo che la maledizione è stata pronunciata, portando
avanti la narrazione fino all'incontro di Gesù con Scribi e Farisei e la sua
maledizione contro di loro e contro il Tempio. Gesù risponde alle espressioni di
stupore dei discepoli con un breve discorso sulla fede e sulla preghiera, e in
Matteo 24,32-35 il secondo Evangelista segue da vicino Marco nel presentare la
parabola dell'albero come segno della venuta certa del Figlio dell'Uomo.
Nell'Apocalisse di Giovanni (6,12-13) è scritto: « Quando l'Agnello aprì il
sesto sigillo, vidi che vi fu un violento terremoto. Il sole divenne nero come
sacco di crine, la luna diventò simile al sangue, e le stelle del cielo si
abbatterono sopra la terra come quando un fico, sbattuto dalla bufera, lascia
cadere i fichi immaturi. » Famosa è poi una citazione di Dante Alighieri: « Rispuose
adunque: "I' son frate Alberigo; / i' son quel da le frutta del mal orto, / che
qui riprendo dattero per figo." » (Inferno XXIII,119-121) Significa "qui ricevo
una punizione assai maggiore della mia colpa, così come il dattero è più dolce
del fico". La parola "fico" si usa in varie locuzioni popolari: "serbare la
pancia ai fichi", cioè evitare i pericoli, avendo cara la pelle; "fare fico",
non riuscire in un'impresa; "t'ho conosciuto fico!", a una persona che si dà
grandi arie ed è venuta dal nulla; "non me ne importa un fico" o "un fico
secco", cioè non me ne frega niente; "fare le nozze coi fichi secchi", cioè,
fare in forma dappoco cosa che dovrebbe essere solenne. Anche la celeberrima
espressione "sei un figo!", tanto cara al linguaggio giovanile, è stata
associata al fico in quanto oggetto simbolico dell'appetito sessuale altrui,
anche se per alcuni linguisti andrebbe invece ricondotta ad una storpiatura
romanesca dell'aggettivo italiano "efficace". Chissà chi ha ragione.

L'albero di Granada, o forse no
Ora ho deciso di parlarvi del melograno
(Punica granatum), un arbusto deciduo fruttifero della famiglia delle Litracee, di
cui un tempo avevo un esemplare nel mio giardino. Il nome melograno deriva dal
latino medievale pomum, "mela", e granatum, "con semi". Forse derivante
dall'antica parola francese per il frutto, pomme-grenade, il melograno era
conosciuto nel medioevo come "mela di Granada", un termine che oggi sopravvive
solo nei blasoni araldici. Questa però è una paretimologia popolare, che
confonde il latino "granatum" con il nome della città spagnola di Granada, il
quale deriva invece dall'arabo"collina degli stranieri". Secondo altri "granade"
deriva dal francese antico "grenat" per metatesi dal latino medievale "granatum",
"di colore rosso scuro", per descrivere il colore della polpa del melograno. Il
nome della melagrana nell'antico egiziano era "rmn" (le vocali sono congetturali
perchè non venivano scritte), da cui derivano l'ebraico rimmôn e l'arabo rummân.
Dall'arabo il termine passò ad altre lingue, come il portoghese (romã) e il
maltese (rummien).
Il melograno è originario dell'Asia sudoccidentale, ma è
presente dall'epoca preistorica nell'area costiera del Mediterraneo: è probabile
che vi sia stato diffuso dai Fenici, dai Greci, dai Romani e in seguito dagli
Arabi. Fu di sicuro uno dei primi alberi da frutto ad essere coltivati nel
Mediterraneo. L'esocarpo carbonizzato del frutto è stato identificato nei
livelli della prima età del bronzo di Gerico, ma anche a a Cipro e Tirinto. Una
grande melagrana secca è stata trovata nella tomba di Djehuty, il maggiordomo
della regina Hatshepsut (XVIII Dinastia, 1478-1458 a.C.); i documenti cuneiformi
mesopotamici menzionano melagrane dalla metà del terzo millennio a.C. in
poi. Nell'iconografia la melagrana fa le sue prime apparizioni nel IV millennio
a.C. in Mesopotamia, a Uruk e a Susa. Resti di melograno impregnati d'acqua sono
stati identificati nelle navi naufragate presso Uluburun intorno al XIV secolo
a.C. al largo della costa della Turchia. Altri reperti sulla nave includono
profumi, avorio e gioielli d'oro, suggerendo che i melograni a quell'epoca
fossero considerati un bene di lusso. Altri ritrovamenti archeologici di resti
di melograno della tarda età del bronzo sono stati trovati principalmente in
residenze signorili, a sostegno di questa ipotesi. Kandahar è famosa in
Afghanistan per i suoi melograni di alta qualità. Sebbene non sia originario
della Corea o del Giappone, il melograno vi è ampiamente coltivato e vi sono
state sviluppate molte cultivar. E' molto utilizzato per i bonsai per via dei
suoi fiori e per l'insolita corteccia contorta degli esemplari più vecchi. Fu
introdotto in America latina dai colonizzatori spagnoli nel 1769, ed è
attualmente coltivato ampiamente in Messico e negli Stati Uniti d'America. Il
nome latino Punica deriva infatti dal nome romano della regione costiera della
Tunisia, e è sinonimo di cartaginese; le piante furono così nominate perché a
Roma i melograni giunsero da quella regione. La pianta può raggiungere i 5-6
metri di altezza e vivere anche oltre 100 anni, è un piccolo albero o un arbusto
con portamento cespuglioso. Ha una forte tendenza a produrre polloni radicali e
a costituire una boscaglia fitta. La perdita invernale delle foglie è tardiva
rispetto ad altre specie cedue, avviene al finire dell'autunno o inizio
dell'inverno. I fiori sono di un colore rosso vivo, di circa 3 cm di diametro e
hanno tre-quattro petali; la fioritura avviene a maggio. Il frutto è una bacca
(detta Balausta) di consistenza molto robusta, con buccia dura e coriacea, ha
forma rotonda o leggermente allungata, a volte quasi esagonale, con dimensione
fortemente condizionata dalla varietà e, soprattutto, dalle condizioni di
coltivazione. Il frutto ha diverse partizioni interne robuste che svolgono
funzione di supporto per i semi, detti arilli, fino a 600 per ogni frutto,
separati da una membrana detta cica. I semi, di colore rosso, in alcune varietà
sono circondati da una polpa traslucida colorata dal bianco al rosso rubino, più
o meno acidula e, nelle varietà a frutto commestibile, dolce e profumata. Il
frutto reca in posizione opposta al picciolo una caratteristica robusta corona,
residuo del calice fioreale. Il frutto matura a ottobre-novembre a seconda delle
varietà. Il melograno viene coltivato per i suoi frutti e come albero e arbusto
ornamentale in parchi e giardini. Gli esemplari maturi possono sviluppare più
tronchi scultorei a corteccia contorta. I melograni sono resistenti alla siccità
e possono essere coltivati in zone asciutte con un clima piovoso invernale
mediterraneo o in climi piovosi estivi. Nelle zone più umide, possono essere
soggetti a marciume radicale a causa di malattie fungine. Possono tollerare il
gelo moderato, fino a circa -12°C. Vi sono più di 500 cultivar cui è stato
dato un nome! I principali produttori a livello globale sono India e Cina,
seguiti da Iran, Turchia, Afghanistan, Stati Uniti, Iraq, Pakistan, Siria e
Spagna. Secondo il Guinness dei Primati, la melagrana più grande mai raccolta al
mondo veniva dalla Cina, pesava 1,85 chili per un diametro di 48,7
centimetri! Fino a qualche decennio fa il melograno era poco diffuso nella
cultura italiana, ma oggi sempre più spesso questo frutto è presente nella
nostra dieta alimentare quotidiana, ed è uno tra i frutti più richiesti e di
tendenza del momento. In Messico i semi di melagrana sono usati per preparare
una ricetta tradizionale, il "chile en nogada", piatto caratteristico perché la
sua presentazione rispecchia i colori della bandiera tricolore messicana (il
rosso dello strato superiore di melagrana, il bianco della crema di noci ed il
verde del chile). Ogni anno si tiene a Goychay (Azerbaigian) il Festival del
Melograno, che presenta le specialità della cucina locale a base di melagrane e
fa sfoggio delle danze e delle musiche tradizionali del paese; esso ha
tradizionalmente luogo in ottobre, il periodo di maturazione delle melagrane. In
Daunia la melagrana è rinomata per essere uno degli ingredienti principali del
grano cotto ("cicce cutte" in dialetto lucerino), un dolce che si prepara per la
Commemorazione dei Defunti. Come tutti gli altri ingredienti (grano, cioccolato,
noci, etc.), i chicchi di melagrana utilizzati per preparare questa ricetta
hanno una simbologia che richiama contemporaneamente la morte e la prosperità.
Nei frutti maturi, il succo ottenuto dalla spremitura dei semi ha un sapore
aspro dovuto al basso pH (4,4) e all'alto contenuto di polifenoli, che possono
causare macchie rosse indelebili sui tessuti. Tale succo è usato nelle miscele
di succhi, contorni frullati e bevande alcoliche, come cocktail e vino. Nella
tradizione armena si produce il vino di melagrana, che giunge a superare la
gradazione alcolica di 11 gradi. Il succo di 100 grammi di semi di melograno
contiene il doppio degli antiossidanti presenti nella stessa quantità di more,
il triplo rispetto ai mirtilli e il quadruplo rispetto alle arance. Si usa la
melagrana anche per le sue proprietà medicinali: la scorza dei frutti raccolta
in autunno, ricche di tannino, viene tagliata a pezzetti e fatta essiccare
all'aria. La polvere ottenuta, utilizzata come decotto, ha proprietà
astringenti. I semi hanno proprietà blandamente diuretiche, e si usano anche per
la preparazione di sciroppi e della Granatina. Dalla scorza si ottiene una
tonalità di giallo tipicamente utilizzata negli arazzi arabi. Dal colore del
frutto invece trae origine il rosso granata, un bordò scuro particolarmente noto
per essere il colore sociale della squadra di calcio del Torino, che quando ero
ragazzo era la mia squadra del cuore, e infatti i suoi giocatori sono noti come
"i granata"!
Anhe il melograno ha una ricchissima simbologia: per il colore dei
numerosi semi, di un rosso traslucido brillante, racchiusi in un involucro
robusto, il frutto ha colpito l'immaginazione umana fin dal buio della
Preistoria; il contrasto è ancora più accentuato dal fatto che la pianta vive in
ambienti semidesertici. Il libro
dell'Esodo (28,33-34) prescrive che le melagrane siano raffigurate sugli abiti
rituali dei Grandi Sacerdoti. La melagrana è uno dei sette frutti elencati nella
Bibbia (Deuteronomio 8,8), come ricchi prodotti della Terra Promessa. Il Primo Libro dei Re (7,13-22) descrive le
melagrane rappresentate sui capitelli che erano sul fronte del Tempio di
Salomone in Gerusalemme. La corona, che nella simbolistica ebraica indica la
santità, è rappresentata dalla "corona", residuo del calice fiorale che permane
nella parte apicale del frutto. Inoltre, secondo il Talmud, la melagrana sarebbe
simbolo di onestà e correttezza, dato che conterrebbe 613 semi, cioè quante le
613 prescrizioni scritte nella Torah, (365 divieti e 248 obblighi) osservando le
quali si ha certezza di tenere un comportamento conforme al volere di Dio. Ed
infatti ancor oggi i rotoli della Torah, quando sono avvolti, sono protetti da
gusci in argento a forma di melagrane (rimmonim)! Sempre secondo il Talmud, il
frutto dell'Albero della Vita del Giardino dell'Eden non era una mela ma una
melagrana, rappresentando con i suoi chicchi il testicolo umano, e quindi un
antico simbolo di fertilità e di benedizione. Anche nel Cantico dei Cantici
(6,11 e 7,13) non
a caso l'amata è paragonata ad un giardino pieno di alberi di melograno, e
l'amore sarà consumato proprio quando gli alberi saranno
fioriti. Secondo il Corano, il melograno cresce nel giardino del paradiso (Sura
55,68). Nella Sura 6,99 e 141 i melograni sono elencati tra le buone cose
create da Dio. Nella mitologia greca, quando Proserpina fu rapita da suo zio Ade
(che non riusciva a trovare una sposa disposta a vivere per sempre con lui nel
Regno dei Morti), le venne offerta della frutta, ed ella mangiò solo sei semi di
melograno. Ignorava però che chi mangia i frutti degli inferi è costretto a
rimanervi per l'eternità. Alla fine si giunse a un compromesso con la mediazione
di Zeus: Proserpina, personificazione della Primavera, sarebbe vissuta sei mesi
sulla terra con la madre Demetra (la Cerere dei Romani) e sei mesi negli inferi
con il marito Ade, dando così vita al ciclo delle stagioni. Anche in questo mito
il melograno rimanda all'unione sessuale, e quindi al matrimonio e alla
fertilità. Si racconta che le donne ateniesi mangiassero i semi del frutto del
melograno per acquisire fertilità e prosperità, e che le spose romane usassero
intrecciare tra i capelli rami di melograno. La melagrana è anche presente
nell'iconografia cristiana, sugli abiti e i paramenti dei sacerdoti per le
funzioni religiose, oltre che sui capitelli medievali. Nel Medioevo la Vergine
Maria era sovente raffigurata con una melagrana fra le mani; nella
cosiddetta Madonna Salting di Antonello da Messina, ora alla National Gallery di
Londra, è Gesù Bambino a tenere in mano una melagrana: in questi casi il frutto
è un simbolo anticipatore della Passione. Per il colore del suo succo la
melagrana richiama infatti da sempre il sangue. Nell'iconografia cristiana
diventerà quindi simbolo di martirio, un martirio fecondo come il frutto pieno
di semi; sarà anche un riferimento alla teologia di Cristo Signore glorioso e
della sua Chiesa "corpo mistico" che racchiude in sé il popolo salvato e sparso
nel mondo, seme santo e santificante. In Grecia ancora oggi quando si compra una
nuova casa è uso mettere quale primo dono presso l'Iconostasi (l'altare
domestico) una melagrana come simbolo di abbondanza, fertilità e
buona fortuna. Nell'Induismo, uno dei nomi del dio Ganesha è "Bijapuraphalasakta",
cioè "colui che gradisce la frutta dai molti semi" (la melagrana): ogni parte
della pianta (radici, corteccia, fiori, foglie) è usata nella medicina Ayurveda.
Il simbolo della melagrana non poteva mancare nella Massoneria, dove simboleggia
l'unione di tutti i fratelli uniti nella Massoneria Universale. Nello stemma
posto nella bandiera della Spagna è presente una melagrana con due foglie che
si biforcano. La melagrana era pure presente nell'emblema della regina
d'Inghilterra Caterina
di Aragona (1485-1536), la sfortunata prima moglie di Enrico VIII; in seguito
all'incapacità di dare alla luce un figlio maschio al Re fu ripudiata, e contro
il parere del Papa Clemente VII il re sposò in seconde nozze Anna Bolena, dando
inizio allo scisma anglicano. Non appena regina, come primo decreto Anna Bolena
cambiò la decorazione del blasone con un falcone bianco che becca i chicchi
della melagrana, come sfida alla regina precedente. Ma la cosa non le portò
fortuna: benché bellissima, anch'ella non riuscì a dare al lussurioso e obeso
sovrano un figlio maschio (fu madre della futura Elisabetta I), e così fu ripudiata con
la falsa accusa di incesto e decapitata il 19 maggio 1536 (il suo fantasma,
secondo i superstiziosi, si aggirerebbe ancora nella Torre di Londra, ma si sa
che un castello britannico senza il suo bravo fantasma non è un castello
britannico). Molto probabilmente il termine francese moderno che indica il
melograno, granade, ha dato il nome alla famigerata arma da lancio chiamata
granata: nei suoi primi modelli era costituita da un guscio rotondeggiante
contenente un grande numero di pallini di metallo che, in seguito all'esplosione
dell'ordigno, venivano proiettati all'intorno per arrecare gravi danni ai
soldati avversari (se l'uomo è bravo a fare una cosa, è ad uccidere i suoi
simili). Esiste anche un minerale chiamato granato, per probabile riferimento al
colore della melagrana. Infine, non dimentichiamo la triste poesia dedicata da
Giosuè Carducci alla morte del figlio Dante: « L'albero a cui tendevi / la
pargoletta mano, / il verde melograno / dai bei vermigli fior... » Ma è meglio
decisamente pensare a questo frutto e ai suoi semi come simbolo di fertilità e
di vita, non siete d'accordo?

L'albero del traditore
Anche se può sembrare incredibile, il cosiddetto
albero di Giuda o siliquastro
(Cercis siliquastrum) appartiene alla famiglia delle leguminose. Cercis, il nome
del genere, deriva dal termine greco "kerkís", perchè il frutto ha la forma di
di una "spola"; invece siliquastro deriva dal latino siliqua, ovvero "baccello".
Esso si presenta come un albero a foglie caduche alto fino a 10 metri, ma può
diventare anche un arbusto. Cresce molto lentamente, ha la corteccia di colore
grigio-nerastro, tendente al rossiccio nei rami giovani, le foglie hanno forma
di cuore e un aspetto liscio e lucido; appaiono abbastanza tardivamente, in
aprile; in autunno assumono un bel colore giallo e cadono a novembre
inoltrato. I fiori sono ermafroditi, con corolla di colore rosa o bianca. Sono
riuniti in racemi che compaiono prima delle foglie, in marzo-aprile;
caratteristica di questa specie è la caulifloria, cioè i fiori spuntano
direttamente dalla corteccia dei rami e del tronco. I frutti sono dei
caratteristici baccelli scuri, molto numerosi, che pendono dalla pianta e
restano attaccati ad essa fino alla fine dell'inverno. Il siliquastro cresce in
tutta l'Europa del Sud e in Asia minore, fino ad un massimo di 500 metri di
quota. È una pianta tipica del bosco di latifoglie, ma cresce difficilmente in
boschi umidi e ombrosi, mostrando elevata capacità di adattamento e arrivando a
colonizzare i pendii aridi e scoscesi e addirittura i luoghi sassosi, come cave
e pareti rocciose naturali. Di sicuro preferisce i terreni calcarei e sassosi,
ed è abbastanza resistente al freddo. A differenza di molte altre piante di cui
ti ho parlato, i frutti non sono commestibili; sono i fiori che vengono usati in
cucina nella preparazione di varie ricette, come ad esempio la minestra o la
marmellata di fiori. Come tutte le altre leguminose, è una pianta in grado di
catturare l'azoto dall'atmosfera e, grazie a dei batteri che vivono in simbiosi
con lui nelle sue radici, lo rilascia nel terreno, arricchendolo. È molto usato
come albero ornamentale nei giardini e per le alberature stradali, grazie alla
sua resistenza all'inquinamento.
E ora, veniamo come sempre al suo
simbolismo. Il nome popolare "albero di Giuda" fa riferimento ad antiche
leggende, legate alle prime comunità cristiane, riguardanti le vicende degli
ultimi giorni di Gesù narrati nei Vangeli. Infatti esso è molto diffuso in Asia
Minore, e da qui nacque la convinzione che fosse originario della Giudea, da
dove si sarebbe diffuso in tutto il bacino del Mediterraneo. Per via della sua
intensa fioritura approssimativamente in corrispondenza del tempo di Pasqua, e
del repentino apparire dei fiori di un intenso colore lilla-violaceo sulla nuda
corteccia, ancor prima delle foglie, i primi Cristiani lo utilizzarono per
rappresentare simbolicamente il tempo della Passione di Cristo ed il colore dei
paramenti liturgici relativi a tale periodo liturgico. Non basta: la
nostra pianta è legata all'episodio secondo cui sotto di essa il traditore Giuda
Iscariota avrebbe dato il famoso bacio a Gesù e, più tardi, tormentato dal
rimorso, vi si sarebbe impiccato (secondo alcuni l'ampia diffusione di questa
credenza suggerirebbe che il siliquastro avesse già un particolare significato
mitologico presso alcuni culti precristiani europei, ma non ne abbiamo le
prove). Anche le bacche color rosso vivido sembrano fare riferimento al sangue
di Giuda, e lo stesso albero appare "traditore" come Giuda Iscariota poiché i
suoirami appaiono robusti ma, in realtà, sono fragili e si spezzano facilmente
se vi si sale sopra. Occhio, perchè l'albero di Giuda non va confuso con lo
Spino di Giuda (Gleditsia triacanthos), che al
contrario è originario delle Americhe e fu in seguito portato in Europa:
anch'esso produce baccelli, ma fa parte della famiglia delle Fabacee e il suo
nome fa riferimento al fatto che è coperto di spine, e quindi alla corona di
spine di Gesù, senza altri riferimenti all'Iscariota.
Val la pena di
sottolineare come nel Nuovo Testamento siano confluite due tradizioni diverse
sulla morte di Giuda (Iscariota significa "Uomo di Kariot" da "Κ-qəriyyôṯ",
originario quindi della città di Kariot, nell'estremo sud della Giudea, ai
confini del Negev). In Matteo 27,5 Giuda, pentito di aver tradito sangue
innocente, butta i trenta denari nel Tempio e va ad impiccarsi, e con quei soldi
i sacerdoti comprano il campo del vasaio, detto da allora "campo di sangue" (Akeldamà),
per la sepoltura degli stranieri. Invece in Atti 1,15-20 San Pietro racconta
agli altri Apostoli che Giuda non si è affatto suicidato, ma con i trenta denari
ha comprato lui il campo del vasaio; in esso però è precipitato (da un albero?),
il suo corpo si è squarciato e le sue viscere si sono sparse all'intorno, da cui
il nome di "campo del sangue". Evidentemente la tradizione matteana e quella
lucana sono tra loro incompatibili, e fanno riferimento a distinte e
indipendenti tradizioni sulla fine di Giuda, che sarebbe stata comunque brutta,
anzi bruttissima. Una terza tradizione è riportata da San Papia di Ierapoli,
discepolo di Giovanni Evangelista e vissuto all'inizio del II secolo: secondo
lui Giuda, dopo il tradimento, andò in giro vagabondando, con il corpo così
gonfio da non poter passare lì dove un carro poteva passare con facilità; e morì
travolto da un carro, con le viscere che uscirono dal suo corpo. La mistica Anna
Katharina Emmerick, le cui visioni ispirarono il film "La Passione di Cristo" di
Mel Gibson, propose una sintesi delle due versioni canoniche: « Spinto
dall'estrema disperazione, il traditore prese la cintura e si impiccò a un
albero. Subito dopo il suo corpo crepò e io vidi le sue viscere spargersi per
terra. » In tempi moderni qualcuno ha provato a "riabilitare" la figura di
Giuda: visto che Gesù non si decideva a scacciare gli odiati Romani, Giuda (che
sarebbe stato vicino agli Zeloti di Barabba) avrebbe cercato di forzare la mano
al Signore, facendolo arrestare nella convinzione che egli avrebbe chiamato gli
angeli in sua difesa; quando vide che ciò non accadeva, e che Gesù sarebbe stato
crocifisso per causa sua, egli si tolse la vita. Secondo altri invece i
sacerdoti, per ottenere l'aiuto di Giuda, lo avrebbero ingannato prospettandogli
la minaccia di un arresto di Gesù da parte dei Romani e la possibilità di
evitarlo se il Sinedrio avesse potuto interrogare preventivamente Gesù; così
appare anche nel "Gesù di Nazaret" di Zeffirelli. In ogni caso, come diceva Papa
Benedetto XVI, nessuno di noi è certo che Giuda si sia effettivamente dannato, e
lo dimostrerebbe quanto detto dal Sacro Cuore in visione a Santa Caterina da
Genova: «...Se tu sapessi ciò che io ho fatto di Giuda! »

L'albero del pubblicano
Adesso vi parlerò di un'altra pianta ampiamente citata nella
Bibbia, e in particolare nell'episodio dell'incontro tra Gesù e Zaccheo. Il
sicomoro (Ficus sycomorus) è una pianta
appartenente alla famiglia delle Moracee, e dunque è parente stretta del fico
comune, di cui abbiamo già parlato. Il suo nome deriva dal greco sykómoros,
composto di "sŷkon", "fico", e "móron", "mora" (infatti il sicomoro in inglese è
detto anche fig-mulberry, cioè fico-gelso). La pianta cresce spontanea nel sud
della penisola Arabica e in alcune regioni dell'Africa, dal Senegal al
Sudafrica, nonché in ristrette aree del Madagascar; è inoltre coltivata fin da
epoche remote in Egitto Israele, Palestina e Siria. Cresce fino ad un'altezza
di 20 metri e raggiunge i 6 metri di larghezza, con una chioma ampia e
tondeggiante. La corteccia va dal verde-giallo all'arancione, mentre le foglie
hanno forma ovale con apice rotondo. Raggiungono i 14 cm di lunghezza per 10 cm
di larghezza, e sono disposte a spirale intorno ai rami. Come accade per il
fico, quello che comunemente viene ritenuto il suo frutto è in realtà una grossa
infiorescenza carnosa piriforme, detta siconio, all'interno della quale sono
racchiusi i fiori unisessuali, piccolissimi; la piccola apertura apicale (ostiolo)
consente l'entrata degli insetti impollinatori; i veri frutti, che si sviluppano
all'interno dell'infiorescenza, sono dei piccoli acheni. Occorre far notare che
le diverse specie di Ficus hanno in genere un rapporto stretto e specifico con i
loro impollinatori, che sono tutti imenotteri della famiglia Agaonidae; invece
il sicomoro rappresenta l'eccezione che conferma la regola, in quanto può essere
impollinato da due differenti agaonidi, Ceratosolen arabicus e Ceratosolen
galili, che condivide con un'altra specie africana, Ficus mucuso.
Anche il
sicomoro ha una lunga storia, che vale la pena di essere narrata. Nella
mitologia egizia era consacrato alla dea Hathor, la dea a forma di vacca con il
sole tra le corna, patrona della gioia, dell'amore, della maternità e della
bellezza; in quanto patrona degli alberi, era invocata come la "Signora del
sicomoro". La mitologia egizia narra che all'arrivo della primavera, l'Uovo
Cosmico plasmato da Ptah e da lui deposto sulle rive del Nilo si apriva e ne
usciva Ra/Osiride, il Sole. Il fiume viveva in simbiosi col dio del sole. Con
questa resurrezione cessava finalmente il pianto di Iside (sempre alla ricerca
del suo amato Osiride) e, per festeggiare la fine del suo dolore, si mettevano
in scena gli episodi del mito di Osiride, culminanti nella resurrezione del dio,
che avveniva quando dalle zolle alla base del sicomoro sacro iniziavano a
spuntare i germogli di grano e orzo. Il sicomoro era insomma considerato un
albero cosmico, il sacro pilastro Djed, simbolo di immortalità, di vittoria
sulla morte, di rinascita, ed il suo legno era usato per la fabbricazione dei
sarcofagi. In Grecia il sicomoro era considerato sacro a Dionisio e a Priapo, il
dio lubrico della fecondità. A Roma invece era sacro a Marte, padre di Romolo e
Remo che secondo il mito erano nati dalla sua unione con Rea Silvia, la giovane
vestale di Alba Longa. La cesta che li accoglieva fu affidata alle acque del
Tevere, ma per volere divino si fermò in una pozza sotto un sicomoro, all'ombra
del quale Romolo e Remo sarebbero stati allattati dalla lupa. Secondo alcune
fonti, il fico che si ergeva alle pendici del colle Palatino era proprio quel
mitologico sicomoro, e per questo nella civiltà romana il sicomoro fu sempre
considerato un albero fausto, venerato soprattutto dai pastori, che gli
portavano offerte di latte. Il sicomoro è citato otto volte nella Bibbia. Nel
Salmo 78,47 i i sicomori sono elencati insieme alle viti tra le fonti di cibo
distrutte dalle piaghe d'Egitto: « Distrusse le loro viti con la grandine e i
loro sicomori con la brina ». Questo versetto implica che il Ficus sycomorus non
poteva sopravvivere nelle regioni montuose. In 1Cronache 27,28 il re Davide
nomina un ufficiale per prendersi cura degli ulivi e dei sicomori delle colline
pedemontane occidentali. In 1Re 10,27 e 2Cronache 1,15 e 9,27 si dice che il re
Salomone rese i cedri (un albero preziosissimo) comuni come i sicomori. Nel
condannare l'arroganza del suo popolo, il profeta Isaia (9,10) usa un contrasto
tra sicomori e cedri. Nel Libro di Amos, redatto nel Regno di Giuda attorno al
750 a.C., il profeta omonimo asserisce di essere stato, prima di dedicarsi alla
missione profetica, "un pastore e pungitore di fichi di sicomoro" (7,14), il che
testimonia che in quell'epoca l'albero era già presente e coltivato in Israele.
Nella Mishnah, uno dei testi fondamentali dell'ebraismo post-70 d.C., colossale
interpretazione della Torah, sono delineati i confini dei vari distretti della
Terra d'Israele, e l'Alta Galilea è definita come l'area a nord di Kfar Hananya
dove il sicomoro non cresce; esso invece cresce nella Bassa Galilea. Il trattato
Berakhot della Ghemara, la parte del Talmud contenente i commentari rabbinici e
le discussioni sorte sull'interpretazione della Mishnah, menziona il sicomoro in
riferimento alla sua decima benedizione. I primi cristiani pensavano che
l'albero al quale si impiccò Giuda Iscariota fosse un sicomoro, poiché i suoi
rami appaiono robusti, ma in realtà sono fragili e si spezzano facilmente,
dunque sono "traditori". Così facendo però gli davano una connotazione negativa,
in contraddizione con il suo largamente diffuso significato di vita e di
risurrezione. Le successive tradizioni dunque associarono piuttosto l'albero di
Giuda al Siliquastro, del quale abbiamo già parlato. Anche nella religione dei
Kikuyu, popolo Bantu del Kenya, il sicomoro è un albero sacro: tutti i sacrifici
a Ngai, il Creatore supremo, vengono eseguiti sotto questo albero. Ogni volta
che un sicomoro cade, questo è interpretato come un cattivo presagio e gli
anziani devono eseguire particolari rituali di purificazione, ancora oggi
praticati.
E ora, l'episodio biblico più famoso. Nel Vangelo secondo Luca
19,1-10 si narra di una visita di Gesù a Gerico; il capo dei pubblicani, un
certo Zaccheo, essendo basso di statura, per vedere Gesù salì su un sicomoro;
Gesù lo vide e lo chiamò, dicendogli che sarebbe venuto a cena a casa sua. Tutti
gli abitanti di Gerico ne furono scandalizzati, perchè i pubblicani, esattori
delle tasse per conto dei Romani, erano considerati dei collaborazionisti e
quindi dei traditori, oltre che dei lestofanti, chiedendo molto di più di quanto
dovuto per impossessarsi della differenza; ma Zaccheo annunciò a Gesù che
avrebbe donato la metà dei suoi beni ai poveri e, se aveva rubato a qualcuno,
avrebbe restituito quattro volte tanto. "Oggi la salvezza è entrata in questa
casa", è il commento del Redentore. Questo il commento in proposito di Papa
Francesco: « La folla, quel giorno, ha giudicato Zaccheo, lo ha guardato
dall'alto in basso; Gesù, invece, ha fatto il contrario: ha alzato lo sguardo
verso di lui. Lo sguardo di Gesù va oltre i difetti e vede la persona; non si
ferma al male del passato, ma intravede il bene nel futuro; non si rassegna di
fronte alle chiusure, ma ricerca la via dell'unità e della comunione; in mezzo a
tutti, non si ferma alle apparenze, ma guarda al cuore. Gesù guarda il nostro
cuore, il tuo cuore, il mio cuore. Con questo sguardo di Gesù, voi potete far
crescere un'altra umanità, senza aspettare che vi dicano "bravi", ma cercando il
bene per sé stesso, contenti di conservare il cuore pulito e di lottare
pacificamente per l'onestà e la giustizia. Non fermatevi alla superficie delle
cose e diffidate delle liturgie mondane dell'apparire, dal maquillage dell'anima
per sembrare migliori. Invece, installate bene la connessione più stabile,
quella di un cuore che vede e trasmette il bene senza stancarsi. E quella gioia
che gratuitamente avete ricevuto da Dio, per favore, gratuitamente donatela,
perché tanti la attendono! E la attendono da voi. »

Il cosiddetto "sicomoro di Zaccheo" a Gerico
L'erba
che minacciò il villaggio di Asterix
Ora vi voglio parlare del
loglio, meglio noto (grazie a una famosissima
parabola evangelica) come zizzania. Lolium è un
genere di graminacee della sottofamiglia delle Pooidee), originario dell'Europa,
dell'Asia e dell'Africa settentrionale, ma è stato coltivato e naturalizzato in
Australia e nelle Americhe. Il loglio è diploide ed è strettamente imparentato
con la festuca. Il genere Lolium contiene alcune specie diffusissime nei prati e
largamente utilizzate come pascolo e come fieno per il bestiame, rappresentando
un mangime altamente nutriente. È la principale erba da pascolo in Nuova Zelanda, dove ogni anno vengono prodotti circa 10 milioni di chilogrammi di sementi
certificate. Il loglio è anche utilizzato nei programmi di controllo
dell'erosione del suolo. La specie più diffusa in tutto il mondo e utilizzata
sia per i prati che come coltura foraggiera è il Lolium perenne. Come molte erbe
della famiglia delle Poacee, ospita un fungo simbiotico endofita, Epichloë,
oppure il suo parente stretto Neotyphodium, entrambi membri della famiglia delle
Clavicipitacee. Alcune specie, in particolare Lolium temulentum, sono
infestanti, per di più possono manifestare una forte resistenza agli erbicidi, e
possono avere un forte impatto sulla produzione di grano e altre colture (e Gesù
lo sapeva molto bene); il loglio annuale o Lolium rigidum ad esempio è una delle
infestanti peggiori dell'Australia meridionale. Come se non bastasse, il polline
di loglio è una delle principali cause del raffreddore da fieno.
Sicuramente la specie più pericolosa per gli agricoltori di tutto il mondo è Lolium
temulentum, detto anche loglio ubriacante, spontanea e con fiori a spiga
rossa. La pericolosità di questa pianta è ben nota fin dai tempi antichi,
soprattutto per l'alto potere intossicante. Infatti il termine latino temulentum
("ubriacante") è riferito agli effetti derivanti dall'ingestione di farine
contaminate da funghi del genere Claviceps, produttori di alcaloidi tossici che
possono causare forti emicranie, vertigini, vomito ed offuscamento della vista.
Tali effetti sono dovuti alla presenza di un micelio fungino che invade la
pianta durante lo sviluppo, esattamente come avviene nella segale con la Segale
Cornuta, da cui viene estratta l'LSD. Si pensi che il botanico greco Teofrasto affermava nel suo "De causis plantarum" (8,7 §1) che il grano può
addirittura trasformarsi in zizzania, poiché i campi seminati a frumento si
scoprono essere tutti di zizzania quando vengono mietuti! Anche se ciò
ovviamente è falso, purtroppo l'eliminazione della zizzania dai campi di
cereali è resa difficoltosa dal fatto che la somiglianza tra queste due piante è
così grande che in alcune regioni la zizzania viene chiamata "falso grano",
almeno finché non compare la spiga. Le spighe di Lolium temulentum sono più
sottili di quelle del grano, sono orientate lateralmente al rachide e hanno una
sola gluma (brattea), mentre quelle di frumento sono orientate con la parte
piatta al rachide e presentano due glume. Il grano inoltre apparirà marrone
quando è maturo, mentre la zizzania è nera.
L'etimologia del termine "Lolium" non è nota. Il latino "zizania" invece deriva
dal greco "zizanion", che da taluni è fatto derivare da "sinoo", "nuoccio", e da
altri da "izano", "perisco", con raddoppiamento dell'iniziale. Dalla stessa
radice vengono anche l'arabo "zivan" e il farsi "sevan". La parola francese per
zizzania è "ivraie", dal latino "ebriacus", "intossicato", termine che esprime
la nausea per aver mangiato la pianta infetta, che può essere anche fatale.
Ciò che ha reso famosa la zizzania in tutto il mondo, anche dove questa pianta
non cresce, è la celebre parabola di Gesù contenuta in Matteo 13,24-30. In essa,
mentre il padrone di un campo di grano dorme, il suo concorrente vi semina
volontariamente del loglio, operazione che, per quanto scritto sopra, in una
civiltà essenzialmente contadina era da considerarsi fra le più criminali.
Nessuno se ne accorge finché non spuntano le spighe, e a quel punto i braccianti
chiedono al padrone del campo se devono strappare l'erba nociva, ma egli
risponde di no, perchè altrimenti correrebbero il rischio di strappare anche il
grano buono. Solo al momento della mietitura i braccianti falceranno sia il
grano che il loglio, ed il primo lo riporranno nei silos, pronto per essere
macinato in farina, mentre il secondo lo legheranno in fasci per bruciarlo,
giacché ad altro non può servire. Una sintesi di questa parabola si trova anche
nell'apocrifo Vangelo di Tommaso: « Gesù disse: "Il regno del Padre è come un
uomo che aveva dei semi. Il suo nemico venne di notte e piantò zizzania in
mezzo al buon seme. L'uomo non permise che togliessero la zizzania. Disse loro:
Che non andiate a togliere la zizzania, e togliate con essa il grano. Poiché il
giorno del raccolto la zizzania sarà palese; saranno presi e bruciati."
» (Vangelo di Tommaso, 57) Il Vangelo di Matteo 13,37-42 fornisce la spiegazione
della parabola (alcuni biblisti hanno supposto che questa sia un'aggiunta da
parte dei copisti, ma non c'è motivo per dubitare dell'autenticità di questo
brano, visto che anche di altre parabole si fornisce la spiegazione). Più che
predicare la teoria della retribuzione (i buoni in Paradiso, i cattivi
all'inferno), con questa parabola il Salvatore intende rispondere ad una domanda
che riecheggia da duemila anni: perchè c'è il Male nel mondo? Se Dio è buono e
detesta il Male, perchè non lo sradica subito? Forse perchè non può farlo? Ma
allora non è
onnipotente? La parabola del grano e del loglio fuga ogni apparente
contraddizione: Dio non elimina i malvagi perchè per farlo occorrerebbe una tale
catastrofe, una sorta di nuovo diluvio universale, da spazzare via anche i buoni
che non meritano alcun castigo (è l'obiezione principale mossa al racconto anticotestamentario del diluvio di Noè: forse anche i bambini erano colpevoli e
degni di essere sterminati?) I giustizialisti, coloro che vorrebbero vedere
immediatamente la punizione dei peccatori, vorrebbero forzare la mano a Dio, il
quale invece conferma che i Suoi tempi non sono i nostri tempi. « Il padrone del
campo non confonde il bene con il male. Sa che quello è salutare e che questo è
nocivo alla salute, ma non permette che i suoi servitori si precipitino, perché
vuol dar tempo alla misericordia. Gesù ci insegna a moderare gli impeti e a
saper attendere: ciò che è male può cambiare in qualcosa di buono. La
conversione è possibile e c'è sempre speranza che si produrrà. » (Francisco
Varo)
Questo concetto riecheggia anche in un noto brano dell'Apocalisse di
Giovanni: « Quando l'Agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le
anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio e della
testimonianza che gli avevano resa. E gridarono a gran voce: "Fino a quando,
Sovrano, Tu che sei santo e verace, non farai giustizia e non vendicherai il
nostro sangue sopra gli abitanti della terra?« Allora venne data a ciascuno di
essi una veste candida e fu detto loro di pazientare ancora un poco, finché
fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli che
dovevano essere uccisi come loro. » (Ap 6,9-11) A tutti dunque è chiesto di
pazientare, perchè solo alla fine del mondo ogni colpa non perdonata sarà
punita, e chi vuole sostituirsi a Dio accelerando i tempi diventa a sua volta un
assassino, un criminale, un terrorista. Da questa parabola deriva il diffuso
modo di dire "seminare zizzania", cioè disseminare di elementi conflittuali un
determinato ambiente rimanendo nell'ombra (il Maligno agisce nottetempo mentre
gli altri dormono, come dice Mt 13,25). Da essa deriva anche il detto "Separare
il grano dal loglio", ossia separare gli elementi di qualità migliore da quelli
dannosi tra essi nascosti. Sulla scia di questa parabola, Dante cita la zizzania
almeno in due occasioni: Purgatorio II,124 e Paradiso XII,119. Non possiamo
stupirci se, nell'ordinare il massacro di tutti i Danesi in Inghilterra nel
giorno di San Brizio, il 13 novembre 1002, Re Etelredo II lo Sconsigliato
(978-1016) affermò spietatamente che « tutti i Danesi che erano spuntati su
quest'isola, germogliando come zizzania tra il grano, dovevano essere distrutti
da un giusto sterminio. »
Ma vi sono altri riferimenti alla nostra pianta nella storia dell'uomo. La
zizzania è uno dei tanti ingredienti della pozione che Mitridate VI, re del
Ponto (111-63 a.C.), avrebbe assunto ogni giorno per rendersi immune da ogni
avvelenamento. La zizzania è menzionata anche nella Satira 2.6 di Orazio (65-8
a.C.), dove viene mangiata dal topo di campagna mentre serve ai suoi ospiti cibi
più elaborati. Il loglio inoltre è citato nel Talmud. I campi da tennis,
compresi quelli dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, la sede
del Torneo di Wimbledon, di solito sono seminati a loglio.
Si noti che esiste anche il genere Zizania, che comprende piante erbacee
monocotiledoni annuali, anch'esse appartenenti alla famiglia delle Poacee;
è affine al genere Oryza (a cui appartiene il comune riso), ma a differenza di
esso, che è adatto a climi con temperature piuttosto elevate e relativamente
costanti, il genere Zizania è adatto in genere a climi più freschi, se non
decisamente freddi. Alcune specie del genere Zizania vengono commercializzate
come riso selvatico (definito negli Stati Uniti ed in Canada "wild rice", "indian
rice" o "water oats"). Il loglio però non appartiene a tale genere; le piante
del genere Zizania poi sono decisamente diverse dal grano comune e non possono
essere confuse con esso, ed erano molto probabilmente sconosciute in Palestina.
Per concludere, la fama della zizzania è giunta fino a René Goscinny
(1926-1977), l'ideatore del personaggio di Asterix. La quindicesima avventura
dell'eroe gallo dai lunghi baffi biondi e dall'elmo alato si intitola infatti "Asterix
e la zizzania" ("La zizanie" nell'originale francese; il titolo della versione
tedesca, "Streit um Asterix", cioè "Litigio per Asterix", banalizza e fa perdere
il riferimento al loglio). In essa Giulio Cesare, resosi conto di non poter
avere la meglio con la forza sui Galli del villaggio in Armorica, almeno
fintanto che questi restano uniti, decide di rompere
l'armonia interna al loro villaggio inviando presso di loro un carcerato romano,
il noto seminatore di discordia Tullius Detritus, dotato della capacità quasi
sovrumana di indurre al litigio coloro che gli sono accanto, praticamente
con la sua sola presenza. Per questo egli si presenta nel villaggio proprio nel
giorno del compleanno del suo capo Abraracourcix annunciando di voler fare un
dono all'"uomo più importante del villaggio" e deponendo il suo regalo ai piedi
di uno stupito Asterix. Questo fatto genera ovviamente l'invidia di
Abraracourcix, la rabbia di sua moglie Beniamina, la gelosia di Obelix, l'ira di Asterix che insiste con il proclamare che Detritus non è suo
amico, e il sospetto degli altri membri del villaggio (il baloon dei Galli
contagiati dal virus della zizzania ha un caratteristico color verde bile). Le
cose si aggravano quando Detritus mette in giro la voce che Asterix e Panoramix
hanno venduto ai Romani il segreto della pozione magica. Di fronte alla sfiducia
dimostrata, Panoramix, Asterix e il fedele Obelix decidono di abbandonare il
villaggio, il che lascia costernati gli altri abitanti. Detritus invita subito l'esercito romano ad attaccare il villaggio, ora che è
privo dei suoi principali difensori e della pozione magica, ma Asterix riesce a convincere i compagni
che la colpa è tutta del diabolico piano di Detritus, e di nuovo tutti uniti
riescono a sgominare i Romani. Dopo la vittoria Asterix riesce anche a
ritorcere la zizzania contro il suo seminatore, ringraziando pubblicamente
Detritus per l'aiuto dato loro nello sconfiggere i Romani: questi gli credono,
accusano Detritus di intelligenza con il nemico e lo riportano subito in
gattabuia. Nel consueto banchetto finale Panoramix conclude: "Sono litigiosi,
illogici, eccentrici... ma in fondo vanno capiti, sono solo umani." Come ripete
spesso Papa Francesco, Dio ci guardi dallo spargere zizzania!

L'umile
pianta che salvò gli scozzesi
Proseguiamo con la rassegna
delle piante citate nella Bibbia; oggi tocca al cardo.
Carduus è un genere di piante da fiore della famiglia delle Asteraceee e della
tribù delle Carduee. La famiglia delle Asteraceee, probabilmente originaria del
Sud America, è la più numerosa del mondo vegetale, comprendendo oltre 23.000
specie distribuite su 1 535 generi! Questo genere in particolare comprende 92
specie native dell'Europa (comprese le Canarie), Asia (fino al Giappone) e
Africa mediterranea. In Italia Carduus è un genere molto diffuso e lo si può
trovare praticamente ovunque, anche perché le sue specie sono molto robuste e
crescono bene in qualsiasi ambiente e nelle condizioni più disparate. Il genere
Carduus è purtroppo noto per il suo numero sproporzionatamente elevato di
erbacce nocive rispetto ad altri generi di piante da fiore. Si tratta
solitamente di erbe annuali o biennali, a volte perenni. Nelle piante con un
ciclo di crescita biennale, il primo anno si produce al più una bassa rosetta
basale di foglie, mentre il secondo anno fiorisce completamente. Tuttavia se il
clima è sufficientemente caldo può fiorire già durante il primo anno di vita. Il
numero dei capolini per ogni pianta può variare oltre che dalla specie anche
dalle caratteristiche del sito in cui si trova la pianta e può andare da 1 a
oltre 100. Le varie specie in Europa crescono fino fra 10 cm e un metro e mezzo
di altezza, ma in America può arrivare a 4 metri. Gli steli eretti sono alati e
spinosi e di solito sono ricoperti di peli lanosi. Le foglie sono di forma
generalmente lanceolata; la lamina può essere lievemente dentata oppure incisa
profondamente in 10 e più lobi; il margine fogliare è quasi sempre spinoso, con
spini che possono essere morbidi o pungenti e duri; la disposizione delle foglie
lungo il fusto è alterna e quelle basali formano una rosetta. L'infiorescenza è
formata da capolini fiorali, ognuno costituito da numerosi fiori tubulosi; il
capolino fiorale è sorretto da un peduncolo nudo o bratteato; l'involucro,
cilindrico o emisferico o ovoidale, è circondato da diverse serie (10 o più) di
squame spinose, che a volte divergono dal corpo centrale in modo eretto, e a
volte sono anche riflesse verso il basso. La forma delle squame è importante
come carattere distintivo della specie. I frutti sono acheni lisci di colore
chiaro e di forma oblunga leggermente compressa. Gli acheni sono "carrucolati",
ossia hanno delle protuberanze per agevolare il distacco dei semi. La
fecondazione avviene di solito tramite l'impollinazione dei fiori. I semi sono
trasportati per alcuni metri dal vento per merito del pappo, un'appendice
piumosa e leggera avente la funzione di favorire la dispersione dei semi per
l'azione del vento (disseminazione anemocora). In alcune specie invece la
dispersione è affidata soprattutto agli insetti come le formiche (disseminazione
mirmecoria). Ogni pianta può produrre migliaia di semi (possono arrivare a 1.000
semi e più per capolino (oltre 100.000 in totale) che vengono dispersi circa un
mese dopo la fioritura. Sembra che un singolo seme rimanga attivo nel suolo fino
a 10 anni, e questo naturalmente non facilita il controllo di queste piante, che
diventano facilmente invasive al di fuori del loro areale nativo, ad esempio in
Australia e negli Stati Uniti. Specie come Carduus acanthoides, Carduus nutans,
Carduus pycnocephalus e Carduus tenuiflorus diventano facilmente erbacce in
habitat come i pascoli sovrasfruttati. Anzi, Carduus nutans è allelopatico, in
quanto produce composti che inibiscono la crescita e lo sviluppo di altre
piante. Gli agenti di controllo biologico dei parassiti che sono stati usati
contro i cardi includono il tonchio della testa del cardo (Rhinocyllus conicus),
il punteruolo della corona del cardo (Trichosirocalus horridus) e la mosca della
corona del cardo (Cheilosia corydon). La ruggine del cardo muschiato (Puccinia
carduorum), che altri non è se non un fungo, può essere usato anche contro
Carduus nutans. Alcune specie di Carduus servono come piante alimentari per le
larve di alcuni Lepidotteri, tra cui Coleophora therinella.
Il nome italiano "cardo" è generico, in quanto nel linguaggio comune si
riferisce a diversi generi e specie di piante. Tra i generi che vengono chiamati
"cardo", oppure hanno una o più specie che comunemente si chiamano con questo
nome, citiamo Carduus, Carduncellus, Carlina, Centaurea, Cnicus, Cynara,
Echinops, Galactites, Jurinea, Onopordum, Scolymus, Silybum, Tyrimnus, tutti
della famiglia delle Asteracee.
Il nome "cardo" deriva dal latino volgare "cardus", che come il persiano "khar"
(e l'italiano "carciofo") va ricollegato alla radice "kas", cioè "raschiare",
"grattare"; da qui derivano anche il latino "carere", "pettinare", e l'italiano
"cardare" la lana. Qualcuno ha fatto derivare "cardo" da un'altra radice, e
precisamente dal greco "ardis", "punta dello strale", alludendo alla spinosità
delle piante di questo genere; ma questa va probabilmente considerata una
paretimologia. Probabilmente "cardo" va correlato alla parola Cardonnacum,
"luogo pieno di cardi"), che è all'origine di Chardonnay, il nome del famoso
vitigno realizzato per produrre lo champagne. Il nome di una delle specie più
diffuse, il Carduus crispus o cardo crespo, deriva dal latino "crispus",
"arricciato", in riferimento alle sue foglie.
Alcune parti di queste piante, se raccolte quando sono ancora giovani, vengono
utilizzate per l'alimentazione umana. Tra le diverse varietà di cardi, lo
"Spadone" è la varietà che comunemente viene interrata all'inizio dell'autunno
per dare vita ai cosiddetti "cardi gobbi", tra cui si distinguono quelli di
Nizza Monferrato. In seguito a quest'operazione le costole diventano
bianchissime, tenere e gobbe. I cardi gobbi, a differenza dei comuni cardi, sono
ottimi anche crudi. Tra le altre varietà c'è il Gigante di Romagna, che può
superare il metro e mezzo di altezza, contraddistinto da foglie chiare e
l'assenza di spine. Tutti i cardi, affinché diventino più teneri e perdano il
sapore amaro, devono essere sottoposti a imbianchimento, cioè alla crescita in
assenza di luce tramite fasce di plastica nera o altri materiali. Per questo
motivo non bisogna raccogliere cardi che abbiano le coste verdastre, perché
quasi sicuramente saranno fibrosi e più amari. Il Cardo Mariano (Cardus marianum)
è invece una varietà selvatica, conosciuta soprattutto per la sua azione
epatoprotettiva.
Dopo l'acquisto i cardi si possono conservare per 4-5 giorni in luogo freddo
(purché non geli) in una cassetta coperta con un telo umido scuro. Nella parte
bassa del frigorifero si mantengono per circa una settimana in un sacchetto di
plastica con qualche foro; non devono essere bagnati, altrimenti iniziano a
marcire. I cardi vanno puliti al momento dell'utilizzo perché anneriscono molto,
come i carciofi. Una volta tagliati, vanno sciacquati e conservati fino alla
cottura o alla consumazione da crudi in una boule con acqua acidulata con succo
di limone. La parte commestibile è il gambo, che va fatto cuocere per almeno
30-60 minuti. I cardi lessati si possono saltare al burro e insaporire con
formaggio grattugiato e noci tritate grossolanamente; saltare in padella con
olio e acciuga; gratinare al forno con besciamella o con formaggio; preparare
come le melanzane alla parmigiana; unire a costine di maiale cotte in umido con
ceci; impanare o friggere in pastella. Il cardo si sposa molto bene con le
acciughe sotto sale, infatti è un accompagnamento obbligatorio per la famosa
bagna cauda, la salsa bollente piemontese a base di acciughe, olio e aglio. Al
cardo sono riconosciuti basso contenuto calorico e alto effetto di sazietà: un
mix ottimale per posizionarsi ai primi posti tra gli ortaggi consigliati nelle
diete autunnali e invernali. Contiene il potassio in buona quantità, ferro,
sodio, calcio e fosforo. Tra le vitamine sono presenti B1, B2 e B3. Oltre a
queste troviamo anche la vitamina C in buona quantità. Il cardo è noto per avere
anche proprietà antiossidanti, toniche e decongestionanti.
Sempre più spesso i cardi ornamentali vengono piantati nelle aiuole fiorite e
nei giardini rocciosi, e per un valido motivo: perché queste piante robuste e
che non richiedono particolari cure riescono a sopportare in modo per lo più
eccellente le estati sempre più calde e secche. Un terreno arido è adatto per i
cardi che, in generale, crescono meglio su terreni sabbiosi, rocciosi e
permeabili. Dai cardi si può ricavare dell'olio e della carta. Inoltre
anticamente le infiorescenze secche del cardo erano usate per la cardatura della
lana.
E ora, come sempre, un po' di storia. Il cardo è una pianta molto antica: i
primi riferimenti certi sono stati trovati nella civiltà egizia. L'antichità del
cardo viene attestata dalle leggende che lo collegano al leggendario pastore
siciliano Dafni, figlio di Hermes cui il dio Pan insegnò a suonare abilmente la
zampogna, diventando presto una figura molto amata da uomini e divinità, simbolo
della vita pastorale e inventore del canto bucolico. Alla sua morte la Terra
soffrì così tanto da far fiorire una pianta piena di spine: il cardo. Nelle
tradizioni norrene il cardo era associato al dio Thor. Il cardo è anche parte
dello stemma reale della Scozia, in seguito ad una singolare leggenda. Questa
narra che, intorno all'anno Mille, un gruppo di vichinghi tese un'imboscata a un
accampamento scozzese. Gli invasori si tolsero i calzari per avanzare
silenziosi, ma quando uno di loro calpestò un cardo selvatico, le sue urla
svegliarono gli scozzesi, e questi riuscirono ad organizzare un contrattacco.
Nel 1470, durante il regno di Giacomo III, furono coniate monete d'argento
recanti proprio il disegno di un cardo, e negli stendardi scozzesi il cardo
viene associato al motto latino "Nemo me impune lacessit" ("Nessuno mi avrà
sfidato impunemente").
Dopo che Adamo ebbe mangiato del frutto proibito, Dio disse: « Maledetto sia il
suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua
vita. Spine e cardi produrrà per te. » (Gen 3,17-18). Queste piante spinose che
crescevano nel deserto divennero simbolo della punizione del peccato. Nelle sue
ultime parole, Davide paragona gli "scellerati" a spine del deserto, che devono
bruciare nel fuoco (2 Sam 23,6s). Il cardo mariano (Cardus marianum) prende il
nome da una leggenda che racconta di come Giuseppe e Maria, in fuga dai soldati
di Erode, si nascosero tra piante di cardo che vennero quindi macchiate dal
latte della Madonna. La lettera agli Ebrei (6,8) paragona gli uomini
allontanatisi dalla fede a un campo che produce pruni e spine. Secondo san
Gregorio Magno, ogni peccato è una spina. E le spine tornano ad essere, per il
tocco di Dio, un simbolo di redenzione: così nell'Antico Testa-mento il roveto
ardente, e nel Nuovo la corona di spine (Gv 19,2). Quale simbolo di sofferenze
terrene, il cardo era una decora-zione molto diffusa nelle raffigurazioni dei
santi.
Nella tradizione celtica si narra che gli elfi e gli gnomi che abitano i boschi
bevono l'acqua piovano utilizzando come bicchieri le foglie di cardo silvestre.
Secondo un'antica usanza popolare le giovani ragazze, per la vigilia di San
Giovanni, andavano strappare un cardo, lo sotterravano per poi dissotterrarlo
l'alba del giorno seguente, il giorno di San Giovanni. A quel punto le ragazze
ne osservavano attentamente la peluria interna: se la peluria del cardo rimaneva
di colore bianco, la ragazza che aveva compiuto il rituale sarebbe rimasta senza
marito o avrebbe avuto un amore non corrisposto, mentre se la peluria diventava
di un altro colore la ragazza si sarebbe sposata entro pochissimo tempo se il
colore era molto vivace, oppure dopo qualche mese se il colore era pallido. Nel
linguaggio dei fiori e delle piante il cardo simboleggia la solitudine e
l'isolamento, tale significato è dovuto alla tendenza della pianta a crescere in
luoghi impervi.
Chiudiamo con la letteratura. Il poeta greco Alceo nel VII secolo a.C. ci ha
lasciato il breve componimento "Solo il cardo è in fiore". "La rosa e il cardo.
Lettere da Fiume e dintorni" è una raccolta epistolare di Gabriele D'Annunzio
(1863-1938) che ripercorre il suo primo tentativo (fallito) di annettere
all'Italia la città di Fiume, assegnata dal Presidente USA Woodrow Wilson alla
neonata Jugoslavia; la sua impresa contribuirà a far nascere il mito della
"vittoria mutilata" che fu il concime ideale per l'ascesa del fascismo. "Il
cardo e la spada" è un romanzo del 2021 di Alessandra Sala (1965-), che ha come
protagonista una giovane prostituta al tempo della Guerra dei Trent'Anni: un
affresco in chiaroscuro sulle contraddizioni della storia e del cuore umano, tra
orrore e speranza, desideri e delusioni, tormento e inaspettata luce. Infine, il
finale della poesia "Davanti a San Guido" di Giosuè Carducci (1835-1907) recita:
« Ansimando fuggìa la vaporiera / mentr'io così piangeva entro il mio cuore; / e
di polledri una leggiadra schiera / annitrendo correa lieta al rumore. / Ma un
asin bigio, rosicchiando un cardo / rosso e turchino, non si scomodò: / tutto
quel chiasso ei non degnò d'un guardo / e a brucar serio e lento seguitò. » Un
explicit citato mille volte che riscatta l'asino da un confronto impari e
stereotipato con il più blasonato cavallo!

Il
fiore rosso cantato da De Andrè
Papaver rhoeas, noto
comunemente come papavero comune o
rosolaccio, è una specie erbacea annuale di pianta
da fiore della famiglia delle Papaveracee. È nativa delle zone temperate ma ha
un'area di distribuzione molto ampia, dall'Africa all'Asia tropicale. In
agricoltura è considerata un'erbaccia infestante. Poiché prospera sui terreno
dissodato, era spesso abbondante nei campi agricoli prima dell'avvento degli
erbicidi, ed infatti distese di papaveri rossi appaiono regolarmente nei campi
incolti; sono però ampiamente coltivate nei giardini e si trovano spesso in
pacchetti di semi etichettati come "miscele di fiori selvatici". Il rosolaccio è
un'erba che cresce come pianta annuale, alta fino a 90 cm. Il fusto è eretto,
coperto di peli rigidi. Tagliato, emette un liquido bianco. I boccioli sono
verdi a forma di oliva e penduli. Il fiore è di un rosso accesissimo, dai petali
delicati e caduchi, spesso macchiato di nero alla base in corrispondenza degli
stami. Fiorisce in primavera da aprile fino a metà luglio; una singola pianta
può produrre fino a 400 fiori in una stagione calda, che durano un solo giorno.
È visitato dalle api per il suo polline di colore nero. Il frutto è una capsula
che contiene molti semi piccoli, reniformi e reticolati. L'allevamento selettivo
ha portato a cultivar di colore giallo, arancione, rosa e bianco.
L'etimologia della parola "papavero" è molto discussa, ma oggi si pensa che si
tratti di una voce composta (come cada-ver), e la prima parte "papa" verrebbe da
una radice indoeuropea che significa "gonfiare". Rhoeas verrebbe invece dal
greco ῥοιάς ("rhoiás"), cioè "melograno", per il suo colore.
Neppure l'origine del papavero è nota con certezza. Come per molte di queste
piante, l'area di origine è spesso attribuita dagli americani all'Europa e dai
nordeuropei all'Europa meridionale. È noto per essere stato associato
all'agricoltura nel Vecchio Mondo sin dai tempi antichi e fin dall'antichità è
stato associato alla fertilità agricola. Ha la maggior parte delle
caratteristiche di una pianta infestante: un ciclo di vita annuale che si adatta
a quello della maggior parte dei cereali, una tolleranza di semplici metodi di
controllo delle infestanti, la capacità di fiorire e seminare prima che il
raccolto venga raccolto e la capacità di formare una banca dei semi di lunga
durata.
Papaver rhoeas contiene l'alcaloide rhoedina, che ha blande proprietà sedative.
Le foglie e il lattice hanno un sapore acre e sono leggermente velenosi per gli
animali al pascolo. Nonostante questo, le giovani foglie della pianta vengono
utilizzate in varie zone del mondo crude oppure preventivamente sbollentate come
gli spinaci, e contribuiscono alla composizione di zuppe o insalate. In Friuli,
per esempio, il cespo di foglie che si sviluppa attorno alla radice all'inizio
della primavera, quando la pianta è ancora poco sviluppata ed è lontana dalla
fioritura, viene consumato lessato o saltato in pentola come verdura nota sotto
il nome di "confenòns". Il sapore è delicato e leggermente amaro. Anche nel
Salento le piantine tenere sono consumate sotto il nome di "paparina fritta",
sbollentate e passate in padella in un soffritto di aglio con l'aggiunta di
olive nere, gherigli di noce ed aromatizzate con buccia d'arancia e barbe di
finocchio. In Romagna, è conosciuta con il nome di "Rosole". I semi neri sono
commestibili e possono essere consumati da soli o come ingrediente nel pane.
L'olio ricavato dal seme è molto apprezzato in Francia. Ricordiamo però ancora
una volta che gli alcaloidi presenti nel papavero sono blandamente tossici, per
cui è sconsigliata l'assunzione abituale di estratti ed infusi ottenuti da
questa pianta, in particolare a bambini ed anziani. I petali contengono un
colorante rosso che viene utilizzato in alcune medicine e vini; anche i petali
essiccati sono occasionalmente usati per dare colore ai pot-pourri. Nella
medicina popolare tradizionale era usato per combattere la gotta e i dolori
articolari. I petali venivano usati per produrre uno sciroppo che veniva
somministrato ai bambini per aiutarli a dormire.
E veniamo alla simbologia. A causa del suolo smosso durante la Prima Guerra
Mondiale per scavare trincee e fortificazioni, i papaveri fiorirono tra le linee
di trincea e le terre di nessuno sul fronte occidentale. Per questo motivo nel
mondo anglosassone Papaver rhoeas è tradizionalmente dedicato alla memoria delle
vittime sui campi di battaglia della prima e della seconda guerra mondiale. Ad
esempio nel Regno Unito, durante il Remembrance Day (l'11 novembre,
commemorazione della fine della Grande Guerra), è diffusa la tradizione di
appuntare un papavero rosso all'occhiello, e per questo si parla informalmente
anche di "Poppy Day". I papaveri sono citati nel poema "In Flanders Fields" del
tenente colonnello canadese John McCrae (1872-1918), una delle poesie in lingua
inglese più citate composte durante la prima guerra mondiale. A questa
simbologia dobbiamo anche gli immortali versi composti dal cantautore genovese
Fabrizio de André (1940-1999) nel testo della sua canzone "La guerra di Piero",
notissima parabola contro tutte le guerre, dedicata ad un soldato che muore
essendosi rifiutato di sparare per primo al nemico: « Dormi sepolto in un campo
di grano: / non è la rosa, non è il tulipano / che ti fan veglia dall'ombra dei
fossi, / ma sono mille papaveri rossi... »
Al simbolo del papavero rosso è legata la locuzione "alto papavero", che sta a
indicare una personalità altolocata o di potere. Il modo di dire deriva
dall'aneddoto raccontato nell'opera "Ab Urbe condita libri" di Tito Livio (59
a.C.-17 d.C.): Sesto Tarquinio chiese al padre, l'ultimo Re di Roma Tarquinio il
Superbo, un consiglio su come impossessarsi della città di Gabii. Il re rispose
decapitando i papaveri più alti del giardino nel quale aveva accolto il
messaggero inviato dal figlio: in tal modo gli comunicò che avrebbe dovuto
eliminare per prime le personalità più influenti della città, che potevano
opporsi a lui con più successo.
Un campo di papaveri rossi è un richiamo all'occhio che è impossibile ignorare,
e difatti molti pittori e fotografi hanno cercato di cogliere e riprodurre la
sensazione di stupore che si prova davanti alla brillantezza del rosso del
papavero. Famosi sono i verdi campi di grano dipinti dai macchiaioli, con tante
macchie rosse tipiche dei papaveri. Tipico esempio ne è "I papaveri" ("Les
Coquelicots"), dipinto nel 1873 da Claude Monet (1840-1926)
Il papavero rosso compare anche su numerosi francobolli, monete e banconote, tra
cui la banconota rumena da 200 lei, la banconota da venti dollari canadesi del
2012 e i francobolli commemorativi del Regno Unito del 2007 per commemorare il
90° anniversario della Battaglia della Somme. Il papavero rosso nel 2002 è stato
votato fiore simbolo della contea di Essex e Norfolk a seguito di un sondaggio
dell'ente di beneficenza per la conservazione delle piante selvatiche Plantlife.
Finito qui? No, perchè il papavero comune è parente stretto del Papaver
somniferum, comunemente noto come papavero da oppio.
Il suo areale nativo è probabilmente il Mediterraneo orientale, ma si è
naturalizzato in gran parte dell'Europa e dell'Asia. A differenza del suo
parente di colore rosso, questo papavero viene coltivato su larga scala per tre
scopi principali. Il primo è quello di produrre semi che vengono mangiati
dall'uomo, comunemente noti come semi di papavero. Il secondo è produrre oppio
destinato principalmente all'industria farmaceutica. Il terzo è produrre altri
alcaloidi, principalmente tebaina e oripavina, che vengono trasformati
dall'industria farmaceutica in farmaci come l'idrocodone e l'ossicodone. Solo
una piccola quantità di Papaver somniferum viene coltivata per scopi
ornamentali.
L'oppio consiste nel lattice essiccato prodotto dai
baccelli del seme di papavero. Esso contiene una classe di alcaloidi presenti in
natura noti come oppiacei, che includono morfina, codeina, tebaina, oripavina,
papaverina e noscapina. Il nome "somniferum" infatti significa "portatore di
sonno", riferendosi alle proprietà sedative di alcuni di questi oppiacei. Il
lattice trasuda dalle incisioni praticate sui baccelli verdi dei semi e viene
raccolto una volta essiccato. La tintura di oppio o laudano è invece costituito
da oppio disciolto in alcool o da una miscela di alcool e acqua, è ancora
commercializzato ma proibito in molti paesi. L'oppio grezzo contiene circa
l'8-14% di morfina in peso secco, e anche di più nelle cultivar ad alto
rendimento; può essere utilizzato direttamente o modificato chimicamente per
produrre oppioidi sintetici come l'eroina, triste piaga di un'intera generazione
ai tempi della mia gioventù.
L'uso del papavero da oppio precede di gran lunga la storia scritta: sono state
ritrovate capsule di Papaver somniferum addirittura negli scavi di palafitte
dell'uomo di Cro-Magnon datate fra i 30.000 e i 20.000 anni fa, anche se non è
possibile stabilire se gli abitanti del sito conoscessero le proprietà di tali
piante. Sappiamo per certo invece che i Sumeri di 5.000 anni fa le conoscevano
bene, e tramandarono l'uso del papavero da oppio alle successive civiltà caldea
e assiro-babilonese: questi ne introdussero l'uso in Egitto e nell'antica Creta
verso il 1500 a.C. Il Libro dei Medicamenti, un antico papiro egiziano,
raccomanda l'uso del papavero da oppio come sedativo. La linfa del Papaver
somniferum fu chiamata "òpion" dagli antichi greci, presumibilmente diminutivo
di "opòs" ("succo"). Il lattice (denso, giallo-verdastro) ottenuto dalla pianta
intera e dai suoi semi, era invece chiamato dai greci mekònion. Altri nomi
dell'oppio sono O-Fu-Jing (lett. "veleno nero") in Cina, "Ahiphema" in India, "Schemeteriak"
in Persia e "Afyun" in Arabia.
Ippocrate, nel IV secolo a.C., consigliava l'oppio come rimedio per numerosi
mali, ma già un secolo dopo Erasistrato metteva in guardia i suoi allievi e i
colleghi medici contro l'uso frequente di questo medicinale, che poteva
rivelarsi gravemente dannoso. L'oppio fece il suo ingresso nella civiltà romana
quando questa occupò la Grecia; Dioscoride, nel I secolo d.C., descrive
accuratamente la pianta del papavero da oppio e le proprietà della sua linfa,
elencando anche una serie di possibili usi. Si deve a Galeno (129-201 d.C.) la
diffusione fra i medici di Roma della teriaca, inventata da Andromaco, medico
personale di Nerone: era un farmaco che conteneva, fra l'altro, una discreta
quantità di oppio. Marco Aurelio ne usò in grande quantità, per cui viene
considerato dagli storici il primo imperatore oppiomane! Dopo la caduta
dell'impero romano non vi sono quasi più notizie sul consumo di oppio in Europa,
mentre nella farmacologia mediorientale venne introdotto verso l'anno Mille dal
medico persiano Ibn Sīnā (980-1037), meglio noto come Avicenna: secondo il suo
discepolo e biografo Abū 'Ubayd al-Jūzjānī fu proprio questa sostanza la causa
della morte del maestro. Allo stesso modo Paracelso (1493-1541) morì intossicato
dall'oppio dopo aver inventato il laudano, sostanzialmente una tintura di
morfina all'1%. Ma già nella seconda metà del Medioevo in Europa il consumo di
oppio era andato aumentando, tanto da suscitare reazioni ufficiali nella classe
medica: la Santa Inquisizione giunse al punto di vietarne l'uso anche come
medicinale. Nel XVI secolo in Turchia e in Egitto l'uso di oppio era
estremamente diffuso a livello popolare. In Cina l'introduzione dell'oppio
avvenne presumibilmente verso il 2800 a.C., ma l'uso popolare iniziò solo molto
più tardi, verso il 1100 a.C., quando iniziò a diffondersi l'usanza di preparare
per alcune festività un dolce a base di oppio. L'uso di oppio in Cina esplose
nel XVII secolo quando l'imperatore vietò l'uso del tabacco da fumo, che i
cinesi usavano mescolare all'oppio, e si iniziò perciò a fumare oppio puro. Il
consumo di oppio aumentò tanto che all'inizio dell'Ottocento i fumatori di oppio
in Cina erano circa 10 milioni, e l'oppio veniva importato dall'India tramite la
potentissima Compagnia Britannica delle Indie orientali, che ne monopolizzava il
commercio in cambio del pregiato tè cinese, molto apprezzato
in patria. Allora l'imperatore Daoguang decise di ridurre le importazioni di
oppio inglese e, poiché le sue disposizioni rimanevano lettera morta, nel 1839
ordinò di distruggere 20.000 casse d'oppio scaricate dalle navi inglesi a Canton,
fatto che scatenò la prima guerra dell'oppio fra Cina e Inghilterra: in seguito
ad essa Hong Kong passò in mani inglesi. Essa fu seguita da una seconda nel
1856, che segnò l'asservimento totale del Celeste Impero alle potenze coloniali.
In Cina nel 1906 venne proibito l'uso dell'oppio che dal 1890 non veniva più
importato dalle colonie inglesi, bensì prodotto nel paese, e nel 1941 il
generale Chiang Kai-Shek ordinò la distruzione di tutte le coltivazioni;
nonostante ciò nel 1946 i fumatori di oppio in Cina erano ancora 40 milioni. Fu
Mao Zedong con i suoi metodi spicci a sradicare definitivamente con successo
questa coltivazione.
In Europa, invece, l'oppio conobbe il suo periodo di massima diffusione nel XIX
secolo: molti poeti e scrittori ne facevano largo uso, fra cui Samuel Taylor
Coleridge, Charles Baudelaire e Thomas Penson De Quincey (1785-1859), autore de
"Le confessioni di un mangiatore d'oppio". Il compositore romantico francese
Hector Berlioz (1803-1869) usò l'oppio come ispirazione, producendo la sua "Symphonie
Fantastique", in cui un giovane artista va in overdose di oppio e sperimenta una
serie di visioni del suo amore non corrisposto. Tuttavia il suo uso rimase per
lo più circoscritto agli ambienti letterari e non si diffuse mai su larga scala,
per la concorrenza del suo principio attivo, la morfina, isolata nel 1802 da
Armand Séquin (1767-1835) che la chiamò così in onore di Morfeo, il dio del
sonno, mentre un anno più tardi Friedrich Sertürner (1783-1841) mise a punto un
metodo economicamente conveniente per isolare la morfina dall'oppio. Com'è noto,
anche Sherlock Holmes viene descritto dal suo autore come fortemente dipendente
dalla morfina. Ancora oggi, invece, i Talebani dell'Afghanistan finanziano il
loro sanguinario regime principalmente con la coltivazione e il commercio
dell'oppio.
Bisogna dire che Papaver somniferum non significa solo oppio. I suoi semi sono
la fonte dell'olio di semi di papavero, un olio commestibile che ha molti usi.
I semi contengono livelli molto bassi di oppiacei e l'olio da essi estratto ne
contiene ancora meno. Il residuo della spremitura dell'olio può essere
utilizzata come foraggio per diversi volatili, soprattutto nel periodo della
muta delle piume. I semi di papavero sono usati come alimento in molte culture:
hanno un sapore cremoso e simile alla nocciola e, se usati con cocco macinato, i
semi forniscono una base di curry unica e ricca di sapore. Possono essere
tostati a secco e macinati per essere utilizzati nel curry. Quando l' Unione
Europea ha tentato di vietare la coltivazione del Papaver somniferum da parte di
privati su piccola scala (come nei giardini personali), i cittadini dei paesi
dell'Europa centro-orientale dove il seme di papavero è molto consumato si sono
opposti con forza, costringendo l'UE a cambiare rotta. Al contrario Singapore,
Iran, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita sono tra le nazioni che vietano
persino di possedere semi di papavero, non solo di coltivare le piante.
Riguardo al laudano, un narcotico e spasmolitico la
cui invenzione come abbiamo detto è attribuita allo svizzero Philippus Aureolus
Theophrastus Bombastus von Hohenheim, detto Paracelso, in realtà la sua ricetta
è dovuta al medico inglese Thomas Sydenham (1624-1689), che lo preparò per primo
in forma liquida. Fu usato nella guerra di secessione americana per alleviare il
dolore dei soldati feriti, soprattutto dopo l'invenzione del fucile a
ripetizione, ma anche per alleviare i disagi psicologici e le "tensioni da
battaglia". Questa prassi causò la nascita dei primi veri morfinomani, i
cosiddetti tossicodipendenti da morfina. Sempre nell'Ottocento il noto filosofo
Friedrich Engels (1820-1895), collaboratore di Karl Marx, ne denunciò l'abuso da
parte della classe operaia inglese: alcuni preparati che avevano come
ingrediente base il laudano, tra cui lo sciroppo Godfrey's Cordial, venivano
somministrati dalle lavoratrici ai loro bambini per calmarli. Con una fiala di
laudano, nel 1862, si suicidò Elizabeth Siddal, modella e compagna di Dante
Gabriel Rossetti (1828-1882). L'artista la celebrò due anni dopo nelle vesti
della Beatrice dantesca in un dipinto, "Beata Beatrix", oggi alla Tate Gallery
di Londra. In "Anna Karenina", romanzo di Lev Tolstoj (1828-1910) pubblicato nel
1878, il personaggio principale, Anna, sotto l'oppressione della gelosia e delle
conseguenze disastrose della sua relazione extraconiugale, inizia ad assumere
laudano sempre più spesso per riuscire a dormire. Ciò contribuirà allo sviluppo
di idee paranoidi e alla progressiva perdita di controllo di se stessa,
portandola infine al suicidio sulle rotaie di un treno. In Italia il suo consumo
è illegale. Meglio stare lontani dalle droghe, di qualunque tipo esse siano!

La
corona di Dioniso
L'edera
(Hedera helix) è una specie di pianta da fiore rampicante e sempreverde della
famiglia delle Araliacee. Il suo areale va dall'Irlanda nord-orientale alla
Scandinavia meridionale, a sud fino al Portogallo e a est fino all'Ucraina,
all'Iran e alla Turchia settentrionale. Essa cresce fino a 20–30 m di altezza
dove sono disponibili superfici adatte (alberi, scogliere, muri). Si arrampica
per mezzo di radichette aeree con cuscinetti che aderiscono fortemente al
substrato. Ciò si ottiene attraverso un complesso metodo di attacco che inizia
quando le radici avventizie che crescono lungo lo stelo entrano in contatto con
la superficie ed estendono i minuscoli peli radicali. Essi penetrano in tutte le
piccole fessure disponibili, secernono nanoparticelle simili a colla e
lignificano. Man mano che si seccano, i peli si restringono e si arricciano,
avvicinando efficacemente la radice alla superficie. La sostanza usata come
colla è un adesivo costituito da nanoparticelle sferiche uniformi di 50-80 nm di
diametro in una matrice polimerica liquida; le analisi chimiche delle
nanoparticelle hanno rilevato solo tracce di metalli, un tempo ritenuti
responsabili della loro elevata resistenza, indicando che sono in gran parte
organici. Un lavoro recente ha dimostrato che le nanoparticelle sono
probabilmente composte in gran parte da proteine di arabinogalattano (AGP), che
esistono anche in altri adesivi vegetali. La capacità di arrampicarsi sulle
superfici varia a seconda delle piante e di altri fattori: Hedera helix
preferisce superfici non riflettenti, più scure e ruvide con pH quasi neutro.
Generalmente prospera in una vasta gamma di pH del suolo, anche se il valore
ideale è 6,5; preferisce posizioni umide e ombreggiate ed evita l'esposizione
alla luce solare diretta, che favorisce l'essiccamento in inverno. Le foglie
sono alterne, lunghe 50–100 mm, con un picciolo di 15–20 mm; sono di due tipi,
con foglie giovani pentalobate su fusti striscianti e rampicanti, e foglie
adulte cordate prive di lobi su fusti esposti al pieno sole, solitamente sulle
chiome degli alberi o sulla cima delle pareti rocciose. I fiori sono prodotti
dalla fine dell'estate fino al tardo autunno, individualmente piccoli, raccolti
in ombrelle di 3-5 cm di diametro, giallo -verdastri e molto ricchi di nettare,
un'importante fonte di cibo nel tardo autunno per api e altri insetti. I frutti
sono bacche da viola-nere a giallo-arancio di 6–8 mm di diametro, che maturano a
fine inverno e sono un'importante fonte di cibo per molti uccelli. In ogni bacca
ci sono da uno a cinque semi, che vengono dispersi dopo essere stati mangiati
dagli uccelli.
Il nome del genere Hedera è affine al greco χανδάνω (khandánō) "prendere,
afferrare", entrambi derivanti dal proto-indoeuropeo *gʰed-, "afferrare,
prendere", per la sua caratteristica di avvinghiarsi ad ogni cosa. L' epiteto
specifico helix invece deriva dal greco antico ἕλιξ (elica) e dal latino "helicem",
"spirale'", usato per la prima volta intorno al 1600. Il nome nel suo insieme ha
quindi il significato di "pianta avvinghiata che si avvolge a spirale". Il nome
inglese "ivy" deriva dall'inglese antico "īfiġ", derivato a sua volta dal
protogermanico *ibahs, che potrebbe essere affine al greco antico ἴφυον ("íphuon"),
che si riferisce non a Hedera helix, ma alla lavanda (Lavandula angustifolia).
Sono note tre sottospecie: H. h. elica, dell'Europa centrale, settentrionale e
occidentale, piante senza rizomi, con frutti maturi viola-neri; H. h. poetarum
Nyman o edera italiana, tipica dell'Europa sudorientale e dell'Asia
sud-occidentale (Italia, Balcani, Turchia), piante senza rizomi con frutti
maturi giallo-arancioni; e H. h. rhizomatifera McAllister, tipica di Spagna
sudorientale, piante rizomatose con frutti maturi viola-neri. Anche le specie
strettamente imparentate Hedera canariensis e Hedera hibernica sono spesso
trattate come sottospecie di Hedera helix, sebbene differiscano per il numero di
cromosomi e quindi non si ibridino facilmente.
Come risultato della sua natura robusta e della sua tendenza a crescere anche
senza l'assistenza umana, l'edera ha raggiunto grande popolarità come pianta
ornamentale, e le piante sfuggite dai giardini si sono naturalizzate al di fuori
del loro areale nativo, tanto che oggi crescono incontrollate in una miriade di
aree selvagge e coltivate. All'interno del suo areale nativo, la specie è molto
apprezzata per attirare la fauna selvatica. I fiori sono visitati da oltre 70
specie di insetti che si nutrono di nettare e le bacche sono mangiate da almeno
16 specie di uccelli.
In Europa l'edera è spesso piantata per ricoprire i muri e il governo bavarese
raccomanda di coltivarlo sugli edifici per la sua capacità di rinfrescare
l'interno in estate, fornendo isolamento in inverno, oltre a proteggere
l'edificio ricoperto di foglie dall'umidità del suolo, dalle fluttuazioni di
temperatura e dall'esposizione diretta alle intemperie. Altri usi includono la
soppressione delle infestanti nelle piantagioni, l'abbellimento di facciate
malmesse e la fornitura di verde aggiuntivo, crescendo sui tronchi degli alberi.
Negli ultimi decenni poi si è scoperto che Hedera helix ha la capacità di
rimuovere dall'aria le sostanze nocive, soprattutto in ambienti chiusi, in
particolare la formaldeide che viene prodotta dagli oggetti elettrici di uso
comune nelle abitazioni. Recenti studi effettuati dalla NASA hanno dimostrato
scientificamente che, per la purificazione dell'aria, l'edera si è dimostrata
una pianta molto efficiente, e per questo spesso viene pubblicizzata come la
migliore pianta da appartamento che si possa avere.
Tuttavia l'edera può essere anche molto problematica: è un rampicante
auto-aggrappante a crescita rapida in grado di causare danni a murature,
grondaie e monumenti, e nascondere difetti strutturali potenzialmente gravi,
oltre a ospitare parassiti indesiderati, persino topi. Le sue radici fibrose
sono difficili da rimuovere, lasciano un'"impronta" antiestetica sui muri e
possono comportare costosi lavori di rifacimento. Per questo sono essenziali
un'attenta pianificazione e posizionamento se si vuole una parete di edera
verde. Hedera helix è molto opportunistica e resistente all'inverno e sopravvive
a temperature di -23,3°C, infatti è etichettata come specie invasiva in molte
parti degli Stati Uniti e la sua vendita o importazione è vietata nello stato
dell'Oregon. Come altre viti invasive, Hedera helix può crescere fino a
soffocare altre piante e creare "deserti di edera". Infatti l'edera può
arrampicarsi sulla chioma di alberi giovani o piccoli in una tale densità che
gli alberi cadono a causa del peso, distruggendo l'habitat della fauna selvatica
nativa; blocca anche il sole dagli alberi che ne hanno bisogno per la
fotosintesi. Si pensa anche che sia un serbatoio per i batteri nocivi.
Le bacche di edera possono essere velenose per l'uomo e per i conigli, a causa
dell'elevato contenuto di saponine, ma gli estratti di edera fanno parte dei
medicinali contro la tosse. In passato le foglie e le bacche venivano assunte
per via orale come espettorante per curare la tosse e la bronchite. Nel 1597
l'erborista britannico John Gerard (1545-1612) raccomandò l'infuso di foglie di
edera per gli occhi irritati e arrossati. Le foglie possono causare gravi
dermatiti da contatto in alcune persone che reagiscono anche alle carote e ad
altri membri delle Apiacee, in quanto contengono lo stesso allergene, il
falcarinolo. È considerata un'erba nociva in tutta l'Australia meridionale e in
Nuova Zelanda.
Nell'antichità l'edera godeva di grande fama: le sue foglie erano usate per
realizzare la corona dei partecipanti alle feste dedicate a Dioniso, alla quale
la pianta era consacrata. Secondo la leggenda un giovane di nome Cisso, il quale
si esibiva nelle feste in onore di Dioniso con salti ed acrobazie spericolate,
ebbe un giorno un grave incidente. Il dio, che si era affezionato al giovane,
per impedirne la morte lo trasformò quindi in una pianta, l'edera, capace di
arrampicarsi su qualsiasi superficie. Un altro mito narra che l'edera comparve
subito dopo la nascita di Dioniso per proteggerlo, dato che era rimasto orfano
di madre (Semele aveva chiesto a Zeus di mostrarsi a lei nel suo vero aspetto, e
il suo fuoco divino la aveva carbonizzata). Il padre allora prese il bambino,
nato prematuro, e se lo cucì in una coscia. Alcuni mesi dopo Dioniso uscì dal
ginocchio, e da qui deriva il suo nome, che significa "ginocchio di Zeus".
L'edera inoltre avvolse tutta la casa di Cadmo a Tebe in cui il dio era nato, e
per questo i tebani considerarono sacra al dio una corona di rami d'Edera e la
chiamarono "perikiósos", "avvolgitore di colonne". Dalla pianta prendeva il nome
anche la fonte Kissoûssa presso Tebe, dove le ninfe avrebbero bagnato il piccolo
Dioniso dopo la nascita. Da queste leggende nacque l'abitudine artistica di
raffigurare Bacco con una corona d'edera sul capo e con il calice di vino
avvolto dai rami di edera. Essendo sacra a Dioniso, tra i greci e poi tra i
latini si diffuse la convinzione che circondare la fronte con una corona di
edera prevenisse gli effetti dovuti alle intossicazioni da eccesso di vino. La
convinzione era così radicata che, secondo Plinio il Vecchio, per placare i
postumi delle sbornie era sufficiente mettere a bollire alcune foglie di edera
nel vino e berlo. Gli antichi credevano inoltre,che la nostra pianta con le sue
foglie potesse separare l'acqua dal vino. In realtà ciò non è vero, ma al giorno
d'oggi si sa che le fibre delle foglie di edera sono in grado di assorbire le
molecole di alcool e di altri liquidi. Ancora oggi nelle osterie dei piccoli
centri urbani è tradizione paesana appende fuori dall'uscio un rametto di edera
per segnalarne la produzione di vino.
Per via delle sue foglie a forma di cuore la nostra pianta divenne nel
vocabolario popolare dell'amore un simbolo della Passione che spinge a unirsi
strettamente, in un abbraccio che si vorrebbe eterno, con l'amato o con l'amata:
un abbraccio simile appunto a quello dell'Edera intorno al tronco di un albero.
Per questo motivo nell'antica Grecia corone di foglie di edera erano adoperate
per incoronare la testa degli sposi il giorno delle nozze, ed in India la nostra
pianta è considerata anche l'emblema della concupiscenza. Nella mitologia
celtica, invece, l'edera è connessa al culto del serpente e del drago, che
rappresentano simboli dell'aldilà.
Scrisse Catullo: « Mentem amore revinciens / Ut tenax hedera huc et illuc /
Arborem implicat errans. » (Carm. LXI, 33). E Orazio: « Me doctarum hederae
proemia frontium / Dis miscent superis » (Odi, libro I) Ne parla anche Giosuè
Carducci: « L'olmo e la verde sposa / Vedi in florido amplesso accolti e
stretti. » ("A Neera") Una foglia di edera era il simbolo politico del Partito
Repubblicano Italiano.
Per concludere, a sorpresa l'edera ha un ruolo importante anche nella storia
della Matematica! Infatti la cissoide di Diocle è una curva piana dotata di una
cuspide, di equazione y2 = (2a – x) x3. Fu studiata da
Diocle, matematico greco della cui vita nulla ci è pervenuto (si pensa che sia
vissuto tra il III e il II secolo a.C.), che la utilizzò per risolvere il famoso
problema della duplicazione del cubo. Il filosofo Teone di Smirne racconta che
gli abitanti di Delo, avendo interrogato l'oracolo di Apollo sul modo di
liberarsi da una grave pestilenza, ricevettero l'ordine di « raddoppiare l'ara
del loro tempio », di forma cubica. Essi costruirono un altare di spigolo
doppio, e la pestilenza infuriò peggio di prima, Allora fu fatto notare che,
raddoppiando lo spigolo, il volume era diventato otto volte quello iniziale,
mentre evidentemente Apollo voleva che ad essere raddoppiato fosse il volume
dell'altare. Questo, noto anche come "problema di Delo", divenne uno dei più
classici problemi dell'antica geometria greca, insolubile se si usano solo riga
e compasso. Ci si cimentarono tra gli altri Ippocrate di Chio, che lo ridusse al
problema dell'inserzione di due medi proporzionali tra due segmenti dati,
Menecmo, che usò l'intersezione di tre coniche, e appunto Diocle, il quale usò
la curva da lui studiata. Ebbene, la parola "cissoide" proviene dal greco
kissoeidēs, "a forma di edera", perchè tale forma ha la figura compresa tra la
cissoide e la circonferenza utilizzata per risolvere il "problema di Delo".

Il
fiore d'oro degli imperatori giapponesi
Il
crisantemo è una pianta erbacea perenne da fiore del genere Chrysanthemum,
che fa parte della famiglia delle Asteraceae. Le foglie sono alterne, divise in
foglioline, e possono essere lobate oppure seghettate, collegate a fusti con
basi pelose. I crisantemi iniziano a fiorire all'inizio dell'autunno;
l'infiorescenza è composta da una serie di diversi capolini, ma talvolta è un
capolino solitario. I capolini si presentano in varie forme, e possono essere a
margherita o decorativi, a forma di pompon o di bottone. I moderni crisantemi
coltivati sono più appariscenti dei loro parenti selvatici; oltre al
tradizionale giallo sono disponibili molti altri colori come il bianco, il viola
e il rosso. Il frutto è un achenio. I Chrysanthemum perenni a fiore grande
vengono coltivati per la produzione del fiore reciso, moltiplicandoli a marzo
per mezzo di talee erbacee ricavate dal taglio a raso terra dalle vecchie
ceppaie; richiedono esposizione in pieno sole, annaffiature regolari,
concimazioni settimanali con fertilizzanti liquidi o con liquame di stalla
diluito; per ottenere fiori più numerosi e piccoli si cimano le varietà
predisposte per questo tipo di produzione, mentre per la produzione del fiore
reciso si deve provvedere alla posa di tutori per ogni stelo e alla soppressione
dei bottoni floreali non desiderati. Si stima che nel mondo esistano oltre
20.000 cultivar di crisantemo, di cui almeno 7.000 nella sola Cina!
Il nome "crisantemo" deriva dal greco "χρυσός" (chrysos), "oro", e "ἄνθεμον" (anthemon),
"fiore". Originariamente avrebbe indicato il ranuncolo, per poi passare ad
indicare il fiore asiatico. Il genere Chrysanthemum fu descritto per la prima
volta da Linneo nel 1753, ed allora comprendeva 14 specie; alcune di esse poi
furono inserite nel genere Dendranthema. La denominazione di questi generi è
stata a lungo controversa, finché una sentenza del Congresso Botanico
Internazionale nel 1999 ha rinominato la specie che definisce il genere "Chrysanthemum
indicum" e ha incluso altre specie nei generi Argyranthemum, Glebionis,
Leucanthemopsis, Leucanthemum, Rhodanthemum e Tanacetum.
I crisantemi (in cinese 菊花, "Júhuā") furono coltivati per la prima volta in
Cina come piante da fiore già nel XV secolo a.C. Nel 1630 se ne conoscevano
oltre 500 cultivar nella sola Cina. La coltivazione del crisantemo in Giappone
iniziò durante i periodi Nara e Heian (dall'inizio dell'VIII alla fine del XII
secolo) e guadagnò popolarità nel periodo Edo (dall'inizio del XVII alla fine
del XIX secolo); qui sono state create molte forme, colori e varietà di fiori.
Varie cultivar di crisantemi create nel periodo Edo erano caratterizzate da una
notevole varietà di forme e di colori, e furono esportate in Cina a partire
dalla fine del XIX secolo, cambiando il modo in cui venivano coltivati i
crisantemi cinesi e la loro popolarità. Nel periodo Meiji (1867-1912) furono
create molte cultivar con fiori di oltre 20 cm di diametro, chiamate Ogiku
(letteralmente "Grande Crisantemo"). Il sigillo imperiale del Giappone è un
crisantemo e l'istituzione della monarchia è anche chiamata Trono del
Crisantemo. In autunno, quando i fiori sbocciano, in tutto il Giappone si
svolgono numerosi festival e spettacoli. Il Giorno del Crisantemo (菊の節句, "Kiku
no Sekku") è una delle cinque antiche feste sacre, e lo si celebra il 9° giorno
del 9° mese. Fu introdotto nel 910, quando la corte imperiale tenne la sua prima
mostra di crisantemi. I crisantemi entrarono nell'orticoltura americana nel
1798, quando l'ingenere John Stevens (1749-1838) importò dall'Inghilterra una
varietà conosciuta come "Dark Purple", allo scopo di accrescere le attrazioni
all'interno degli Elysian Fields a Hoboken, nel New Jersey. La fondazione
dell'industria americana dei crisantemi risale al 1884, quando i fratelli
Enomoto di Redwood City, in California, coltivarono estensivamente i primi
crisantemi in quello stato. Ma già il 5 e 6 novembre 1883, a Filadelfia, la
Pennsylvania Horticultural Society (PHS), su richiesta della Florists and
Growers Society, aveva tenuto il suo primo Chrysanthemum Show nella
Horticultural Hall: questo fu il primo di numerosi eventi sui crisantemi
presentati al pubblico dalla PHS.
Il Chrysanthemum cinerariaefolium, classificato anche come Tanacetum
cinerariaefolium, meglio noto piretro ed originario della Dalmazia, è largamente
utilizzato per produrre insetticida fn dal 1860: i componenti attivi chiamati
piretrine, presenti negli acheni, vengono estratti e venduti sotto forma di
oleoresina. Viene utilizzato come sospensione in acqua o olio o come polvere: le
piretrine attaccano il sistema nervoso di tutti gli insetti e inibiscono le
punture delle zanzare femmine. Sono dannose per i pesci, ma molto meno tossici
per i mammiferi e gli uccelli rispetto a molti insetticidi sintetici. Non sono
persistenti, essendo biodegradabili, e si decompongono facilmente se esposti
alla luce. Invece i cosiddetti piretroidi come la permetrina sono insetticidi
sintetici a base di piretro naturale. Nonostante ciò, le foglie del crisantemo
ospitano sovente parassiti distruttivi, come le mosche minatrici del genere
Agromyzidae.
Non ci crederete, ma il crisantemo ha persino degli usi culinari! I fiori di
crisantemo gialli o bianchi della specie Chrysanthemum morifolium in alcune aree
dell'Asia orientale vengono bolliti per preparare una sorta di tè. La bevanda
risultante è conosciuta semplicemente come tè al crisantemo (菊花茶, "júhuā chá" in
cinese). In Corea viene consumato un vino di riso aromatizzato ai fiori di
crisantemo detto gukhwaju (국화주). Nella cucina cinese le foglie di crisantemo
vengono cotte al vapore o bollite e consumate come verdura. I fiori possono
essere aggiunti a piatti come il mixian in brodo o la zuppa densa di carne di
serpente (蛇羹) per esaltarne l'aroma. Il sashimi della cucina giapponese (刺身,
pesce fresco crudo o carne tagliata a pezzi sottili con salsa di soia) utilizza
piccoli crisantemi come guarnizione.
Il crisantemo ha un simbolismo culturale tra i più diffusi nel regno vegetale.
In alcuni paesi europei come Francia, Belgio , Spagna, Polonia, Ungheria,
Croazia ed anche Italia, i crisantemi sono legati ai riti funebri ed utilizzati
per decorare le tombe. In Cina, Giappone e Corea tale simbolismo è sconosciuto,
tuttavia in Asia orientale i crisantemi bianchi simboleggiano avversità, lamento
e dolore. Negli Stati Uniti, invece, il fiore ha solitamente significato
positivo, nonostante l'importante eccezione rappresentata da New Orleans. Nel
linguaggio vittoriano dei fiori, il crisantemo aveva diversi significati. Il
crisantemo cinese significava allegria, mentre il crisantemo rosso era usato per
dire "Ti amo" e il crisantemo giallo simboleggiava l'amore non corrisposto.
In Cina il crisantemo è il fiore delle città di Pechino, Tongxiang e Kaifeng. La
tradizione della coltivazione di diverse varietà di crisantemi in queste città
risale a 1600 anni fa e raggiunse il culmine durante la dinastia Song. E' molto
rinomato il Festival del Crisantemo di Kaifeng, che dal 1983 si tiene tra il 18
ottobre e il 18 novembre di ogni anno. L'antica città cinese di Xiaolan era un
tempo chiamata Ju-Xian, che significa "città dei crisantemi". Il crisantemo è
uno dei "Quattro Gentiluomini" (四君子) della Cina; gli altri sono il fiore di
pruno, l' orchidea e il bambù. Si dice che il crisantemo fosse il fiore
preferito di Tao Qian (365-427), uno dei maggiori poeti cinesie, ed essendo
considerato il simbolo della nobiltà e della longevità, è l'argomento di
centinaia di poesie cinesi. Il "fiore d'oro" a cui si fa riferimento nel film
del 2006 "La maledizione del fiore d'oro" è proprio un crisantemo. La medicina
popolare cinese raccomanda due tipi di crisantemo per uso medico, detti Yejuhua
e Juhua. Storicamente si dice che Yejuhua tratti il carbonchio, i foruncoli,
la congiuntivite, il mal di testa e le vertigini, mentre Juhua cureebbe il
raffreddore, il mal di testa, le vertigini e la congiuntivite. Una curiosità:
l'espressione cinese "porta del Crisantemo" (菊花门, "jú huā mén"), è
un'espressione gergale per indicare l'ano.
In Giappone il crisantemo è stato utilizzato sin dal X secolo come tema della
waka, un particolare tipo di poesia tradizionale giapponese costituita da una
strofa di 5 versi di 5-7-5-7-7 sillabe rispettivamente), come dimostra il "Kokin
Wakashū", una delle più famose antologie di Waka. Nel XII secolo, durante il
periodo Kamakura, quando l'imperatore in pensione Go-Toba (1180-1239) lo adottò
come stemma di famiglia ("mon") della famiglia imperiale, in Giappone iniziò a
simboleggiare l'autunno. L'attuale stendardo dell'Imperatore del Giappone è
costituito da un crisantemo dorato di sedici petali posto al centro di uno
sfondo rosso; l'Imperatrice utilizza lo stesso simbolo, ma a forma di coda di
rondine; l'Ordine Supremo del Crisantemo è un'onorificenza giapponese conferita
dall'imperatore su indicazione del governo giapponese. Oggi, ogni autunno, si
tengono mostre di crisantemi allo Shinjuku Gyo-en, al Santuario Meiji e al
Santuario Yasukuni di Tokyo. Anche in Corea si tiene una serie di mostre
floreali come il Festival del crisantemo di Masan Gagopa. I crisantemi rimangono
ancor oggi un motivo comune per le arti tradizionali giapponesi e coreani come
la porcellana, gli oggetti laccati e i kimono, e la coltivazione del crisantemo
è ancora praticata attivamente come hobby da molti giapponesi che partecipano a
concorsi appositi. Le "bambole di crisantemo", spesso raffiguranti personaggi di
fantasia provenienti sia da fonti tradizionali come il teatro Kabuki che da
fonti contemporanee come i cartoni Disney, vengono esposte durante i mesi
autunnali, e la città di Nihonmatsu ospita ogni autunno la "Mostra delle bambole
di crisantemo".
Il crisantemo però non è il simbolo reale del solo Giappone: compare anche in
uno scudo in bronzo all'interno dello stemma del Regno di Giordania, trattandosi
di un motivo comune nell'arte e nell'architettura araba. In Iran i crisantemi
erano associati all'angelo zoroastriano Ashi Vanghuhi (letteralmente "buone
benedizioni"), di sesso femminile. In Australia, durante la festa della mamma,
che cade a maggio quando il fiore è di stagione, tradizionalmente si indossa un
crisantemo bianco per onorare le proprie mamme, a cui vengono regalati mazzi di
crisantemi (un uso che in Europa farebbe rizzare i capelli in testa). Negli
Stati Uniti il crisantemo è stato riconosciuto nel 1966 come il fiore ufficiale
della città di Chicago dal sindaco Richard J. Daley, ed è anche il fiore simbolo
della città di Salinas, in California.
Nei paesi europei il crisantemo è il fiore che tradizionalmente si porta ai
propri cari defunti al cimitero ed è generalmente associato al lutto. Una
probabile ragione di tale usanza è il fatto che la pianta fiorisce tra la fine
di ottobre e l'inizio di novembre, in coincidenza con il Giorno dei Morti (il 2
novembre). E non dimentichiamo che nel 1890 Giacomo Puccini (1858-1924) scrisse
"Crisantemi", un movimento per quartetto d'archi, in memoria del suo amico
Amedeo di Savoia (1845-1890), Duca d'Aosta e Re di Spagna dal 1870 al 1873,
deceduto a soli 45 anni durante la
pandemia di influenza russa.
Chiudiamo, come al solito, con una bella leggenda dedicata a questo fiore, e
proveniente dal Giappone. In una casetta in mezzo al bosco vivevano una mamma e
la sua bambina, e intorno alla casetta sbocciavano bellissimi fiori. Un giorno
la mamma della bimba si ammalò gravemente; allora ella colse uno dei fiori, cose
al tempio della dea Amaterasu e glielo offrì, chiedendole di far guarire la sua
mamma. Mentre pregava sentì una voce dal cielo: "La tua mamma vivrà tanti anni
quanti sono i petali del fiore che mi hai donato!" La bimba si accorse
inorridita che il fiore aveva solo quattro petali, ma si sa che ognuno di noi
farebbe l'impossibile per salvare la propria mamma. E così, la bimba ebbe
un'idea: si tolse dai capelli lo spillone che teneva ferma la crocchia, e con
essa tagliò i petali in finissime striscioline. Così i petali divennero decine,
e la mamma guarì e visse ancora tantissimi anni con l'amata figlia. Era nato il
crisantemo, il fiore dai mille petali, sbocciato dall'amore infinito di una
bambina nei confronti della propria cara mamma.

Il
fiore dorato che ispirò Leopardi
E veniamo alla
ginestra. Genisteae è una tribù di alberi, arbusti
e piante erbacee nella sottofamiglia della Faboidee della famiglia delle Fabacee.
Comprende tra le altre la ginestra, il lupino e il maggiociondolo. La maggior
parte dei generi è originaria dell'Europa, dell'Africa, delle Isole Canarie,
dell'India e dell'Asia sud-occidentale. Le Genisteae comparvero tra 35 e 30
milioni di anni fa, nel periodo del Cenozoico chiamato Oligocene). I membri di
questa tribù formano una vera e propria clade monofiletica, come hanno
dimostrato le analisi genetiche odierne. La ginestra odorosa (Spartium junceum),
nota anche come ginestra comune, è una delle specie più diffuse della famiglia.
È una pianta perenne a portamento arbustivo, alta da mezzo metro a tre metri. Il
lungo fusto è verde, cilindrico, ramosissimo, abbastanza resistente da essere
difficile strapparlo da suolo a mani nude. Le foglie sono lanceolate, i fiori
sono portati in racemi terminali di colore giallo vivo. L'impollinazione è
entomogama; fiorisce nel periodo fra maggio e luglio e i frutti sono dei legumi;
i semi vengono lasciati cadere per gravità a poca distanza dalla pianta madre.
Risulta endemica in gran parte dell'area del bacino del Mediterraneo e cresce in
zone soleggiate dal livello del mare fino a 1200 metri di quota. Predilige i
suoli aridi e sabbiosi, ma può vegetare anche su terreni argillosi, purché non
siano troppo umidi con acque stagnanti. Il metodo più utilizzato per coltivarla
è la propagazione per seme: la semina si effettua in settembre oppure da marzo a
metà aprile. I tagli di ringiovanimento sono di ostacolo alla fioritura e alla
fruttificazione; pertanto, se si vogliono ottenere fiori e semi, occorre
lasciare inutilizzato, per cinque o sei anni, un numero adeguato di piante.
Molto popolare sulle coste del Nordamerica, la ginestra dei carbonai (Cytisus
scoparius, in tedesco Besenginster) è stata introdotta come pianta ornamentale
(in California dal 1860) ed è nota in gran parte degli stati del Pacifico come
"ginestra scozzese". Purtroppo si è naturalizzata ed è diventata un'erba
invasiva, a causa della sua aggressiva dispersione dei semi, e la sua rimozione
si è rivelata molto difficile; è una delle principali specie problematiche anche
nelle zone più fresche e umide dell'Australia meridionale e della Nuova Zelanda,
poiché spazza via rapidamente la vegetazione autoctona e cresce in modo più
prolifico nelle aree meno accessibili.
Genista tinctoria (ginestra del tintore, nota anche come erba verde del
tintore), fornisce un utile colorante giallo ed è stata coltivata
commercialmente per questo scopo in alcune parti della Gran Bretagna all'inizio
del XIX secolo. I panni di lana venivano tinti di giallo con quest'erba, quindi
erano immersi in una vasca di colorante blu indaco per produrre il famoso "Kendal
Green" (questo è anche un nome comune locale per la pianta). La Ginestra
dell'Etna (Genista aetnensis) è una specie endemica della Sicilia, dove cresce
sul versante orientale dell'Etna,e della Sardegna orientale. Resiste alla
siccità e cresce spontaneamente in Sicilia, ma è presente anche in Calabria ed è
stata introdotta, per motivi di rimboschimento, sul Vesuvio e sui monti
Peloritani.
Altre specie di ginestre popolari in orticoltura sono la ginestra viola (Chamaecytisus
purpureus), cosiddetta per il colore dei fiori viola; la ginestra dell'Atlante (Argyrocytisus
battandieri), dal fogliame argentato; la ginestra nana (Cytisus procumbens), la
ginestra provenzale (Cytisus purgans) e la ginestra spagnola (Spartium junceum).
Il tagasaste (Chamaecytisus proliferus), originario delle Isole Canarie, è
ampiamente coltivato come foraggio per le pecore. Molte delle ginestre più
apprezzate nei giardini però sono ibridi, in particolare la ginestra di Kew
(ibrido tra Cytisus ardoinii e Cytisus multiflorus) e la ginestra di Warminster
(ibrido tra Cytisus purgans e Cytisus multiflorus)
L'estratto dei fiori è una fragranza ricca con una nota burrosa particolare, che
viene prodotto per lo più a Grasse, in Provenza, a partire da fiori provenienti
dalla Calabria. La "concreta di ginestra" è una sostanza cerosa intensamente
profumata, di colore giallo bruno, che ricorda il miele e la cera d'api sia nel
colore che nel profumo. La concreta viene ricavata per mezzo di solventi (come
l'esano) il prodotto finale è un miscuglio di oli essenziali, acidi grassi e
cere. La distillazione sottovuoto di questa sostanza fornisce una sostanza
aromatica denominata genêt absolu, ossia "ginestra assoluta". Dai fusti si può
estrarre una fibra tessile; questa specie di ginestra è utilizzata nell'ambito
della cesteria per produrre i fondi e i bordi dei cesti. Essendo una pianta che
sviluppa le sue radici in profondità, può essere utilizzata per consolidare
terreni e per la stabilizzazione delle dune sabbiose. Sono ampiamente utilizzate
anche come piante paesaggistiche ornamentali e per la bonifica di terreni
incolti, ad esempio resti di miniera.
Può sembrare incredibile, ma alcune parti della ginestra sono commestibili! In
particolare i fiori possono essere usati come sostituti dei capperi o aggiunti
ad altre verdure nelle insalate. Il seme tostato è uno dei tanti surrogati del
caffé. Si consiglia però un uso moderato di questa pianta
in quanto può contenere sostanze tossiche. Secondo la medicina popolare la
ginestra avrebbe molte proprietà medicamentose: sarebbe antiaritmica (regola
l'azione del cuore); antireumatica (attenua i dolori dovuti all'infiammazione
delle articolazioni); cardiotonica (regola la frequenza cardiaca); catartica
(avrebbe proprietà generiche di purificazione dell'organismo); diuretica
(facilita il rilascio dell'urina); emetica (utile in caso di avvelenamento in
quanto provoca il vomito); vasocostrittrice (restringe i vasi sanguigni
aumentandone la pressione). In base a quest'ultima proprità, è necessario
prestare attenzione prima di assumerla, specie se si stanno già prendendo
farmaci contro l'ipertensione. Viene inoltre sconsigliata in caso di
ipersensibilità alle sue componenti e in gravidanza, in quanto può provocare
l'aborto.
L'etimologia del nome latino Genista è molto controversa. Secondo il professor
Guido Borghi dell'Università di Genova, se ammettiamo che fosse ereditaria
indoeuropea in latino (non ci sono veri motivi per negarlo) e che sia da
confrontare col lettone "dzenulis", "stimolo" (da "punta") e col medioirlandese
"geind", "cuneo, spicchio", l'antecedente indoeuropeo doveva suonare già
praticamente come in latino ed essere formato da una radice √*gen- che, sulla
base di questa stessa interpretazione, significherebbe più o meno "pungere". Il
suo nome inglese "broom" e quello tedesco "besen" derivano invece dal germanico
occidentale *bráma- (antico alto tedesco "brâmo", "rovo"), a sua volta da una
radice germanica "bræ̂m-" probabilmente collegata al proto-indoeuropeo *bh(e)rem-,
"arbusto spinoso". L'uso dei rami di queste piante (soprattutto della specie
Cytisus scoparius) per realizzare scope ha dato origine nel XV secolo al termine
inglese "broom" con cui oggi si indica la scopa, sostituendo gradualmente
l'antico inglese "besema", che sopravvive come forma dialettale. Invece il nome
del genere Cytisus deriverebbe dalla parola greca "kutisus", usato per indicare
una specie di trifoglio (in riferimento alla forma delle foglie), che a sua
volta potrebbe derivare da qualche idioma dei primi abitatori dell'Asia Minore.
Della ginestra in età classica parlano il greco Teofrasto e il romano Plinio il
Vecchio. Secondo Plinio, le ceneri della Ginestra contenevano oro, perchè il
colore splendente della sua fioritura ricorda il sole. É possibile che per gli
antichi Ebrei la parola "ginestra" designasse il ginepro e in particolare lo
Juniperus oxycedrus, della famiglia delle conifere. I poveri ne mangiavano le
radici amare, come attesta la Bibbia: « Da lungo tempo regione desolata,
raccogliendo erbe amare accanto ai cespugli e radici di ginestra per loro cibo.
» (Gb 30,4). La ginestra è citata anche come luogo di riposo di Elia sfinito nel
deserto, dopo essere stato costretto alla fuga dalla regina pagana Gezabele: «
Egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una
ginestra. Desideroso di morire, disse: "Ora basta, Signore! Prendi la mia vita,
perché io non sono migliore dei miei padri." Si coricò e si addormentò sotto la
ginestra. Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: "Àlzati, mangia!" » (1Re
19,4-5).
È noto sin dall'antichità il suo impiego come pianta da fibra. Fenici,
Cartaginesi, Greci e Romani la utilizzavano per la produzione di stuoie, corde e
vari manufatti. L'industria rurale del panno ginestrino si ritrova ancor oggi in
varie regioni del Mediterraneo, e dai primi del novecento si riscontrano notizie
su ginestrifici nei comuni di Prato, Scandicci e Montelupo Fiorentino.
L'estrazione della fibra di ginestra era preceduta dalla raccolta degli steli in
mazzi sistemati poi a macerare; completata la macerazione, i viscidi fasci
vegetali presentavano una buccia che si staccava facilmente. La "scorticatura"
era realizzata scartando la parte esterna e separandola dalla fibra; i fasci poi
erano essiccati e la battitura era realizzata a mano con un bastone di legno
finché la fibra non acquisiva un colore bianco. Il residuo morbido era poi
utilizzato per imbottire i materassi, mentre quello legnoso, una volta
essiccato, era usato per avviare il fuoco. I filamenti destinati alla filatura
erano "pettinati" e passati sopra una tavola di legno chiodata fino a ottenere
una fibra sottile per tessuti leggeri. Poi la fibra era trasformata in filato
mediante l'utilizzo di rudimentali attrezzi fatti a mano, infine il filato era
raccolto e pronto per la tessitura.
La ginestra ha il suo posto nella storia grazie ai re della dinastia dei
Plantageneti i quali, considerando anche i rami collaterali, regnarono
sull'Inghilterra, sull'Irlanda e su vaste aree della Francia dal 19 dicembre
1154, anno dell'ascesa al trono di Enrico II al termine di un periodo di
anarchia, fino al 22 agosto 1485, quando lo shakespeariano Riccardo III fu
ucciso nella Battaglia di Bosworth. Essi infatti avevano nel loro stemma una
pianta di ginestra, "planta genista" in latino, originariamente l'emblema di
Goffredo d'Angiò, padre di Enrico II. La ginestra selvatica è ancora comune
nelle zone aride dell'Angiò, in Francia. Anche Carlo V di Francia (1364-1380) e
suo figlio Carlo VI (1380-1422) usarono il baccello della pianta della ginestra
come emblema per colletti e distintivi della livrea.
Nel sonetto "La Nunziata" del 12 gennaio 1832, così il poeta romanesco Giuseppe
Gioacchino Belli (1791-1863) riscrive la pagina evangelica dell'Annunciazione: «
Ner mentre che la Verginemmaria / se maggnava un piattino de minestra, /
l'angiolo Grabbiello via via / vieniva com'un zasso de balestra. / Per un vetro
sfasciato de finestra / j'entrò in casa er curiero der Messia; / e co ‘na rama
immano de ginestra / prima je recitò ‘na vemmaria. » Ma soprattutto, i più
conoscono la ginestra grazie all'omonima opera di Giacomo Leopardi (1798-1837):
« Qui su l'arida schiena / del formidabil monte / sterminator Vesevo, / la qual
null'altro allegra arbor nè fiore, / tuoi cespi solitari intorno spargi, /
odorata ginestra, / contenta dei deserti... » Si tratta della penultima lirica
di Leopardi, scritta nella primavera del 1836 a Torre del Greco nella villa
Ferrigni e pubblicata postuma nell'edizione dei "Canti" nel 1845. Il poeta di
Recanati sceglie questo fiore, che aveva visto crescere sulle pendici del
Vesuvio, come simbolo della resistenza umana di fronte al destino inevitabile
che la natura riserva all'uomo. Un simbolo coraggioso e malinconico, che però
accetta con umiltà il suo destino, a differenza dell'uomo, che anela invano
all'immortalità. Insomma, tutto il testamento leopardiano in un fiore!!

Il
fiorellino blu caro al Romanticismo
Ricordo che, da ragazzo,
compravo ogni sabato la "Settimana Enigmistica" sfidando me stesso a risolvere
tutti i rebus prima che l'autobus da scuola mi riportasse a casa, e una volta
c'era un quesito relativo a un'indagine poliziesca realizzata a fumetti, un caso
che il lettore doveva risolvere. In essa era stato ucciso un insegnante di greco
che, prima di morire, aveva scritto su un foglio "orecchio di topo". Mi è stato
facile indovinare la soluzione del quesito: ad essere arrestato era il suo
assistente Aristoteles Myosotis, perchè in greco "myosotis" (μυοσωτίς)
significa proprio "orecchio di topo". Orbene, siccome il nome scientifico del
genere di piante da fiore note come nontiscordardimè
è proprio Myosotis, per la presunta somiglianza delle loro foglie con i
padiglioni auricolari del suddetto roditore, ora vi parlerò proprio di esse.
La specie tipo è Myosotis scorpioides (chiamata anche "erba scorpione" a causa
della curvatura a spirale della sua infiorescenza). I Myosotis sono piante annuali o perenni,
erbacee, con fiori dotati di cinque sepali e petali, il cui diametro misura al
massimo 1 cm o meno. Possono essere di colore
blu, rosa, bianco o giallo con centro giallo.
Fioriscono tipicamente in primavera, subito dopo lo scioglimento della neve
negli ecosistemi alpini.
I semi sono contenuti in piccoli baccelli a forma di tulipano lungo lo stelo
fino al fiore. I baccelli si appiccicano ai vestiti quando vengono sfiorati e alla
fine cadono, lasciando che il piccolo seme all'interno del baccello germini
lontano dalla pisnta genitrice. I semi possono essere raccolti posizionando un foglio di carta sotto
gli steli e scuotendo i baccelli sulla carta.
Le specie Myosotis sono cibo per le larve di alcune specie di lepidotteri come
le Xestia c-nigrum.
Questo genere è diffuso nell'Eurasia occidentale, con circa 60 specie note, e in Nuova Zelanda con circa 40 specie
endemiche. Poche specie sono originarie di Nord America, Sud
America e Papua Nuova Guinea. Naturalmente oggi le specie di Myosotis sono comuni in tutte le latitudini temperate a causa della
diffusione di cultivar molto popolari nei giardini di tutto il mondo. Preferiscono gli habitat
umidi, e di conseguenza, nelle località in cui non sono native, spesso si rifugiano nelle zone umide
e sulle sponde dei fiumi. L'analisi genetica indica che il genere ha avuto
origine nell'emisfero settentrionale e che le specie originarie di Nuova
Zelanda, Australia, Nuova Guinea e Sudamerica formano un lignaggio di specie
strettamente correlate che probabilmente derivano da un singolo evento di
dispersione nell'emisfero meridionale. Il nontiscordardimè delle Isole Chatham,
invece appartiene al genere Myosotidium (le Chatham sono un arcipelago del
Pacifico meridionale amministrato dalla Nuova Zelanda).
Degli oltre 510 nomi registrati di questo genere, attualmente sono accettate
solo 152 specie. Secondo il botanico Sandro Pignatti (1930-), autore del più
recente trattato di floristica relativo all'intero territorio nazionale, in
Italia esistono 19 specie endemiche, di cui la più famosa è Myosotis alpestris o
nontiscordardimè alpino. Esso ha un fusto eretto che raggiunge i 30 cm di
altezza, ha foglie piccole e ispide ed i fiori celesti, blu, bianco, rosa e
raramente gialli (il centro del fiore è giallo). Predilige le zone molto
soleggiate dell'arco alpino. Due parole anche su Myosotis sylvatica, il
"nontiscordardimé dei boschi", dai fiori blu molto apprezzati. Ampiamente
coltivato in tutti i climi temperati, è particolarmente associato ad aiuole
ricche di altre specie a fioritura primaverile, in particolare narcisi,
tulipani, violacciocche e primule. In genere i semi vengono seminati un anno per
fiorire l'anno successivo. Sebbene di breve durata, le piante si autoseminano
facilmente in situazioni favorevoli e mantengono la crescita delle foglie
durante l'inverno. Tra le varie cultivar di Myosotis sylvatica ricordiamo "Blue
Basket", una varietà alta con fiori di un blu profondo; "Musica", eretta e dai
fiori grandi; "Pompadour", compatta, globosa e con grandi fiori di colore rosa;
"Palla di neve" con fiori bianchi; e "'Victoria Rose", con fiori di un rosa
brillante.
A questo fiorellino è associato un simbolismo molto complesso, soprattutto nei
paesi di lingua germanica. La denominazione di "nontiscordardimé" (in tedesco "Vergissmeinnicht")
è legata a una leggenda tedesca secondo la quale, quando Dio stava dando il nome
alle piante, una piantina ancora senza nome Gli gridò: "Non ti scordar di me, o
Dio!" ed Egli replicò: "Quello sarà il tuo nome!"
Secondo una leggenda più recente invece il nome insolito sarebbe legato ad un avvenimento occorso
in Austria: si narra che un giorno due innamorati stessero
passeggiando lungo il Danubio, scambiandosi tenerezze e promesse d'amore.
Rimasero affascinati dai piccoli fiori azzurri trasportati dalla corrente del
fiume: il ragazzo si chinò per raccoglierne uno e donarlo alla sua amata, ma
scivolò e cadde in acqua, gridandole: "Non ti scordar di me!" come estremo saluto prima di essere inghiottito
dalle acque. Questo mito è narrato in una cantata di Anton
Bruckner (1824-1896).
Nella Germania del XV secolo, sui diceva che chi indossava questo fiore non
sarebbe stato dimenticato dalla propria amata, mentre le donne lo indossavano
come simbolo per eccellenza di fedeltà e di amore eterno. Nell'Inghilterra
dell'epoca vittoriana era comune decorare gli abiti delle spose con dei
nontiscordardimè.
Il Myosotis era chiamato dagli antichi "erba sacra", era considerato un potente
talismano in grado di fornire protezione contro le streghe, ed era usato nella
preparazione di medicamenti per gli occhi. Plinio il Vecchio dice che il fiore
era considerato simbolo di salvezza dal dolore e da tutto ciò che può
amareggiare la vita. Di conseguenza nella storia dell'arte il nontiscordardimé viene utilizzato per ricordare i
cari defunti, ed è molto comune nei ritratti funerari. Associato com'è all'amore
e alla morte, il nontiscordardimè divenne simbolo d'ispirazione del movimento
letterario del Romanticismo, grazie a un'idea del grande poeta e filosofo
romantico tedesco Novalis (vero nome Georg Friedrich Philipp Freiherr von
Hardenberg, 1772-1801) nel suo incompiuto romanzo di formazione "Heinrich von Ofterdingen".
In esso il giovane protagonista sogna un fiore blu (in tedesco "Blaue Blume")
che lo chiama e assorbe la sua attenzione: esso assurge a paradigma del
desiderio, dell'amore e dello sforzo metafisico di accostarsi all'infinito e
all'irraggiungibile, tutti tratti tipici della
corrente romantica. Pochi i dubbi che il fiore azzurro di Novalis fosse un nontiscordardimè.
Ancor oggi in Germania il nostro fiore è utilizzato anche dalla popolazione per
commemorare i soldati caduti nelle guerre mondiali; in modo simile all'uso dei
papaveri commemorativi nel Regno Unito. Analogo uso esso ha nella provincia
canadese di
Terranova e Labrador. Sempre legato alla morte, il nontiscordardimè è anche il simbolo del centenario del genocidio armeno:
il punto nero centrale simboleggia la sofferenza del popolo armeno, i cinque petali viola simboleggiano i cinque continenti in
cui gli armeni fuggirono e il centro giallo simboleggia l'eternità.
In Lituania, il fiore è diventato uno dei simboli per la commemorazione degli
eventi del gennaio 1991 che portarono, dopo la fallita repressione sovietica,
all'indipendenza del paese.
Nei Paesi Bassi il nontiscordardimè è il simbolo di "Alzheimer
Nederland", una fondazione che aiuta le persone affette da demenza senile, e un
analogo simbolismo lo troviamo anche in Nuova Zelanda. A partire dal 1983 il
Myosotis rappresenta la Giornata Mondiale dei Bambini Scomparsi, ma è anche il
fiore simbolo della Festa dei Nonni, celebrata il 2 ottobre di ogni anno in
Italia, e in date diverse in altri Paesi. Questo fiorellino fu utilizzato anche
da Legambiente Lazio per la sua campagna per la qualità e la vivibilità degli
edifici scolastici e per promuovere la piantumazione di fiori nei loro giardini.
Infine, una curiosità. Visto il suo simbolismo romantico, il fiore blu del
nontiscordardimè fu utilizzato nel 1926 come emblema dalla
Loggia Massonica tedesca "Zur Sonne". Ora, nel 1938 un distintivo con la forma del
nontiscordardimè, prodotto
dalla stessa fabbrica del distintivo massonico, fu scelto per il congresso annuale del
Partito Nazista.
Questa coincidenza ha permesso ai Massoni di indossare il distintivo del
nontiscordardimè come segno segreto di appartenenza, visto che la Massoneria era
fuorilegge sotto i regimi nazifascisti, e i frammassoni erano considerati alla
stregua di dissidenti politici.
Dopo la seconda guerra mondiale il fiore del nontiscordardimé fu nuovamente
utilizzato come emblema massonico nel 1948 in occasione della prima Convenzione
annuale delle Logge Unite della Germania, ed ancor oggi i Massoni di tutto il
mondo indossano questo distintivo sul risvolto delle giacche per ricordare i
Fratelli Muratori perseguitati da quei regimi.

Gli "attaccapanni
per la carne"
Yucca è un genere di arbusti
e alberi perenni della famiglia Asparagacee, sottofamiglia delle Agavoidee.
Comprende 49 specie e 24 sottospecie che si distinguono fra loro per le loro rosette di foglie sempreverdi,
dure, a forma di spada, e per le grandi pannocchie terminali di fiori bianchi.
L'areale naturale di distribuzione del genere Yucca copre una vasta area delle Americhe:
è rappresentato in tutto il Messico e si estende a
nord attraverso la Baja California, verso nord negli Stati Uniti sudoccidentali, attraverso gli stati centrali più aridi fino all'estremo nord
dell'Alberta meridionale in Canada (Yucca glauca ssp. albertana). Si trova anche
nelle pianure costiere degli Stati Uniti sudorientali, lungo il
Golfo del Messico e gli Stati dell'Atlantico meridionale, dalla costa del Texas
al Maryland.
Le yucche si sono adattate a una gamma altrettanto vasta di condizioni
climatiche ed ecologiche: si trovano nei deserti rocciosi e nei calanchi, nelle
praterie e nelle regioni montuose, nei boschi, nelle sabbie
costiere (Yucca filamentosa) e persino nelle zone subtropicali e semitemperate. Diverse specie si trovano nelle zone tropicali umide (Yucca lacandonica), ma la maggior parte
vive in condizioni aride, con
i deserti del Nord America considerati il centro di
irradiazione della biodiversità di questo genere.
Le prime descrizioni delle specie di yucca hanno portato a confonderle con la manioca (Manihot
esculenta). Di conseguenza, Linneo ricavò erroneamente il nome del genere
dalla parola in lingua Taíno che indicava la manioca, cioè yuca. Gli Aztechi
precolombiani chiamavano la specie
locale di yucca (Yucca gigantea) con il nome di iczotl, in lingua Nahuatl, da cui deriva
il nome in spagnolo, izote.
Dal 1897 al 1907, il botanico tedesco Carl Ludwig Sprenger (1846-1917) creò e
battezzò ben 122 ibridi di Yucca.
In natura raggiungono anche i 15–20 m di altezza, ma negli ambienti domestici
non superano i 2 metri; hanno un fusto robusto, cilindrico, spesso a portamento
arboreo, poco ramificato, che porta folti ciuffi di foglie lineari, persistenti,
dure e generalmente spinose all'apice; i fiori sono generalmente piccoli,
raramente grandi, di colore bianco o crema, penduli e solitamente riuniti in
grandi pannocchie terminali.
Le yucche hanno un sistema di impollinazione mutualistico molto specializzato.
Sono impollinate dalle falene della yucca (appartenenti alla famiglia delle Prodoxidae); l'insetto
trasferisce il polline dagli stami di una pianta allo stigma di un'altra, e
contemporaneamente depone un uovo nel fiore; la larva della falena si nutre
quindi di alcuni dei semi in via di sviluppo, lasciando sempre semi sufficienti
per perpetuare la specie. Alcune specie della falena yucca hanno sviluppato
caratteristiche di antagonismo nei confronti della pianta: non contribuiscono
cioè all'impollinazione della pianta, ma continuano a deporre le uova nella
pianta per proteggerle. Molte specie di yucca ospitano i bruchi delle specie Megathymus yuccae
e Megathymus ursus.
Le yucche sono ampiamente coltivate come piante ornamentali nei giardini. Molte
specie hanno anche parti commestibili, tra cui frutti, semi, fiori, steli fiorali, e più raramente
le radici. I riferimenti alla radice di yucca come cibo spesso derivano dalla
confusione con la yuca, dal nome molto simile ma botanicamente non correlata,
cioè con la manioca.
I petali del fiore sono comunemente mangiati in America centrale, ma vengono prima rimossi
i suoi organi riproduttivi (le antere e le ovaie) a causa della
loro amarezza. I petali vengono sbollentati per 5 minuti e poi cotti alla messicana con pomodoro, cipolla, peperoncino,
o usare per realizzare tortitas con salsa verde o rossa. In Guatemala vengono
bolliti e mangiati con succo di limone.
In El Salvador si mangiano le punte tenere degli steli, conosciuti come "cogollo de izote".
L'estratto di yucca è anche usato come agente schiumogeno in alcune bevande come
la root beer e la soda.
Le radici della yucca saponata (Yucca elata) sono ricche di saponine e sono usate come shampoo nei rituali dei nativi americani. Le foglie di
yucca essiccate e le fibre del tronco hanno una bassa temperatura di accensione,
rendendo la pianta utile per accendere il fuoco tramite
attrito, cioè facendo girare un bastoncino dentro un altro pezzo di legno, arte
in cui i Nativi Americani sono abilissimi. Lo stelo che sfoggia i fiori, una
volta essiccato, viene spesso
utilizzato in collaborazione con un robusto pezzo di legno di cedro per accendere il
fuoco. Nelle aree rurali degli Appalachi le specie come la Yucca filamentosa
sono chiamate "attaccapanni per la carne" perchè, con le loro punte acuminate, le
foglie dure e fibrose venivano usate per forare la carne, e poi annodate per formare
un cappio cui appendere la carne per la salatura o negli affumicatoi. Le
fibre possono essere utilizzate per realizzare cordame e filo per cucire.
Le yucche sono ampiamente coltivate come piante da giardino e forniscono
un aspetto drammatico alla progettazione del paesaggio. Tollerano una serie di
condizioni avverse, ma crescono meglio in pieno sole nelle zone subtropicali o temperate.
Diverse specie di yucca possono essere coltivate all'aperto nelclima
mediterraneo, tra cui
Yucca filamentosa,
Yucca flaccida,
Yucca glauca,
Yucca gloriosa,
Yucca ricurvifolia e
Yucca rostrata.
La yucca più comune come pianta d'appartamento è però la Yucca gigantea. In
natura è un arbusto sempreverde che cresce fino a 8–12 m di altezza,
popolarmente chiamata yucca senza spina dorsale, yucca dalla punta morbida,
yucca a gambo blu, yucca gigante, canna di yucca e itabo. Può avere un tronco
spesso e singolo o essere multitronco, con più tronchi che crescono da una base
inferiore ispessita, simile al piede di un elefante. Le foglie, eccezionalmente
strette, si aprono a ventaglio in ciuffi. Sono simili a cinghie, senza spina
dorsale e lunghe fino a 1,2 m. I fiori bianchi sono prodotti in estate. Le
piante mature producono punte erette di fiori pendenti lunghi fino a un metro,
che producono frutti carnosi marroni, ovali e lunghi fino a 2,5 cm. Il nome
Yucca gigantea fu assegnato nel novembre 1859 dal botanico francese Charles
Antoine Lemaire (1800-1871), ma è conosciuta anche come Yucca elephantipes (per
la forma della base del tronco), nome datole nel febbraio 1859 dall'orticoltore
tedesco Eduard August von Regel (1815-1892). Yucca gigantea cresce
spontaneamente in Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua e nella parte orientale del Messico (stati di Quintana Roo, Yucatán,
Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Puebla orientale e Tamaulipas
meridionale), ma si è naturalizzata anche a Porto Rico, nelle Isole Sottovento e
in Ecuador. Questa specie di yucca può essere coltivata in una varietà di
terreni ed è resistente alla siccità, ma cresce meglio in un clima caldo
semi-arido, quindi le piante coltivate in appartamento sono soggette a marciume
radicale se innaffiate troppo spesso. Le piante più vecchie sono generalmente le
più sensibili, e per questo motivo le piante d'appartamento migliori sono gli
alberi giovani e più bassi, in quanto sono più adattabili ai cambiamenti
ambientali. La specie ha una certa tolleranza al freddo, ma non al gelo. La
yucca gigantea può essere colpita da una serie di parassiti tra cui cocciniglie,
piralidi della yucca e punteruoli della yucca. La propagazione avviene per
polloni, talee o seme.
Il fiore di Yucca gigantea è il fiore nazionale di El Salvador, dove è conosciuto
come "flor de izote" ed è ampiamente utilizzato nella cucina salvadoregna.
Un'altra specie molto comune nei nostri appartamenti è la Yucca aloifolia,
considerata la specie tipo per il genere Yucca e detta anche pianta del pugnale
o baionetta spagnola. Cresce in terreni sabbiosi, soprattutto sulle dune di
sabbia lungo la costa.; è originaria delle coste atlantiche e del Golfo del
Messico; Yucca aloifolia è una popolare pianta paesaggistica nelle zone di
spiaggia lungo la costa orientale americana, dalla Virginia alla Florida. Ha un
tronco eretto di 7–13 cm di diametro, che raggiunge un'altezza di 1,5–6 m prima
che diventi pesante e si ribalti. Quando ciò accade, la punta si gira verso
l'alto e continua a crescere. Il tronco è armato di foglie appuntite con bordi a
denti fini, ciascuna lunga circa 0,6 m. Le foglie giovani vicino all'apice
crescente sono erette; quelle più vecchie sono rivolte verso il basso, e le più
vecchie appassiscono e diventano marroni, pendendo intorno alla parte inferiore
del tronco come una gonna hawaiana. La punta del tronco sviluppa una pannocchia
di fiori bianchi con sfumature violacee, ciascuno di circa 13 cm di diametro.
Dopo la fioritura il tronco smette di crescere, ma presto si formano uno o più
germogli laterali e quello più in alto diventa un nuovo germoglio terminale.
Yucca aloifolia produce anche nuovi germogli vicino alla base del fusto,
formando il tipico boschetto spesso osservato nelle zone sabbiose e cespugliose
delle spiagge del sud-est degli Stati Uniti e di molte zone d'Europa in cui è
stata trapiantata. I frutti sono allungati, carnosi, lunghi fino a 5 cm e
vengono mangiati sia dagli uccelli che dall'uomo, mentre i fiori possono essere
consumati cotti o crudi. Le radici di Yucca aloifolia possono essere utilizzate
come sapone e shampoo.
Parliamo anche di Yucca elata, una pianta perenne nota anche come yucca
saponaria, soaptree yucca, soapweed e palmella. È originaria del Nord America
sudoccidentale, del deserto di Sonora e del deserto di Chihuahuan; la si trova
in Texas occidentale, New Mexico, Arizona, Nevada meridionale, Utah
sudoccidentale e negli stati messicani di Chihuahua, Coahuila,Sonora e Nuevo
Léon, anche se purtroppo la sua popolazione sembra essere in diminuzione. Cresce
da 1,2 a 4,5 m di altezza, con un tronco scarsamente ramificato di colore bruno,
di forma cilindrica e di piccolo diametro; spesso presenta dei fori praticati
dalle larve. Le foglie sono disposte in un denso vortice a spirale all'apice
degli steli, ciascuna foglia lunga da 25 cm a un metro è molto sottile, larga
solo da 0,2 a 1,3 cm. I fiori bianchi a forma di campana crescono in un denso
grappolo su uno stelo sottile all'apice dello stelo. Il frutto è una capsula
lunga 4–8 cm e larga 2–4 cm, che matura e diventa marrone in estate, quando si
divide in tre sezioni per rilasciare i semi neri. Non fiorisce ogni anno. E'
molto resistente al freddo, ma ha bisogno di molta luce solare. I nativi
americani usavano la fibra delle foglie della Yucca elata per realizzare
sandali, cinture, stoffe, cestini, corde e stuoie, e ne consumavano i fiori.
All'interno del tronco e delle radici della pianta si trova una sostanza collosa
ricca di saponine. In passato questa sostanza era comunemente usata come sapone
e shampoo, ma anche per trattare la forfora e la caduta dei capelli. In tempi di
siccità gli allevatori hanno utilizzato questa pianta come riserva alimentare
d'emergenza per il loro bestiame. Non è certo un caso se il fiore di Yucca elata è il fiore
simbolo dello stato del New Mexico. Si può però vedere un altissimo esemplare di
Yucca elata anche in alcune scene con vista mare della fiction "Il Commissario
Montalbano"!
Le piante di yucca sono naturalmente usate come simbolo dei vari clan in alcune
culture dei Nativi Americani. Tra i Navajo ad esempio vi è un clan chiamato
Hashk'aa hadzohi il cui totem è la Yucca elata. Alcune tribù Pueblo hanno tra le
loro tradizioni di danza tribale anche una "Danza della Yucca". Ovviamente non
possono mancare le leggende dei Nativi che vedono questa pianta come
protagonista. Una di esse ha come protagonista Naiyenesgani ("Massacratore di
Nemici"), un eroe mitico della tradizione Navajo che, insieme a suo fratello
Tobadzischini, avrebbe liberato il mondo dagli Anaye, una razza di mostri a
volte paragonati ai Titani greci o ai Giganti antidiluviani della Bibbia (alcuni
antropologi sostengono che questi semidei malvagi vissuti nella notte dei tempi
sarebbero il ricordo ancestrale degli incontri dei nostri lontani antenati con
gli ultimi uomini di Neanderthal). Sasnalkáhi (in lingua Navajo "L'orso che
insegue") era un Anaye sotto forma di orso gigante che si nascondeva nella sua
caverna, uccidendo chiunque si avvicinasse. Nayenezgani lo attirò all'esterno
facendo del chiasso e, quando mise fuori la testa dalla grotta, gliela mozzò di
netto. La testa rotolò a terra e da essa nacque la prima pianta di yucca.
Secondo un'altra versione del mito, quando tutti gli Anaye furono sterminati,
Nayenezgani continuò a vagare in tutto il Nord America con il proprio bastone,
timoroso che qualche creatura fosse sopravvissuta. Alla fine salì in cima alla
Grande Montagna Bianca e si guardò intorno in tutte le direzioni, ma invano: non
c'erano più mostri in circolazione. Allora buttò via il suo bastone e, una volta
caduto in terra, esso divenne una pianta di yucca. Infine si lavò dalle mani lo
sporco causato dall'uccisione dei mostruosi Anaye e lo gettò in direzioni
diverse; dove cadde, esso si trasformò in bestiame (bovini, capre e pecore).
"Con questi miei doni avrete di che vivere", disse agli antenati dei Navajo.
Ecco perché pecore e bovini mandano un cattivo odore, provenendo dalla sporcizia
che Nayenezgani si era lavato via dalle sue mani. Da allora i Navajo vivono dei
bovini, e delle pecore e della pianta di yucca!
Infine, una piccola escursione nella criptozoologia. Per i residenti nella
California meridionale, il famigerato Yucca Man è noto quasi quanto Bigfoot lo è
per gli stati settentrionali degli USA. Si tratta di un presunto Sasquatch
adattato al deserto che vivrebbe in California, Nevada e Arizona. Simile
all'incrocio tra uno scimmione e una pianta di yucca, Yucca Man sarebbe un
umanoide alto 10 piedi (tre metri), tutto ricoperto di peli lunghi e spettinati
che avanzerebbe con un'andatura goffa e strascicata. Yucca Man sarebbe stato
avvistato in tutta la California meridionale, dai sobborghi di Lancaster alle
piste della base aeronautica di Edwards, e addirittura filmato; i più recenti
avvistamenti di questo criptide si sarebbero verificati nel Joshua Tree National
Park. Secondo gli appassionati di criptozoologia, le apparizioni del Bigfoot e
delle sue innumerevoli versioni turberebbero i sonni dei cittadini USA fin dai
tempi di George Washington, però vi è da dire che in nessuna mitologia nativa si
ritrova una creatura di tipo scimmiesco (ad esempio, gli Anaye sono modellati su
rocce, orsi o uccelli rapaci, mai su primati). E siccome la maggior parte degli
avvistamenti di Yucca Man sarebbero avvenuti negli anni '70 e '80 del secolo
scorso vicino a strutture militari governative, ci sono pochi dubbi che si
tratti di scherzi di cattivo gusto giocati ai marines dai soliti buontemponi.

Il "veleno gradevole"
Mi rendo conto che non vi ho
ancora parlato... della
vite! La Vitis vinifera, o vite comune, è un'angiosperma
(tecnicamente, una liana!) il cui nome latino vīte(m), in origine "rampicante",
deriva da viēre, "intrecciare"; la stessa etimologia dunque di "vimini". Pensate
che esistono tra le 5.000 e le 10.000 varietà di Vitis vinifera, coltivate in
tutti i continenti ad eccezione dell'Antartide, anche se solo poche di esse
hanno un importante significato commerciale per la produzione di vino e uva da
tavola. L'uva selvatica invece è spesso classificata come Vitis sylvestris. Le
viti domestiche hanno fiori ermafroditi, ma Vitis sylvestris è dioica (ha i
fiori maschili e femminili su piante separate) ed è necessaria l'impollinazione
per lo sviluppo dei frutti. L'uva può essere consumata fresca o essiccata per
produrre uva sultanina. Le foglie d'uva sono utilizzate nella cucina di molte
culture. L'uva fresca viene spremuta e il suo succo viene fermentato per
produrre aceto e vino, a sua volta distillato per dare grappa. A sorpresa, oggi
il primo produttore mondiale di uva è... la Repubblica Popolare Cinese, con 14,8
milioni di tonnellate l'anno, seguita proprio dall'Italia con 8,2 milioni, dagli
USA con 7 milioni e dalla Francia con 6,4 milioni (per la cronaca, il primo
produttore di uva dell'America Latina è il Cile con 2,5 milioni di tonnellate
all'anno, che ne fanno lottavo produttore mondiale). Invece il primo produttore
mondiale di vino nel 2022 era l'Italia con 50,3 milioni di ettolitri, nonostante
l'estate terribilmente siccitosa, seguita dalla Francia con 44,2 milioni, dalla
Spagna con 33 milioni, dagli USA con 23,1 milioni, e poi a sorpresa dal Cile con
12,4 milioni, dall'Australia con 12,1 milioni e dall'Argentina con 11,4 milioni
di ettolitri: questi numeri sono dovuti certamente alla forte emigrazione
italiana verso quei paesi.
E ora un po' di storia. L'uva selvatica veniva
raccolta dai cacciatori-raccoglitori neolitici sia per il suo valore medicinale
che nutrizionale; la sua storia è intimamente intrecciata con la storia del
vino. I cambiamenti nella forma del seme (più stretto nelle forme domestiche) e
nella distribuzione indicano che l'addomesticamento si è verificato intorno al
3.500-3.000 a.C. nell'Asia sudoccidentale, nel Caucaso meridionale e nella
regione costiera del Mar Nero occidentale. La prima prova dell'esistenza di uva
domestica è stata trovata a Gadachrili Gora, vicino al villaggio di Imiri, nel
sud-est della Georgia: la datazione al carbonio indica addirittura il 6.000 a.C.,
segno del fatto che essa fu oggetto di attenzione già da parte dei primi
agricoltori. La coltivazione dell'uva domestica si è diffusa in altre parti del
Vecchio Mondo già in epoca preistorica. primi resoconti scritti sull'uva e sul
vino si trovano addirittura nell'Epopea di Gilgamesh, il primo poema epico della
storia, giuntoci in lingua accadica ma basato su un antico testo sumerico del
III millennio a.C. Numerosi sono anche i riferimenti nei geroglifici dell'antico
Egitto, secondo i quali il vino era riservato esclusivamente ai sacerdoti, ai
funzionari statali e al faraone, come il cacao ai sovrani aztechi. La prima
rappresentazione del procedimento di vinificazione è stata realizzata dagli
egizi nel corso del III millennio a.C. su bassorilievi raffiguranti scene di
pigiatura dell'uva, mentre anfore ricolme di vino bianco sono state riportate
alla luce nella necropoli di Umm el-Qa'ab di Abido, nella tomba del 7° faraone
della I dinastia egizia, Semerkhet. Esiodo nelle sue "Opere e giorni" fornisce
descrizioni dettagliate delle vendemmie e delle tecniche di vinificazione, e ci
sono anche molti riferimenti in Omero (siamo nell'VIII secolo a.C.). I coloni
greci introdussero poi queste pratiche nelle loro colonie, soprattutto
nell'Italia meridionale, ed infatti l'Italia nell'antichità preclassica era
conosciuta anche come Enotria, "Terra del Vino", per il suo clima propizio alla
viticoltura. Gli Etruschi migliorarono le tecniche di vinificazione e
svilupparono un commercio di esportazione anche oltre il bacino del
Mediterraneo. I Romani svilupparono ulteriormente le tecniche apprese dagli
Etruschi, come dimostrano numerose opere letterarie contenenti informazioni
valide ancora oggi: "De Agri Cultura" (160 a.C. circa) di Catone il Censore, "De
re rustica" (37 a.C.) di Marco Terenzio Varrone, le "Georgiche" di Virgilio e il
"De re rustica" (70 d.C.) di Lucio Columella. La lunga crisi dell'Impero Romano
d'Occidente generò un'instabilità nelle campagne che portò ad una riduzione
della viticoltura in genere, la quale si sostenne solo in prossimità dei centri
urbani e lungo le coste. Tra il V e il X secolo la viticoltura fu portata avanti
quasi esclusivamente nei monasteri dai diversi ordini religiosi. I Benedettini
estesero il limite di coltivazione della vite verso nord e piantarono anche
nuovi vigneti a quote e latitudini più elevate rispetto all'epoca romana. Oltre
alla viticoltura 'ecclesiastica', si sviluppò anche, soprattutto in Francia, una
viticoltura 'nobile', praticata dall'aristocrazia come simbolo di prestigio. La
coltivazione della vite è stata un'attività economica significativa anche in
Medio Oriente fino al VII secolo, quando l' espansione dell'Islam ne ha causato
il declino, visto che il Corano proibisce il consumo di vino. Tra il Basso
Medioevo e il Rinascimento la viticoltura riprese a fiorire. La pressione
demografica, la concentrazione della popolazione nelle città e l'aumento della
capacità di spesa di artigiani e commercianti hanno dato luogo a maggiori
investimenti nella viticoltura, che è diventata ancora una volta
economicamente sostenibile. Molto è stato scritto durante il Rinascimento sulla
coltivazione della vite e sulla produzione del vino, favorendo un approccio più
scientifico, con la nascita della moderna ampelografia. L'uva seguì i coloni
europei in tutto il mondo, arrivando in Nord America intorno al XVII secolo,
dove ha generato ibridi con specie autoctone del genere Vitis, e poi in Africa,
Sudamerica e Australia. L'alcolismo fu una vera piaga tra i popoli raggiunti dai
sedicenti "civilizzatori" europei, come i nativi americani, gli aborigeni
australiani o i Maori; e tutti sappiamo come l'era del Proibizionismo in America
non fece degli americani un popolo di morigerati, ma anzi fece la fortuna di
mafiosi senza scrupoli come Lucky Luciano e Al Capone. Nel XIX secolo due
malattie e un insetto provenienti dall'America sconvolsero la viticoltura: la
Peronospora della vite, l'oidio e la fillossera, che distrussero enormi quantità
di vigneti tra il 1870 e il 1950. I coltivatori furono costretti a innestare i
vitigni sopravvissuti su specie ed ibridi di origine americana (Vitis
berlandieri, Vitis rupestris,Vitis riparia), a volte creati intenzionalmente per
essere resistenti alla fillossera, e ad utilizzare regolarmente prodotti
fitosanitari come lo zolfo e il rame per contrastare l'oidio e la peronospora.
Nella seconda metà del XX secolo c'è stato un cambiamento radicale nella
viticoltura dalle tecniche tradizionali al metodo scientifico basato su
microbiologia, chimica e genetica, anche a causa dei cambiamenti negli aspetti
economici e culturali e nel modo di vivere e nelle abitudini di consumo di ampi
strati della popolazione che cominciavano a richiedere prodotti di qualità. Nel
2007 Vitis vinifera è stata la quarta specie di angiosperma il cui genoma è
stato completamente sequenziato. Questi dati hanno contribuito in modo
significativo alla comprensione dell'evoluzione della pianta, e anche di come le
caratteristiche aromatiche del vino siano determinate in parte dai suoi geni.
Questo lavoro è il risultato una collaborazione tra ricercatori italiani
(Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Biologia Molecolare delle Piante,
Istituto di Genomica Applicata) e francesi (Genoscope e Institut National de la
Recherche Agronomique). Sempre nel 2007, scienziati dell'Australia's
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), che
lavorano nel Cooperative Research Center for Viticulture, hanno suggerito che
alcune mutazioni estremamente rare e indipendenti in due geni (VvMYBA1 e VvMYBA2
dell'uva rossa) hanno prodotto un ' vitigno bianco che è stato il
capostipite di quasi tutti i vitigni a bacca bianca del mondo. Se fosse stato
mutato un solo gene, la maggior parte dell'uva sarebbe ancora rossa e non
avremmo oggi le oltre 3000 cultivar a bacca bianca disponibili!!
Anche la storia
del vino risale ad epoche antichissime, probabilmente alla fine del Neolitico,
in seguito ad un'accidentale fermentazione di uva conservata in rudimentali
recipienti. Esistono innumerevoli miti che narrano la prima coltivazione della
vite e la sua fermentazione. Si è ipotizzato che la parola in lingua greca
antica οίνός, che diverrà "vinum" in lingua latina grazie all'intermediazione
della lingua etrusca, appartiene alla famiglia delle lingue indoeuropee e risale
alla radice "wVn"; divenne "inu" in lingua accadica, "wiyana" in lingua hittita e
wo(i)no in lingua micenea. Le lingue semitiche la avrebbero presa in prestito
nella forma "*wain", da cui deriva "yin" in lingua ugaritica e "ynn" in lingua
ebraica. L'origine ancestrale del termine è con tutta probabilità
anatolico-caucasica; proprio là dove, sulle pendici del Monte Ararat, il testo
della Bibbia pone il luogo in cui fu piantato il primo vitigno della storia: in
Genesi 9,20 si narra come Noè, dopo il Diluvio universale, divenne agricoltore
(probabilmente in precedenza era un pastore nomade, segno del passaggio dalla
vita nomadica a quella sedentaria) e coltivò l'uva, produsse il primo vino e se
ne ubriacò. Nel 2007 un team di 27 archeologi irlandesi, statunitensi e armeni
hanno scoperto un sito vicino al fiume Arpa nei pressi di Areni (villaggio a
tutt'oggi rinomato per la sua produzione vinicola), in cui, all'interno di una
grotta suddivisa in tre locali, sono stati rinvenuti dei vasi pieni di semi
d'uva, forse risalenti a più di 6.000 anni fa: se così fosse, si tratterebbe del
più antico sito in cui abbia avuto luogo un'operazione di vinificazione.
Trovandosi non lontano dal monte Ararat, la leggenda biblica avrebbe trovato una
clamorosa conferma archeologica. Il suddetto racconto dell'ebbrezza di Noè e
della conseguente maledizione di Cam e di suo figlio Canaan è oggi interpretato
come un racconto eziologico per spiegare come mai gli Ebrei avevano il diritto
di scacciare i cananei ed occupare le loro terre. Una famosa leggenda rabbinica
narra che il diavolo sotto mentite spoglie convinse Noè a sacrificare nella sua
vigna quattro animali: un agnello, un leone, un maiale e una scimmia, con la
conseguenza che da allora chi si ubriaca diventa simile a uno di questi animali
(remissivo, violento, folle, dimentico della natura umana). La memoria di quest'origine della
viticoltura "al di là delle montagne" venne perpetuata anche dalle
tavolette della Mesopotamia, secondo cui nel "paese tra i due fiumi" il vino fu
sempre percepito come proveniente da un non meglio precisato "altrove", dalle
zone montuose in direzione della terra armena o della regione siriaca. A
Babilonia esso è chiamato "birra delle montagne" il più antico testo
mesopotamico inerente al vino è un'iscrizione del sovrano di Lagash Urukagina
datata al 2.340 a.C. in cui si afferma d'essere stata costruita "una casa di
riserva della birra di montagna conservata in giare". Il vino costituì
essenzialmente un bene di lusso riservato alle divinità e ai principi, ma poté
costituire anche un premio come accade nel mito babilonese del diluvio, in cui
Utnapishtim (alias Noè) lo regala agli operai che gli hanno permesso di
costruire la grande arcache lo dovrà mettere in salvo dalle acque. Il Codice di
Hammurabi (XVIII secolo a.C.) prevede il supplizio del fuoco per quelle
sacerdotesse che avessero aperto la porta d'ingresso alle riserve di vino del
tempio. Tra gli Ittiti la vite, simbolo di vitalità e fecondità, fu associata ai
rituali di fondazione dei nuovi edifici, alla purificazione delle città o delle
abitazioni dopo il funerale e la libagione. Nella mitologia ittita il vino è
presente nel Ciclo di Kumarbi, dove si descrive Ullikummi mentre beve "vino
dolce" e Astarte che cerca di scoraggiare Baal dal recarsi nella casa di Asherah
per bere vino. La legislazione puniva i danni causati ai vigneti ordinando
l'arresto dei colpevoli e un indennizzo in caso di incendio. Sembra che la
produzione locale risultasse essere del tutto insufficiente, per cui gli Ittiti
dovevano ricorrere molto spesso alle forniture provenienti dalla Cilicia, da
Karkemish e da Ugarit. Nel testo sacro iranico Avestā si racconta la vicenda
dello Shah Jamshid il quale uccise un serpente che aveva attaccato un uccello
magico; l'animale salvato lo ringraziò lasciandogli come dono un piccolo seme
che diede origine alla vite. I grappoli e gli acini d'uva vennero raccolti in
grandi vasi, ma la successiva fermentazione del mosto gli fece assumere uno
strano odore; supponendo allora che si trattasse di una sostanza tossica, venne
designato come veleno e riposto nei sotterranei delle cantine. Una delle donne
del suo harem, trascurata e infine bandita, pensò al suicidio, si recò di
nascosto nei magazzini reali, cercò una giara contrassegnata con la dicitura
"veleno" e contenente proprio i resti di quelle uve che si erano rovinate e che
pertanto venivano ritenute non più commestibili. Dopo averne bevuto il contenuto
si sentì alquanto risollevare lo spirito. La deliziosa bevanda ripristinò la sua
allegria, ella fece immediatamente partecipe della sua scoperta il re il quale,
assaggiata la nuova bevanda, se ne innamorò, riammise la giovane concubina al
proprio cospetto rinnovandole i propri favori, e decretò anche che tutte le uve
cresciute a Persepoli avrebbero dovuto essere destinate da quel momento in poi
esclusivamente alla vinificazione. In riferimento a questa leggenda il vino in
Iran viene ancora oggi chiamato "Zeher-i-khos", cioè "il veleno gradevole"! La
Mitologia greca ha attribuito la scoperta della viticoltura all'infanzia del dio
Dioniso, ubicandola sul Monte Nisa in Elicona; egli insegnò poi la pratica ai
popoli dell'Anatolia centrale. A causa di questo fatto venne ricompensato
assumendo il ruolo di "dio del vino". Un altro mito narra invece che il dio al
ritorno dal suo viaggio in India avesse appreso e insegnato agli uomini come
produrre il vino. Secondo un mito egiziano, Iside divenne gravida dopo aver
gustato dell'uva, e diede alla luce Horus. Il dio del torchio Shesmu porge ai
morti del vino, in quanto bevanda che conserva la vita. Dall'equiparazione
simbolica del vino col sangue deriva la sua importanza per il culto dei morti. A
Creta i cadaveri venivano lavati con del vino caldo. Secondo il racconto
dell'Eneide, alla morte di Didone il vino da lei offerto con l'incenso si
trasformò in sangue. Dai tempi più antichi, nei proverbi vino e verità sono
associati; nella Bibbia, Dio stesso ci dà « il vino, che allieta il cuore
dell'uomo » (Sal 104,15). Mentre la moderazione anche nel bere è virtù regale, «
il vino dev'essere dato a chi ha l'amarezza nel cuore » (Proverbi 31,4). Degli
eletti di Dio si dice che «gioirà il loro cuore come inebriato dal vino»
(Zaccaria 10,7). Il vino diviene inoltre immagine di doni spirituali; così la
sapienza divina « ha preparato il vino e ha imbandito la tavola» (Proverbi 9,2).
Valore messianico acquista la benedizione che Giacobbe pronuncia su suo figlio
Giuda: « Egli lega alla vite il suo asinello e a scelta vite il figlio della sua
asina, lava nel vino la veste e nel sangue dell'uva il manto » (Gen 49,11). Il
banchetto escatologico sarà un banchetto di vini eccellenti e raffinati (Isaia
25,6). Come suo primo miracolo Gesù, alle nozze di Cana, ha trasformato l'acqua
in vino (Gv 2,3-10), un'allusione all' incipiente gioia e pienezza di grazia del
regno di Dio. Il pietoso samaritano versa olio e vino nelle ferite del viandante
assalito dai briganti (Lc 10,34); il passo parallelo di Marco che forse si
riferisce indirettamente a questa parabola (Mc 12,34) dimostra
incontestabilmente il rapporto col tema del regno di Dio. Olio e vino si trovano
associati anche in altri passi; essi non solo hanno un'azione risanatrice in
senso terreno, ma guidano alla salvezza anche in un senso soprannaturale. Perciò
perfino al cavaliere apocalittico sul cavallo nero, inviato da Dio come
tribolazione sulla terra, viene gridato: « Olio e vino non siano sprecati! » (Ap
6,6). Culmine del simbolismo del vino nella Scrittura sono le parole di Gesù
nell'ultima cena, quando egli porge il calice ai suoi di scepoli: « Bevetene
tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in
remissione dei peccati » (Mt 26,27). Giustino martire vide nella benedizione di
Giacobbe su Giuda un riferimento a Cristo, per il cui sangue tutti coloro che
credono in Lui sono lavati e divengono puri. Come nei canti della vigna (Is
5,1-7 e Sal 80) trovava espressione l'amore di Dio per il suo popolo, così il
vino, offerto nel calice dell'Eucaristia, diviene segno del legame sponsale tra
Cristo e la Chiesa. Pane e vino sull'altare sono il mistero dell'unione con
Cristo. Alcuni Padri della Chiesa, come Ireneo, hanno visto nella mescolanza
liturgica di vino e acqua un simbolo della congiunzione in Cristo di divinità e
umanità. La miscela di acqua e vino del calice eucaristico è stata anche
interpretata come l'acqua e il sangue che uscirono dal costato del Signore. Nei
mistici l'ebbrezza diviene simbolo dell'essere ricolmi di Dio e dell'unione con
lui. Matilde di Magdeburgo, alludendo al Cantico dei cantici (2,4), parla
dell'ingresso nella celletta del vino: « la sposa diviene ebbra al contemplare
il nobile viso ». Per concludere, quando Leif Eriksson sbarcò per primo nel
continente americano nell'anno 1000, battezzò quello che oggi conosciamo come
Terranova con il nome di Vinland, "la terra del vino" (stesso significato di
Enotria) per la possibilità di coltivarvi la vite: e questo, secoli prima di
Cristoforo Colombo e dei colonizzatori spagnoli!!

La
tomba di Polidoro
Viene il turno di un'altra pianta dall'importante simbologia: il
mirto (Myrtus communis), un'angiosperma della
famiglia delle Mirtacee. Il mirto è un arbusto o un cespuglio tipico della
macchia mediterranea, alto fino a tre metri, molto ramificato ma fitto; in
esemplari anziani arriva a 4–5 m. In Sardegna viene chiamato "sa murta", ed è di
genere femminile. E' una latifoglia sempreverde, ha una crescita molto lenta e
può diventare plurisecolare. La corteccia, rossiccia nei rami giovani, col tempo
assume un colore grigiastro. Ha foglie ovali, coriacee e lucide, di colore
verde scuro superiormente, a margine intero, con molti punti traslucidi in
corrispondenza delle glandole aromatiche. I fiori sono ascellari, profumati,
peduncolati, di colore bianco o roseo. La fioritura, abbondante, avviene in
tarda primavera, da maggio a giugno; un evento piuttosto frequente è la seconda
fioritura che può verificarsi in tarda estate, da agosto a settembre e, con
autunni caldi anche in ottobre. Il fenomeno è dovuto principalmente a fattori
genetici. I frutti sono delle bacche ovoidali di colore nero, azzurro,
rosso scuro o più raramente biancastro, con numerosi semi. Maturano da novembre
a gennaio persistendo per lungo periodo sulla pianta. Il mirto può essere
riprodotto per talea o per seme. Per il suo contenuto in olio essenziale (mirtolo),
tannini e resine, è un'interessante pianta dalle proprietà aromatiche e
officinali. Al mirto sono attribuite proprietà balsamiche, antinfiammatorie,
astringenti, leggermente antisettiche, pertanto trova impiego in campo
erboristico e farmaceutico per la cura di affezioni a carico dell'apparato
digerente e del sistema respiratorio. Il prodotto più importante è rappresentato
dalle bacche, utilizzate per la preparazione del liquore di mirto, un prodotto
tipicamente sardo ottenuto per infusione alcolica delle bacche attraverso
macerazione, e considerato il digestivo per eccellenza. Fino agli anni novanta
ha interessato un mercato di nicchia a livello regionale, ma successivamente
l'attività dell'industria liquoristica ha subito una notevole espansione
promuovendo il prodotto nel mercato nazionale. La domanda di materia prima,
tradizionalmente soddisfatta dai raccoglitori stagionali nella macchia
mediterranea, ha portato a una notevole pressione sulla vegetazione spontanea,
che ormai non è più in grado di sostenere un'attività su larga scala. A partire
dalla metà degli anni novanta, pertanto, si sta promuovendo in Sardegna la
coltivazione del mirto in impianti specializzati. La tecnica di coltura è in
piena fase di evoluzione in quanto è ancora oggetto di recente ricerca in
diversi suoi ambiti, soprattutto in relazione alla meccanizzazione. L'impiego
fitocosmetico del mirto risale al Medioevo: con la locuzione di "acqua degli
angeli" si indicava il distillato di fiori di mirto.
250 semi fossili di Myrtus
palaeocommunis sono stati trovati negli strati del Miocene medio dell'area di
Fasterholt vicino a Silkeborg nello Jutland centrale, in Danimarca. Nell'antica
Grecia, il mirto era sacro ad Afrodite, in quanto si riteneva che la dea, appena
nata dalla spuma del mare, si fosse rifugiata in un boschetto di mirti. Il mirto
era sacro nche a Demetra: Artemidoro affermava che nell'interpretazione dei
sogni "una ghirlanda di mirto è di buon auspicio per i contadini a causa di
Demetra e per le donne a causa di Afrodite". Pausania spiegava che una delle
Grazie nel santuario di Elide teneva in mano un ramo di mirto perché "la rosa e
il mirto sono sacri ad Afrodite e connessi con la storia di Adone." (Adone,
giovane bellissimo amato da Afrodite ma ucciso da un cinghiale, è il
corrispondente indoeuropeo del semitico Adonai, identificato con il Dio di
Israele). Al mirto sono legati due miti; nel primo, Myrsine era una ragazza
casta prediletta da Atena che superava nelle gare tutti gli altri atleti, e
fu uccisa per rappresaglia; Atena la trasformò in un mirto, che le divenne
sacro. Nel secondo, Myrina era una devota sacerdotessa di Afrodite che
desiderava sposarsi nonostante i suoi voti. Afrodite la trasformò in mirto e le
donò un profumo fragrante, come la sua pianta prediletta e sacra. A Roma,
Virgilio spiegava che "il pioppo è carissimo ad Alcide (Ercole, discendente di
Alceo), la vite a Bacco, il mirto alla bella Venere, e l'alloro a Febo". Nei
Veneralia, le donne facevano il bagno indossando corone intrecciate di rami di
mirto, e il mirto era usato nei rituali nuziali. Quando i guerrieri romani
tornavano da una campagna vittoriosa senza spargimento di sangue, invece
che della consueta corona d'alloro si adornavano di una corona di mirto. Nel
secondo canto dell'Eneide, il figlio di Anchise strappa dei rami da un
cespuglio di mirto sulle coste della Tracia e ne sgorga il sangue, perchè esso è
spuntato sopra la tomba dello sfortunato Polidoro, ucciso dal re di Tracia
Polimestore; la voce di Polidoro lo avverte di andarsene, perchè quella terra è
maledetta.
Nella liturgia ebraica, il mirto è una delle quattro piante sacre di Sukkot, la Festa dei Tabernacoli che rappresenta i diversi tipi di personalità
che compongono la comunità. Il mirto che ha profumo ma non gusto gradevole,
rappresenta coloro che hanno buone azioni al loro attivo pur non avendo
conoscenza dallo studio della Torah. I rami impiegati nella Festa delle Capanne comprendev:ano, oltre
ai rami di palma e salici di torrente, anche "rami con dense foglie" (Lv 23,40):
con questa definizione probabilmente si parlava del mirto, come tra l'altro si
può dedurre da Neemia 8,15. Attorno a Sion « invece di ortiche cresceranno
mirti, ciò sarà a gloria del. Signore, un segno eterno che non scomparirà
» (Isaia 55,13). L'angelo del Signore che promise al profeta Zaccaria il ritorno
del suo popolo e la ricostruzione di Gerusalemme, cavalcava un cavallo rosso e «
stava fra i mirti in una valle profonda » (Zc 1,8): in questo caso gli
alberi alludono al carattere gioioso della profezia. Nella Cabala ebraica il
mirto rappresenta la forza fallica maschile all'opera nell'universo: per questo
motivo a volte venivano dati rami di mirto allo sposo quando entrava nella
camera nuziale dopo le nozze. Le foglie di mirto venivano aggiunte all'acqua nel
settimo ed ultimo risciacquo della testa nel tradizionale manuale sefardita
tahara che insegna il rituale per lavare i morti. San Girolamo vede nel mito un
simbolo del profumo di Cristo che promana dalla Chiesa. Nella religione mandea,
che considera Giovanni il Battista come il Messia, le ghirlande di mirto sono
usate dai sacerdoti in importanti rituali e cerimonie religiose, come il
battesimo e le messe funebri, e fanno parte del darfash, il simbolo ufficiale
del mandaismo costituito da una croce di legno d'ulivo ricoperta da un panno di
seta bianca. Nei moderni rituali neopagani dei culti Wicca, il mirto, sebbene
non indigeno al di là del bacino del Mediterraneo, è comunemente associato e
sacro a Beltane, la festa del Primo Maggio. Nel XVIII canto della "Gerusalemme
Liberata" di Torquato Tasso compare un mirto fatato: Rinaldo è stato liberato
dagli incanti della maga Armida che lo ha tenuto prigioniero nel suo giardino
sulle isole Fortunate, è tornato a Gerusalemme dove ha ottenuto il perdono di
Goffredo ed è l'' in grado di affrontare gli incanti della selva di Saron,
dalla quale non è possibile tagliare legna per farne macchine di assedio, dopo
che tutti i suoi compagni (incluso Tancredi) ne sono usciti sconfitti. I demoni
della foresta gli riservano un trattamento diverso, dal momento che a lui non si
presentano inizialmente mostri o apparizioni spaventose, bensì un "locus amoenus"
del tutto simile al giardino di Armida e poi una falsa apparizione di quest'ultima,
che cerca di irretirlo con una scena di perfetta seduzione. Rinaldo non si
lascia però fuorviare e riesce a superare la prova, tagliando il mirto magico al
centro della selva incantata: « L'estranio mirto i suoi gran rami spiega, / piú
del cipresso e de la palma altero, / e sovra tutti gli arbori frondeggia; / ed
ivi par del bosco esser la reggia. [...] / Sopra il turbato ciel, sotto la terra
/ tuona: e fulmina quello, e trema questa; / vengono i venti e le procelle in
guerra, / e gli soffiano al volto aspra tempesta. / Ma pur mai colpo il cavalier
non erra, / né per tanto furor punto s'arresta; / tronca la noce: è noce, e
mirto parve. / Qui l'incanto forní, sparír le larve. » (XVIII, 25.37) A parte
l'uso fantasy che ne fa il poeta di Sorrento, in Europa a partire dal
Rinascimento il mirto divenne noto soprattutto come simbolo d'amore, il che
portò alla continua tradizione della corona di mirto come parte del bouquet
nuziale, quale simbolo di verginità, in ricordo della virtuosa regina Ester, il
cui nome ebraico Atossa significa appunto "mirto". Come il suo modello anticotestamentario Ester, anche
Maria è divenuta « l'amabile mirto del Signore »!

La
fibra tessile che avvolse Dio
Il lino
(Linum usitatissimum) è una pianta con fiori della famiglia delle Linacee. Viene
coltivato come coltura alimentare e da fibra nelle regioni del mondo con climi
temperati. È una pianta erbacea annuale con un ciclo vegetativo di tre-quattro
mesi ed è alta tra i 30 e i 60 cm con fusto eretto, molto fragile, ramificato
nella parte finale. Nella corteccia del fusto sono presenti da 20 a 35 fasci di
fibre, avvolti in sostanze gommose dette pectine, che li fanno aderire alle
cellule della corteccia. Le foglie sono alterne, sessili o brevemente
picciolate, lanceolate, intere, strette, glabre. I fiori sono solitari o riuniti
in corimbi, grandi, di colore azzurro. La fioritura dura dai 10 ai 20 giorni, i
frutti sono capsule ciascuna contenente due semi di piccole dimensioni, leggeri,
lisci, piatti, lucidi, di colore dal bruno scuro al giallo paglierino a seconda
delle varietà, e ricchi di olio. Il lino da fibra comprende forme a taglia alta,
stelo elastico, fibre lunghe e duttili, infiorescenze ridotte, semi piccoli,
mentre quello da olio comprende forme a taglia ridotta, a portamento rigido, con
steli brevi e robusti, ramificati alla base, con semi più grandi. Diverse altre
specie del genere Linum sono simili nell'aspetto a Linum usitatissimum, comprese
alcune che hanno fiori blu simili e altre con fiori bianchi, gialli o rossi.
Alcune di queste sono piante perenni, a differenza di Linum usitatissimum, che è
una pianta annuale.
Il lino, in portoghese inho, in latino linum, in greco linon in lituano linas,
in olandese "linnen", in danese "linned", in lettone lini, in antico slavo, linu,
in russo ënu, in boemo e polacco len, in antico irlandese lin, viene forse dalla
radice indoeuropea Li-, "sciogliere", da cui il sanscrito Linas, "sciolto",
l'antico gotico "lein", pannolino e il tedesco "linde", "tiglio", per via della
morbidezza del suo filo. Alcuni però vi vedono lo stesso tema del latino "liber",
"corteccia", o meglio la parte fibrosa interna vicina alla parte legnosa, mentre
non è provata una parentela con l'antico anglosassone "lytel" con
l'inglese "little", che secondo alcuni in origine voleva dire anche "misto".
Invece il latino "usitatissimum" significa "molto utile". L'attuale parola
inglese e tedesca "flax" e quella dell'antico inglese "fleax" per "lino" invece
derivano dal proto-germanico *flahsą, e questa dal proto-indoeuropeo *pleḱ-,
"intrecciare".
La prima prova che gli esseri umani usavano il lino selvatico come tessuto proviene
dall'attuale Georgia: le fibre di lino selvatico filate,
tinte e annodate trovate nella grotta di Dzudzuana risalgono addirittura a
30.000 anni fa, quindi al Paleolitico
superiore: sicuramente il lino fu la prima fibra tessile in assoluto usata
dall'uomo. I nostri antenati addomesticarono per la
prima volta il lino nella regione della Mezzaluna Fertile: esistono prove
di lino dai semi oleosi domesticato con dimensioni del seme aumentate per
selezione umana da Tell Ramad in Siria, e frammenti di tessuto di lino da Çatalhöyük in Turchia,
un sito vecchio di ben 9.000 anni. L'uso del lino si diffuse rapidamente, arrivando
fino alla Svizzera e alla Germania 5.000 anni fa. In Cina e in India il lino
domestico veniva coltivato almeno 5.000 anni fa.
Il lino era ampiamente coltivato nell'antico Egitto, dove le pareti dei templi
erano decorati da affreschi in cui è riconoscibile il lino in fiore, e le mummie venivano
bendate utilizzando fasce di
lino. I sacerdoti egiziani indossavano solo vesti di lino, poiché era
considerato un simbolo di purezza. Una fabbrica dell'età del bronzo dedicata
alla lavorazione del lino è stata scoperta a Euonymeia, in Grecia. I Fenici commerciavano il
prezioso lino egiziano
in tutto il Mediterraneo, e i Romani lo usavano per le vele delle loro navi. Con il
declino dell'Impero Romano, anche la produzione di lino declinò, ma grazie a leggi
volte a pubblicizzare l'igiene dei tessuti di lino e le salutari proprietà dell'olio di
semi di lino, Carlo Magno fece rivivere il raccolto nell'VIII secolo. Le Fiandre divennero il principale centro dell'industria europea del
lino nel Medioevo. I coloni introdussero il lino in Nord America, e i mulini per la filatura del lino furono inventati da John Kendrew e Thomas
Porthouse di Darlington (Inghilterra) nel 1787. Nuovi metodi di lavorazione del
lino hanno portato a un rinnovato interesse per l'uso del lino come fibra
industriale, ma all'inizio del XIX secolo fu soppiantato dal cotone, più buon mercato.
L'aumento
dei salari agricoli causò la concentrazione della produzione di lino
nella Russia settentrionale, che arrivò a fornire il 90% della produzione
mondiale. Da allora il lino ha perso la sua importanza come coltura commerciale,
a causa della facile disponibilità di fibre più durevoli.
I terreni più adatti alla coltivazione del lino sono quelli alluvionali e quelli argillosi
contenenti una grande percentuale di sostanza organica. Le argille pesanti non sono adatte, così come i terreni di
natura ghiaiosa o sabbiosa asciutta. L'agricoltura del lino richiede pochi
fertilizzanti o pesticidi: entro otto settimane dalla semina, la pianta può
raggiungere i 10–15 cm di altezza, e i 70–80 cm
entro 50 giorni.
La fibra di lino viene estratta dalla rafia sotto la superficie dello stelo
della pianta di lino: è morbida, lucente e flessibile, e i fasci di fibre hanno
l'aspetto di capelli biondi e sono da due a tre volte più
resistenti delle fibre di cotone. Inoltre, le fibre di lino sono naturalmente
lisce e diritte. L'Europa e il Nord America dipendevano entrambi dal lino per i
tessuti a base vegetale fino al XIX secolo, quando il cotone superò il lino come
pianta più comune per la produzione di carta a base di stracci. Il lino è uno
dei tessuti più resistenti che esistano grazie alla sua componente cellulosica
che rinforza le fibre. La trama non troppo stretta rende il tessuto di lino
traspirante, leggero e fresco al tatto. Ha proprietà isolanti, termoregolatrici
e di assorbimento dell'umidità, che lo rendono una fibra ideale sia per
l'abbigliamento che per la biancheria per la casa. Essendo una fibra naturale, è
anallergico, non irrita la pelle e non attira le polveri, oltre ad essere
biodegradabile e riciclabile.
Oltre che come fibra tessile, il lino viene coltivato per i suoi semi, che
possono essere macinati in farina o trasformati in olio di semi di lino.
I semi di lino si presentano in due varietà: marroni o gialli entrambi sono molto ricchi di omega-3 (in
particolare acido alfa-linolenico), e sebbene entrambe possano essere consumate,
i semi di lino marroni sono più comunemente utilizzati nella produzione di
vernici, per la fibra e per l'alimentazione del bestiame. L'olio di semi di lino è uno dei più antichi oli
commerciali ed è ottenuto per pressatura,
talvolta seguita da estrazione con solvente. L'olio di semi di lino trattato con
solvente è stato utilizzato per molti secoli come olio essiccante nella pittura
e nella verniciatura.
I semi di lino possono anche essere consumati dall'uomo. Una porzione di 100
grammi di semi di lino macinati fornisce circa 534 kilocalorie, 41 g di grassi, 28 g di
fibre e 20 g di proteine. I semi di lino interi sono chimicamente stabili per
molti mesi,
ma la farina di semi di lino macinata, a causa dell'ossidazione, può diventare
rancida se lasciata esposta all'aria a temperatura ambiente in appena una
settimana. La refrigerazione e la conservazione in contenitori sigillati
manterranno la farina di semi di lino macinata per un periodo più lungo prima
che diventi rancida. Sono molto apprezzati i panini conditi con semi di lino prima della cottura.
Dopo aver schiacciato i semi per estrarre l'olio di semi di lino, la farina di
semi di lino risultante è un mangime ricco di proteine per ruminanti, conigli
e pesci. È spesso usata anche nel cibo per cani. L'alto
contenuto di acidi grassi omega-3 della farina di semi di lino
"ammorbidisce" il latte, le uova o la carne, cioè provoca un
maggiore contenuto di grassi insaturi e quindi ne riduce il tempo di
conservazione. L'alto contenuto di omega-3 ha anche un ulteriore
svantaggio, perché questo acido grasso si ossida e irrancidisce rapidamente. Un altro svantaggio della farina è che contiene
un antagonista della vitamina B6 (piridossina) e può richiedere l'integrazione
di questa vitamina, specialmente nei polli. Inoltre i semi di lino contengono
il 2-7% di fibra, che può essere utile agli esseri umani e
ai bovini, ma non può essere digerita dai non ruminanti e può essere
dannosa per gli animali giovani, a meno che non venga trattata con enzimi.
I semi di lino crudi e immaturi contengono composti cianogenici
e possono essere pericolosi per animali monogastrici come cavalli o conigli; la
cottura elimina questo pericolo.
La paglia di lino avanzata dalla raccolta dei semi oleosi è poco nutriente; è
dura e indigesta e non è consigliabile utilizzarlo come foraggio per ruminanti,
sebbene possa essere utilizzato come lettiera o imballato come frangivento.
La fibra di lino è una materia prima utilizzata nell'industria della carta di
alta qualità per l'uso di banconote stampate, carta assorbente e filtro, cartine
per sigarette e bustine di tè. Il lino viene coltivato anche come pianta
ornamentale nei giardini.
La moderna medicina ha dimostrato che il consumo di più di 30 g di semi di lino al
giorno per più di 12 settimane può ridurre l'indice di massa corporea, la pressione arteriosa sistolica
e diastolica e il colesterolo
totale nel sangue.
I semi di lino e il loro olio sono generalmente riconosciuti come sicuri per il
consumo umano; il glicoside cianogenico che contengono in piccole quantità non è tossico se consumato in
bassi dosi. Se si mettono 5 g di semi a macerare per 30 minuti in almeno 150 ml
d'acqua e li si assume 2-3 volte al giorno, l'effetto lassativo è assicurato, ma
occorre evitare di prolungare il trattamento con semi di lino oltre le 3-4
settimane per evitare l'insorgere di fenomeni di occlusione intestinale. I semi
di Lino possono essere assunti anche in forma di zuppa: vasta triturare un
cucchiaio di semi, lasciarli a riposare in acqua bollente e poi unirli a una
passata di verdure. Invece, per ottenere un cataplasma bisogna mettere 60 g di
farina di lino in 250 ml d'acqua e far cuocere per circa 5 minuti fino a che non
si ottiene una pasta abbastanza densa, quindi la si applica sul petto il più
caldo possibile, avvolgendolo in un telo di cotone e ripetendo più volte
l'applicazione per favorire il benessere delle vie respiratorie.
Nel settembre 2009, secondo quanto comparso sugli organi di stampa, le cultivar canadesi di lino sarebbero state contaminate
da una cultivar geneticamente modificata, chiamata "Triffid", che aveva ottenuto l'approvazione per la sicurezza di
alimenti e mangimi in Canada e negli Stati Uniti. I coltivatori
canadesi e il Flax Council of Canada hanno espresso preoccupazione per la
commerciabilità di questa cultivar in Europa, dove esiste una politica di
tolleranza zero nei confronti degli organismi geneticamente modificati non
approvati; di conseguenza, Triffid è stato cancellato dalla registrazione nel
2010 e non è mai stato coltivato commercialmente in Canada o negli Stati Uniti. Le cultivar di semi di lino canadesi sono state
ricostituite con semi privi di Triffid utilizzati per piantare il raccolto del
2014, e i laboratori sono certificati per testare la presenza di Triffid al
livello di un seme su 10.000.
Nell'ambiente italiano il lino ha trovato situazioni favorevoli sia per la
produzione di fibra tessile che di seme.
La grande industria liniera italiana ebbe origine verso il 1840, con l'impianto di opifici
meccanici a Villa d'Almè e a Cassano d'Adda. Nel 1928, l'industria, che produce
in misura inferiore alle esigenze del mercato, è concentrata specialmente in
Lombardia, Veneto, Emilia e Campania.
Dopo aver raggiunto la massima espansione negli anni 1850-1870, quando occupava
una superficie di 50.000 ettari, il lino andò progressivamente perdendo
terreno. L'affermazione di fibre naturali alternative al lino e
successivamente delle fibre sintetiche, fu alla base di declino, al quale dette
un contributo decisivo anche l'arretratezza tecnica della linicoltura che,
mancando di moderne strutture per la macerazione e la lavorazione, condotte per
lo più a livello familiare, non seppe adeguarsi alle esigenze dell'industria,
che richiedeva un prodotto di qualità, con caratteristiche specifiche uniformi.
Un importante tentativo di rilancio della coltivazione del lino ebbe luogo tra
le due guerre: nel 1940 la produzione di paglia di lino raggiunse le 24.500
tonnellate, mentre le superfici investite raggiunsero complessivamente i 15.000
ettari. Questi successi non riuscirono tuttavia ad impedire un nuovo
declino, che cominciò dopo la guerra.
Il territorio del Comune di Linera, in provincia di Catania, prima della sua
fondazione fu adibito alla coltivazione del lino, e con la fondazione del nucleo abitato, avvenuta
agli inizi del XIX secolo, il paese ha assunto la denominazione attuale in
ricordo di queste antiche coltivazioni.
La semina avviene normalmente ai primi di marzo, la raccolta dalla metà alla
fine di maggio e proporzionalmente più tardi nelle regioni del Nord. Nel 2021 gli
ettari coltivati erano 429, con una produzione di 9.294 quintali. La Toscana
coltivava 315 ettari, il resto era distribuito tra Lazio, Lombardia, Piemonte,
Emilia Romagna e Veneto. La coltivazione del lino da fibra copriva 16
ettari.
Il lino è ampiamente citato nella Bibbia. Quando Giuseppe è nominato Vicerè
d'Egitto, « i faraone si tolse di mano l'anello e lo pose sulla mano di
Giuseppe; lo rivestì di abiti di lino finissimo e gli pose al collo un monile
d'oro » (Gen 41,42). Nel corso delle Piaghe d'Egitto, « il lino e l'orzo erano
stati colpiti, perché l'orzo era in spiga e il lino in fiore » (Es 9,31) Mosè
comunica al popolo gli ordini del Signore per quando riguarda le vesti: « Il
sacerdote, indossata la tunica di lino e vestiti i calzoni di lino sul suo
corpo, toglierà la cenere, dopo che il fuoco avrà consumato l'olocausto sopra
l'altare » (Lv 6,3). Ezechiele riprende questa prescrizione per i sacerdoti: «
Quando entreranno dalle porte dell'atrio interno, indosseranno vesti di lino;
non porteranno alcun indumento di lana… Porteranno in capo turbanti di lino e
avranno calzoni di lino sui fianchi: non si cingeranno con indumenti che fanno
sudare. » (Ez 44,17-18) Il libro di Ester ci ricorda che il palazzo del re
Assuero (secondo alcuni l'imperatore persiano Serse, secondo altri suo figlio
Artaserse I) era decorato di questo tessuto nobile: « La sala era adornata con
drappi di lino delicato e pregiato, appesi a cordoni di lino color porpora,
fissati a ganci d'oro e d'argento, su colonne di marmo pario e di pietra » (Est
1,6) Secondo il libro di Daniele, persino gli angeli sono vestiti di lino: «
Alzai gli occhi e guardai, ed ecco un uomo vestito di lino, con ai fianchi una
cintura d'oro di Ufaz... » (Dan 10,5) Nell'elogio della donna virtuosa, il libro
dei Proverbi dice: « Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le
mani... » (Prov 31,13) Del ricco epulone e dell'omonima parabola il Vangelo
dice: « C'era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino
finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti... » (Lc 16,19) L'evangelista
Giovanni utilizza il lino per festeggiare le nozze dell'Agnello, che sono
simbolo del Regno dei Cieli: « Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a Lui
gloria, perché sono giunte le nozze dell'Agnello; la sua sposa è pronta: le fu
data una veste di lino puro e splendente. » E specifica: « La veste di lino sono
le opere giuste dei santi. » (Ap 19,7-8)
Ma soprattutto, è tessuta in lino a spina di pesce la Sindone di Torino, un
lenzuolo di circa 4,41 x 1,13 metri, su cui è visibile la doppia immagine
del corpo di un uomo morto in seguito ad una serie di torture culminate con la
sua crocifissione. L'immagine è danneggiata da due linee nere strinate e da una
serie di lacune, a causa dell'incendio scoppiato nel 1532 a Chambéry dove era
conservata. Secondo la tradizione cattolica, la Sindone di Torino è il lenzuolo
citato nei Vangeli (Mt 27,59; Mc 15,46; Lc 23,53) che fu usata da San Giuseppe
d'Arimatea per avvolgere il corpo di Gesù nel sepolcro. Secondo alcuni la
Sindone coinciderebbe con il Mandylion di Edessa, trasferito a Costantinopoli
per sfuggire all'occupazione araba e poi trafugato da Crociati durante lo
scigurato Sacco di Costantinopoli del 1204. I credenti fanno leva sul mistero
che avrebbe portato alla formazione dell'immagine sindonica, al crocifisso su di
essa rappresentato e su varie prove scientifiche (es. la presenza di pollini
provenienti solo da Palestina e Anatolia), mentre gli scettici citano una
datazione al carbonio-14 effettuata nel 1988, che ha datato il lenzuolo
all'inizio del XIV secolo, ma anche quest'ultima datazione è controversa perchè
quasi certamente il tessuto datato era contaminato. Comunque sia, di sicuro la
Sindone è importante perchè rappresenta un rimando diretto e immediato che aiuta
a comprendere e meditare la drammatica realtà della Passione di Gesù, e per
questo San Giovanni Paolo II l'ha definita «della passione, della morte e della
resurrezione testimone muto, ma nello stesso tempo sorprendentemente eloquente
». E' in lino anche il cosiddetto Sudario di Oviedo, che non mostra immagini
riconoscibili ma solo macchie di sangue, che però sono perfettamente compatibili
con il volto dell'Uomo della Sindone, infittendo il mistero.
Per concludere, nelle prime versioni della fiaba della Bella Addormentata, come "Sole, Luna e Talia" di Giambattista Basile
(1583-1632), la principessa si punge il dito non su un
fuso, come mostra il celebre lungometraggio animato di Walt Disney, ma su una scheggia di lino.
"Il lino" è anche il titolo di una bella fiaba dello scrittore danese Hans
Christian Andersen (1805-1875), nel quale il lino racconta in prima persona la
propria avventurosa vita dalla semina all'utilizzo come carta.
Due pittori belgi, attivi nello stesso periodo, hanno rappresentato il
momento della raccolta del lino nei loro dipinti: Modeste Huys (1874–1932) ed Emile Claus
(1849–1924). Nel settembre 1889, poco prima della sua morte in circostanze mai
del tutto chiarite,
Vincent van Gogh (1853-1890),
dipinse la "Contadina che stiglia il lino" a Saint-Rémy-de-Provence, ispirandosi
al disegno su carta di Jean-François Millet che fa parte della raccolta "The Labours of the Fields" esposta nello stesso Museo.
Invece "Le filatrici di lino" è un'opera dell'inglese Mark Senior (1864–1927) Il motivo del
Il lino è stato adottato come simbolo dell'Irlanda del Nord: i sei
fiori indicano le sei contee che compongono il Paese, mentre la pianta ricorda la
sua storia e la sua importanza nell'agricoltura e nelle industrie
manifatturiere. Nel 1986 è stata emessa, con un conio totale di 10.409.501 pezzi,
una moneta da una sterlina recante sul retro il disegno di una pianta di lino e
il diadema reale che rappresentano l'Irlanda del Nord.

I
giunchi su cui fu scritta la storia dell'uomo
E veniamo al
papiro. Cyperus papyrus, conosciuto anche come
canna della carta o erba del Nilo, è una pianta da fiore acquatica appartenente
alla famiglia delle Ciperacee. È una tenera pianta erbacea perenne, originaria
dell'Africa, e forma alti banchi di vegetazione palustre simile a un canneto in
acque poco profonde. Questa pianta acquatica alta e robusta può crescere da 4 a
5 m, ma ai margini di laghi d'alta quota come il lago Naivasha in Kenya e il
lago Tana in Etiopia, ad altitudini di circa 1.800 m, i culmi di papiro possono
misurare fino a 9 metri di altezza. Ogni culmo è un ' internodo, il più
lungo conosciuto di qualsiasi pianta. Forma un ciuffo di steli verdi triangolari
che si alzano da spessi rizomi legnosi. Ogni stelo è sormontato da un denso
grappolo di raggi filiformi sottili, verde brillante, lunghi da 10 a 30 cm (da 4
a 10 pollici), che assomigliano a un piumino quando la pianta è giovane.
L'infiorescenza è un'ombrella appuntita, ciascuno dei fino a mille raggi
dell'ombrella termina in un spiga di piccoli fiori bruno-verdastri, i quali poi
lasciano il posto a frutti marroni simili a noci. Sebbene non siano visibili
foglie al di sopra della superficie del suolo, le parti più giovani del rizoma
sono ricoperte da squame rosso-marroni, cartacee, triangolari, che ricoprono
anche la base dei culmi. Tecnicamente si tratta di foglie ridotte, quindi in
senso stretto non è del tutto corretto chiamare questa pianta "senza foglie"come
fanno alcuni. Il papiro tollera temperature annuali da 20° a 30°C e un pH del
suolo da 6,0 a 8,5. Fiorisce a fine estate e preferisce il pieno sole a
condizioni parzialmente ombreggiate. Come la maggior parte delle piante
tropicali, è sensibile al gelo. Il carice di papiro forma vasti popolamenti
nelle paludi, nei laghi poco profondi e lungo le rive dei corsi d'acqua nelle
parti più umide dell'Africa; in acque più profonde è il principale costituente
delle masse di vegetazione galleggianti e aggrovigliate note come sudd. Le teste
fiorite sono siti di nidificazione ideali per molte specie sociali di uccelli.
L'areale originario della specie era l'Africa tropicale e subtropicale, dal
Madagascar ala Giordania; secondo alcuni potrebbe essere originario anche della
Sicilia orientale, mentre secondo altri vi è stato introdotto dagli Arabi nel IX
secolo. Come nella maggior parte dei carici, l'impollinazione avviene tramite il
vento, non con gli insetti, e i frutti maturi dopo il rilascio vengono
distribuiti dall'acqua. Nel delta del Nilo Cyperus papyrus era ampiamente
coltivato fin da tempi antichissimi: ad esempio è raffigurato su un frammento di
stucco restaurato dal palazzo di Amenhotep III vicino all'attuale villaggio di
Malkata. In Egitto la produzione di papiro ebbe un brusco rallentamento fino a
scomparire nell'XI secolo, dopo 4200 anni di produzione, a causa di una forte
siccità che dal 1052 al 1055 colpì il fiume Nilo, portando il papiro egiziano
vicinissimo all'estinzione: né l'esploratore Peter Forsskål (1732-1763),
discepolo di Carlo Linneo, recatosi in Egitto nel 1760, né la spedizione
napoleonica del 1799 lo videro nel Delta. Fu riscoperto nel 1968, ed attualmente
in Egitto rimane solo una piccola popolazione di papiro a Wadi El Natrun. Oggi
però è stato introdotto in molti altri paesi. Secondo Teofrasto (Storia delle
piante, IV, 10) cresceva anche in Siria, mentre Plinio il Vecchio (Naturalis
Historia) vi aggiunge i corsi dei fiumi Niger ed Eufrate. In Europa cresce
spontaneamente solo in alcune zone umide della Sicilia orientale, in particolare
nel territorio di Siracusa, lungo il corso dei fiumi Anapo e Ciane, e alle
sorgenti del Fiumefreddo nel catanese. Negli Stati Uniti ha invaso la Florida,
la Louisiana, la California e le Hawaii.
La pianta del papiro è relativamente facile da coltivare dal seme, anche se in
Egitto è più comune dividere il portainnesto, che cresce abbastanza velocemente
una volta stabilito. È preferibile un terreno estremamente umido o radici
affondate nell'acqua e la pianta può fiorire tutto l'anno. La propagazione
vegetativa è il processo suggerito per creare nuove piante: la si esegue
dividendo i rizomi in piccoli gruppi e piantandoli separatamente.
La parola papiro, da cui derivano l'inglese "paper", il tedesco e il polacco
"papier", il danese e il norvegese "papir", lo svedese "papper", lo spagnolo e
il portoghese "papel", il finlandese "paperi", l'estone "paber" e l'antico slavo
"papirije", tutti nel significato generico di "carta", è a volte ricondotta
attraverso il greco "papyros" al termine "pappos", "lanugine", ma questa
etimologia non è convincente, perchè quasi certamente la parola è di origine
egiziana antica. Qualcuno la riconnette al copto "papirop", cioè "germoglio". Da
notare che fa eccezione l'italiano, in cui la parola "papiro" è usata solo per
indicare un qualche documento, specialmente burocratico. La parola "carta"
invece deriva dal latino "charta", che indicava in origine un singolo foglio di
papiro o di pergamena. A sua volta "charta" deriva dal greco "chartes", parola
che alcuni ricollegano al greco "charasso", "incido" (come si incidevano le
tavolette di cera o di argilla); forse però anche tale termine ha un'origine
molto più lontana, e anch'essa egiziana, da un termine utilizzato per indicare i
singoli fogli di papiro. Invece il nome latino del genere, Cyperus, proviene dal
greco "kypeiros", probabilmente di origine semitica e riconnesso all'ebraico "kōper",
che indicava una resina citata anche nella Bibbia.
Oggi il papiro viene coltivato soprattutto a scopo ornamentale, ma nell'Antico
Egitto (dove era chiamato "aaru") aveva molteplici usi: il midollo era usato
come alimento e fonte di fibre tessili, i fiori per farne ghirlande, il rizoma
come combustibile e le parti più robuste (radici e fusto) per pentole, utensili,
calzature, sartiame e addirittura per farne imbarcazioni. Esse sono visibili nei
bassorilievi della IV dinastia che mostrano uomini che tagliano il papiro per
costruire una barca; barche simili sono ancora prodotte nel Sudan meridionale. I
pescatori del delta dell'Okavango usano ancor oggi piccole sezioni dello stelo
come galleggianti per le loro reti. Secondo l'Odissea, Ulisse fece chiudere
l'ingresso nella sua sala da pranzo con una fune di papiro quando fece strage
dei Proci (Odissea XXI,390). Il papiro inoltre era fondamentale nei riti
religiosi della Valle del Nilo. Nel Basso Egitto il papiro era simbolo di
fertilità, fecondità e rigenerazione; la pianta veniva offerta come dono agli
dei egizi durante le processioni religiose e funerarie. Per esempio nel Papiro
di Ani, databile al 1250 a.C., scoperto nel 1888 ed oggi conservato al British
Museum di Londra, è possibile osservare la raffigurazione dello scriba reale Ani
e di sua moglie mentre offrono agli dei doni sacrificali per poter accedere al
cospetto di Osiride (è la versione più completa del cosiddetto "Libro dei
Morti"); il papiro nelle mani della moglie simboleggia la rinascita ad una nuova
vita. E non basta: gli antichi Egizi si nutrivano di papiro crudo, lessato
oppure arrosto, ne mangiavano le radici e ne bevevano il succo. A Siracusa era
abitudine dei pastori estrarre dalla parte più tenera della pianta, ovvero dal
midollo, il succo dolciastro.
L'uso più famoso del papiro era però un altro: dal papiro si ricava un materiale
di supporto alla scrittura che ebbe un vastissimo utilizzo nell'antichità. Si
otteneva incollando opportunamente svariati strati di strisce di midollo
disposti perpendicolarmente l'uno all'altro. Si può dire che sul papiro sia
stata scritta la storia delle civiltà mediterranee dell'antichità:
l'introduzione della pergamena, più resistente, risale infatti solo al II secolo
e la sua diffusione al V. Il nome più antico di questa pianta è byblos,
derivante da quello dell'antica città fenicia di Byblos che ne faceva commercio;
non a caso, da tale termine deriva quello odierno di "libro", ma anche di
"Bibbia!" I più antichi papiri ritrovati dagli archeologi risalgono al terzo
millennio avanti Cristo grazie al clima secco dell'Egitto. I ritrovamenti sono
comunque rari e perciò sono molto famose alcune raccolte di frammenti, come
quella rinvenuta nell'antica città egiziana di Ossirinco e quella più
recentemente scoperta a Nag Hammadi. Una parte dei celebri Manoscritti del Mar
Morto ritrovati presso l'antica comunità essena di Qumran e databili tra il 150
a.C. e il 70 d.C. fu scritta su papiro. Ricordiamo tra l'altro il Papiro di
Rhind, compilato dallo scriba Ahmes verso il 1650 a.C. durante il regno di
Aauserra Ipepi (quinto sovrano della XV dinastia), forse utilizzando il
materiale di papiri più antichi; oggi si trova al British Museum, che lo
acquistò nel 1865. Il nome Rhind fa riferimento ad Alexander Henry
Rhind (1833-1863), un antiquario scozzese che acquistò il papiro nel 1858 sul
mercato nero egiziano. Probabilmente è il più esteso papiro egizio di
argomento matematico giunto fino a noi: contiene 84 problemi aritmetici,
algebrici e geometrici con le relative soluzioni. Dal momento che nel clima europeo un
papiro poteva conservarsi in buono stato per circa trecento anni, non sono
sopravvissuti in Europa molti papiri originali di età greca o romana; le uniche
eccezioni sono i papiri carbonizzati rinvenuti nella famosa Villa dei Papiri di Ercolano, che tecniche modernissime hanno reso nuovamente leggibili. Nel 641
d.C. l'Egitto venne conquistato dagli Arabi, e le conseguenze per il commercio
del papiro furono esiziali, perché i nuovi padroni decisero di commerciare solo
con genti di fede musulmana. Tutta l'Europa rimase quindi tagliata fuori dal
commercio del papiro. La cancelleria pontificia redasse l'ultimo documento su
papiro nel 1057; il papiro fu sostituito prima dalla pergamena e poi dalla più
economica carta. In epoca moderna fu l'archeologo catanese Saverio Landolina
Nava (1743-1814) a far riprendere la produzione della millenaria carta di papiro
verso il 1780 nella città di Siracusa, e lo fece utilizzando i papiri del fiume
Ciane e le istruzioni dell'antico romano Plinio il Vecchio, il quale le aveva
lasciate scritte nella sua "Naturalis Historia". La nuova produzione imita
sostanzialmente i papiri antichi ed è indirizzata ad un mercato essenzialmente
turistico.
Una curiosità: fino agli anni settanta era chiamato scherzosamente "papiro" un
documento rilasciato dagli studenti degli ultimi anni alle giovani "matricole",
dietro opportuno compenso. Serviva di fatto come una specie di passaporto di
frequentazione dell'università, che la matricola doveva portare con sé per
evitare atti di nonnismo (a volte pesanti) soprattutto da parte degli studenti
più anziani e fuori corso.
Il papiro è citato molte volte nella Bibbia. La madre di Mosè, « non potendo
tenerlo nascosto più oltre, prese per lui un cestello di papiro, lo spalmò di
bitume e di pece, vi adagiò il bambino e lo depose fra i giunchi sulla riva del
Nilo » (Es 2,3) Il tema della nascita di Mosè si colloca in un diffuso genere
letterario circa le narrazioni dell'infanzia di uomini famosi, che sarebbero
stati abbandonati in una foresta o in una cesta in balia delle acque, furono
salvati da provvidenziali soccorritori e divennero chiavi di volta della storia.
Tra gli altri hanno avuto questo destino Romolo e Remo, Edipo di Tebe, Paride
figlio di Priamo e Sargon di Akkad, conquistatore mesopotamico del XXIII secolo
a.C. che sarebbe stato abbandonato sull'Eufrate in una cesta, e sarebbe stato
salvato e allevato dal giardiniere degli déi. Inoltre un antico mito egizio, di
cui gli Ebrei furono a conoscenza durante la loro permanenza nel delta, narra
che la dea Iside nascose suo figlio Horus, appena nato, in una macchia di papiro
del delta per salvarlo dalla morte minacciata da Seth. Giobbe dice poi: i miei
giorni « volano come barche di papiro, come aquila che piomba sulla preda. » (Gb
9,26) Alle famose barche di papiro fa riferimento anche il profeta Isaia in un
suo celebre oracolo contro 'Etiopia: « Ah! Terra dagli insetti ronzanti, che ti
trovi oltre i fiumi dell'Etiopia, che mandi ambasciatori per mare, in barche di
papiro sulle acque... » (Is 18,1-2): probabilmente il profeta si riferisce ai
cosiddetti "Faraoni Neri" della XXV dinastia, di origine nubiana, che
approfittarono dello stato di anarchia feudale in cui versava l'Egitto per
conquistarlo e governarlo dal 727 al 671 a.C., per poi essere ricacciati a sud
dall'invasione degli Assiri guidati da Assurbanipal.
Per finire, non possiamo non citare l'esploratore ed avventuriero norvegese Thor
Heyerdahl (1914-2002), sostenitore di tesi archeologiche eterodosse e per lo più
respinte dagli storici accademici. Nel tentativo di dimostrare che antichi
popoli africani o mediterranei avrebbero potuto raggiungere l'America
precolombiana e popolarla, una tesi che periodicamente torna alla ribalta ma che
non ha mai trovato tesi convincenti a suo sostegno, egli fece costruire una
barca interamente in papiro utilizzando solo le tecniche note all'epoca
faraonica, la battezzò "Ra" e nel 1969 partì dalla città marocchina di Safi,
nota anche ai Fenici, ma dopo 56 giorni naufragò a solo una settimana di
navigazione dalla meta. Ci riprovò l'anno successivo con il "Ra II ", stavolta
costruita da nativi americani Aymara del lago Titicaca, percorse in 57 giorni
3.270 miglia e finalmente raggiunse l'isola di Barbados. Gli storici riconoscono
che con questa impresa egli dimostrò la fattibilità tecnica, già nell'antichità,
di lunghe traversate oceaniche, ma ovviamente questo non significa che tali
traversate furono fatte davvero. Gli antichi eseguivano per lo più navigazioni
sottocosta, temendo di affrontare l'ondoso mare, e la totale assenza oltreoceano
di manufatti egizi o fenici autentici (di fasulli ne sono stati spacciati
parecchi) rende improbabile che tali imprese siano state compiute davvero,
nonostante la resistenza delle navicelle realizzate con il solo apparentemente
fragile papiro.

Il
fiore che per poco non costò caro a 007
La digitale (Digitalis
purpurea) è una pianta erbacea e perenne dai grandi fiori rossi, la cui
classificazione tassonomica è in via di definizione in quanto fino a poco tempo
fa il suo genere apparteneva alla famiglia delle Scofulariacee, mentre oggi con
i nuovi sistemi di classificazione filogenetica è stata assegnata alla famiglia
delle Plantaginacee. In spagnolo è chiamata anche "Alcahueta del cerezo"
("Protettrice del ciliegio").
Si tratta di una pianta alta da mezzo metro fino a un metro e mezzo con ciclo
biologico bienne; il fusto fiorito si sviluppa il secondo anno; le gemme sono
situate alla base del terreno, mentre i fusti hanno un'infiorescenza terminale.
Il fusto è eretto, a sezione cilindrica e di colore bianco; la sua superficie è
ricoperta di peli ghiandolari e non è ramificato. Tutte le foglie sono ricoperte
da nervature reticolate e crenate sui bordi; sono bianche sulla pagina
inferiore, mentre quella superiore è colorata di verde scuro. Le foglie basali,
raccolte in rosette, hanno forma da ovale o oblunga a spatolata, acute all'apice
e picciolo strettamente alato; dimensione delle foglie basali: larghezza 2 – 3
cm; lunghezza 12 - 15 cm; invece quelle nella parte aerea dello stelo sono
lanceolate, disposte a spirale lungo il fusto. L'infiorescenza è formata da un
racemo allungato, che arriva a mezzo metro di lunghezza, e alla base di ogni
pedicello è presente una brattea. I singoli fiori sono penduli, onde proteggere
il polline e il nettare dalla pioggia. I fiori sono ermafroditi, tetraciclici
(sono composti da calice, corolla, androceo e gineceo) e pentameri (calice e
corolla sono divisi in cinque parti). La corolla ha forma campanulata, è di
colore rosso porporino chiazzata di bianco (ma esistono varietà in cui il fiore
è rosa, giallo o bianco) e nella zona dell'ovario prende una forma tubolare
nella parte che contiene il nettare. È noto che i colori dei petali della
Digitalis purpurea sono determinati da almeno tre geni che interagiscono tra
loro. Nella parte interna sono presenti delle setole pelose. Gli stami sono
cinque e sono inclusi nella campanula corollina. Normalmente fiorisce da maggio
a luglio. L'impollinazione avviene tramite insetti. Le antere maturano prima
degli stimmi, e quindi è possibile l'autoimpollinazione, ma è anche chiaro che
tutta la struttura del fiore è predisposta per favorire l'impollinazione
soprattutto da parte dei calabroni. Il frutto è una capsula verde allungata che
si apre per fenditure longitudinali, in modo che venga disperso al vento un gran
numero di piccolissimi semi di 0.1-0.2 mm di diametro. I semi cadono a terra
dopo essere stati trasportati per alcuni metri dal vento, e sono successivamente
dispersi soprattutto da insetti come le formiche (disseminazione mirmecoria).
Originaria dell'area del Mediterraneo occidentale, in Italia è spontanea
principalmente in Sardegna; altrove è coltivata nei giardini. Oggi è stata
diffusa praticamente in tutto il mondo per motivi ornamentali. Il suo tipico
habitat sono le radure boschive collinari, i pascoli montani, le strade
forestali e le aree incendiate. Il substrato preferito è siliceo con pH acido ed
alti valori nutrizionali del terreno, che deve essere mediamente umido. Sui
rilievi la si può trovare da 500 fino a 1.700 m sul livello del mare. Digitalis
purpurea è resistente fino a temperature di - 15°C.
I botanici si sono chiesti l'utilità delle macchie e delle setole pelose
all'interno della corolla. Probabilmente le macchie hanno una funzione di guida
alla ricerca del nettare da parte degli insetti pronubi, mentre la presenza
delle setole pelose non trova tutti concordi in una univoca spiegazione: c'è chi
dice che servano a tenere lontani certi insetti troppo piccoli, o chi al
contrario che le setole servano come punto di appoggio per essi.
Le larve del carlino della digitale (Eupithecia pulchellata) si nutrono dei
fiori della digitale: i bruchi di questa falena strisciano nei fiori appena
sbocciati, un bruco per fiore, quindi tessono una tela di seta sull'imboccatura
del fiore, sigillandolo, e procedono a nutrirsi degli stami e dei semi in via di
sviluppo. Quando gli altri fiori non infetti cadono, la corolla dei fiori
infetti rimane sulla pianta e il bruco diventa una pupa dentro il fiore. Questa
specie è stata segnalata in Gran Bretagna, Germania, Svizzera e Austria.
Esistono anche lepidotteri che mangiano le foglie, tra cui Mellicta athalia e
Xestia ashworthii in Gran Bretagna, Eurodryas aurinia in Romania e Mellicta
deione in Portogallo.
Il primo studioso ad introdurre il nome del genere fu il botanico e fisico
germanico Leonhart Fuchs (1501-1566); il termine "Digitalis" significa "ditale",
e indubbiamente il fiore ricorda questo oggetto da sartoria, visto che un dito
umano vi può essere infilato per intero. In seguito il botanico francese Joseph
Pitton de Tournefort (1656-1708) lo rese popolare nelle sue opere, Linneo
assegnò a questo genere una dozzina di specie. Il nome della specie ("purpurea")
allude invece al colore porporino dei fiori.
Secondo le leggende celtiche irlandesi, il fiore della Digitalis sarebbe usato
dagli elfi come copricapo. Si dice che le fate malvagie abbiano creato i suoi
fiori per le volpi affinché le usino come guanti in modo da irrompere nei pollai
senza provocare alcun rumori, e che il disegno dei fiori corrisponda alle
impronte digitali delle fate sfortunate.
L'uso di estratti della Digitalis purpurea per il trattamento dello scompenso
cardiaco fu descritto per la prima volta dal britannico William Withering
(1741-1799). Le foglie di questa pianta contengono infatti alcuni glicosidi
farmacologicamente attivi (digitossina e digossina) che hanno potenti effetti
sul cuore, inibendo la attività della ATPasi sodio-potassio; ciò causa un
aumento del Na+ intracellulare e del calcio, il che produce un
aumento della forza di contrazione del muscolo cardiaco. Sono principalmente
indicati nella terapia dell'aritmia e dell'insufficienza cardiaca; tuttavia le
stesse sostanze, se assunte in dosi eccessive, possono causare seri problemi,
dall'aritmia all'arresto cardiaco, talora letali. La digitale è un classico
esempio di farmaco derivato da una pianta usata un tempo come rimedio dalla
medicina popolare: inizialmente, una volta accertata l'utilità della digitale
nel regolarizzare il polso, la pianta venne impiegata per curare un gran numero
di patologie, compresa l'epilessia e altri disturbi convulsivi. Durante la
seconda guerra mondiale furono istituiti comitati erboristici per raccogliere
erbe medicinali quando la guerra navale degli U-boot tedeschi creava carenza di
farmaci; i comitati raccoglievano anche la Digitalis purpurea che veniva usata
per regolare il battito cardiaco. Oggi però per tutte queste indicazioni l'uso
della digitale è considerato inadeguato, ed anche in erboristica il suo uso è
stato ormai abbandonato a causa del suo basso indice terapeutico e della
difficoltà nel determinare la dose attiva. Infatti un leggero aumento nel
dosaggio di queste sostanze può fare la differenza tra una dose innocua e una
fatale. L'intossicazione da digitale derivante da sovradosaggio può manifestarsi
con una visione in itterico (giallo) e con la comparsa di contorni confusi
(aloni) e bradicardia; i sintomi comprendono inoltre nausea e vomito. La
possibile insorgenza di blocco atrio-ventricolare può essere fatale. Nel famoso
film "007 - Casino Royale" (2006), James Bond interpretato dall'algido Daniel
Craig si scontra in un torneo di poker con il cattivone di turno, Le Chiffre, il
quale, sconfitto, gli fa versare estratto di Digitalis nel suo Martini. Bond ne
beve un sorso, si sente male e va in arresto cardiaco, ma viene salvato da
Vesper Lynd con un defibrillatore portatile. Bella mossa, ma se il film descrive
correttamente i sintomi della tossicità della Digitalis, il tempismo è
sbagliato: la Digitalis richiede in genere almeno sei ore per mostrare i suoi
effetti in modo acuto. Naturalmente i film di James Bond si basano su drammi
sensazionalistici, e questo spiega anche l'uso di un defibrillatore, un
trattamento che secondo i medici potrebbe innescare aritmie cardiache ancora
peggiori o interrompere del tutto il battito cardiaco. La lidocaina, il farmaco
che Bond si inietta, probabilmente sarebbe stato sufficiente, sebbene la stessa
lidocaina possa anche contribuire alle aritmie se non dosata correttamente.
Alcuni storici sostengono che il dottor Paul Ferdinand Gachet (1828-1909) abbia
prescritto estratto di Digitalis a Vincent Van Gogh (1853-1890) per curare la
sua epilessia. Ma questo estratto comprometterebbe la percezione visiva e
tingerebbe la visione di giallo, proprio come si vede in molti suoi quadri. In
effetti Van Gogh ha dipinto il "Ritratto del dottor Gachet con ramo di
digitale", ma non ci sono prove dirette che il grande pittore ne abbia assunto
l'estratto.
Infine, "La Digitale purpurea" è una celebre poesia di Giovanni Pascoli
pubblicata nel 1898 nei "Primi Poemetti". La composizione prende spunto da un
ricordo di Maria, sorella di Pascoli, che raccontò al fratello della presenza di
questa specie vegetale presso l'istituto di suore che la ospitava, a Sogliano al
Rubicone, e le suore le avevano vietato di avvicinarsi ad esso perchè velenoso.
Pascoli inventa la storia di una donna bionda, Maria, personificazione della
sorella, e di una seconda donna bruna, Rachele, simbolo dell'altra sorella Ida.
Le due donne si incontrano dopo molti anni, uscite dal convento, e parlando dei
ricordi in comune Rachele confessa a Maria di essersi avvicinata al fiore e di
averlo odorato. « L'aria soffiava luce di baleni / silenzïosi. M'inoltrai
leggiera, / cauta, su per i molli terrapieni / erbosi. I piedi mi tenea la folta
/ erba. Sorridi? E dirmi sentia: Vieni! / Vieni! E fu molta la dolcezza! molta!
/ Tanta, che, vedi… (l'altra lo stupore / alza degli occhi, e vede ora, ed
ascolta / con un suo lungo brivido…) si muore! » Ida infatti si è sposata e,
attraverso il matrimonio, ha odorato la Digitalis purpurea, ovvero ha provato la
trasgressione consumando un rapporto sessuale. In altre parole Rachele/Ida ha
odorato il fiore che le ha fatto provare l'abbandono dei sensi, ed ora è come
morta, come Eva dopo aver mangiato il frutto proibito. Insomma, la poesia mostra
la contrapposizione tra innocenza e sensualità, un tema molto caro al
Decadentismo (ritornerà ne "Il Piacere" di D'Annunzio, dove il protagonista
Andrea Sperelli è diviso tra due donne assai diverse tra loro, Maria Ferres la
pudica ed Elena Fuentes la trasgressiva). Quanta poesia in un fiore purpureo a
forma di ditale!

La
fibra degli Assassini
E ora, la
canapa! Cannabis è un genere di piante da fiore
della famiglia delle Cannabacee. Il genere Cannabis era precedentemente
collocato nella famiglia dell'ortica, le Urticacee, o nella famiglia del gelso,
le Moracee; successivamente, insieme al genere Humulus (quello del luppolo), è
stata creata per essa una famiglia separata. Recenti studi filogenetici basati
sull'analisi del sequenziamento genico suggeriscono che le Cannabaceee in senso
stretto siano comparse all'interno della precedente famiglia delle Celtidacee, e
che le due famiglie dovrebbero essere unite per formare un'unica famiglia monofiletica.
Il numero di specie all'interno del genere Cannabis è controverso; di solito le
tre specie riconosciute sono Cannabis sativa,
Cannabis indica (la famigerata "canapa indiana") e
Cannabis ruderalis, ma alcuni includono quest'ultima
in Cannabis sativa, altri trattano tutte e tre come sottospecie di Cannabis
sativa. Il genere è ampiamente accettato come originario dell'Asia. La cannabis
è un'erba annuale, dioica, con foglie palmate composte o digitate, con
foglioline seghettate. La prima coppia di foglie di solito ha una sola
fogliolina, il numero aumenta gradualmente fino a un massimo di circa tredici
foglioline per foglia (solitamente sono sette o nove), a seconda della varietà e
delle condizioni di crescita. Nella parte superiore di una pianta in fiore,
questo numero diminuisce nuovamente a una singola fogliolina per foglia. Le
foglie hanno un modello di venatura peculiare che varia leggermente tra le
varietà e che consente una facile identificazione delle foglie di cannabis da
specie non imparentate con foglie simili. Tutti i ceppi conosciuti di Cannabis
sono impollinati dal vento, e il frutto è un achenio. La cannabis è
prevalentemente dioica, con fiori staminati "maschili" e fiori pistillati
"femminili" presenti su piante separate. I fiori maschili sono normalmente
portati sciolti pannocchie, e i fiori femminili sono portati su racemi. Sono
state descritte anche molte varietà monoiche, che portano fiori maschili e
femminili in posizioni diverse sulla stessa pianta. Le varietà dioiche sono
preferite per la produzione di droga, dove vengono utilizzati i frutti, e per la
produzione di fibre tessili, mentre le varietà monoiche sono preferite per la
produzione di polpa e carta.
Le piante di cannabis producono un gran numero di sostanze chimiche come difesa
contro gli erbivori. Un gruppo di queste sostanze sono chiamate cannabinoidi,
che inducono effetti fisici e psichici se consumati. Cannabinoidi, terpenoidi e
altri composti sono secreti dai tricomi ghiandolari che si trovano più
abbondantemente sui calici floreali e sulle brattee delle piante femminili. Sono
stati isolati nella Cannabis almeno 85 cannabinoidi diversi, molti dei quali
producono lo "sballo" che si può provare consumando marijuana. I due
cannabinoidi solitamente prodotti in maggiore abbondanza sono il cannabidiolo (CBD)
e/o il Δ 9 - tetraidrocannabinolo (THC), ma solo il THC è psicoattivo. Sebbene
la produzione complessiva di cannabinoidi sia influenzata da fattori ambientali,
il rapporto THC/CBD è determinato geneticamente e rimane fisso per tutta la vita
di una pianta.
La parola "canapa" deriva dall'antico inglese "hænep", dal proto-germanico *hanapiz. Alcuni
studiosi ritengono che sia un prestito non ricostruito di origine scitica. Anche
la parola greca κάνναβις, da cui deriva quella cannabis, è considerata un
prestito della stessa origine scita, abbastanza antico da essere influenzato
dalla legge di Grimm, per cui l'iniziale proto-indoeuropea *k- diventa *h- in
germanico. Lo spostamento di *k → h indica che era una parola in prestito nella
lingua madre germanica in una profondità temporale non successiva alla
separazione del germanico comune dal proto-indoeuropeo, verso il 500 a.C. Altri
sostengono che il nome viene dal greco "kanna" per la forma della pianta e dal
suffisso "bis", che si riferirebbe ai termini "bosm" (ebraico) e "busma" (aramaico)
col significato di "aromatico, dal buon profumo". Invece "ḥashīsh" in arabo
significa semplicemente "erba".
Probabilmente la Cannabis si è separata dal suo parente più stretto, Humulus (il
luppolo) alla metà dell'Oligocene, circa 27,8 milioni di anni fa, secondo le
stime dell'orologio molecolare. Il centro di origine della Cannabis è
probabilmente nell'altopiano tibetano nord-orientale. I pollini di Humulus e
Cannabis sono molto simili e difficili da distinguere; il polline più antico che
si ritiene provenga dalla Cannabis proviene dal Ningxia, in Cina, al confine tra
l'altopiano tibetano e l'altopiano del Loess, e risale al primo Miocene, circa
19,6 milioni di anni fa. Cannabis si è ampiamente distribuito in Asia dal tardo
Pleistocene. La cannabis più antica conosciuta nell'Asia meridionale risale a
circa 32.000 anni fa.
Secondo le prove genetiche e archeologiche, la cannabis fu domesticata per la
prima volta circa 12.000 anni fa nell'Asia orientale durante il primo Neolitico.
L'uso della cannabis come droga che altera la mente è stato documentato da
reperti archeologici nelle società preistoriche in Eurasia e in Africa. La più
antica testimonianza scritta dell'uso di cannabis è il riferimento dello storico
greco Erodoto agli Sciti dell'Eurasia centrale che facevano bagni di vapore alla
cannabis. Nelle sue Storie (440 a.C.) scrive: "Gli Sciti, come ho detto,
prendono un po' di questo seme di canapa [presumibilmente, fiori] e, strisciando
sotto le coperture di feltro, lo gettano sulle pietre arroventate;
immediatamente fuma ed emette un tale vapore come nessun bagno di vapore greco
può superare; gli Sciti, deliziati, gridano di gioia." Anche i Greci e i Romani
usavano la cannabis. In Cina le proprietà psicoattive della cannabis sono
descritte nello Shennong Bencaojing del III secolo d.C. Il fumo di cannabis
veniva inalato dai taoisti, che lo bruciavano insieme all'incenso. In Medio
Oriente l'uso si è diffuso in tutto l'impero islamico fino al Nord Africa. Nel
1545 la cannabis si diffuse nel Nuovo Mondo, dove gli spagnoli la importarono in
Cile per usarla come fibra. In Nord America la cannabis veniva coltivata per
essere utilizzata per fabbricare corda, stoffa e carta. Il cannabinolo (CBN) è
stato il primo composto ad essere isolato dall'estratto di cannabis alla fine
del 1800. La sua struttura e sintesi chimica furono ottenute nel 1940, seguite
da alcuni dei primi studi di ricerca clinici per determinare gli effetti dei
singoli composti derivati dalla cannabis in vivo. A livello globale, nel 2013
sono stati prodotti legalmente 60.400 chilogrammi di cannabis.
Purtroppo, come si sa, la cannabis è una droga popolare in tutto il mondo,
quarta dietro l'alcol, la caffeina e il tabacco. Solo negli Stati Uniti si
ritiene che oltre 100 milioni di americani abbiano provato la cannabis, e nel
2014 c'erano circa 182,5 milioni di consumatori di cannabis in tutto il mondo
(il 3,8% della popolazione mondiale di età compresa tra 15 e 64 anni). Come
droga di solito si presenta sotto forma di infruttescenze essiccate
("marijuana"), resina ("hashish") o vari estratti noti collettivamente come olio
di hashish. Durante il XX secolo è diventato illegale nella maggior parte del
mondo coltivare o possedere Cannabis, anche per uso personale. È noto che gli
effetti psicoattivi della cannabis includono uno stato di rilassamento e, in
misura minore, l'euforia dovuta al suo principale composto psicoattivo, il THC.
Tra i casi di ansia e paranoia sono stati segnalati effetti psicoattivi
secondari, come una facilità per il pensiero filosofico, l'introspezione e la
metacognizione. Ma tra gli effetti psicoattivi della droga si possono includere
anche un aumento della frequenza cardiaca e della fame, che si ritiene siano
causati dall'11-OH-THC, un metabolita psicoattivo del THC prodotto nel
fegato. La normale cognizione del tempo e dello spazio viene ripristinata dopo
circa tre ore per dosi maggiori tramite una pipa o un vaporizzatore, ma se una
grande quantità viene assunta per via orale, gli effetti possono durare molto
più a lungo. Dopo 24 ore fino ad alcuni giorni, si possono avvertire effetti
psicoattivi minori, a seconda del dosaggio, della frequenza e della tolleranza
al farmaco. Secondo uno studio nel 2007, la cannabis ha un fattore di rischio
per la dipendenza inferiore rispetto sia alla nicotina che all'alcol. Tuttavia
l'uso quotidiano di cannabis può essere correlato a crisi di astinenza, come
irritabilità o insonnia, e la suscettibilità a un attacco di panico può
aumentare con l'aumento dei livelli di metaboliti del THC.
Per fortuna esistono anche usi terapeutici della Cannabis e dei suoi
cannabinoidi: sono usati per ridurre la nausea e il vomito durante la
chemioterapia, per migliorare l'appetito nelle persone affette da HIV e per
trattare il dolore cronico e gli spasmi muscolari. Mancano prove che possano
curare depressione, ansia, disturbo da deficit di attenzione e iperattività,
sindrome di Tourette, disturbo da stress post-traumatico e psicosi. Due estratti
di cannabis, dronabinol e nabilone, sono approvati dalla FDA come farmaci in
forma di pillola per il trattamento degli effetti collaterali della
chemioterapia e dell'AIDS. Gli effetti collaterali più comuni includono
vertigini, sensazione di stanchezza, vomito e allucinazioni. Gli effetti a lungo
termine della cannabis non sono chiari, e includono problemi di memoria e
cognizione, rischio di dipendenza, schizofrenia e rischio che i bambini la
prendano per sbaglio.
Come detto, però, il termine canapa è usato per denominare la fibra morbida e
durevole dal gambo della pianta di cannabis. Le cultivar di cannabis sativa sono
utilizzate per le fibre a causa dei loro lunghi steli, che possono crescere più
di sei metri di altezza. La cannabis per usi industriali è preziosa in decine di
migliaia di prodotti commerciali, in particolare come fibra che va dalla carta
al cordame, al materiale da costruzione, ai tessuti in generale e
all'abbigliamento. La canapa è più resistente e duratura del cotone, ed è anche
un'utile fonte di alimenti (latte di canapa, semi di canapa, olio di canapa) e
biocarburanti. La canapa è stata utilizzata da molte civiltà, dalla Cina
all'Europa, negli ultimi 12.000 anni. Negli Stati Uniti la "canapa industriale"
è classificata dal governo federale come cannabis contenente non più dello 0,3%
di THC in peso secco.
La pianta di cannabis ha anche una storia di usi medicinali che risale a
migliaia di anni fa in molte culture. Tra le tombe di Yanghai, un vasto cimitero
antico situato nel distretto di Turfan della regione uigura dello Xinjiang nel
nord-ovest della Cina, è stata scoperta la sepoltura di uno sciamano vissuto
2700 anni fa (si pensa che appartenesse alla cultura Jushi). Vicino alla testa
dello sciamano c'era una ciotola di legno contenente 789 grammi di cannabis,
ottimamente conservati dalle condizioni climatiche e della sepoltura. Un team
internazionale ha dimostrato che questo materiale conteneva THC. La cannabis era
presumibilmente impiegata da questa cultura come agente medicinale e come aiuto
alla divinazione: gli sciamani la assumevano, perdevano il contatto con la
realtà ed erano convinti di entrare in contatto con le divinità e con gli
spiriti dei trapassati. Questa è la più antica documentazione della cannabis
come agente farmacologicamente attivo. La prima prova del fumo di cannabis è
stata trovata invece nelle tombe di 2.500 anni fa del cimitero di Jirzankal tra
le montagne del Pamir nella Cina occidentale, dove sono stati trovati residui di
cannabis in bruciatori con ciottoli carbonizzati, probabilmente usati durante i
rituali funebri. Insediamenti che risalgono al 2200-1700 a.C. nella Battriana e
nella Margiana (Iran orientale) contenevano elaborate strutture rituali con
stanze contenenti tutto il necessario per preparare bevande contenenti estratti
di papavero (oppio), canapa (cannabis) ed efedra (che contiene efedrina, un
altro stupefacente. L'uso cultuale della Cannabis insomma andava dalla Romania
al fiume Yenisei, un areale vastissimo. La cannabis viene menzionata per la
prima volta nei Veda indù tra il 2000 e il 1400 a.C. e alcuni in India lo
chiamavano "il cibo degli dei" (ci ricorda il cacao d'oltreoceano...) L'uso di
cannabis alla fine divenne un elemento rituale della festa indù di Holi. Uno dei
primi ad usare questa pianta per scopi medici sarebbe stato Korakkar, uno dei 18
Siddha, i leggendari padri spirituali dei Tamil ed infatti in lingua Tamil la
Cannabis si chiama Korakkar Mooli ("erba di Korakkar"). Nel Buddismo al
contrario la cannabis è generalmente considerata una sostanza inebriante e può
essere un ostacolo allo sviluppo della meditazione e della chiara
consapevolezza. A partire dal IV secolo i testi taoisti menzionano l'uso della
Cannabis negli incensieri. Nell'antica cultura germanica la Cannabis era
associata alla dea dell'amore norrena, Freya. Secondo l'antropologa polacca Sula
Benet (1903-1982) la pianta q'neh bosem (קְנֵה-בֹשֶׂם) menzionata cinque volte
nella Bibbia ebraica e usata nell'olio dell'unzione sacra del Libro dell'Esodo,
era in realtà la Cannabis, ma molti dizionari biblici come quelli di Michael
Zohary (1985), Hans Arne Jensen (2004) e James A. Duke (2010) identificano la
pianta in questione con Acorus calamus o Cymbopogon citratus. Nel 2020 uno
studio a Tel Arad, un santuario di 2700 anni fa allora alla frontiera
meridionale del Regno di Giuda, ha scoperto che le offerte bruciate su un altare
contenevano composti di cannabinoidi, suggerendo l'uso rituale della cannabis
all'interno dell'antico giudaismo. I sufi hanno usato la cannabis nella loro
spiritualità sin dal XIII secolo. Il santuario pakistano di Lal Shahbaz Qalandar
nella provincia del Sindh è particolarmente rinomato per l'uso diffuso di
Cannabis durante i suoi riti.
L'uso di Cannabis nel Medioevo è specialmente legato al famoso ordine islamico
dei Nizariti, un ramo degli Ismailiti diffuso in Siria e sulle montagne della
Persia dall'XI al XIII secolo. Essi erano noti agli altri musulmani del Medio
Oriente come gli Ḥashīshiyyīn, cioè i guerrieri dell'Hashish. Infatti, come
narrano Marco Polo ne "Il Milione" e poi Boccaccio nel suo "Decameron", il
fondatore della setta, Hassan-i Sabbah (1034-1124), detto "il Vecchio della
Montagna", avrebbe usato l'hashish per ottenere un esercito di fanatici
fedelissimi: secondo il racconto del mercante veneziano egli reclutava adepti,
li portava nella sua imprendibile fortezza di Alamuth, sulle montagne
dell'Iran, faceva loro assumere hashish e li faceva vivere per un certo periodo
in un bellissimo giardino con ogni delizia a disposizione, poi li sottraeva a
tutto questo e prometteva loro che sarebbero tornati in quel paradiso, se
avessero combattuto e fossero morti per conto suo. Dal termine Ḥashīshiyyīn deriva
la parola italiana "Assassini". Una delle prime loro vittime fu il visir dei
sultani selgiuchidi Niẓām al-Mulk, pugnalato nel 1092, ma durante la Terza
Crociata essi tentarono di assassinare sia Riccardo Cuor di Leone che il
Saladino. La setta fu distrutta nel 1273 da Hulagu Khan, nipote di Gengis Khan,
che rase al suolo Alamuth e fece uccidere l'ultimo erede del Vecchio della
Montagna. Gli storici moderni contestano questa versione dei fatti come
leggendaria, e secondo loro al-Hashīshiyyūn significherebbe "seguaci di Hasan",
ma il mito dei guerrieri inebriati dall'Hashish che andavano incontro alla morte
con il sorriso sulle labbra è sopravvissuto fino ai giorni nostri, e lo si
ritrova ad esempio in Umberto Eco.
Nei tempi moderni, il movimento Rastafari considera la Cannabis quasi come un
sacramentale. Anche alcune sette cristiane gnostiche moderne hanno affermato che
la cannabis è l'albero della vita citato nella Genesi. Gli anziani della
Ethiopian Zion Coptic Church, un movimento religioso fondato negli Stati Uniti
nel 1975 senza legami né con l'Etiopia né con la Chiesa copta, identifica la
Cannabis addirittura con l'Eucaristia, rivendicandola come una tradizione orale
etiope risalente al tempo di Cristo. In Messico i seguaci del culto della Santa
Muerte usano regolarmente il fumo di marijuana nelle cerimonie di purificazione,
con la marijuana che spesso prende il posto dell'incenso usato nei rituali
cattolici tradizionali. Esiste persino un'intera religione moderna che ruota
intorno alla nostra pianta, l'Assemblea della Cannabis, a testimonianza del
legame storico tra gli effetti psicotropi e le visioni mistiche. Al contrario,
prima della sua elezione al Soglio, Papa Francesco si è espresso varie volte
contro la liberalizzazione della cannabis. Nel 2013 a Buenos Aires ha
affermato: « Una riduzione della diffusione e dell'influenza della
tossicodipendenza non sarà raggiunta da una liberalizzazione del consumo di
droga ». Il Catechismo della Chiesa cattolica ribadisce che « l'uso di droghe
arreca gravissimi danni alla salute e alla vita ».
In passato la coltivazione della canapa era comune nelle zone mediterranee e
centroeuropee, perché questa pianta cresceva su terreni difficili da coltivare
con altre piante industriali e perché vi era una forte richiesta di piante così
polivalenti e a buon mercato. Durante i secoli delle grandi conquiste marittime
europee, la domanda di tele e cordami assicurò la straordinaria ricchezza dei
comprensori che fornivano la canapa di qualità migliore per l'armamento navale.
In Italia eccelsero tra le terre da canapa Bologna e Ferrara. In queste zone
ancora oggi sono visibili nella campagna i cosiddetti "maceri", piccoli laghetti
artificiali utilizzati per mantenere immersi in acqua i tronchi leggeri della
canapa raccolti in "fascine", posti sotto il peso di grossi sassi arrotondati,
che solitamente venivano conservati ai bordi del macero. Dopo alcuni giorni le
fibre esterne al tronco venivano staccate con facilità, recuperate e mandate ai
filatoi. I resti secchi degli stessi tronchi decorticati venivano usati poi come
combustibile povero (in dialetto ferrarese questi tronchi fragili e leggeri,
ridotti in pezzetti, venivano chiamati "stich"). La vitalità dell'economia
canapicola felsinea è testimoniata dal maggior agronomo bolognese del Seicento,
Vincenzo Tanara, che ci ha tramandato le tecniche agricole della canapa.
L'Italia divenne il secondo produttore mondiale di canapa e divenne
addirittura il primo fornitore della marina britannica. Il tramonto della
produzione canapiera iniziò con la diffusione delle prime navi a carbone. Dopo
la colonizzazione britannica dell'India e la rivoluzione agricola negli Stati
del Sud degli USA, si ebbe un ulteriore calo di produzione della canapa, perché
i filati di cotone e juta avevano prezzi molto concorrenziali rispetto alle
altre fibre. Il successivo uso del petrolio fece poi calare i prezzi dei
combustibili per l'illuminazione. Dopo la prima guerra mondiale si ebbe un
ulteriore calo di produzione, quando le corde ottenute da sostanze sintetiche
sostituirono pian piano le corde di canapa e si sviluppò la tecnica per produrre
la carta dal legno. Durante la seconda guerra mondiale, la produzione
mediterranea ritornò per un breve periodo ad aumentare velocemente, perché
l'isolamento commerciale indotto dal conflitto, fece sì che tornassero
convenienti le produzioni di fibre tessili e gli oli della canapa. Esisteva
inoltre l'esigenza di materie prime contenenti cellulosa da cui poter ricavare
esplosivi, passando attraverso la nitrocellulosa. In particolare in Italia
Benito Mussolini cercò di rilanciare la coltivazione della canapa nel periodo
dell'"autarchia". Il vero colpo di grazia per la coltivazione della canapa fu il
"Marijuana Tax Act" del 1937 che la si mise al bando negli USA, e poi di
riflesso in gran parte del resto del mondo. In Italia la coltivazione
industriale è consentita dalla circolare ministeriale dell'8 maggio 2002,
limitata a varietà di canapa certificata, appositamente selezionate per avere un
contenuto trascurabile di THC, che ne costituisce il principio attivo
farmacologico e psicotropo. Secondo alcuni storici la proclamazione di leggi
proibizionistiche nei confronti della Cannabis negli Stati Uniti prima della
seconda guerra mondiale è stata provocata dalla concorrenza tra la nascente
industria petrolifera e la consolidata usanza dell'epoca di usare l'olio di
questa pianta come combustibile per i motori Diesel, dalla concorrenza tra la
nascente industria cartiera e la consolidata usanza dell'epoca di usare la fibra
di questa pianta per la produzione di carta, e dalla concorrenza tra la nascente
industria tessile basata sulle fibre sintetiche sia per la produzione di cordami
sia di tessuti. L'utilizzo dell'olio di canapa nel settore automobilistico, e in
particolare nel biodiesel, avviato nel 1937 da Henry Ford, fu ripreso dalla casa
inglese Lotus negli anni 2000. Tra i paesi ad aver legalizzato l'uso terapeutico
della Cannabis vi sono Australia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Germania,
Grecia, Israele, Italia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Svizzera e
Regno Unito. Negli Stati Uniti l'uso terapeutico della pianta è stato
legalizzato in 37 stati federati, 4 territori e nel Distretto di Columbia.
Alcuni paesi ad aver legalizzato l'uso della Cannabis come stupefacenti: Canada,
Georgia, Malta, Messico, Sudafrica, Thailandia e Uruguay. Negli Stati Uniti
questo uso della pianta è stato legalizzato in 19 stati federati, 2 territori e
nel Distretto di Columbia; in Australia soltanto nel Territorio della Capitale
Australiana. Circa l'uso della cannabis come droga, oggi in Italia è in corso un
dibattito tra proibizionisti e antiproibizionisti, come al solito basato non su
dati scientifici oggettivi ma sulla polarizzazione destra-sinistra (della serie:
"la penso così perchè il mio avversario politico la pensa nell'altro modo").
Veniamo alla letteratura. L'importanza della coltivazione della canapa nel
Settecento è attestata dal poemetto "Il canapajo" del sacerdote Girolamo
Baruffaldi (1675-1753), tipico prodotto della letteratura didascalica del sei e
settecento (« E canterò la canape, e la vera / cultura d'un sì nobile virgulto,
/ che ne' campi d'Italia, e piucchè altrove, / nel felsineo terreno, e nel
vicino / centese floridissimo recinto, / (dov'è una terra, che città può dirsi,
/ tanto in se stessa, e ne' suoi degni e illustri / abitatori oggi è pregiata al
mondo) / s'alza e verdeggia, e selve forma ombrose, / quando la stagion fervida
comincia / a cuocer l'aria, e finché il Lion rugge / nel ciel, dura a far ombra
su la terra... »). Lo scrittore francese François Rabelais (1483-1553) nel terzo
libro delle sue "Gesta e dei detti eroici del nobile Pantagruel" dedica ben due
capitoli alla canapa, descrivendone le qualità e la sua utilità soprattutto per
la navigazione, considerandola così eccezionale da attribuirle il nome del suo
protagonista. Dal Rinascimento all'ottocento la Cannabis divenne un oggetto e
uno strumento narrativo sempre più presente nella letteratura europea,
soprattutto francese. Troviamo straordinarie descrizioni dei suoi effetti nelle
opere di autori come Gerard de Nerval, Théophile Gautier, Honoré de Balzac,
Alexandre Dumas padre. Ne "Il poema dell'hashish", prima parte dei
"Paradisi artificiali", Charles Baudelaire (1821-1867) ammette di farne largo
uso e descrive le sue esperienze con la Cannabis in pagine segnate da vistose e
profonde contraddizioni. Da un lato egli esalta le visioni e i rapimenti causati
dal fumo, e dall'altro denuncia i danni che questo causa sulla coscienza, la
volontà e anche sulla creatività letteraria.
Infine, una foglia di Cannabis è presente nello stemma di Kanepi Vald, una
municipalità rurale dell'Estonia. "Kanep" in lingua estone significa proprio
canapa!

Il
frutto dei Malavoglia che matura sotto la paglia
Il
nespolo (Crataegus germanica) è un albero della famiglia delle rosacee.
Fino a poco tempo fa, Crataegus germanica era l'unica specie conosciuta di
nespolo. Tuttavia, nel 1990 fu scoperta una nuova specie nel Nord America, ora
chiamata Crataegus canescens. La varietà nota come "nespolo giapponese" è in
realtà Eriobotrya japonica, e dunque fa parte di un altro genere. Per un certo
periodo si è ipotizzato che si trattasse di una specie con risorse genetiche
limitate e quindi soggetta ad elevati rischi di erosione genetica, per cui la
limitata evoluzione della diversità di Crataegus germanica è stata ascritta allo
scarso interesse economico per questa specie da frutto negli ultimi secoli.
Tuttavia i risultati della moderna genetica dimostrano che le popolazioni di
nespolo in natura sono molte e con un elevato potenziale genetico, che potrebbe
essere utilizzato per migliorare la produzione utilizzando genotipi specifici.
In condizioni ideali, la pianta decidua cresce fino a 10 metri di altezza, ma
generalmente è più basso e più simile ad un arbusto che ad un albero. Ha una
vita piuttosto breve, arrivando al più ai 60 anni. La sua corteccia è
bruno-grigiastra con profonde fessure verticali che formano placche
rettangolari. le quali tendono a sollevarsi. La forma selvatica di Crataegus
germanica è per lo più una pianta spinosa, più arbustiva che arborea, alta tra
1,5 e 4 m. Nelle forme coltivate le spine sono generalmente ridotte o del tutto
assenti. Ha chioma sporgente, quasi rotonda, e il tronco ha un diametro
solitamente compreso tra 20 e 25 cm, ma in casi eccezionali può arrivare fino a
50 cm. Le radici sono molto ramificate e di ampia portata, con un apparato
radicale piuttosto fibroso. Il legno ha una tessitura fine, ma è molto duro: per
lo più è bianco, leggermente sfumato di rosa. I boccioli invernali sono
appuntiti, ovoidali e lunghi fino a 5 millimetri. Le foglie sono verde scuro ed
ellittiche, lunghe 8–15 centimetri e larghe 3–5 cm, densamente pelose nella
parte inferiore, e diventano rosse in autunno prima di cadere. I fiori del
nespolo hanno un diametro di 2–5 cm, un gambo corto e sono terminali e singoli
sui germogli laterali corti. Hanno cinque sepali allungati e stretti e cinque
petali liberi, bianchi o rosa pallido. Rispetto ad altri alberi da frutto delle
latitudini europee, il nespolo fiorisce molto tardi (maggio o giugno). I fiori
sono ermafroditi e impollinati dalle api, ma normalmente in questa pianta
avviene l'autoimpollinazione. Il fiore sviluppa frutti appiattiti,
bruno-rossastri, pelosi con polpa succosa. Il frutto, o più precisamente il
falso frutto, è un pomo bruno-rossastro di 2–3 cm di diametro, con sepali
persistenti e diffusi attorno a un nocciolo centrale, che conferisce un aspetto
"cavo' al frutto"; nelle forme coltivate il diametro può essere compreso tra 3 e
8 cm. I semi, in genere cinque, sono distribuiti da vari animali come uccelli,
scoiattoli e cervi; alcune varietà di nespolo sono sterili, e possono quindi
essere propagate solo per via vegetativa.
La parola "nespola" deriva dal latino "mespĭlum", a sua volta dal greco "μέσπιλον",
con passaggio di m- a n-, dovuto a un fenomeno di dissimilazione, e documentato
anche in altri casi (per es. in "nappa" dal lat. "mappa"). Tale fenomeno
consiste nel mutamento di un suono determinato dalla presenza nella stessa
parola di un altro, simile o identico (per es. in "urlare" e in "giglio",
rispettivamente dal lat. "ululare" e "lilium" con due "l" che si succedevano
vicine). In tedesco però è ancora "mispel". Siccome il suffisso
indoeuropeo *-p- forma nomi di alberi e il suffisso secondario *-ĭlŏ- anche, la
radice deve essere √*mĕs-, che in indoeuropeo significa "allungare il braccio" e
"allettare". L'etimo sarebbe dunque *mĕ́s-p-ĭlŏ-m, "(l'albero / il frutto)
allettante", forse perché non può essere mangiato appena raccolto. Secondo
altri invece il greco "μέσπιλον" è di
origine non indoeuropea ed è affine al proto-cartveliano *sxmarṭl- ("nespola")
con metatesi delle consonanti iniziali. "Crataegus" poi viene
dal greco "κράταιγος", "biancospino". Il nome della specie è "germanica",
ma dopo un ampio studio della letteratura e dei campioni vegetali, il botanico
polacco Kazimierz Browicz (1925-2009) ha concluso che la vera patria del
Crataegus è da localizzarsi nella parte sudorientale della penisola balcanica,
in Asia Minore, nel Caucaso, in Crimea, nel nord dell'Iran e forse anche nek
Turkmenistan. Questa specie potrebbe essere coltivata da almeno 3.000 anni. Il
geografo greco Strabone (60 a.C.-21 d.C.) fa riferimento a un "μέσπιλον" nella
sua opera "Geographica", libro 16, capitolo 4. Il nespolo fu introdotto in
Grecia intorno al 700 a.C. e a Roma intorno al 200 a.C. Fu un'importante pianta
da frutto in epoca romana e medievale. Nel XVII e XVIII secolo, tuttavia, fu
gradualmente soppiantato, nell'intera Europa, dal nespolo giapponese,
inizialmente importato come semplice pianta ornamentale delle Corti di Francia,
e oggi è poco coltivato. In Italia, grazie alla sua resistenza al freddo, si è
tradizionalmente ambientato nelle regioni del Nord, anche se è stato piantato
anche in alcune zone dell'Italia centrale e meridionale, come dimostra la
cosiddetta "Casa del Nespolo" di Aci Trezza in Sicilia, citata nei "Malavoglia"
di Giovanni Verga.
In Piemonte la nespola si diffuse attraverso la tradizione popolare,
ribattezzata con il termine "puciu": un frutto anche qui molto comune almeno
fino al XX secolo, poi via via rimpiazzato dalla nespola giapponese. Tuttavia, i
"puciu" vengono ancor oggi coltivati, appunto per tradizione, soprattutto nel
Basso Piemonte, in particolare in provincia di Cuneo e nelle Langhe meridionali,
ai confini con la Liguria, anche attraverso delle esposizioni e delle fiere
dedicate. Le più famose sono a Farigliano, dove tra novembre e dicembre si
svolge una festa dedicata alla frazione di San Nicolao abbinata alla "Fiera dei
Puciu", e a Trinità, dove l'ultima domenica di novembre si svolge la “fera dij
puciu e dij bigat”, riproposta nel 2000 dopo 50 anni di interruzione durato,
dove il puciu è associata all'antica coltivazione del baco da seta ("bigat" in
piemontese). Ogni anno, la seconda domenica di novembre, si tiene a Virle
Piemonte una fiera dedicata alla zucca e al nespolo.
Il nespolo richiede condizioni climatiche temperate e mediterranee con estati
calde e inverni miti, e temperature dell'aria comprese tra 18 e 20°C. Esso
tollera una temperatura fino a -20°C, e le gelate tardive difficilmente causano
danni. La forma selvatica è stata trovata in aree aride con precipitazioni
annuali di 700 mm e ad altitudini comprese tra 0 e 1.100 m. Esso cresce in
un'ampia gamma di tipi di terreno ma preferisce terreni argillosi freschi e ben
drenati con un pH compreso tra 6 e 8. Si trova in tutta l'Europa meridionale
dove è generalmente rara e si è cercato di naturalizzarlo in alcuni boschi del
sudest dell'Inghilterra, ma in quest'isola si trova solo in pochi giardini. Le
nespole sono uno dei pochi frutti che diventano commestibili in inverno,
rendendolo un albero importante per i giardinieri che desiderano avere frutti
disponibili tutto l'anno. Le forme coltivate vengono propagate mediante inesto
su vari substrati come biancospino, sorbo, pero o mela cotogna per migliorarne
le prestazioni in diversi terreni; queste cultivar producono frutti da 6 a 7
anni dopo l'innesto e la mantengono per 20-25 anni. La produzione di frutti
varia tra 30 e 70 chilogrammi per albero e anno, a seconda della varietà e
dell'età. Si sconsiglia l'innesto su piantine di nespolo a causa della crescita
lenta degli innesti; se i germogli fruttiferi vengono potati dopo la raccolta,
si favorisce la formazione di nuovi germogli corti e fertili.
Il nespolo solo raramente viene attaccato da malattie o danneggiato dagli
insetti. Nelle piantagioni possono causare danni le larve della specie di
farfalle estratte dalle foglie Lithocolletis blancardella. Inoltre, soprattutto
in anni con elevate precipitazioni, il fungo Monilia fructigena può provocare
macchie marroni sul frutto e continuare a diffondersi finché il frutto non
marcisce completamente. Il nespolo può essere infettato anche da Podosphaera
clandestina, l'agente patogeno dell'oidio, che può portare all'avvizzimento di
foglie e germogli, nonché da Entomosporium mespili che provoca macchie fogliari.
Le nespole si colgono in autunno, ancora acerbe, ma non possono essere consumate
alla raccolta, essendo dure e con sapore acido ed astringente, e vanno lasciate
"ammezzire" in un ambiente asciutto e ventilato (una volta, sotto la paglia),
cioè rammollire e virare di colore dal marrone chiaro al marrone scuro. La
trasformazione enzimatica modifica infatti la polpa, riducendo il contenuto di
tannini e degli acidi della frutta, aumentando il contenuto di zucchero e
rendendole commestibili e zuccherine (ma la robusta buccia ed i numerosi e duri
semi rendono comunque problematico il consumo). La lunga maturazione a riposo
nella paglia fin oltre il periodo natalizio, associata alla graduale e crescente
dolcezza del frutto, ha fatto nascere il famoso proverbio « col tempo e con la
paglia si maturano le nespole », espressione con cui si vuol significare che il
tempo risana tutto e risolve le difficoltà, e che viene ripetuta come invito ad
avere pazienza e ad evitare la fretta. Legato a questo aspetto si diffuse
l'antico detto piemontese "stago da puciu" ("sto come un puciu"), ad indicare
uno stato di pace, riposo e tranquillo tepore domestico. Sempre metaforicamente,
il termine dialettale piemontese "puciu" indicava la forma del "piccolo pomo" di
capelli lunghi delle giovani ragazze che si otteneva raccogliendoli dietro la
nuca e fermandoli con un fermacapelli, e da qui, sempre metaforicamente, il
soprannome della ragazza stessa.
Una volta sbucciato, il frutto può essere consumato crudo, a volte con zucchero
e panna, o utilizzato per preparare gelatina di nespole. Viene utilizzato nel
"formaggio di nespole", simile alla cagliata di limone, fatto con polpa di
frutta, uova e burro. I frutti acerbi hanno un contenuto di tannini
relativamente elevato, pari a circa il 2,6%, e vengono quindi utilizzati per la
concia delle pelli. Il tannino provoca la flocculazione delle proteine,
consentendone l'utilizzo per ridurre la torbidità del vino. Nella Saarland,
lander occidentale della Germania, dal frutto della nespola si ricava una grappa
che viene raffinata con il biancospino. Invece il cosiddetto "tè di nespola" di
solito non è preparato con Crataegus germanica, ma con bacche di goji, che a
volte sono chiamate "nespole rosse". L'olio di nocciolo di nespola contiene
circa il 40% di acido oleico e di acido linoleico, ed è stato utilizzato per
produrre biodiesel. Le foglie di nespolo venivano utilizzate per produrre
carbone attivo onde rimuovere metalli pesanti come Ni2+ da soluzioni
acquose. Le nespole sono ricche di potassio, calcio, fosforo, magnesio e ferro,
ma anche di monoterpeni e acidi organici. Amminoacidi, zuccheri e acidi organici
ne influenzano il sapore. A causa dei loro effetti diuretici e astringenti, esse
sono state ampiamente utilizzate nella medicina tradizionale. Le nespole aiutano
la digestione, sono ricche di vitamina C e hanno un ottimo potere saziante, a
dispetto del loro limitato apporto calorico.
E ora, qualche riferimento nella letteratura. Frutto fatto maturare prima di
consumarlo fino a sembrare marcio, la nespola è stata usata dagli scrittori in
senso figurato come simbolo di prostituzione o di indigenza prematura. Ad
esempio, nel Prologo di "The Reeve's Tale", uno dei "Canterbury Tales", opera
principale ed incompiuta di Geoffrey Chaucer (1343-1400), considerato il padre
della letteratura inglese, il protagonista Oswald lamenta la sua vecchiaia,
paragonandosi alla nespola. Nell'opera "Misura per misura" (1604) di William
Shakespeare (1564-1616), Lucio scusa la sua negazione della passata fornicazione
perché « altrimenti mi avrebbero fatto sposare con una nespola marcia ». (Atto
IV, scena III). In "Come vi piace" (1599), Rosalind usa un complicato gioco di
parole in cui paragona il suo interlocutore agli alberi intorno a lei che
portano lettere d'amore e ad un nespolo: « Lo innesterò con te, e poi lo
innesterò con un nespolo. Poi lo sarà il primo frutto del paese; perché sarai
marcio prima di essere mezzo maturo, e questa è la giusta virtù della nespola.»
(Atto III, scena II) Il riferimento più famoso alle nespole, spesso espunto
finché le edizioni moderne non lo accettarono, appare in "Romeo e Giulietta"
(1597), quando Mercuzio ride dell'amore non corrisposto di Romeo per la sua
amante Rosalina (Atto II, scena I): « Starà seduto sotto un nespolo ad augurarsi
che la sua ragazza sia magari quel genere di frutto che le fanciulle, quando
vogliono ridere, chiamano appunto nespolo. Oh, Romeo, se davvero ella fosse una
nespola [letteralmente, un "culo aperto"], e tu una pera di Poperin! » (città
delle Fiandre) Nel XVI e XVII secolo, infatti, le nespole venivano chiamate
oscenamente "culi aperti" ("open-arse") a causa della forma dei frutti,
ispirando giochi di parole indecenti in molte commedie dell'età elisabettiana e
giacobina, nome che è sopravvissuto nell'uso comune fino addirittura al XX
secolo! Alle nespole ad esempio erano paragonate ironicamente le zitelle, perché
esse, per essere gustate, hanno bisogno di lunga stagionatura tra la paglia!
Nel "Don Chisciotte" di Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), l'eroe omonimo
e Sancho Panza « si sdraiano in mezzo a un campo e si abbuffano di ghiande o
nespole ». Nel "Gargantua e Pantagruel" di François Rabelais (1490-1553), le
nespole svolgono un ruolo nell'origine dei giganti, compresi i personaggi
eponimi. Dopo che Caino uccise Abele, infatti, il sangue del giusto morto
fetilizzò la Terra, facendo crescere enormi nespole. Gli esseri umani che
mangiarono queste nespole crebbero fino a raggiungere immense proporzioni e
divennero giganti, gli antenati di Gargantua e Pantagruel.
Nelle "Memorie" di Glückel di Hameln (1646-1727), l'autrice ricorda di aver
avuto una voglia matta di nespole quando era incinta del figlio Giuseppe,
tuttavia la ignorò. Quando il bambino nacque, era malaticcio e troppo debole per
essere allattato al seno. Ricordando una superstizione sui pericoli che corrono
le donne incinte che non soddisfano i loro desideri, Glückel chiese che qualcuno
le andasse a prendere delle nespole per il bambino. Non appena il frutto toccò
le labbra del bambino, questi mangiò tutta la polpa che gli era stata data e
poté essere allattato al seno (Libro 4, sezione 14). E, naturalmente, ci sono i
notissimi "Malavoglia" (1881) di Giovanni Verga (1840-1922), che vivono nella
già citata "Casa del Nespolo" di Aci Trezza (Catania): « Il nespolo
intanto stormiva ancora, adagio adagio, e le ghirlande di margherite, ormai
vizze, erano tuttora appese all'uscio e le finestre, come ce le avevano messe a
Pasqua delle Rose ». Reggie Fortune, il
detective creato dalla fantasia di Henry Christopher Bailey (1878-1961), ama
molto le nespole. Sir Philip Pullman (1946-) nel suo romanzo "Il coltello
sottile" (1997) descrive il profumo di Sir Charles Latrom come "marcito
come una nespola".
Infine, nel linguaggio popolare l'interiezione “Nespole!” viene spesso usata per
esprimere grande meraviglia, forse per l'aspetto "magico" attribuito un tempo
alla loro metamorfosi da acide a dolcissime. Per estensione, un tempo "nespola"
era sinonimo di colpo dato in modo rapido e secco. Ed anche in quest'ultima
accezione si trova un illustre riferimento letterario: il poeta fiorentino Luigi
Pulci (1432-1484) scrive infatti nel suo poema "Morgante" (1478): «Morgante non
lo stima una farfalla, / ed appiccogli una nespola acerba, / tanto che tutto
pel colpo traballa »! Quante inaspettate metafore per un frutto così squisito,
una volta che lo si può consumare!

L'albero di Zeus (e di Robin Hood)
Quando parliamo della
quercia, ci viene in mente un albero maestoso del genere Quercus, che appartiene
alla famiglia delle Fagacee. Esistono almeno 500 specie diverse di querce, ed il
nome "quercia" compare in specie in generi affini, in particolare Lithocarpus
(le cosiddette "querce da pietra"), e persino in quelli di specie non
imparentate come Grevillea robusta (le cosiddette "querce setose"). Il genere
Quercus è originario dell'emisfero settentrionale e comprende specie decidue e
sempreverdi che si estendono dalle latitudini temperate fredde a quelle
tropicali nelle Americhe, in Asia, in Europa e nel Nord Africa. Il Nord America
ha il maggior numero di specie di querce, con circa 160 specie in Messico di cui
109 endemiche e circa 90 negli Stati Uniti. La seconda maggiore area del mondo
per specie di querce è la Cina, con circa 100 specie. L'inquadramento
tassonomico delle specie del genere Quercus era assai difficoltoso, in quanto
sono frequenti i fenomeni di ibridazione tra specie che condividono lo stesso
territorio, dando luogo ad individui dalle caratteristiche intermedie che alcuni
studiosi tendono a considerare nuove specie, mentre altri li ascrivono come
sottospecie o varietà di specie già esistenti. L'avvento delle tecniche
molecolari per l'analisi filogenetica ha trasformato la comprensione delle
relazioni tra le querce, in particolare per i gruppi che ibridano facilmente. Di
solito il portamento è imponente e può arrivare ai 35 metri di altezza, anche se
ci sono specie poco più che arbustive come Quercus coccifera. Si pensa che la
quercia di Bowthorpe, cresciuta a Bourne, nel Lincolnshire, abbia 1.000 anni,
una longevità sorprendente persino per una quercia. Le querce hanno foglie
disposte a spirale, con margini lobati, anche se alcune specie hanno foglie
seghettate o foglie intere con margini lisci. In primavera una singola quercia
produce sia fiori staminati ("maschili") sia piccoli fiori pistillati
("femminili"); il frutto è una noce chiamata ghianda, incastrata in una
struttura a forma di coppa nota come cupola; ogni ghianda contiene un seme
(raramente due o tre) e impiega da 6 a 18 mesi per maturare, a seconda della
specie. Le ghiande e le foglie contengono acido tannico, che le aiuta a
proteggersi da funghi e insetti. Del genere Quercus fanno parte anche piante
come il cerro e il leccio, tipiche della macchia mediterranea; dalla corteccia
della Quercus suber si ricava il prezioso sughero (circa il 50% della produzione
mondiale viene dal Portogallo) per realizzare tappi di bottiglie. Il legno di
quercia ha una densità di circa 750 kg/m3 ed è caratterizzato da
grande resistenza e durezza; è molto resistente agli attacchi di insetti e
funghi a causa del suo alto contenuto di tannini, e forma disegni molto
accattivanti per il mobilio. Il fasciame di quercia era comune sulle navi
vichinghe del IX e X secolo. Le larghe tavole di quercia segate in quarti sono
state apprezzate fin dal Medioevo per la costruzione di mobili di pregio e per i
rivestimenti interni di edifici prestigiosi come la sala dei dibattiti della
Camera dei Comuni a Londra. Dopo la fine dell'era delle navi di legname, il
legno di quercia è ancor oggi comunemente usato per la produzione di mobili e
pavimenti e per la produzione di impiallacciatura. Particolarmente ricercato è
il legno di rovere, prodotto dalla Quercus robur. L'albero da legname standard è
Quercus alba, la "quercia bianca" spesso usata per fare botti di vino e da
whisky. Per via del tannino che contiene, la corteccia di quercia è usata dai
conciatori per la concia delle pelli.
Le foglie e le ghiande della quercia in grandi quantità sono velenose per il
bestiame a causa dell'acido tannico in esse contenuto, che causa danni ai reni e
gastroenterite; fa eccezione è il maiale domestico, che come noto può essere
nutrito esclusivamente di ghiande, e viene tradizionalmente allevato in boschi
di querce. Pochi sanno che le ghiande sono commestibili per l'uomo, previa
eliminazione dei tannini (esiste anche un caffè di ghiande). La quercia possiede
proprietà astringenti, emostatiche, antinfiammatorie, analgesiche del cavo
orale. Utilizzato come decotto o infuso per lavarsi, diminuisce la sudorazione.
I trucioli di legno di quercia sono usati anche per affumicare pesce, carne e
formaggi.
La parola latina quercus, da cui l'omologa italiana quercia, risale a una forma
aggettivale (arbor) quercea, che sembra essere derivata dalla duplicazione della
radice indoeuropea kar-, "essere duro" per la durezza del legno, da cui il
sanscrito kharas, "duro, ruvido" e il greco keras, "corno" (da cui anche
"corniolo"). L'inglese "oak" e il tedesco "Eiche" vengono invece dal
proto-germanico *aiks, a sua volta dal proto-indoeuropeo *h₂eyǵ-, di
significato incerto, perchè la radice indoeuropea che significa quercia, "*deru",
ha portato invece all'inglese "tree". "Ghianda" viene messo in relazione con il
sanscrito "galana", "che cade", dalla radice "gal", "cadere giù", per
l'abitudine delle ghiande di cadere da sole dalla pianta. "Rovere" viene
direttamente da "robur", in latino "forza" (da cui anche "robusto"), da alcuni
un tempo collegato a "ruber", "rosso" (è il colore del sangue, della forza e
della vitalità, ma anche delle venature del regno di rovere). Oggi si pensa
piuttosto a un legame con la radice indoeuropea rabh-, da cui il sanscrito "rabhas",
"impeto, forza", ed anche l'italiano "rabbia" (ma anche "lavoro", attraverso il
latino "labor"); questa è anche l'etimologia del neologismo "robot", dal ceco "robota",
"lavoro", la cui parentela con "rabhas" è evidente!
Possibili fossili del genere Quercus sono stati riconosciuti in alcuni depositi
del tardo Cretaceo in Nord America e Asia orientale, tuttavia la loro esatta
attribuzione è molto discussa. Tra le più antiche testimonianze inequivocabili
di Quercus vi è invece del polline fossile proveniente dall'Austria, e risalente
al confine tra Paleocene ed Eocene, circa 55 milioni di anni fa. I documenti più
antichi di Quercus in Nord America provengono dall'Oregon risalgono
all'Eocene medio, circa 44 milioni di anni fa.
Nella letteratura è celebre la quercia sotto cui Torquato Tasso (1544-1595) si
riposava e leggeva durante il suo soggiorno a Roma. Giovanni Pascoli (1855-1912)
scrisse il poemetto "La quercia caduta", dove la morte della quercia è il
pretesto per un'allegoria dell'egoismo umano. Seconde le tradizioni inglesi del
Medioevo, sotto una grande quercia al centro della foresta di Sherwood il
leggendario bandito gentiluomo Robin Hood (la cui storicità è molto discussa)
riuniva la sua allegra banda di ladri che rubavano ai ricchi per dare ai poveri
(la "quercia di Robin Hood" è tuttora mostrata ai turisti, ma secondo i più
recenti studi essa era appena germogliata nel XIII secolo, quando Robin Hood
sarebbe vissuto). Ne "Lo Hobbit" di John R. R. Tolkien (1892-1973), il
personaggio di Thorin Scudodiquercia deve il suo soprannome al fatto che durante
una battaglia lo scudo di Thorin viene infranto e l'eroe nano usò la sua ascia
per tagliare un ramo di una quercia, usandolo poi per parare i colpi, e
guadagnando così l'appellativo che lo ha reso immortale. La Royal Oak ("Quercia
reale") fu la quercia all'interno della quale si nascose il re d'Inghilterra
Carlo II per sfuggire alle Roundheads che si erano lanciate al suo inseguimento
dopo la battaglia di Worcester del 3 settembre 1651; la sua storia è ricordata
ogni anno nella festa tradizionale inglese del Royal Oak Day. La Quercia del Kaiser,
situata nel villaggio di Gommecourt nell'Artois, in Francia, è così chiamata in
onore del Kaiser Guglielmo II, e segnò simbolicamente dalla fine del 1914
all'aprile 1917 il punto più avanzato raggiunto ad ovest dall'esercito tedesco durante la prima guerra mondiale.
La quercia è un simbolo comune di forza e resistenza, ed è stata scelta come
albero nazionale di molti paesi. In Inghilterra le querce sono state un simbolo
nazionale almeno dal XVI secolo, e ancor oggi rimangono un simbolo della storia
della nazione, delle tradizioni e della bellezza della sua campagna. Già antico
simbolo germanico, nel novembre 2004 il Congresso degli Stati Uniti ha approvato
una legge che designa la quercia come albero nazionale americano. Anche altri
paesi hanno designato la quercia come albero nazionale, tra cui Bulgaria,
Croazia, Cipro (la quercia dorata), Estonia, Francia, Germania, Moldavia,
Giordani, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Serbia e Galles. La quercia è
l'emblema della contea di Londonderry nell'Irlanda del Nord, poiché una vasta
parte della contea era ricoperta da foreste di querce fino a tempi relativamente
recenti. Il nome della contea deriva dalla città di Derry, originariamente in
irlandese conosciuta come Doire, che significa "quercia". La contea irlandese di
Kildare originariamente in irlandese suonava Cill Dara, che significa "Chiesa
della Quercia".
La città di Raleigh, in Carolina del Nord, è conosciuta come la "Città delle
querce". La quercia è usata come simbolo anche da numerosi partiti
politici: è il simbolo del Partito Conservatore nel Regno Unito, e lo era dei
Democratici di Sinistra in Italia. Le foglie di quercia sono tradizionalmente
una parte importante delle insegne dell'esercito tedesco: il partito nazista
usava la tradizionale aquila tedesca appollaiata su una svastica all'interno di
una corona di foglie di quercia. Simboleggiano anche i gradi delle forze armate
degli Stati Uniti: una foglia di quercia d'oro indica il grado di maggiore o
tenente comandante, mentre una foglia di quercia d'argento indica un tenente
colonnello o un comandante.
La quercia é un albero sacro in molte tradizioni del mondo antico.
Le tribù indoeuropee preistoriche adoravano la quercia e la collegavano con un
dio del tuono o del fulmine, forse perchè, essendo alta, viene colpita dal
fulmine più probabilmente di altri alberi; questa tradizione la ritroviamo in molte culture
classiche.
Nella mitologia greca la quercia è l'albero sacro a Zeus: nell'oracolo di Zeus a Dodona, in Epiro, la quercia sacra era il
centro del
recinto cultuale, e i sacerdoti indovinavano i presagi del dio interpretando il
fruscio delle foglie della quercia. i diceva che i mortali che abbattevano
tali alberi fossero puniti dagli dei, poiché gli antichi greci credevano che
fossero abitati da ninfe chiamati Amadriadi.
Nel politeismo celtico il nome della quercia faceva parte della parola
proto-celtica per "druido", *derwo-weyd- da cui *druwid-. Come
in altre fedi di origine indoeuropea, Taranis, essendo un dio del tuono, era associato
alla quercia (si noti che Asterix invoca spesso Teutates, dio della guerra,
Belenos, il dio del sole, e sua moglie Belisama, dea del fuoco, ma Taranis per
lo più lo ignora).
Nella mitologia norrena, naturalmente, la quercia era sacra al dio del tuono, Thor.
Nella mitologia baltica e slava, la quercia era l'albero sacro del dio lettone Pērkons, del lituano Perkūnas, del prussiano Perkūns e dello slavo Perun,
in ogni caso
il dio del tuono (e una delle divinità più importanti). Nella Repubblica Romana
si donava una corona di foglie di quercia a chi aveva salvato in battaglia la
vita di un cittadino romana.
Nella Bibbia la quercia è associata al culto e alle offerte sacrificali (Os 4,1.3),
ma soprattutto è
il luogo dove il Cielo comunica con la Terra: Abramo ricevette la visita
di tre uomini, variamente interpretati dai commentatori, alle Querce di Mamre,
presso Hebron, dove il Padre dei Monoteisti si era stabilito (Gen
3,18). Gli Ebrei interpretano i tre uomini come Dio (YHWH) e due Suoi angeli,
mentre per noi cristiani si tratta di una prefigurazione anticotestamentaria
della Santissima Trinità; e così appare infatti nella celeberrima Trinità di
Andrej Rublëv (1360-1430), dipinta verso il 1422. In essa i tre uomini appaiono
identici, tranne che per il colore del vestito, e quello al centro e quello a
destra piegano il capo di fronte a quello a sinistra, segno che a sinistra è
raffigurato Dio Padre con il vestito dorato (simbolo di regalità), mentre al
centro c'è il Figlio con il vestito rosso (come il sangue sparso sulla croce) e
a destra c'è lo Spirito Santo con il mantello verde (simbolo della vita). In
alto si vedono appunto le querce di Mamre! E ancora alle Querce di Mamre Abramo riceve da Dio la promessa
della Terra alla sua discendenza (Gen 12,6-7). La quercia di Sichem è il luogo
dove Giacobbe seppellisce gli dèi stranieri del suo popolo (Gen 35,4). Giosuè
erige una pietra sotto una quercia come primo simbolo dell'alleanza con YHWH
(Giosuè 24,25–7). I lunghi capelli di Assalonne rimangono impigliati in una quercia e permettono a Ioab
di ucciderlo (2 Sam 18,9). Da universale simbolo di forza,
la quercia può essere anche simbolo di orgoglio (Is 2,12-13).
Nel Medio Evo, a
causa del suo legno che non marciva, divenne simbolo di immortalità: e forse c'è
un fondo di verità, se la quercia Jurupa, una colonia clonale di quercia di Palmer
trovata nella contea di Riverside, in California, ha davvero almeno 13.000 anni! Nell'iconografia di san Bonifacio si ricorda l'abbattimento che egli fece di una
quercia consacrata al dio Donar, rappresentandolo con il piede sulla quercia
mentre battezza i convertiti, segno della vittoria cristiana sugli dei pagani.
La venerazione della quercia sopravvive nella tradizione della Chiesa Ortodossa
Serba: le celebrazioni natalizie includono il badnjak, un ramo preso da una
quercia giovane abbattuto cerimonialmente la mattina della vigilia di
Natale e gettato in un falò, similmente al nostro ceppo di Natale. In tempi
recenti, solo i rami vengono raccolti, portati a casa e gettati cerimoniosamente
in una stufa o in un falò della chiesa. Le grandi querce isolate con una croce
incisa sul tronco rimasero a lungo luoghi di aggregazione pubblica e persino di
culto cristiano dove le chiese non erano disponibili. Ad esempio, nel 1815, in
un'assemblea intorno a una grande quercia a Takovo, Miloš Obrenović dichiarò l'inizio della
seconda rivolta serba. Anche in tempi moderni, l'abbattimento di queste querce
"sacre" può provocare proteste pubbliche, ad esempio nel caso di costruzione
di nuove strade. Il Gernikako Arbola ("albero di Guernica" in lingua basca) è
una Quercus robur che simboleggia la tradizionale libertà di tutto il popolo
basco: tutti i sovrani baschi dovevano giurare sotto il Gernikako Arbola di
rispettare le libertà del popolo e, ancora oggi, il Lehendakari dei Paesi Baschi
(il Presidente del Governo della Comunità Autonoma dei Paesi Baschi) deve
accettare la propria carica proprio sotto questa quercia. Non dimentichiamo poi
che fu su un leccio (Quercus ilex) che il 13 maggio 1917 la Vergine Maria
apparve ai tre pastorelli Lucia Dos Santos, Jacinta Marto e Francisco Marto in
Cova da Iria, presso Fatima, una delle più importanti apparizioni mariane dei
tempi moderni!
Per finire, al largo delle coste della Nuova Scozia (Canada) si trova
Oak Island, un'isoletta di soli 57 ettari divenuta famosa in tutto il mondo per
la leggenda del favoloso tesoro che essa ospiterebbe. Si racconta che nel 1795
(ma alcuni indicano altre date) il giovane Daniel McGinnis, giunto lì per
cacciare, venne incuriosito da una depressione del terreno situata vicino a una
vecchia quercia, dai rami della quale pendeva una carrucola del tipo usato sulle
navi. Il giorno dopo Daniel e due suoi amici, al corrente di antiche
leggende locali su pirati e tesori nascosti, cominciarono a scavare, speranzosi,
ma ben presto si resero conto che quella depressione nascondeva un pozzo
profondo: ogni tre metri trovavano una piattaforma di tavole in legno di quercia
e, arrivati al terzo strato, furono costretti a gettare la spugna, giudicando l'impresa troppo
ardua per loro. Nacque così la leggenda di Oak Island: quel pozzo prese il nome
di "Money Pit", il pozzo del denaro. Nel 1802 una compagnia privata, la Onslow
Company, dando credito alla storia, riprese gli scavi. Furono trovati alcuni
strati di carbone e argilla ma, soprattutto, fibre di cocco, che sicuramente non
erano del luogo, perché in Canada la palma da cocco non cresce. A trenta metri
di profondità gli scavatori si trovarono di fronte a un'enorme lastra di pietra
che recava incisioni indecifrabili. La rimossero, ed era ormai notte quando,
sondando il terreno sottostante, sentirono qualcosa di duro: si dice che fosse
lo scrigno di un possibile tesoro. I lavoratori, esausti, decisero di rimandare
la scoperta al giorno dopo, ma li aspettava una brutta sorpresa: nel corso della
notte l'acqua dell'Oceano aveva completamente allagato il pozzo, e i tentativi
di svuotarlo furono vani; il livello dell'acqua rimaneva costante. Si dice
infatti che ci sia un reticolo di tubi che parte sotto la baia vicina, e
quando la marea sale il condotto porta l'acqua nel Money Pit. Nel corso degli
anni sono stati fatti un altro centinaio di tentativi, l'ultimo dei quali,
datato 1966, fu un ennesimo fallimento. Sono state avanzate mille ipotesi sul
presunto tesoro che il Pozzo di Oak Island custodirebbe gelosamente:
c'è chi pensa che si tratti del tesoro di un famoso pirata (Henry Morgan o Edward Teach
detto Barbanera), o del tesoro dei Cavalieri Templari messo in salvo nel Nuovo
Mondo dall'ingordigia di Filippo IV il Bello, o addirittura del Sacro Graal o
dell'Arca dell'Alleanza (che non mancano mai in queste teorie). Ancor oggi molti
credono al mito del tesoro perduto e auspicano una ripresa dei lavori (anche se
l'isola ora è di proprietà privata e non si può sbarcare su di essa). La tesi
tuttavia più accreditata dagli storici è che il pozzo sia di origine naturale,
così come altri pozzi tipici della zona, visto che il terreno dell'isola è
carsico, e che la stessa vicenda di Daniel McGinnis non sia altro che una
leggenda (infatti si diceva che Oak Island avesse la forma di punto
interrogativo, mentre un rapido giro su Google Earth dimostra che non è così).
Per la precisione, si tratterebbe di una leggenda di origine massonica (i
Massoni si ritengono spesso gli eredi dei Cavalieri Templari e i depositari
della loro sapienza): al centro di molte tradizioni massoniche infatti c'è una
cripta segreta in cui sono nascosti segreti ancestrali, come la mitica grotta
sotto il Monte del Tempio in cui il profeta Geremia avrebbe nascosto l'Arca
dell'Alleanza prima della distruzione del Primo Tempio da parte di Nabucodonosor
II; per trovare tale ipogeo occorre seguire le indicazioni di una mappa o
interpretare una pietra tombale con un'iscrizione apparentemente indecifrabile
(guarda caso...). In realtà tale cripta altro non rappresenta che la Verità, nascosta al volgo e
riservata agli Affiliati alla Loggia, che soli, dopo una lunga iniziazione, sarebbero in
grado di accedere ad essa. Ma questa leggenda non dimostra se non la
persistenza sino al giorno d'oggi del concetto della quercia come albero sacro,
l'' degno di custodire la Verità, quella con la V maiuscola!

La cosiddetta "quercia di Robin Hood" al centro della foresta di Sherwood, nel Nottinghamshire
L'albero
della leggendaria Regina Giovanna
Il
castagno (Castanea sativa) è un albero
della famiglia delle Fagacee, originario dell'Europa meridionale e dell'Asia
Minore, che rappresenta una delle più importanti essenze forestali dell'Europa
meridionale, in quanto ha riscosso, fin dall'antichità, l'interesse dell'uomo
per i suoi molteplici utilizzi. Albero deciduo resistente e longevo, raggiunge
un'altezza di 20–35 metri con un tronco spesso di 2 m di diametro, ma esistono
esemplari con un diametro superiore a 4 m. I castagni vivono fino a un'età
compresa tra 500 e 600 anni, ma quelli coltivati possono anche raggiungere 1.000
anni o più. Il famoso "Castagno dei Cento Cavalli" in Sicilia ha addirittura un
diametro di 18 metri, sebbene si sia diviso in più tronchi fuori terra, e un'età
di 2.200 anni. La corteccia ha spesso un disegno a forma di rete con solchi o
fessure profondi che corrono a spirale in entrambe le direzioni lungo il tronco.
Quest'ultimo è per lo più diritto con ramificazioni che iniziano ad altezze
basse. Le foglie oblungo-lanceolate e dentate sono lunghe 16–28 centimetri e
larghe 5–9 cm. I fiori di entrambi i sessi sono portati in amenti eretti lunghi
10–20 cm, i fiori maschili nella parte superiore e quelli femminili nella parte
inferiore. Nell'emisfero settentrionale compaiono tra la fine di giugno e
l'inizio di luglio e, entro l'autunno, il fiore femminile dà vita al frutto, che
tecnicanente è un achenio, comunemente chiamato castagna o marrone, con
pericarpo di consistenza cuoiosa e di colore marrone, glabro e lucido
all'esterno, peloso all'interno. La forma è più o meno globosa, con un lato
appiattito, detto pancia, e uno convesso, detto dorso. Il polo apicale termina
in un piccolo prolungamento frangiato, detto torcia, mentre il polo prossimale,
detto ilo, si presenta leggermente appiattito e di colore grigiastro. Questa
zona di colore chiaro è comunemente detta cicatrice. Sul dorso sono presenti
striature più o meno marcate, in particolare nelle varietà del gruppo dei
marroni. Gli acheni sono racchiusi all'interno di un involucro spinoso,
comunemente chiamato riccio, derivato dall'accrescimento della cupola. A
maturità, il riccio si apre dividendosi in quattro valve. Alcune cultivar
producono solo un seme grande per riccio, mentre altre producono fino a tre
semi. All'interno è presente una parte commestibile, color bianco crema,
sviluppatasi dai cotiledoni. Occorre distinguere il castagno dall'ippocastano
(Aesculus hippocastanum), al quale è solo lontanamente imparentato:
l'ippocastano infatti porta semi dall'aspetto simile in un contenitore simile,
che però non sono commestibili dall'uomo. Negli ultimi decenni è stato
introdotto, per motivi fitopatologici, il castagno giapponese (Castanea
crenata).
Un po' di storia. L'etimologia della parola "castagna" è sconosciuta; a volte la
si accosta a "Kastanìa", nome di un villaggio greco della Tessaglia, o a
"Kastanis", città del Ponto, ma è più probabile che questi toponimi derivino dal
nome del frutto che viceversa. Secondo il mio amico Guido Borghi dell'Università
di Genova, la dossografia vulgata va bene fino al greco κάστανον <kắstănŏn>
"castagno" e al dorico κάστον <kắstŏn> "legno"; il legno di castagno più antico
in un sito archeologico è del 6000-5700 a.C. (Гълъбник <Gălăbnik>, in Bulgaria
sudorientale), e quindi i due lessemi sono con ogni probabilità già indoeuropei:
*k̑ə̥̆ₐs-tŏ-m ‘legno’ → *k̑ə̥̆ₐs-thₐ-ănŏ-s ‘(Fāgācĕă) da legno’ (> celtico
*kăssănŏ-s "quercia").
Si pensa che il castagno sia sopravvissuto
all'ultima era glaciale in diversi rifugi dell'Europa meridionale, sulla costa
meridionale del Mar Nero con un centro principale sul versante meridionale del
Caucaso e nella regione della Siria nord-occidentale, estendendosi forse fino al
Libano.I dati sui pollini indicano che la prima diffusione di Castanea sativa
dovuta all'attività umana iniziò intorno al 2100–2050 a.C. in Anatolia , nella
Grecia nordorientale e nella Bulgaria sudorientale. Rispetto ad altre colture,
il castagno aveva probabilmente un'importanza relativamente minore ed era
distribuito in modo molto eterogeneo in queste regioni. I primi resti di carbone
di castagno risalgono solo all'850-950 a.C. circa. Una fonte più recente ma più
affidabile sono le opere letterarie dell'antica Grecia, la più ricca delle quali
è la "Historia plantarum" di Teofrasto , scritta nel terzo secolo a.C. Teofrasto
si concentra principalmente sull'uso del legno di castagno come legname e
carbone, menzionando l'uso del frutto solo una volta per commentare le
difficoltà digestive che provoca, ma lodandone le qualità nutritive. Diversi
autori greci descrissero le proprietà medicinali della castagna, in particolare
come rimedio contro le lacerazioni delle labbra e dell'esofago. Similmente
all'introduzione della coltivazione della vite e dell'olivo nel mondo latino, si
pensa che la Castanea sativa sia stata introdotta durante la colonizzazione
della penisola italica da parte dei Greci. Ulteriori indizi che supportano
questa teoria possono essere trovati nell'opera di Plinio il Vecchio, che
menziona solo le colonie greche in relazione alla coltivazione del castagno.
L'odierna mappa filogenetica del castagno, sebbene non del tutto compresa,
mostra una maggiore somiglianza genetica tra gli alberi di Castanea sativa
italiani e quelli dell'Anatolia occidentale rispetto agli esemplare
dell'Anatolia orientale, rafforzando quella ipotesi. Ciononostante, fino
all'inizio dell'era cristiana, la diffusione e l'utilizzo del castagno in Italia
rimasero limitati. Castagne carbonizzate furono trovate in una villa romana di
Pompei, distrutta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Indizi nell'arte e nella
letteratura tuttavia indicano un'avversione per le castagne da parte
dell'aristocrazia romana. Come Teofrasto, gli autori latini sono scettici nei
confronti di questi frutti, e Plinio il Vecchio arriva addirittura ad ammirare
quanto bene la natura abbia nascosto questo frutto apparentemente di così scarso
valore. Solo all'inizio dell'era cristiana ci si rese conto del valore e della
versatilità del legno di castagno, portando ad una lenta diffusione della
coltivazione degli alberi di Castanea sativa: teoria, questa, supportata da dati
pollinici e fonti letterarie, così come il crescente utilizzo del legno di
castagno per realizzare pali e strutture di sostegno, nelle opere in legno e
nella costruzione di moli tra il 100 e il 600 d.C. La crescente presenza di
polline di castagno in Svizzera, Francia, Germania e nella penisola iberica nel
I secolo d.C. suggerisce la diffusione dei castagni coltivati da parte dei
Romani. Alcuni gusci di castagne, datati al terzo o all'inizio del quarto
secolo, sono stati identificati sul fondo di un pozzo romano presso la Great
Holts Farm, a Boreham nell'Essex , in Inghilterra, deposito che include resti di
altre piante alimentari esotiche e non fornisce alcuna prova che qualcuna di
esse abbia avuto origine localmente (infatti nessun'altra prova di consumo di
castagne nella Britannia romana è stata sinora confermata), e non è stato
individuato alcun centro di coltivazione del castagno al di fuori della penisola
italiana in epoca romana. L'uso diffuso del castagno nell'Europa occidentale
inizia nell'alto Medioevo e fiorisce nel tardo. Il longobardo Editto di Rotari
del 643 d.C. stabiliva una multa di un solido per l'abbattimento di un castagno
appartenente ad un'altra persona. Nel 1477 il medico sabaudo Pantaleone da
Cofienza elogiò la dieta montanara costituita prevalentemente da castagne, latte
e latticini, affermando che essa era in grado di offrire una nutrizione
completa. La crisi del castagno ebbe inizio a partire dal Rinascimento,
presumibilmente in concomitanza con il progresso tecnico in agricoltura e con il
crescente sviluppo della cerealicoltura. Da allora e fino all'Ottocento, il
castagno subì un lento e progressivo abbandono, nonostante si verificassero
espansioni di portata locale che, nel corso dei secoli, fecero variare in Italia
la distribuzione della castanicoltura. Alla fine dell'Ottocento iniziò il
declino vero e proprio della castanicoltura, protraendosi per decenni a causa
del concorso di molteplici cause: l'evoluzione delle abitudini alimentari delle
popolazioni europee, l'introduzione di materiali alternativi quali il metallo e
la plastica nell'allestimento di manufatti e opere infrastrutturali, civili e
agricole, la crisi dell'industria del tannino dopo gli anni trenta, il crescente
interesse verso altre specie forestali da legno alternative al castagno (robinia
e ciliegio), la pressione antropica sugli ambienti forestali. Alla riduzione
delle superfici forestate a castagno hanno inoltre contribuito le decimazioni
dovute ai parassiti di questa specie. Nel complesso, la castanicoltura si è
fortemente ridimensionata, ed è circoscritta alle aree di maggiore vocazione,
sia per le castagne sia per il legno, mentre i castagneti progressivamente
abbandonati nel corso dei secoli sono scomparsi o si sono evoluti verso altri
tipi di bosco. Al giorno d'oggi, tuttavia, lo sviluppo di prodotti a base di
castagne di alto valore nutritivo, combinato con le mutevoli esigenze di una
società urbana tecnologizzata, sta portando a una rinascita della coltivazione
di Castanea sativa.
Castanea sativa è oggi ampiamente distribuito in tutta Europa, dove nel 2004
veniva coltivato su 2.250.000 ettari di foresta, di cui 1.780.000 erano
coltivati principalmente a bosco e 430.000 per la produzione di frutti. In
alcuni paesi europei Castanea sativa è stato introdotto solo di recente, ad
esempio nei Paesi Bassi. Esso richiede un clima mite e un'umidità adeguata per
una buona crescita e un buon raccolto. La sua crescita annuale è sensibile alle
gelate della tarda primavera e dell'inizio dell'autunno. Le foglie forniscono
cibo per alcuni animali, tra cui la falena Coleophora anatipennella.
I due principali patogeni fungini del castagno sono la peronospora
(Cryphonectria parasitica) e la malattia dell'inchiostro causata da Phytophthora
cambivora e Phytophthora cinnamomi. Nel Nord America e nell'Europa meridionale
Cryphonectria parasitica ha distrutto la maggior parte della popolazione di
castagni nel XX secolo. Oggi grazie ad opportuni trattamenti la popolazione di
castagni non è più minacciata dalla peronospora del castagno e si sta
rigenerando. La malattia dell'inchiostro prende il nome dagli essudati neri
alla base del tronco ed infesta gli alberi per lo più in terreni umidi, con il
micelio che invade la radice e provoca l'avvizzimento della foglia, ma
oggigiorno esistono cultivar resistenti alla malattia dell'inchiostro. Un altro
parassita pericoloso e difficile da controllare è la vespa biliare (Dryocosmus
kuriphylus), originaria dell'Asia ma recentemente introdotta nell'Europa
meridionale.
Si possono distinguere tre diversi sistemi di coltivazione del castagno. 1)
Ceduazione: principalmente per l'estrazione del legno. In condizioni standard si
ottengono 15 metri cubi di legno per ettaro e per anno. 2) Foresta: produzione
di frutti da alberi innestati. Gli alberi hanno un tronco corto e una grande
chioma, un'alta densità e il terreno tra gli alberi viene spesso utilizzato come
pascolo. 3) Fustaia: produzione di legno e frutta. Questa forma di coltivazione
è meno intensiva e richiede la sostituzione degli alberi ogni 50–80 anni. Gli
alberi crescono dai semi e costruiscono una fitta chioma.
Il castagno cresce bene su terreni privi di calcare e il valore ottimale del pH
del terreno è compreso tra 4,5 e 6; l'albero non può tollerare la compattazione
del suolo. La tolleranza ai terreni umidi e ai terreni ricchi di argilla è molto
bassa. È un albero amante del caldo che necessita di un lungo periodo di
vegetazione. La temperatura media ottimale è compresa tra 8°C e 15°C, e a
gennaio la temperatura preferibilmente non dovrebbe essere inferiore a -1°C,
anche sepuò tollerare temperature fino a -15°C. Le basse temperature in autunno
possono danneggiare i frutti. L'altitudine massima dipende fortemente dal clima,
simile a quello della viticoltura. Un albero cresciuto dal seme può impiegare 20
anni o più prima che dia frutti, ma una cultivar innestata come "Marron de Lyon"
o "Paragon" può iniziare la produzione entro cinque anni dalla piantagione.
Entrambe le cultivar producono frutti con un unico grande seme, invece dei
soliti due o quattro più piccoli. La resa di frutta per albero è solitamente
compresa tra 30 e 100 chilogrammi, ma può arrivare fino a 300 chilogrammi. [18]
Il periodo della raccolta è compreso tra metà settembre e metà novembre.
Esistono tre tecniche di raccolta: 1) A mano: le castagne vengono raccolte con
un rastrello o una scopa, con una velocità di raccolta da 5 a 30 chilogrammi
ogni ora a seconda del rilievo del terreno. Inoltre la capsula rende la raccolta
più complicata e perfino dolorosa per il lavoratore. 2) A mano con reti: questa
tecnica richiede meno tempo e protegge i frutti da lesioni. Tuttavia
l’installazione delle reti richiede un lavoro lungo e faticoso. 3) Meccanico: I
frutti vengono raccolti con una macchina che funziona in modo simile ad un
aspirapolvere. Usarla fa risparmiare tempo ed è economico, ma è possibile che
alcuni frutti si danneggino. Il trattamento post-raccolta più diffuso prima
della conservazione è l'idrosalatura, un processo in cui le castagne vengono
immerse in acqua per nove giorni. Lo scopo di questa pratica è quello di
limitare i principali problemi di conservazione che minacciano il castagno: lo
sviluppo di funghi e la presenza di larve di insetti. In alternativa al
trattamento con acqua, a livello commerciale viene utilizzato anche il
trattamento con acqua calda. In seguito le castagne vengono conservate in un
ambiente controllato con elevate concentrazioni di anidride carbonica. A
differenza di un sistema di conservazione a freddo, in cui i frutti vengono
conservati a basse temperature in aria non trattata, il metodo dell'ambiente
controllato evita l'indurimento della polpa che influisce negativamente sulla
lavorabilità del prodotto.
Castanea sativa è caratterizzata da un elevato contenuto di umidità che varia
dal 41% al 59%. 100 grammi di castagne forniscono 213 kcal di energia, 45,54 g
di carboidrati, 8,1 g di fibra alimentare, 2,26 g di grassi di cui 0,425 saturi,
2,42 g di proteine, vitamina A, B1, B2, B3, B12. La castagna è una buona fonte
di amido e fornisce rame, fosforo, manganese e potassio.
Il castagno risponde molto bene al ceduo, ancora praticato in Gran Bretagna, e
produce un buon raccolto di legno ricco di tannino ogni 12-30 anni, a seconda
dell'uso previsto e del tasso di crescita locale. Il tannino rende il legno
giovane durevole e resistente agli agenti atmosferici per uso esterno, quindi
adatto per pali o recinzioni. Il legno è di colore chiaro, duro e forte e ha una
densità di 560 kg per metro cubo. Viene utilizzato per realizzare mobili, botti
(a volte utilizzate per invecchiare l'aceto balsamico) e travi per tetti,
soprattutto nell'Europa meridionale. È anche un buon combustibile, anche se non
è adatto ai fuochi aperti poiché tende a scoppiettare e a diffondere pericolose
scintille. La corteccia e il legno del castagno sono particolarmente ricchi di
tannini (circa il 7%) e possono essere impiegate per la sua estrazione,
destinata alle concerie. Questa destinazione d'uso, in Italia, ha riscosso un
particolare interesse nei primi decenni del XX secolo, epoca in cui l'industria
del tannino nazionale faceva largo impiego del castagno, ma dopo il 1940 ha
perso importanza, sia per la contrazione di questo settore, sia per il ricorso,
come materia prima, al legno di scarto
Veniamo alla cucina. La grande diversità genetica della specie e le diverse
cultivar vengono sfruttate per usi come farina, bollitura, tostatura,
essiccazione e dolci. Le castagne crude, pur essendo commestibili, hanno
una buccia astringente e sgradevole da mangiare quando sono ancora umide; dopo
un certo periodo di essiccazione la buccia sottile perde la sua astringenza, ma
è comunque meglio asportarla per raggiungere il frutto bianco sottostante. La
cottura a secco in forno o sul fuoco normalmente aiuta a rimuovere questa
buccia. Le castagne vengono tradizionalmente arrostite nella loro dura buccia
marrone dopo aver rimosso i ricci spinosi in cui crescono sull'albero, le bucce
vengono sbucciate e scartate e le castagne calde vengono immerse nel sale prima
di mangiarle. Le caldarroste vengono tradizionalmente vendute nelle strade, nei
mercati e nelle fiere da venditori ambulanti con bracieri portatili. La buccia
delle castagne crude può essere rimossa con relativa facilità sbollentando
rapidamente le noci dopo averle incise con una fessura a croce all'estremità del
ciuffo. Una volta cotte, le castagne acquistano un sapore dolce e una
consistenza farinosa simile alla patata dolce. Le castagne cotte possono essere
utilizzate per farcire il pollame, come verdura o negli arrosti. Possono essere
utilizzati anche per dolci, budini, dessert e torte. Vengono macinati per
ottenere una farina, che permette la panificazione come sostituto dei cereali.
Ma può essere usata persino come sostituto del caffè, come addensante nelle
zuppe e come brodo da ingrasso. Da essa si può estrarre perfino uno zucchero. La
varietà corsa di polenta è fatta con farina dolce di castagne; anche una varietà
locale di birra corsa utilizza le castagne. Il prodotto viene venduto come pasta
zuccherata mescolata con vaniglia detta "crème de marrons", zuccherata o non
zuccherata come purea di castagne o sotto forma di squisite castagne candite
dette "marrons glacés". Gli infusi di foglie vengono utilizzati per curare le
malattie respiratorie e sono un rimedio popolare contro la pertosse. Uno shampoo
per capelli può essere preparato con un infuso di foglie e bucce di frutta.
L'apicoltura è un'attività accessoria che può appoggiarsi alla castanicoltura.
Pur avendo impollinazione prevalentemente anemogama, i fiori maschili del
castagno sono bottinati dalle api, che ne raccolgono il polline ed il nettare,
perciò questa pianta è considerata mellifera. Il miele di castagno ha una
colorazione variabile dall'ambra al bruno scuro, retrogusto amaro, resiste alla
cristallizzazione per lungo tempo, ed è particolarmente ricco di fruttosio e
polline. La sua produzione si localizza naturalmente nelle zone a maggiore
vocazione per la castanicoltura e, principalmente, nella fascia submontana fra i
500 e i 1000 metri di altitudine, lungo l'arco alpino, in Emilia-Romagna, e sul
versante tirrenico della fascia appenninica e nelle zone montane della Sicilia
settentrionale.
L'uso del castagno a scopo medicamentoso è piuttosto marginale, tuttavia questa
specie è considerata una pianta officinale nella farmacopea popolare: per il
contenuto in tannini, la corteccia ha proprietà astringenti, impiegabile in
fitocosmesi per il trattamento della pelle. Alle foglie, oltre alle proprietà
astringenti, sono attribuite proprietà blandamente antisettiche e sedative della
tosse. Sempre nella farmacopea popolare di alcune regioni, la polpa delle
castagne, cotta e setacciata, trova impiego in fitocosmesi per la preparazione
di maschere facciali detergenti ed emollienti.
Il Castagno dolce è anche uno dei 38 fiori di Bach, secondo cui l'essenza
ricavata dai suoi fiori, associata alle qualità di robustezza e longevità della
pianta, viene consigliata per superare le difficoltà d'animo e guadagnare
fiducia; occorre però ricordare che si tratta di una disciplina
pseudoscientifica per la quale non esiste alcuna prova che dimostri che possa
controllare, curare o prevenire qualsiasi tipo di malattia, compreso il cancro,
nonostante la fede riposta in ciò dai suoi assertori.
La presenza del castagno fin dall'antichità ha fatto sì che alcuni esemplari,
ancora oggi esistenti, abbiano un particolare valore storico, culturale,
paesaggistico e, come tali, sono definiti alberi monumentali. Il più famoso è il
già citato Castagno dei Cento Cavalli, ubicato alle pendici orientali dell'Etna,
nel territorio del Comune di Sant'Alfio in provincia di Catania, nel cui stemma
civico è raffigurato: è considerato il più famoso d'Italia e uno dei più vecchi
alberi d'Europa. Ad esso sono associate leggende, e ad esso si sono ispirati
artisti e letterati. L'albero è ubicato alle falde dell'Etna, ha una
circonferenza di 22 metri e un'altezza di 22 metri. L'età è stata variamente
stimata tra i 2000 e i 4000 anni, ma nel 2021 uno studio del CREA
(Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria),
basato sull'impronta genetica, ha indicato un'età di 2.200 anni. Le prime
notizie storiche sul Castagno dei Cento Cavalli sono documentate già nel XVI
secolo, ma la sua storia si fonde con la leggenda di una misteriosa regina
Giovanna, mai identificata con alcuna figura storica, e di cento cavalieri con i
loro destrieri, che, si narra, vi trovarono riparo da un temporale (da cui il
nome): la regina Giovanna I d'Angiò, vissuta dal 1326 al 1382, principale
candidata al ruolo, non è mai stata da quelle parti.
Veniamo alle lettere. Come dettaglio ricorrente nel paesaggio rurale e
strettamente correlato alla civiltà contadina, il castagno è frequentemente
citato nella letteratura, in genere come elemento di sfondo del contesto
specifico o, talvolta, come oggetto specifico dell'opera. Giovanni Boccaccio
(1313–1375) cita il castagno nel Decameron come elemento del paesaggio rurale,
affiancandolo all'olivo e al nocciolo: « Ivi forse una balestra rimosso
dall'altre abitazioni della terra, tra ulivi e nocciuoli e castagni, de' quali
la contrada è abondevole, comperò una possessione ».
In "Proserpina", quinto idillio dell'opera "La sampogna", Giovan Battista Marino
(1569–1625) descrive Vertunno, dio dei giardini e della frutta nella mitologia
romana, con due ricci di castagno al posto delle tempie: « Ne l'una e l'altra
tempia / tien duo non anco aperti / di pungente castagno ispidi ricci... »
Nel 1771 Giuseppe Parini (1729-1799), su incarico della Casa d'Asburgo,
descrisse i festeggiamenti in onore delle nozze fra Ferdinando d'Asburgo-Este e
Maria Beatrice d'Este, e in un passo di quest'opera descrive uno dei carri
allegorici del corteo, che rappresentava un castagno, sotto la cui chioma
pascolava un gregge di pecore: « Il primo di questi, che nella sua perfetta
semplicità venne giudicato bellissimo, era un carro rappresentante un piccolo
spazio di terreno, sopra di cui elevavasi un alto castagno. All'ombra di questo
forse dodici pecore stavano pascendo l'erbe; e un biondo e rubicondo pastore,
appoggiandosi al tronco... »
Ippolito Nievo (1831–1861), nel secondo capitolo del romanzo "Le confessioni di
un italiano", ricorre alla metafora del pollone emesso dalla vecchia ceppaia di
castagno, per descrivere il rapporto che legava la giovane Clara, fin dalla sua
infanzia, alla nonna inferma: « Sembrava fin d'allora il rampollo giovinetto di
castagno che sorge dal vecchio ceppo rigoglioso di vita. »
Nell'ode "Piemonte", Giosuè Carducci (1835–1907) cita il castagno nel
riferimento storico all'esilio portoghese di Carlo Alberto di Savoia, a seguito
della sconfitta di Novara e l'abdicazione in favore di Vittorio Emanuele II.
Carlo Alberto infatti si ritirò a Porto, in una villa presso la foce del Duero,
in vicinanza della quale sorgeva un bosco di castagni. « E lo aspettava la
brumal Novara / e a' tristi errori mèta ultima Porto. / Oh sola e cheta in mezzo
de' castagni / villa del Douro, / che in faccia il grande Atlantico sonante / a
i lati ha il fiume fresco di camelie, / e albergò ne la indifferente calma /
tanto dolore! »
Il castagno diventa addirittura un protagonista nelle opere di Giovanni Pascoli
(1855–1912), che dedicò all'albero interi componimenti. "Il castagno", nella
sezione "Alberi e fiori" della raccolta "Myricae", enfatizza il ruolo della
pianta nella civiltà contadina di un tempo: esso accompagna, con la sua costante
presenza, la scansione delle stagioni, e nelle freddi sere dell'autunno e
dell'inverno diventa un protagonista nella vita della famiglia contadina, con lo
scoppiettìo della sua corteccia che brucia nel focolare e le castagne che
cuociono nella pentola: « Per te i tuguri sentono il tumulto / or del paiolo che
inquïeto oscilla; / per te la fiamma sotto quel singulto / crepita e brilla: /
tu, pio castagno, solo tu, l'assai / doni al villano che non ha che il sole; /
tu solo il chicco, il buon di più, tu dai / alla sua prole... »
Il castagno e i suoi frutti appaiono anche nel ritratto che Grazia Deledda
(1871–1936) fa della famiglia di zia Grathia, nel romanzo "Cenere". Deledda
presenta la castagna sia come bene economico sia come componente integrante
della quotidianità nella famiglia rurale della montagna barbaricina: « Le
castagne del piccolo Zuanne scoppiavano fra la cenere che si spargeva sul
focolare... »; « Si alzò, accese una primitiva candela di ferro nero, e preparò
la cena: patate e sempre patate: da due giorni Olì non mangiava altro che patate
e qualche castagna... »
Il poeta ottocentesco sardo Peppino Mereu (1872-1901) cita il pane di castagne
come alimento rifugio dei poveri in tempi di carestia nella sua più celebre
poesia, "Nanneddu meu". La poesia, che ha subito diversi arrangiamenti musicali
nei canti popolari della Sardegna e in una più nota versione interpretata dal
gruppo dei Tazenda, è un canto di protesta che, in forma di lettera ad un amico,
descrive lo stato di miseria e oppressione in cui versavano gli strati sociali
più bassi nella metà dell'Ottocento: « Famidos nois semos pappande / pane e
castanza, terra cun lande / terra ch'a fangu, torrat su poveru / senz'alimentu,
senza ricoveru. » (« Affamati noi stiamo mangiando / pane di castagne e terra
con ghiande / terra come il fango, ridiventa il povero / senza cibo, senza
ricovero. »)
Il Castagno dei Cento Cavalli è citato dal poeta ottocentesco siciliano Giuseppe
Borrello (1820–1894) che rievocò in una sua composizione la leggenda da cui
deriverebbe il nome dell'albero: « Un pedi di castagna tantu grossu / ca ccu li
rami so' forma un paracqua / sutta di cui si riparò di l'acqua, di fùrmini, e
saitti / la riggina Giuvanna ccu centu cavaleri, / quannu ppi visitari
Mungibeddu vinni surprisa di lu timpurali. / D'allura si chiamò st'àrvulu
situatu 'ntra 'na valli / lu gran castagnu d'i centu cavalli. » (« Un piede di
castagna tanto grosso / che con i rami forma un ombrello / sotto il quale si
riparò dalla pioggia, dai fulmini e dalle saette / la regina Giovanna con cento
cavalieri / quando per visitare Mongibello venne sorpresa dal temporale. / Da
allora si chiamò quest'albero situato entro una valle / il gran castagno dei
cento cavalli. »
Ancora come elemento figurativo rappresentativo del paesaggio boschivo, il
castagno è riproposto da Italo Calvino (1923–1985) in un racconto di "Ultimo
viene il corvo". Un castagno dal tronco cavo si presenta agli occhi del
partigiano Binda, mentre attraversa i boschi per portare gli ordini alle
postazioni: « Un castagno dal tronco cavo, un lichene celeste su una pietra, lo
spiazzo nudo d'una carbonaia, quinte di uno scenario spaesato e uniforme,
s'animavano in lui radicate ai ricordi più remoti... »
Passiamo alla letteratura non italiana. Hermann Hesse (1877–1962) dedicò al
castagno l'apertura del suo "Narciso e Boccadoro", descrivendo il maestoso
albero ubicato presso l'ingresso del seminario di Maulbronn, nella Germania
meridionale, dove studiò da giovane. Nella descrizione, Hesse cita alcuni
aspetti che evidenziano la natura esotica del castagno, vista la sua posizione
al limite settentrionale dell'areale: « Davanti all'arco d'ingresso, retto da
colonnette gemelle, del convento di Mariabronn, sul margine della strada c'era
un castagno, un solitario figlio del Sud, che un pellegrino aveva riportato da
Roma in tempi lontani, un nobile castagno dal tronco vigoroso; la cerchia de'
suoi rami si chinava dolcemente sopra la strada, respirava libera ed ampia nel
vento; in primavera, quando intorno tutto era già verde ed anche i noci del
monastero mettevano già le loro foglioline rossicce, esso faceva attendere
ancora a lungo le sue fronde, poi quando le notti eran più brevi, irradiava di
tra il fogliame la sua fioritura esotica, d'un verde bianchiccio e languido, dal
profumo aspro e intenso, pieno di richiami, quasi opprimente; e in ottobre,
quando l'altra frutta era già raccolta ed il vino nei tini, lasciava cadere al
vento d'autunno i frutti spinosi dalla corona ingiallita: non tutti gli anni
maturavano; per essi s'azzuffavano i ragazzi del convento, e il sottopriore
Gregorio, oriundo del mezzodí, li arrostiva in camera sua sul fuoco del camino.
»
Il castagno figura come elemento di sfondo anche nello scenario che accompagna
le riflessioni esistenziali di Antoine Roquentin ne "La nausea" di Jean-Paul
Sartre (1905-1980):
« Invano cercavo di contare i castagni, di situarli in rapporto alla Velleda, di
confrontare la loro altezza con quella dei platani: ciascuno di essi sfuggiva
dalle relazioni nelle quali io cercavo di rinchiuderli, s'isolava, traboccava. »
In "1984" di George Orwell sono presenti alcuni riferimenti al castagno: il bar
frequentato dal protagonista Winston Smith si chiama "Bar del Castagno", e lungo
l'intero romanzo viene citata la "Canzone del Castagno": « Sotto il castagno,
chissà perché. / Io ti ho venduto, e tu hai venduto me: / sotto i suoi rami alti
e forti, / essi sono defunti e noi siam morti. »
Il carattere di rappresentatività del castagno come elemento paesaggistico della
civiltà rurale lo ha portato anche ad essere raffigurato come soggetto nella
pittura, ad esempio nel "Castagno dei Cento Cavalli" di Jean-Pierre Houël
(1735–1813), nei "Castagni" di Paul Cézanne (1839–1906) e nell'omonimo dipinto
di Camille Pissarro (1830–1903).
Chiudiamo con qualche curiosità. Talvolta il ciclo biologico del castagno era
abbinato dalle popolazioni montanare alle ricorrenze del calendario liturgico
cattolico. In Garfagnana (provincia di Lucca), per esempio, erano diffusi i
seguenti detti:
« Per san Giacomo e sant'Anna allegano i fiori in castagna. » (25-26 luglio)
« Per santa Maria la castagna cria. » (15 agosto)
« Per san Luca la castagna si pilucca. » (18 ottobre)
Nella metà di novembre in molti borghi si svolgono le tradizionali castagnate
autunnali, dove si possono gustare specialità a base di castagna come le
caldarroste e altri piatti tipici. In Emilia-Romagna, nella zona tra Castenaso,
Budrio e Medicina, in provincia di Bologna, esiste un termine, "ansali", che si
riferisce alle castagne cotte e affumicate, e consumate il giorno di Santa
Lucia, il 13 dicembre. Un gusto simile è quello del "Lagavulin", whisky scozzese
invecchiato in botti di legno di castagno.
L'espressione "prendere in castagna" è un'antica frase fatta che significa
"sorprendere qualcuno in errore". La data e il luogo d'origine del detto non
sono noti. Probabilmente,il modo di dire trae origine dal termine tardo latino
"marro, marronis" che significa "errore". Infatti in francese antico "marrir"
significava "confondersi", analogamente allo spagnolo "marrar" che significava
"errare". Con il passare del tempo la frase "prendere in marrone" è diventata
"prendere in castagna", associando il frutto dell'albero Castanea sativa
all'errore, vista l'omonimia tra castagna e marrone!
Il castagno, infine, ha acquisito anche un valore simbolico: in Cina la
tradizione ne ha fatto il simbolo della previdenza, in quanto il frutto serve da
nutrimento per tutto l'anno; altrove rappresenta la giustizia. Nell'esegesi
biblica alla castagna si attribuisce il valore di castità, poiché il suo nome
latino "castanea" contiene la radice "casta", ovvero "pura". Per l'etimologia
del termine e per la sua particolare conformazione, chiusa in un guscio con
aculei spinosi, è associata a Maria come riferimento alla concezione virginale
di Cristo: la castagna è racchiusa in un guscio di spine senza esserne scalfita,
così come la Madonna è immune dal peccato originale nonostante questo la
circondi. Per il presbitero e teologo Filippo Picinelli (1604–1678) è la
metafora del buon cristiano, che fuori mostra le spine come il riccio, ma dentro
è pieno di virtù come la castagna, gustosa e nutriente. Essa rappresenta anche
la povertà, sia per essere un cibo semplice sia per essere brutta fuori ma
dentro assai virtuosa. Nel linguaggio araldico il frutto è simbolo di
resistenza, virtù nascoste e fede inalterabile. Forse è per questo che in
italiano il termine "castagna" può anche avere il significato di "pugno in pieno
viso"!

Il Castagno dei Cento Cavalli
L'avversario di Tom Bombadil
I salici sono circa 350
specie (per lo più ibride) di alberi e arbusti tipicamente decidui del genere Salix, che crescono principalmente su terreni umidi nelle regioni fredde e
temperate. Alcuni salici, e in particolare le specie artiche e alpine, sono
arbusti a crescita bassa o striscianti; ad esempio, il salice nano (Salix
herbacea) raramente supera i 6 centimetri di altezza, sebbene si diffonda
ampiamente sul terreno! In Italia le specie più diffuse sono Salix alba o
"salice bianco", Salix caprea noto come "salcio di montagna", Salix purpurea o
"salice rosso", Salix cinerea o "salice cinerino", ma si trovano anche specie
esotiche acclimatatesi da noi, come il Salix babylonica, meglio noto come
"salice piangente". Alti fino a 25 m, i salici hanno tutti nella corteccia
un'abbondante linfa acquosa, ricca di acido salicilico. Il loro legno è legno
morbido, solitamente flessibile; ha rami sottili e radici grandi, fibrose,
spesso stolonifere, notevoli per la loro robustezza, dimensione e tenacia: le
radici germogliano prontamente dalle parti aeree della pianta. Le foglie sono
tipicamente allungate, ma possono anche essere rotonde o ovali, spesso con bordi
seghettati. Come detto, la maggior parte delle specie sono decidue; i salici
semisempreverdi con foglie coriacee sono rari, ad esempio Salix micans e Salix
australior nel Mediterraneo orientale. Tutte le gemme sono laterali; non si
forma mai una gemma assolutamente terminale. Le foglie mostrano una grande
varietà di colori verdi, che vanno dal giallastro al bluastro.
I salici sono tra le prime piante legnose a spuntare in primavera e le ultime a
lasciar cadere le foglie in autunno. Nell'emisfero settentrionale le foglie
possono spuntare già a febbraio a seconda del clima e dea temperatura dell'aria.
Se le massime diurne raggiungono i 10 °C, per alcuni giorni consecutivi, un
salice tenterà di far uscire foglie e fiori. Nell'emisfero settentrionale, la
caduta delle foglie in autunno si verifica quando la durata del giorno si riduce
a circa dieci ore e mezza, il che varia a seconda della latitudine: già dalla
prima settimana di ottobre per le specie boreali come Salix alaxensis, e fino
alla terza settimana di dicembre per i salici che crescono nelle zone più
meridionali. Ad eccezione di Salix martiana, i salici sono dioici, con fiori
maschili e femminili che appaiono come amenti (infiorescenze) su piante
separate; gli amenti vengono prodotti all'inizio della primavera, spesso prima
delle foglie. I fiori staminati (maschili) sono privi di entrambi i calici con
corolla; sono costituiti semplicemente da stami, in numero variabile da due a
10, accompagnati da una ghiandola nettarifera e inseriti sulla base di una
scaglia che a sua volta è portata sul rachide di un racemo ricadente. Le antere
sono rosate sul bocciolo, ma arancioni o porpora dopo l'apertura del fiore. I
fiori pistillati (femminili) sono anch'essi privi di calice e di corolla, e
consistono in un ' ovario accompagnato da una piccola ghiandola nettarifera
inserita sulla base di una scaglia portata sul rachide di un amento.
Il latino "salix" risale a una radice indoeuropea con alternanza *səlik (in
latino), *selik (nel greco ἑλίκη helíkē), *sol(i)k nell'area germanica (antico
alto tedesco "salaha", tedesco "Salweide", anglosassone "sealh"); la voce latina
è collegata anche con l'irlandese "sail" e con il basco "saliga", ed è fatta
risalire al sanscrito "saras", "acqua" ("sarit", "fiume", e "sarami", "scorro")
perchè il salice ne richiede parecchia; da questa radice deriverebbe anche la
parola "sale". Nei dialetti italiani il nome della pianta è perlopiù derivato
dall'accusativo salicem (salice è un latinismo ormai desueto) e spesso in forma
femminile: abruzzese "sàucia", laziale "sarcia" o "sàucia", elbano "salgo",
pitiglianese "la salce"; il ligure ha il maschile "saxo". In area romanza, da
saliceus derivano il bolognese "salìz", il francese "saule", il provenzale "saletz";
dalla forma tarda *salicārius il catalano "salguer", il portoghese "salgueiro",
lo spagnolo "salguera", il veneziano "salghèr", il friulano "salgàr" (da cui il
cognome del grande Emilio Salgari, nato a Verona); da *salicum il rumeno "sargǎ",
il guascone "saligo" e lo spagnolo "sarga".
Passiamo ai cenni storici. Le foglie e la corteccia del salice sono già
menzionate in antichi testi provenienti da Assiria, Sumeria ed Egitto. I semi
dell'albero Haluppu erano raccomandati nella narrativa sumerica come trattamento
per l'infertilità, e l'"albero Haluppu" è stato variamente identificato con
quercia, pioppo o salice. L'antico Papiro Ebers menziona il salice (di specie
incerta) in tre rimedi. Uno, come parte di un'elaborata ricetta per un
cataplasma per "rendere flessibile il met" (il significato di "met" è incerto,
ma potrebbe avere a che fare con il sistema nervoso). Il secondo fa parte di un
trattamento per la "grande debolezza", quando il "giunco del salice verde" è
combinato con pane fresco, erbe di campo, fichi, uva e vino. Infine veniva
utilizzato in un miscuglio di "carne grassa, fichi, datteri, incenso, aglio e
birra dolce" per mettere in ordine il cuore. Nell'antica Grecia il medico
Ippocrate di Coo scrisse delle sue proprietà medicinali nel V secolo a.C.
L'autore romano Aulo Cornelio Celso cita il salice una sola volta: le foglie,
pestate e bollite nell'aceto, dovevano essere utilizzate come cura per il
prolasso uterino, ma non è chiaro quale ne fosse l'azione terapeutica; è
improbabile che sia stato un sollievo dal dolore, poiché ha raccomandato la
cauterizzazione nel paragrafo successivo.
Il medico e botanico inglese Nicholas Culpeper (1615-1654), vissuto agli albori
della scienza moderna, in "The Complete Herbal" suggerisce molti usi del salice,
tra l'altro per tamponare le ferite, per "trattenere il calore della lussuria"
e come diuretico, ma non fa menzione di eventuali presunte proprietà analgesiche.
La sua raccomandazione di utilizzare le ceneri bruciate della corteccia di
salice, mescolate con aceto, per "portare via verruche, duroni e carne
superflua", sembra corrispondere agli usi moderni dell'acido salicilico. Il
medico e naturalista William Turner (1508-1568), da non confondere con l'omonimo
pittore dell'ottocento, si concentrò sulla capacità delle foglie e della
corteccia di "resistere a tutti i flussi di sangue", se bollite nel vino e
bevute, ma aggiunge un trattamento per la febbre, dicendo: "i rami verdi con le
foglie possono benissimo essere portati nelle camere e sistemati sui letti di
coloro che sono malati di febbre, poiché raffreddano potentemente il calore
dell'aria, il che è un meraviglioso ristoro per i malati." Nel 1763 il reverendo
Edward Stone (1702-1768) inviò una lettera alla Royal Society descrivendo i suoi
esperimenti con la corteccia polverizzata di salice bianco (Salix alba): egli
aveva notato che la corteccia di salice aveva un sapore amaro, come la
"corteccia peruviana" (la china), che era usata per curare le febbri, e ipotizzò
che il salice avrebbe avuto un effetto simile. Per diversi anni lo testò su una
cinquantina di pazienti e lo trovò molto efficace. Sebbene il rimedio di Stone
sia stato sperimentato da altri in quell'epoca, non fu mai adottato
ufficialmente dai medici. Durante la Guerra civile americana, tuttavia, le forze
confederate sperimentarono anche il salice come cura per la malaria, senza
successo.
Nel suo celeberrimo romanzo "L'Isola Misteriosa" (1875), Jules Verne (1828-1905)
descrisse lo stato delle conoscenze scientifiche riguardanti gli usi medicinali
del salice quando uno dei suoi personaggi, Herbert Brown, era in gravi
condizioni a causa della febbre alta indotta da una ferita da arma da fuoco. Nel
romanzo, Herbert viene trattato con corteccia di salice in polvere senza alcun
effetto e viene salvato quando il misterioso Capitano Nemo gli fa avere una
scatola di chinino. È chiaro nel romanzo che le cause delle febbri erano poco
conosciute e non vi è alcun suggerimento di possibili effetti analgesici
derivanti dall'uso del salice.
La prima prova duratura che il salicilato, derivato dal salice e da altre specie
vegetali, potesse avere reali usi medicinali arrivò nel 1876, quando il medico
scozzese Thomas John MacLagan (1838-1903) sperimentò con notevole successo la
salicina come trattamento per i reumatismi acuti. Nel frattempo, gli scienziati
tedeschi avevano provato l'acido salicilico sotto forma di salicilato di sodio,
con meno successo ed effetti collaterali più gravi. Il trattamento della febbre
reumatica con la salicina ottenne gradualmente una certa accettazione negli
ambienti medici. Intanto la scoperta dell'acetanilide diede origine a una mania
di "acetilazione", in cui i chimici sperimentarono l'aggiunta di un gruppo
acetilico a vari composti organici aromatici. Nel 1853 il chimico Charles
Frédéric Gerhardt (1816-1856) trattò per la prima volta il salicilato di sodio
con cloruro di acetile per produrre acido acetilsalicilico. Più di 40 anni dopo,
nel 1897, Felix Hoffmann (1868-1946) sintetizzò lo stesso acido a partire dalla
pianta Spiraea, e nel 1899 scoprì il suo effetto analgesico. Questo acido fu
battezzato "Aspirina" dal datore di lavoro di Hoffmann, l'industria Bayer AG.
Contrariamente a quanto si crede di solito, la scoperta dell'aspirina è quindi
solo indirettamente collegata al salice.
Alla fine degli anni '90 del secolo scorso, l'antropologo Daniel Moerman (1941-)
descrisse molti usi del salice da parte dei nativi americani, che in tutte le
Americhe ne usavano la corteccia per curare disturbi come mal di gola e
tubercolosi, e affermò inoltre che "Diversi riferimenti menzionano la corteccia
di salice da masticare come analgesico per mal di testa e altri dolori,
apparentemente un presagio dello sviluppo dell'aspirina alla fine del 1800."
Gli usi erboristici del salice sono continuati fino ai tempi moderni. All'inizio
del XX secolo la naturalista inglese Maud Grieve (1858-1941) descrisse l'uso
della corteccia e della radice polverizzata del salice bianco per le sue qualità
toniche e astringenti e ne raccomandò l'uso nel trattamento di dispepsia, vermi,
diarrea cronica e dissenteria. Come altri erboristi, non fece menzione del fatto
che avesse alcun effetto analgesico, nonostante il già diffuso uso dell'aspirina
al suo tempo, e ne considerava il tannino il principio attivo. Solo molto tempo
dopo l'invenzione dell'aspirina è emersa l'idea che la corteccia di salice fosse
un efficace antidolorifico, e si è diffusa la falsa convinzione che il salice
contenga effettivamente aspirina. Oggi molti documentari, libri e articoli
ripetono l'affermazione secondo cui gli antichi usavano il salice per alleviare
il dolore, e numerosi prodotti a base di salice possono essere acquistati per
questo scopo, con i soliti alti profitti a vantaggio dei furbastri. La ricerca
moderna però suggerisce che solo l'effetto analgesico più lieve potrebbe essere
derivato dall'uso dell'estratto di salice, e anche questo potrebbe essere dovuto
tanto ai flavonoidi e ai polifenoli quanto all'acido salicilico.
É invece certo che alcuni dei primi oggetti fabbricati dall'uomo furono
realizzati con il salice: una rete da pesca in salice risale all'8300 a.C.!
Cestini, nasse, trappole per pesci, recinti di canniccio e muri di canniccio e
fango erano spesso realizzati in vimini, cioè con i rami giovani e flessibili di
alcune specie di salici, decorticati e adatti per lavori d'intreccio (prima di
utilizzarli è necessario ammorbidirlo mettendolo in ammollo). Anche il vimine ha
una lunga storia, documentata dagli archeologi: il colle Viminale, uno dei sette
colli di Roma, deriva il suo nome dalla parola latina per vimini, !viminia"! Il
legno di salice è utilizzato nella fabbricazione di scatole, scope, mazze da
cricket, assi delle culle, sedie, bambole, pali, manici di utensili,
impiallacciatura di legno, bacchette, flauti e fischietti. Inoltre, dal legno
possono essere prodotti tannino, fibra, carta, corda e spago. Sono stati
effettuati numerosi esperimenti e modelli matematici sull'utilizzo dei salici
per biomasse o biocarburanti, a causa della loro rapida crescita. Un tempo i
poveri mangiavano spesso amenti di salice cotti per formare un purè. La
corteccia interna può essere consumata cruda o cotta, così come le foglie
giovani e i germogli sotterranei. Il salice può essere coltivato per produrre
carbone. Sono state condotte interessanti ricerche sull'eventuale utilizzo dei
salici per la futura biofiltrazione delle acque reflue al fine della bonifica
dei terreni, anche se ciò per ora non è commercialmente conveniente. Sono
utilizzati per la stabilizzazione degli argini (bioingegneria), dei pendii, per
il controllo dell'erosione del suolo, come cintura frangivento e per favorire
l'habitat della fauna selvatica. I salici sono spesso piantati ai margini dei
corsi d'acqua, in modo che le loro radici intrecciate possano proteggere la riva
dall'azione dell'acqua.
Sorprendentemente, durante la seconda guerra mondiale i salici erano un
materiale strategico per l'esercito britannico. Tutto ciò che veniva lanciato
dai paracadute veniva fatto cadere in ceste, leggere e resistenti: potevano
essere realizzate in qualsiasi forma e rimbalzare al momento dell'impatto. La
produzione britannica di salici era di circa 2000 tonnellate all'anno da parte
di circa 630 produttori che impiegavano 7000 cestai. Lawrence Ogilvie
(1898-1980), patologo delle piante che aveva studiato e scritto la sua tesi di
laurea magistrale all'Università di Cambridge degli anni '20 sulle malattie del
salice, è considerato il maggior esperto di tutti i tempi dei salici e le loro
malattie.
Nel mondo dell'arte, il salice viene utilizzato per realizzare carboncini per
disegnare e sculture viventi, intrecciate a partire da rami di salice vivo in
forme come cupole e tunnel. Gli steli di salice sono usati per intrecciare cesti
e sculture tridimensionali di animali e altre figure, ma anche per fabbricare
elementi decorativi da giardino, come pannelli e obelischi. Il salice è un
soggetto famoso nelle opere di molti pittor dell'Estremo Oriente, in particolare
nei dipinti a penna e inchiostro provenienti dalla Cina e dal Giappone.
Venendo alle religioni, nel buddismo un ramo di salice è uno degli attributi
principali di Kwan Yin, il bodhisattva della compassione. Il salice è una delle
quattro specie associate alla festa ebraica di Sukkot o Festa dei Tabernacoli,
citata in Levitico 23,40: i rami di salice sono usati durante il servizio della
sinagoga per Hoshana Rabbah, il settimo giorno di Sukkot (Aravah è il nome
ebraico del salice). Le chiese cristiane dell'Europa nordoccidentale,
dell'Ucraina e della Bulgaria usavano spesso rami di salice al posto delle palme
nelle cerimonie della Domenica delle Palme. Secondo una nota leggenda, i soldati
romani strapparono i rami di un salice per flagellare Gesù, e da allora
l'albero, addolorato, si trasformò in un salice piangente. In Cina molte persone
portano con sé rami di salice nel giorno della pulizia delle tombe o del
Festival di Qingming; i rami di salice sono messi su cancelli e porte d'ingresso
delle case dei cinesi, i quali credono che aiutino a scongiurare gli spiriti
maligni che vagano durante tale festa, vagamente simile ad Halloween. Una
leggenda macabra afferma che, durante il Festival di Qingming, il sovrano degli
inferi permette agli spiriti dei morti di tornare sulla terra, e poiché la loro
presenza potrebbe non essere sempre gradita, i rami di salice li tengono
lontani. Nelle immagini tradizionali della dea della misericordia Guanyin, essa
viene spesso mostrata seduta su una roccia con un ramo di salice in un vaso
d'acqua al suo fianco. La Dea utilizza quest'acqua e il ramo per mettere in fuga
i demoni. Le sacerdotesse taoiste usano anche un piccolo intaglio in legno di
salice per comunicare con gli spiriti dei morti: l'immagine viene inviata negli
inferi, dove si ritiene che lo spirito disincarnato vi penetri e fornisca le
informazioni desiderate ai parenti sopravvissuti al suo ritorno. Una gisaeng
(geisha coreana) di nome Hongrang, che visse al tempo della dinastia Joseon
(1392-1897), scrisse la poesia "Presso il salice sotto la pioggia la sera", che
dedicò al suo amante in partenza: «...sarò il salice al tuo capezzale! », dice
tra l'altro.
Nella tradizione giapponese il salice è associato agli yūrei (幽霊), i fantasmi
della tradizione giapponese (da yū 幽, "evanescente", "oscuro", e rei 霊,
"anima"). Si suppone comunemente che un fantasma appaia dove cresce un salice.
"IL Salice Verde" è una storia giapponese di fantasmi in cui un giovane samurai
si innamora di una donna chiamata Salice Verde che ha uno stretto legame
spirituale con un salice. Anche nel folklore inglese il salice è considerato un
albero piuttosto sinistro, capace di sradicarsi da solo e inseguire i
viaggiatori (sarà). Forse ispirato da questa fosca leggenda, John R. R. Tolkien
(1892-1973) introduce nel suo "Legendarium" (l'universo fantasy alternativo da
lui creato) il "Vecchio Uomo Salice", appartenente alla categoria degli Ucorni,
antichissimi "alberi spirituali" (in quanto "abitati" da particolari spiriti)
che formavano la primordiale Grande Foresta di Arda (nome tolkieniano del
pianeta Terra). A partire dalla Terza Era, il Vecchio Uomo Salice dimora nella
Vecchia Foresta, al confine est della contea, lungo le sponde del fiume
Sinuosalice, ha potere sui venti e trae energia dalla terra attraverso le sue
profondissime radici. Per mezzo di un potente sortilegio, una melodia
incantatrice appena udibile nel delicato fruscio delle foglie al vento, è in
grado di indurre al sonno le malcapitate vittime, il cui destino è quello di
scomparire inglobate nel suo tronco: e questo rischia di essere anche il destino
degli Hobbit Merry, Pipino, Sam e Frodo, nel capitolo VII del primo libro de "La Compagnia
dell'Anello" (primo volume del "Signore degli Anelli"). L'' con il potere
sufficiente ad opporglisi è Tom Bombadil, che infatti costringe il Vecchio Uomo
Salice a lasciarli liberi per continuare il loro viaggio. Quanto a Tom Bombadil,
egli viene chiamato anche Iarwain Ben-adar, ossia "il Più Anziano e Senza
Padre"; e alla domanda di Frodo « Messere, chi sei? », egli così risponde, in
maniera a dir poco enigmatica: « Il più anziano, ecco chi sono. Ricordate,
amici, quel che vi dico: Tom era qui prima del fiume e degli alberi; Tom ricorda
la prima goccia di pioggia e la prima ghianda... Era qui prima dei Re e delle
tombe e degli Spettri dei Tumuli. Quando gli Elfi emigrarono a ovest, Tom era
già qui, prima che i mari si curvassero; conobbe l'oscurità sotto le stelle
quand'era innocua e senza paura: prima che da Fuori giungesse l'Oscuro Signore.
» Tolkien non ha mai fornito chiarimenti riguardo alla sua esistenza, salvo
affermare che egli nacque da un gioco di suo figlio Michael, e solo in un
secondo momento venne inserito nel Legendarium, alla cui struttura mitologica
però appare abbastanza estraneo. Sicuramente non è un elfo, pur essendo dotato
di una vita così lunga; potrebbe essere uno degli Istari, cioè degli stregoni
come Gandalf e Saruman (di solito si dice che essi sono cinque, ma nei "Racconti
Incompiuti" si fa cenno al fatto che ve ne potrebbero essere altri), o uno dei
Valar in incognito che ha preso forma umana (forse Oromë, il Vala che più di
tutti amava la Terra di Mezzo e le foreste), o ancora una creatura unica,
superstite di una razza più antica di tutte tra i Figli di Ilúvatar. Simpatica,
ma poco credibile, la proposta, avanzata da alcuni fan, che Tom sia una
rappresentazione letteraria dello stesso Tolkien. Altre ipotesi stravaganti
sostengono che Bombadil rappresenti Väinämöinen, protagonista del poema
nazionale finlandese "Kalevala" (ma questa deità creatrice è stata identificata
con vari personaggi del Legendarium) oppure Adam Kadmon, figura del misticismo
ebraico che rappresenta una sorta di centro antropocentrico del cosmo e di
"Eletto" dotato di straordinari poteri, in quanto primo tra gli uomini. Le
parole della sua sposa Baccador (« Tom Bombadil è Signore ») e il fatto che Tom
Bombadil sia « senza Padre » rendono convincente piuttosto l'ipotesi che egli
sia addirittura un'ipostasi di Ilúvatar in persona, cioè del Dio
giudeo-cristiano; lo stesso Tolkien comunque lascia volutamente quest'essere
avvolto da un alone di mistero. Lo stesso che sembra avvolgere la chioma del
salice e la sua magia!

Maestoso esemplare di salice piangente da me fotografato sulla riva del Lago Maggiore presso Locarno
L'albero
che costò caro a Sigfrido
E ora, dietro richiesta di
Guido Borghi, vi parlerò del tiglio. Tilia è un genere di
circa 30 specie di alberi o arbusti, diffuso nella maggior parte dell'emisfero
settentrionale temperato., ma la
più grande diversità di specie si trova in Asia. In cinese, "椴/duàn" o "椴樹/duànshù"
è un termine generico per tutte le specie di Tilia. Questo genere è stato
inizialmente inserito nella famiglia delle Tiliacee, ma la ricerca genetica
eseguita dall'Angiosperm Phylogeny Group ha
portato all'incorporazione di questo genere nelle Malvacee. Come per i salici e
per altre piante di alto fusto,
il numero esatto di specie del genere è incerto, poiché molte specie possono ibridarsi
facilmente sia in natura che coltivate. I tigli sono per lo più grandi alberi decidui, che raggiungono in genere
da 20 a 40 m di altezza, e alla loro base si sviluppano frequentemente numerosi
polloni.
Il robusto tronco dei tigli si erge come un pilastro e i rami si suddividono in numerose ramificazioni su cui i rametti sono fini e fitti. In
estate questi sono abbondantemente rivestiti di grandi foglie e il risultato è
una fittissima chioma verdissima di foglie asimmetriche a forma
di cuore che misurano da 6 a 20 cm. Le infiorescenze sono protette da una
brattea fogliacea ovoidale di colore verde-pallido, che rimane
nell'infruttescenza e come un'ala agevola il trasporto a distanza dei frutti.
Questi sono dei minuscoli piselli con la superficie pelosa e con un endocarpo
legnoso e resistente, chiamata carcerulo. Tutte le specie di tiglio possono essere propagate
per talea e innesto, oltre che per seme, ma sono notoriamente difficili da
propagare dai semi, a meno che non vengano raccolti freschi in autunno. Se
lasciati essiccare, i semi entrano in una profonda dormienza e impiegano 18 mesi
per germogliare. Crescono rapidamente in terreni ricchi, ma sono soggetti
all'attacco di molti insetti.
In particolare, gli afidi sono attratti dalla ricca riserva di linfa, e sono a
loro volta spesso "allevati" dalle formiche proprio per la produzione della linfa,
di cui
le formiche vanno ghiotte, e il risultato può spesso essere uno
sgocciolamento di linfa in eccesso sui rami e sulle foglie inferiori e su
qualsiasi altra cosa sottostante. Le auto lasciate sotto gli alberi possono
rapidamente ricoprirsi di una pellicola di melassa dolciastra lasciata cadere
dai rami, anche se il processo di "allevamento" degli afidi da parte
delle formiche non sembra causare
gravi danni agli alberi.
Tilia è anche l'' genere ectomicorrizico conosciuto nella famiglia delle Malvacee;
ciò significa che i tigli vivono con un'ampia gamma di simbionti fungini, con
una preferenza particolare verso i partner fungini Ascomycota. I tigli sono
utilizzati come piante alimentari dalle larve di alcuni lepidotteri.
Il latino tilia è affine al greco πτελέᾱ, ptelea, "olmo",
che deriva dalla radice proto-indoeuropea *ptel-ei̯ā
con il significato di "ampio"; da qui anche il latino "latus" e quindi
il termine "latifoglie". Alcuni però affermano che il nome del genere deriva dal greco πτιλον ptilon,
"ala", per la
caratteristica brattea fogliacea che facilita la disseminazione anemocora dei
grappoli di frutti. In inglese il nome dell'albero è "lime" o "linden",
dall'inglese antico lind o linde, dal proto-germanico *lindō, affine al latino "lentus", "flessibile",
e al sanscrito "latā", "liana". Nella famiglia delle lingue germaniche, l'inglese "lithe"
e l'olandese e il tedesco "lind" per "indulgente, arrendevole" derivano dalla stessa
radice.
Fossili di tiglio sono stati trovati nelle formazioni terziarie di Grinnell Land,
in Canada, a 82°N di latitudine, e nelle Svalbard, in Norvegia.
In Europa alcuni tigli hanno raggiunto età considerevoli. Si stima che un bosco
ceduo di Tilia cordata nel Westonbirt Arboretum del Gloucestershire abbia 2000
anni. Nel cortile del Castello Imperiale di Norimberga si trova un tiglio
che, secondo la tradizione, fu piantata intorno al 1000 dall'imperatrice Santa Cunegonda
di Lussemburgo (975-1033),
moglie di Enrico II di Germania (973-1024). Il tiglio di Naters, in Svizzera, è citato in un documento del 1357 e
descritto dall'autore dell'epoca come già altissimo; una lapide ai suoi piedi
ricorda che nel 1155 in questo punto esisteva già un tiglio. Accanto al Tempio Yinghua nella Città Proibita di
Pechino ci sono due alberi di tiglio piantati circa cinquecento anni fa dall'Imperatrice Vedova Li, la
madre dell'Imperatore Wanli (1563-1620).
Il tiglio di Eminescu (in rumeno "Teiul lui Eminescu") è un tiglio di
500 anni cresciuto a Iași, in Romania: Mihai Eminescu (1850-1889), il più
noto poeta rumeno di tutti i tempi, avrebbe
scritto alcune delle sue migliori opere sotto questo albero, facendolo diventare
uno dei monumenti naturali più importanti della città di Iași e di tutta la
Romania.
Il tiglio è consigliato come albero ornamentale quando si desidera una grande massa di
fogliame o un'ombra profonda. Produce fiori profumati ed è
un'importante pianta mellifera per gli apicoltori, che dà origine a un miele
monofloreale pallido ma riccamente aromatizzato; famoso è il miele di tiglio dei
Monti Iblei, in Sicilia. In Cina, il miele di tiglio prodotto nella regione
nord-orientale viene chiamato "miele bianco" o "miele delle nevi" per il suo
colore. Nella fitoterapia europea e nordamericana i fiori sono utilizzati anche
per tisane e tinture. I fiori sono usati per le tisane in inverno in Grecia e
Turchia. I fiori essiccati sono leggermente dolci e appiccicosi e il frutto è
piuttosto dolce e mucillaginoso. In Cina i fiori essiccati di tiglio sono usati
anche per preparare un tè dal gusto gradevole, dovuto
all'olio volatile aromatico presente nei fiori. I fitochimici nei fiori di Tilia
includono flavonoidi e tannini con proprietà astringenti. Il decotto di
corteccia dei giovani rami raccolto in primavera ha proprietà astringenti,
utilizzato come clistere per la cura di diarree e infezioni intestinali.
L'infuso, la tisana e lo sciroppo dei fiori con le brattee, raccolti in
giugno-luglio e fatti seccare all'ombra, vantano proprietà anticatarrali,
bechiche, sudorifere, emollienti, antispasmodiche, vasodilatatrici e calmanti
nei confronti degli stati d'ansia. Da alcune specie di tiglio si ricavano
persino dei profumi.
Nei giardini paesaggistici inglesi, i viali di tigli erano di moda soprattutto
tra la fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo. Molte antiche case di campagna hanno
un "viale dei tigli": ad esempio quello della Hatfield
House fu piantato tra il 1700 e il 1730. Questa moda derivava dalla pratica di piantare tigli in
lunghi filari in Germania, Paesi Bassi,
Belgio e Francia settentrionale per fornire ombra e frescura. La maggior parte degli alberi utilizzati nei
giardini britannici erano cultivar provenienti dai Paesi Bassi.
I tigli producono legname tenero e facilmente lavorabile, che ha pochissima
grana e una densità di 560 kg/m3. Era spesso usato dalle tribù germaniche
per costruire scudi; in Germania è stato il classico legno per le
sculture dal Medioevo in poi, ed è il materiale usato per elaborate pale
d'altare. In Inghilterra fu il legno
preferito dallo scultore Grinling Gibbons (1648–1721). Il legno di tiglio è
anche il materiale preferito per tapparelle e persiane. Il legno di tiglio è utilizzato
ancor oggi anche nella fabbricazione e nell'intaglio di marionette e burattini,
avendo una grana
fine ed essendo relativamente leggero. In Cina è stato ampiamente
utilizzato anche per intagli o mobili, decorazioni di interni ed opere di
artigianato.
La facilità di lavorazione e le buone proprietà acustiche rendono il legno di
tiglio molto usato per le chitarre elettriche, i bassi e per
gli strumenti a fiato come i flauti dolci. I produttori di percussioni a volte
usano il legno di tiglio come materiale per i fusti della batteria, sia per
migliorare il loro suono che per la loro estetica.
In Cina il fungo Sarcomyxa edulis, chiamato "dongmo" nel Paese di Mezzo, cresce bene sui tronchi in decomposizione degli alberi di
tiglio nelle foreste secolari; pertanto i tronchi degli
alberi di tiglio sono usati per coltivare funghi con ottimi risultati.
Dalla corteccia fibrosa interna dell'albero di tiglio si può ricavare una
fibra resistente: si stacca la corteccia e la si immerge in
acqua per un mese, dopodiché le fibre interne possono essere facilmente
separate. La rafia ottenuta dall'interno della corteccia dell'albero Tilia
japonica è stata utilizzata dall'antichissimo popolo Ainu del Giappone
settentrionale per tessere i loro
abiti tradizionali, gli "attus". Gli scavi archeologici in Gran Bretagna hanno dimostrato che
la fibra di tiglio era la preferita per confezionare capi di abbigliamento durante l'età del
bronzo. Il popolo Manciù nelle montagne della Cina nord-orientale fabbricava
corde, ceste, impermeabili e grandi reti da pesca dalla rafia di tiglio.
E ora, come sempre, parliamo un po' della complessa simbologia di quest'albero
così caro agli uomini. Cominciamo dalla
mitologia greca.
Omero, Orazio, Virgilio e Plinio citano il tiglio e le sue virtù. Nell'ottavo
libro delle sue "Metamorfosi", Publio Ovidio
Nasone (43 a.C.-18 d.C.) racconta la storia di Filemone e Bauci: un giorno Zeus
ed Hermes, attraversando la Frigia con sembianze umane, cercarono ospitalità a
mille porte, ma i soli che li accolsero furono Filemone e Bauci, una coppia di
anziani che viveva in una povera capanna costruita con canne e fango. La coppia
si offrì di lavare i piedi ai viaggiatori, e diede poi loro da mangiare il loro
pranzo. Dopo il pranzo gli déi condussero Filemone e Bauci sopra un'alta
montagna vicina alla capanna e venne loro comandato di non guardarsi mai
indietro: quando lo fecero, videro la città sommersa da un lago tranne la loro
povera capanna, che venne trasformata in un tempio maestoso. Zeus, grato, si
offrì di esaudire qualunque loro desiderio, ma Filemone e Bauci chiesero solo di
diventare sacerdoti del tempio di Zeus e di poter morire insieme. Dopo aver
vissuto ancora molti anni, i due coniugi furono infine trasformati in alberi:
Filemone in una quercia e la moglie Bauci proprio in un tiglio, uniti per il
tronco.
Erodoto dice: «
Gli indovini sciti prendono la foglia del tiglio e, dividendola in tre
parti, se le attorcigliano intorno alle dita; poi le sciolgono ed esercitano
l'arte divinatoria ». Inoltre
Filira, madre del centauro Chirone, si trasformò in un tiglio dopo aver
partorito il centauro sapiente, precettore di déi ed eroi, per la vergogna di
aver partorito un essere mezzo uomo e mezzo cavallo dopo lo stupro da parte di
Poseidone, cui il cavallo era sacro (tale mito è ripreso da John Updike
(1932-2009) nel suo romanzo "Il centauro" (1963).
Il tiglio era un albero altamente simbolico e sacro anche per i popoli
germanici.
In origine le comunità norrene si riunivano non solo per festeggiare e ballare
sotto un tiglio, ma anche per tenervi le lorosedute al fine di
ristabilire la giustizia e la pace, poiché si credeva che l'albero avrebbe
aiutato a portare alla luce la verità. Così l'albero fu associato alla
giurisprudenza anche dopo la cristianizzazione, ce i verdetti
nella Germania rurale furono spesso pronunciati "unter der linden" (sotto un
tiglio) fino
all'età dell'Illuminismo.
Il Nibelungenlied ("Canzone dei Nibelunghi") è la più importante opera
letteraria tedesca medievale basata sulla
tradizione orale che raccontava eventi capitati alle tribù germaniche nel V e VI secolo
(alcuni personaggi sono storici, come il re burgundo Gunther, il re ostrogoto
Teodorico e il Khan degli Unni Attila). In esso l'eroe
Sigfrido ottiene l'invulnerabilità bagnandosi nel sangue del drago Fáfnir da lui
ucciso, ma durante il bagno una foglia di tiglio gli si posò sulla schiena, lasciando una
zona del suo corpo non toccata dal sangue, che risultò il suo ' punto vulnerabile,
analogamente al tallone di Achille. Sigfrido rivelò questo segreto alla moglie
Crimilde, sorella di Gunther, e il traditore Hagen la convinse ad indicargli
questo punto, con la scusa di proteggerlo in ogni modo, ed invece d'intesa con
Gunther lo uccise colpendolo proprio in quel punto. Crimilde si vendicò sposando
in seconde nozze Attila ed istigandolo ad uccidere Hagen e Gunther.
Nel folklore tedesco il tiglio è "l'albero degli innamorati": il noto poema
dell'alto tedesco medio "Sotto il tiglio" di Walter von der Vogelweide (1200
circa) descrive un appuntamento tra una servetta e un cavaliere sotto un
tiglio.
La strada più importante di Berlino, che conduce dal centro di Berlino a Potsdam,
la residenza di campagna dei re prussiani, si chiama Unter den Linden, dal nome
degli alberi che fiancheggiano il viale.
Hohenlinden ("Alto tiglio") è una cittadina nel distretto bavarese di Ebersberg in cui
il 3 dicembre 1800 ebbe luogo la battaglia di Hohenlinden durante le Guerre
rivoluzionarie francesi. In essa le truppe austro-bavaresi al comando del
diciottenne arciduca Giovanni d'Asburgo-Lorena e del generale Esterházy
affrontarono l'armata francese del Reno al comando del generale Jean Victor
Marie Moreau nei pressi di questa località, ma rimediarono una sonora sconfitta
e furono costrette all'armistizio.
Lo stemma di Mariehamn, capoluogo delle Isole Åland, parte della Finlandia pur
essendo quasi interamente abitata da svedesi, contiene ancor oggi tre foglie di
tiglio, albero un tempo considerato sacro in quell'arcipelago. Si pensi che in Svezia, dove il tiglio si chiama "Lind", i 100 cognomi più comuni nel 2015
includevano al 17° posto Lindberg ("montagna del tiglio"), al 21° Lindström ("ramoscello
di tiglio"), al 22° Lindqvist ("ramo di tiglio"), al 23° Lindgren (altra
versione di "ramo di tiglio), e al 99° Lindholm ("isola
del tiglio")!
Veniamo all'antica mitologia slava. In essa il tiglio ("lipa", come viene
chiamato in tutte le lingue slave) era considerato un albero sacro. In particolare in Polonia molti villaggi hanno
il nome "Święta Lipka" che letteralmente significa "Tiglio
Sacro".
Ancor oggi il tiglio è uno degli emblemi nazionali di Repubblica Ceca, Slovacchia,
Slovenia e Lusazia. Nel mondo cristiano ortodosso slavo, il
legno di tiglio era il legno preferito per la pittura di icone su tavola. Le
icone del grande Andrej Rublëv (1360-1430), tra cui la "Santissima Trinità", ora nella Galleria Statale Tretyakov di Mosca, sono
dipinte su legno di tiglio: il suo legno è stato scelto per la sua capacità di
essere levigato molto liscio e per la sua resistenza alla deformazione una volta
stagionato. Dalla parola "Lipa" deriva il nome slavo
tradizionale del mese di giugno (in croato "lipanj") o luglio (in polacco "lipiec",
in ucraino "lypen'/липень"). È anche la radice della città tedesca di Lipsia,
che deriva
dal suo nome sorabo Lipsk. Il villaggio sloveno di "Lipica" significa
"piccolo
tiglio" e ha dato il nome alla celebrata razza di cavalli lipizzani. L'ex valuta croata, la kuna,
andata fuori corso il 14 gennaio 2023 in seguito all'adozione dell'euro da parte
di Zagabria, era suddivisa in 100 lipa. Il nome"Lipa" fu anche proposto
nel 1990 per la valuta slovena dopo l'indipendenza del paese dalla Jugoslavia, ma
alla fine prevalse il nome "tolar" (Tallero), andato a sua volta
fuoricorso il 14 gennaio 2007 dopo l'adozione dell'euro da parte di Lubiana.
Nella mitologia baltica la dea del destino è chiamata Laima e il suo albero sacro è il tiglio. La dimora di Laima
infatti era un tiglio, dove
ella prendeva le sue decisioni; per questo le donne lituane pregavano
e facevano sacrifici sotto i tigli chiedendo fortuna e fertilità, parlando con loro come se fossero esseri umani.
E veniamo alla Cina. Siccome nel nord della Cina non cresce l'albero Bodhi,
l'albero sacro del buddismo, siccome la forma delle foglie di tiglio è simile a
quella dell'albero Bodhi, molto tigli sono stati piantati nei templi per
sostituire l'albero sacro. L'imperatore Qianlong (1711-1799) della dinastia Qing scrisse
ben due poesie dedicate ai tigli del Tempio Yinghua nella Città Proibita di
Pechino, già citati sopra, le scolpì su tavolette di
pietra e le collocò nel padiglione di fronte al tempio.
Veniamo alla letteratura. Come raccontano le Guide Turistiche dell'Associazione Ippogrifo, che raggruppa professionisti delle città venete, ai tempi di Dante
nel giardino privato dei Della Scala, in piazza Viviani a Verona, sorgeva un
maestoso tiglio, ed il Sommo Poeta amava meditare e studiare all'ombra di quell'albero,
ospite dell'amico Cangrande, cui avrebbe dedicato il suo "Paradiso". Fino agli
anni '60 del secolo scorso gli anziani veronesi lo chiamavano "il tiglio di
Dante".
Molte delle brevi poesie ("Fraszki") del poeta rinascimentale polacco Jan Kochanowski
(1530-1584) sono dedicate al tiglio. Il suo "Na Lipę" ("All'albero
di tiglio"), pubblicato nel 1584, è stato
ispirato da un albero da lui molto amato nella sua tenuta di campagna a Czarnolas.
Kochanowski contemplava, riposava e scriveva alla sua ombra, offriva ristoro
agli ospiti sotto la sua chioma, e questi momenti sono tutti rappresentati nella
sua poesia.
Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) presentò il tiglio come un simbolo centrale nella sua
poesia "This Lime-Tree Bower My Prison" pubblicata per la
prima volta nel 1800.
Una poesia dal ciclo di poesie "Winterreise" del tedesco Wilhelm Müller
(1794-1827) si chiama "Der
Lindenbaum" ("L'albero di tiglio"). Nel 1827 Franz Schubert
(1797-1828) scrisse il famoso ciclo di
canzoni "Winterreise" basato su queste poesie. Nel romanzo "La
Montagna Incantata" (1924) di Thomas
Mann (1875-1955), una registrazione di questo ciclo di canzoni è un'importante pietra di paragone filosofica
all'interno della sua complessa trama.
Il racconto "L'elfo della rosa" di Hans Christian Andersen (1805-1875) menziona un
tiglio e le sue foglie.
Nella fiaba dei fratelli Grimm Il principe ranocchio, la principessa lascia
cadere la sua palla d'oro nello stagno mentre è seduta sotto un tiglio. Ne "I
dolori del giovane Werther" (1774) di Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) il
protagonista è sepolto sotto il suo amato albero di tiglio dopo il suo suicidio.
Ne "La via di Swann", il primo libro di "Alla ricerca del tempo perduto" di
Marcel Proust (1871-1922), il narratore intinge una tortina in una tazza di tè ai fiori di tiglio.
L'aroma e il gusto della torta e del tè innescano il suo primo ricordo
involontario cosciente.
"I tre tigli" è una fiaba del 1912 di Hermann Hesse (1877-1962) fortemente influenzata dalla
leggenda greca di Damone e Pizia. raccontata da Cicerone e Diodoro Siculo: la
fiaba, ambientata nel periodo medievale, cerca di spiegare tre enormi tigli i
cui rami si intrecciano fino a ricoprire l'intero cimitero dell'Ospedale dello
Spirito Santo a Berlino. Il grande John R. R. Tolkien (1892-1973) compose il poema
"Light as Leaf on Lindentree", originariamente
pubblicato nel 1925 nel volume 6 della rivista "The Gryphon". Dopo molti
rimaneggiamenti esso fu incluso ne "Il Signore degli Anelli" sotto forma di una
canzone cantata da Aragorn sulla meravigliosa storia d'amore di Beren e Lúthien.
Il compositore britannico
Ralph Vaughan Williams (1872-1958) scrisse nel 1900 la sua prima canzone "Linden Lea".
Infine, il titolo della canzone del gruppo moldavo O-Zone "Dragostea din Tei",
divenuta il tormentone estivo del 2004 nonostante sia cantata in lingua rumena,
significa letteralmente "amore sotto il tiglio", espressione idiomatica che in
Moldavia corrisponde a "amore a prima vista" o "amore non corrisposto". Chi non
ricorda il suo trascinante ritornello? « Nu mă, nu mă iei, nu mă, nu mă, nu mă
iei », cioè « non mi, non mi prendi [con te], non mi, non mi, non mi prendi [con
te] »...

Il Viale dei Tigli a Gallarate, dove si trova il Liceo in cui insegna l'autore di questo sito
Il
guscio che racchiude l'universo
Passiamo al
noce. Juglans regia (noce da frutto o noce bianco)
è un grande albero a foglie decidue, che raggiunge 200 anni di età ed altezze di
25-35 metri e il cui tronco raggiunge i 2,5 m di diametro. Di solito presenta un
tronco corto e un'ampia chioma. La corteccia è liscia, bruno-olivastra quando è
giovane e grigio-argentea sui rami più vecchi, e presenta ampie fessure sparse
con una tessitura più ruvida. Il midollo dei rametti è di colore brunastro, le
foglie sono lunghe 25–40 cm, disposte alternativamente; i fiori maschili sono
riuniti in amenti pendenti di 5-10 cm di lunghezza, mentre i fiori femminili
sono radunati in grappoli da due a cinque, che maturano in autunno in un frutto
con una buccia verde carnosa e un nocciolo marrone dal guscio ondulato,
comunemente chiamato noce. Il frutto intero, compreso il mallo, cade in autunno;
il seme è grosso, con guscio relativamente sottile, commestibile, dal sapore
ricco. Gli alberi di noce crescono meglio in terreni ricchi e profondi con pieno
sole e lunghe estati, come le valli della California. Il noce tende a diventare
più alto e più stretto in una fitta competizione forestale; è una specie che
richiede luce e richiede il pieno sole per crescere bene. Altre piante spesso
non crescono sotto gli alberi di noce perché le foglie e le bucce cadute
contengono juglone, una sostanza chimica che agisce come un erbicida naturale. I
cavalli che mangiano foglie di noce possono sviluppare laminite, una malattia
dello zoccolo. Juglans regia è infestata da Rhagoletis juglandis, comunemente
nota come mosca del mallo di noce, che depone le uova nei malli dei frutti.
Il nome Junglas del genere deriva dal latino "glans", "ghianda", per la
somiglianza tra la sua parte terminale e il frutto della quercia. Il nome latino
del noce era nux gallica, non con riferimento alla Francia ma alla Galazia,
regione dell'Asia minore abitata da Celti che si trova sugli altopiani
all'estremità occidentale della distribuzione naturale dell'albero. Come il
francese "noix", lo spagnolo "nuez", il portoghese "noz", il rumeno "nuc", il
provenzale "notz", l'inglese "nut" e il tedesco "nusz" derivano tutte dal latino
"nux" che forse ha perduto una c iniziale ("cnux"), come mostra l'antico tedesco
"hnuz", da una radice "gn-" o "kn-", che significa "tenere insieme" (da cui
l'inglese "knot", "nodo" e il tedesco "knochen", "osso", ma anche gli italiani
"nocca" e "nuca"), visto che il guscio trattiene all'interno il gheriglio.
Quest'ultimo a sua volta viene probabilmente dal greco "karyos", "noce".Il
termine inglese antico "wealhhnutu" viene da "wealh" (straniero) e "hnutu"(noce)
quindi "la noce delle terre romane" (Gallia e Italia) distinta dalla nocciola
nativa secondo l'Oxford English Dictionary. In lingua cinese il noce è chiamato
胡桃(hú táo), che significa letteralmente "pescaHu", il che suggerisce che gli
antichi cinesi associassero l'introduzione dell'albero nell'Asia orientale con i
barbari Hu delle regioni settentrionali e nord-ovest della Cina. In Messico si
chiama nogal de Castilla, perché i nativi messicani associavano l'introduzione
dell'albero in Messico con gli spagnoli della Castiglia, al contrario delle noci
nere originarie del Nord America.
Fossili di noci del genere Juglans sono stati trovati negli strati del Cenozoico
in Nord America. Uno dei centri di origine di Juglans regia è l'Iran ma, come
per altre antiche e diffuse piante coltivate, non è facile ricostruirne la
distribuzione originaria e determinare i confini dei passati areali naturali. Ci
sono molte testimonianze riguardanti i primi pollini e noci fossili di Juglans
regia, il che suggerisce che Juglans regia sia probabilmente sopravvissuto alle
ultime glaciazioni in diversi santuari in Europa meridionale, Vicino Oriente e
Himalaya. Le maggiori foreste si trovano in Kirghizistan, a 1.000-2.000 metri di
altitudine. Nel IV secolo a.C. Alessandro Magno introdusse questa "noce
persiana" (καρυα ή Περσική come la chiamava Teofrasto) in Grecia e Macedonia,
dove si è ibridata con specie locali, dando vita ad alberi a portamento laterale
con frutti più grandi. Questi ultimi furono diffusi dai Romani nell'Europa
meridionale e nell'Africa settentrionale. Si pensa che in Cina sia stato
introdotto dall'Asia centrale circa 2000 anni fa e in alcune aree si sia
naturalizzato. La Juglans regia coltivata fu introdotta molto presto nell'Europa
occidentale e settentrionale, e nelle Americhe nel XVII secolo dai coloni
inglesi. I principali produttori mondiali sono Cina (con 2,52 milioni di
tonnellate su 4,50 totali),Stati Uniti, Iran, Turchia e Messico. Ultimamente la
coltivazione si è diffusa in altre regioni, come la Nuova Zelanda e il sud-est
dell'Australia. Viene coltivato estensivamente da 30° a 50° di latitudine
nell'emisfero boreale e da30° a 40° in quello australe. I suoi frutti di alta
qualità vengono consumati sia freschi che spremuti per il loro olio ricco di
sapore; sono state selezionate numerose cultivar con noci più grandi con gusci
più sottili.
I gherigli di noce contengono il 4% di acqua, il 65% di grassi, il 15% di
proteine e il 14% di carboidrati; forniscono vitamine del gruppo B, tiamina,
folati, fibre e diversi minerali tra cui manganese, fosforo, magnesio, zinco e
ferro; 100 grammi forniscono 654 calorie, Omega-3, acido oleico ed acido
linoleico, e dunque sono poco indicati a chi è sovrappeso. Alcuni studi
epidemiologici hanno rivelato che le persone che consumano noci abitualmente
corrono meno rischi di subire cardiopatie coronariche e che il consumo di vari
tipi di semi, tra cui le noci, può diminuire le concentrazioni del colesterolo
LDL. L'alto contenuto di arginina stimola la produzione di ossido nitrico che è
indispensabile all'elasticità dei vasi sanguigni. Le noci prevengono l'artrite e
rendono lapelle più bella. Le caratteristiche nutrizionali le rendono adatte
anche ad un consumo controllato durante il periodo della gravidanza. Però, come
tutta la frutta a guscio, sono fonti di allergeni alimentari che possono causare
gravi reazioni allergiche.Quello di noce è un legno duro, resistente e tra i più
pregiati al mondo. Il legno vivo appena tagliato può essere color senape, per
poi scurirsi fino a diventare marrone nel giro di pochi giorni. Il legname
essiccato è di un color cioccolato tendente al nero, e può presentare disegni
insoliti nella tramatura. È apprezzato dai migliori falegnami per la sua durata
e lucentezza, ed è utilizzato per parquet,chitarre, mobili, impiallacciature,
maniglie e calci di pistola. Da notare che un tipo di legno chiamato "noce
Tanganica non ha niente a che vedere conil genere Juglans, in quanto è ricavato
da una pianta del genere Pouteria chiamata Aningeria altissima, che cresce nelle
foreste umide della fascia equatoriale africana dalla Costa d'Avorio al Kenya.
La farina di gusci di noce può essere utilizzata nei composti di amido
termoplastico per sostituire i derivati del petrolio. La tribù Navajo
utilizzavano i gusci di noce per produrre una tintura marrone.
Passiamo al mondo dei simboli. La noce ha sempre rappresentato richiamo
all'organo genitale maschile per via della somiglianza della noce ai testicoli
quando è ancora avvolta dal mallo;di fatto, quindi, questo albero simboleggia la
fertilità e la fecondità. Gli antichi Greci chiamavano questo albero "Karya
basilica", ovvero "noce regale,essendo amato dai re persiani. Nella ricca
mitologia greca il Noce è legato al dio Dioniso e al suo amore per la
principessa Caria. La leggenda narra che Dioniso, ospite presso Dione, re della
Laconia, si invaghì di Caria, una delle sue giovani figlie. Orfe e Lico, sorelle
maggiori di Caria, invidiose delle attenzioni che Dioniso stava riservando alla
loro sorella, avvertirono subito il padre. Dioniso, colmo di collera per questo
tradimento, dopo averle fatte impazzire le trasformò in rocce. Caria, disperata
per la sorte riservata alle due amate sorelle, morì poco dopo di dolore.
Dioniso, ancora innamorato di Caria, ebbe pietà di lei e la trasformò in un
albero di noce, dandole la possibilità di produrre frutti fecondi. La morte di
Caria fu annunciata da Artemide ai Laconi, e questi fecero costruire un tempio
ponendo al suo ingresso delle statue scolpite in legno di noce. Queste statue
raffiguravano delle figure femminili denominate, in seguito, "Cariatidi" proprio
per questo motivo (famose quelle dell'Eretteo sull'Acropoli di Atene).
Nella simbologia popolare la noce evoca la trimurti sacra che presiede a ogni
manifestazione:corpo (guscio), spirito (il mallo) e anima (il gheriglio). Già
Sant'Agostino la indicava come simbolo di Cristo: il mallo sta per la carne di
Gesù, il guscio allude alla croce e il gheriglio alla natura divina di Cristo.
Il "Battesimo di Gesù", opera giovanile di Piero della Francesca (1412-1492),
offre un'intensa meditazione sul mistero trinitario, di cui il battesimo di Gesù
è la prima epifania, e nona caso cita il Concilio di Firenze che tentò un
accordo fra cattolici e ortodossi proprio sulla Trinità. L'albero in primo piano
il cui tronco bianchissimo è in corrispondenza con il candore della carne di
Cristo è un noce, citazione allusiva alla valle di Nocea, dove, secondo la
leggenda, i due fondatori della città di San Sepolcro, ritratta sullo sfondo,
decisero di fondare la prima chiesa della futura città. Come tutti i simboli, la
noce possiede un'ambivalenza di significato. L'eccentrico pittore Giuseppe
Arcimboldo (1526-1593), in uno dei suoi dipinti reversibili, cioè osservabili
anche capovolti, inserisce la noce. Un quadro, oggi a Cremona, raffigura ortaggi
in un vaso tra i quali si vede il mallo di una noce spezzata, segno della
fertilità della terra. Guardato capovolto il dipinto offre invece il volto di un
ortolano che ha per occhio proprio la noce. L'Arcimboldo, attento alle
simbologie, ha voluto così indicare come la fecondità di un'esistenza dipenda
dal modo con cui l'uomo guarda la realtà. La noce nella sua ambivalenza disegno,
frutto del bene o del male, esprime tale modalità.
Benevento è la patria di un'antica tradizione di stregoneria: si diceva che le
streghe beneventane venissero da tutta Italia per riunirsi per i loro sabba
sotto il sacro noce di Benevento. Nel 1526 il giudice Paolo Grillandi scrisse di
streghe a Benevento che adoravano una dea nel sito di un vecchio noce. Per
esorcizzare questi riti infausti invalse l'uso di raccogliere le noci per
realizzare il nocino, una sorta di panacea della salute, nel giorno di san
Giovanni Battista, il 24 giugno. Questa leggenda ha ispirato molte opere, tra
cui il balletto del 1812 "Il Noce di Benevento" di Salvatore Viganò e Franz
Xaver Süssmayr, un tema da cui è stato adattato in un brano per violino
chiamato "Le Streghe" di Niccolò Paganini (1782-1840). Il liquore beneventano
Strega (dal quale deriva il nome di un noto premio letterario) raffigura
sull'etichetta il famoso albero di noce con le streghe che danzano sotto di
esso. E non è un caso se, come abbiamo visto parlando del mirto,
l'albero delle stregonerie e dei demoni tagliato da Rinaldo nel XVIII Canto
della "Gerusalemme Liberata", altro in realtà non era se non un noce!
Plinio il Vecchio cita nella sua "Naturalis Historia" un resoconto di Cicerone
in cui si afferma che una versione manoscritta dell'Iliade di Omero sarebbe
entrata in una noce: « in nuce inclusam Iliadem Homeri carmen in membrana
scriptum tradit Cicerone » (ma si sa che Cicerone amava spararle grosse).
Nell'"Amleto"(Atto 2, Scena 2) il protagonista esclama: « Oh Dio, potrei essere
rinchiuso in un guscio di noce e sentirmi re dello spazio infinito! » Nelle
favole le noci sono sempre legate a tesori e sorprese positive: nella fiaba "Il
forno" dei fratelli Grimm, una principessa riceve dalla regina dei rospi tre
noci, che la aiuteranno a conquistare l'amore di un bellissimo principe: in ogni
noce, infatti, si nasconde un meraviglioso abito. In "Mignolina" di Hans
Christian Andersen (1805-1875), invece, la piccola protagonista ha come culla
proprio un guscio di noce. Ne "I promessi sposi", buona parte del terzo capitolo
è dedicata al famoso "Miracolo delle noci" raccontato da Fra Galdino. Questi
giunge a casa di Lucia per la "cerca delle noci", una pratica usuale in quell'epoca,che
consisteva nel raccogliere le noci come offerta per il convento. Mentre la
promessa sposa va a prendere le noci, il frate racconta ad Agnese la famosa
storia del miracolo delle noci. In un convento di frati cappuccini in Romagna
viveva Padre Macario; un giorno vide in un campo dei braccianti che si
accingevano ad abbattere una pianta di noce perchè non produceva più frutti da
diversi anni. Il frate esortò il proprietario a non farlo, promettendogli che
quell'anno l'albero avrebbe prodotto più frutti che foglie. Il benefattore, che
si fidava del frate, ordinò ai braccianti di risparmiare l'albero e promise a
Padre Macario metà del suo raccolto di noci. In effetti lo straordinario
raccolto di noci ci fu, ma il benefattore morì prima di vederlo, lasciando tutto
in eredità al figlio, uomo egoista che si burlava dei religiosi e pensava solo a
divertirsi. Quando il frate tornò da lui per riscuotere il dovuto, egli si
rifiutò di onorare la promessa fatta dal padre, asserendo di non aver mai
sentito che i frati producessero noci, e lo cacciò via. Un giorno, però, mentre
si vantava della vicenda davanti ai suoi amici, li invitò a vedere la sua
incredibile provvista di noci nel granaio, ma con enorme sorpresa vi trovò
solamente un mucchio di foglie secche. La notizia del miracolo si diffuse
rapidamente e quell'anno il convento ricevette così tante elemosine in noci che
poté ridistribuirle a tutti i poveri del circondario.
Infine, "L'universo in un guscio di noce" è un saggio pubblicato nel 2001 dal
grande scienziato e divulgatore britannico Stephen Hawking (1942-2017), noto al
grande pubblico perle sue ricerche sui buchi neri e per la malattia che lo
costringeva in carrozzina. Maestoso albero, dentro i tuoi semi tu puoi
racchiudere persino l'infinità del cosmo!

Le
figlie del dio Sole
La nostra scorribanda in
questo giardino botanico virtuale ci porta davanti a un maestoso esemplare di
pioppo. Populus è un genere di una trentina specie
di piante da fiore decidue della famiglia delle Salicacee, originarie
dell'emisfero settentrionale. L'altezza dei pioppi va dai 15 ai 30 metri e
oltre, con fusti che possono superare i 2,5 metri di circonferenza. La corteccia
degli individui giovani è liscia, con colorazioni che vanno dal bianco al
verdastro al grigio scuro, spesso screziato; sugli esemplari più vecchi, diventa
rugosa e profondamente fessurata. I germogli sono robusti e sono presenti le
gemme apicali (contrariamente ai loro parenti salici, di
cui abbiamo parlato sopra); le foglie sono disposte a spirale e la loro forma
varia da triangolare a circolare o, più raramente, lobata, con lunghi piccioli.
I piccioli sono appiattiti, sicché il vento può facilmente muovere le foglie
dando l'impressione che l'albero "tremi". Si tratta di piante solitamente
dioiche; le piante femminili e maschili sono facilmente distinguibili: le prime
hanno rami grandi, chiome voluminose e grosse gemme, mentre le altre sono più
slanciate e hanno gemme più piccole ma più numerose; queste notevole diversità
ha fatto sì che in passato i sessi venissero erroneamente classificati come due
specie diverse. L'età riproduttiva comincia a 10-15 anni. I fiori compaiono
all'inizio della primavera e prima delle foglie e sono raccolti in infiorescenze
allungati, pendente e peduncolate. Quelli maschili sono più corti e tozzi e
compaiono prima di quelli femminili, che hanno spighe più lunghe e più pendenti.
I frutti sono capsule, verdi o bruno-rossicce, e maturano tra metà primavera e
metà estate. Contengono numerosi piccoli semi marroncini che poi vengono
dispersi dal vento tramite una sorta di pappo, da cui il nome inglese del
pioppo, cottontree, cioè "albero del cotone".
I pioppi del genere Populus sono probabilmente le latifoglie più diffuse
nell'emisfero boreale, e il pioppo balsamico occidentale (Populus trichocarpa) è
stato il primo albero il cui DNA è stato sequenziato completamente, nel 2006.
Populus è una voce latina, per la precisione scritta pōpulus, distinta dunque da
pŏpulus, "popolo" per via della vocale "o" lunga. Una paretimologia comune, già
attestata presso gli antichi, lo considera l'"albero del popolo". In realtà
l'etimologia è differente e dibattuta, probabilmente facente parte del sostrato
mediterraneo prelatino. La parola italiana "pioppo" deriva da una forma latina
medievale *ploppus, da cui anche l'emiliano "fioppa", il napoletano "chiuppo",
il rumeno "plop", lo spagnolo "chopo" e il portoghese "choupo", passata anche
nell'irlandese "pobhuil", nell'albanese "plepi", nel tedesco "Pappel",
nell'antico slavo тополь/"topolĭ" e nel greco moderno τοπόλι/"topóli", mentre la
forma classica pōpulus è riconoscibile nel veneto "povolo". L'ipotesi più
probabile è che pōpulus e *ploppus derivino per raddoppiamento del
radicale pal- che si trova nel greco "pallo", "agito" (e nell'italiano "palla")
per via dell'agitarsi rumoroso delle foglie del pioppo al minimo refolo di
vento. Questa ipotesi è rafforzata dal fatto che, nel greco antico, pioppo
suonava "algeiros", dalla stessa radice del sanscrito "egati", cioè "agitarsi",
da cui si pensa che derivi anche il latino "aegrus", "malato", perchè chi ha la
febbre trema a causa dei brividi, e forse persino il verbo italiano "agire".
Il più antico fossile identificabile di questo genere appartiene a Poplus
wilmattae e proviene dal tardo Paleocene del Nord America, circa 58 milioni di
anni fa. Il genere Populus è stato tradizionalmente suddiviso in sei sezioni
sulla base dei caratteri fogliari e floreali, e i recenti studi genetici lo
hanno ampiamente supportato, confermando i sospetti circa un'evoluzione molto
complessa a causa di continui eventi passati di ibridazione tra i gruppi, dato
che alcune specie hanno relazioni diverse indicate dal loro DNA nucleare
(ereditato paternamente) e dalle sequenze del DNA dei cloroplasti (ereditato
maternamente), una chiara indicazione di una probabile origine ibrida. Di solito
si parla di pioppo bianco (clima subartico circumpolare e temperato freddo) come
ad esempio Populus alba; pioppo nero (Nord America, Europa, Asia occidentale;
clima temperato) come Populus nigra; pioppo balsamico (Nord America, Asia; clima
temperato fresco) come Populus balsamifera; pioppo a foglie grandi (Nord America
orientale, Asia orientale; clima temperato caldo) come Populus heterophylla;
pioppo subtropicale (sud-ovest asiatico, Africa orientale; clima da subtropicale
a tropicale) come Populus euphratica; e pioppo messicano (Messico; clima da
subtropicale a tropicale) come Populus guzmanantlensis.
I pioppi sono importanti piante alimentari per le larve di un gran numero di
specie di lepidotteri. Il fungo Pleurotus populinus si trova esclusivamente sul
legno morto degli alberi Populus in Nord America. Purtroppo diverse specie di
pioppo nel Regno Unito e in altre parti d'Europa hanno subito un pesante
deperimento, in parte dovuto a causa dell'insetto Sesia apiformis che perfora il
tronco dell'albero durante il suo stadio larvale.
Molti pioppi vengono coltivati come alberi ornamentali, avendo il vantaggio di
crescere fino a dimensioni molto grandi a un ritmo rapido. Quasi tutti i pioppi
attecchiscono facilmente per talea o dove giacciono al suolo rami spezzati;
spesso possono formare enormi colonie da un ' albero originario, come la
famosa foresta di Pando composta da migliaia di cloni di Populus tremuloides.
Nota anche come "Trembling Giant" ("gigante tremulo"), è un bosco nello stato
dello Utah, nella foresta nazionale di Fishlake, e dai marcatori genetici della
pianta si è stabilito che tutte le sue ramificazioni di Pando fanno parte dello
stesso organismo vivente, con un massiccio sistema di radici il cui peso è stato
stimato in circa 6.615 tonnellate, il che lo rende l'organismo vivente più
pesante conosciuto. Inoltre il sistema radicale di Pando è considerato tra i più
antichi organismi viventi al mondo, con un'età di circa 80.000 anni!
Gli alberi con ramificazione colonnare sono particolarmente apprezzati e sono
coltivati in Europa e nel sud-ovest asiatico. Tuttavia, come i
salici, i pioppi hanno apparati radicali molto vigorosi e
invasivi che si estendono fino a 40 metri dagli alberi; piantarli vicino a case
o vicino a tubi dell'acqua in ceramica può causare danni alle fondamenta e crepe
nei muri e nei tubi, a causa della loro ricerca di umidità.
Il legno di Populus è un materiale leggero e poroso; la sua flessibilità e la
grana fine lo rendono adatto a numerose applicazioni, simili a quelle del
salice. I Greci e gli Etruschi facevano scudi di pioppo, e anche Plinio il
Vecchio raccomandava di usare il legno di pioppo to per questo scopo. Il pioppo
continuò ad essere utilizzato per la costruzione di scudi durante tutto il
Medioevo, ed era rinomato per una durabilità simile a quella della quercia, ma
con una sostanziale riduzione di peso. Il legno di pioppo è oggi ampiamente
utilizzato nell'industria dello snowboard, perché ha un'eccezionale
flessibilità, ed è talvolta utilizzato nei corpi di chitarre elettriche e
batterie. Viene utilizzato anche per realizzare fiammiferi, scatole di
fiammiferi e le scatole per il famoso formaggio Camembert. A causa del suo alto
contenuto di acido tannico, la corteccia è stata utilizzata per la concia delle
pelli.
Non basta: il pioppo è sfruttato come coltura energetica per le biomasse. In
Italia questa coltura può produrre fino a 16,4 tonnellate secche di biomassa per
ettaro ogni anno, per cicli di taglio semestrali e triennali, con un bilancio
energetico positivo e un'elevata efficienza energetica. Il biocarburante è
un'altra opzione per utilizzare il pioppo come fonte di bioenergia. I pioppi
sono spesso utilizzati come frangivento intorno ai campi agricoli per proteggere
dall'erosione del vento. Il pioppo rappresenta anche un candidato idoneo per il
fitorisanamento, essendo stato utilizzato con successo per abbattere molti
tipi di inquinanti, tra cui oligoelementi nel suolo[24] e fanghi di depurazione.
Sembrerà incredibile ma, oltre al fogliame e ad altre parti delle specie Populus
consumate dagli animali, lo strato di linfa amidacea sotto la corteccia esterna
è commestibile per l'uomo, sia crudo che cotto. Inoltre il pioppo è ampiamente
utilizzato per la fabbricazione della carta.
Nel campo artistico, il pioppo era il legno più utilizzato in Italia per i
dipinti su tavola; la "Gioconda" e i più famosi dipinti del primo Rinascimento
italiano sono su pioppo. Due celebri poesie in inglese lamentano l'abbattimento
dei pioppi: "The Poplar Field" di William Cowper (1731-1800) e "Binsey Poplars"
di Gerard Manley Hopkins (1844-1889). "Vecchio Pioppo" è una struggente lirica
di Federico Garcìa Lorca (1898-1936). Nella sua famosa canzone "Strange Fruit",
la grande Billie Holiday (1915-1959) cantava: « Black bodies swinging in the
southern breeze/Strange fruit hanging from the poplar trees... »
Un famoso mito greco afferma che Fetonte, figlio di Elio (il dio sole) e
dell'oceanina Climene, chiese al padre il permesso di provare a guidare il carro
di fuoco solare, e il padre non seppe rifiutarglielo. I cavalli alati però
correvano velocissimi, l'inesperto Fetonte si fece prendere dal panico e perse
il controllo del carro, che prima si avvicinò troppo alla terra, riducendo la
Libia a uno sterile deserto, e poi si accostò troppo alla volta del cielo
lasciandovi una profonda bruciatura, la Via Lattea. Per evitare che il carro
impazzito del sole distruggesse l'universo, Zeus fu costretto a fulminare
Fetonte, che cadde nel fiume Eridano, variamente identificato, ma di solito
considerato l'antico nome del Po. Come racconta Ovidio nel secondo libro delle
sue "Metamorfosi", le sue sorelle, le Eliadi, piansero inconsolabili la sua
morte, fino a che Zeus impietosito non le trasformò proprio nei pioppi che
costeggiano il Po, mentre le loro lacrime si trasformarono in gocce di ambra.
Secondo alcuni, l'identificazione dell'Eridano con il Po ha permesso
l'identificazione del greco Fetonte con la divinità veneta Aponus (Fons Aponi è
l'attuale Abano Terme).
Secondo un altro mito, delle foglie di pioppo si sarebbe cinto il capo Ercole
quando discese negli Inferi, per cui la faccia esterna delle foglie divenne nera
per il fumo, mentre quella interna restò bianca perché aderente alla fronte. A
causa del colore bianco e nero delle foglie, simboleggia anche il tempo che
scorre. Questa particolarità ha fatto del pioppo il simbolo del confine fra la
terra e il regno degli inferi. Per questo motivo quest'albero rappresenta nel
calendario celtico l'equinozio d'autunno che demarca il passaggio del Sole dalla
parte settentrionale a quella meridionale dello zodiaco, ovvero agli inferi
della stagione invernale. Sempre secondo il calendario arboreo celtico il pioppo
rappresenta uno dei segni dello zodiaco. Per via del mito di Ercole, in araldica
il pioppo è simbolo di coraggio, e lo si trova nello stemma di Albareto (PR),
Bareggio (MI), Gazzo (PD) e Aspach (in Francia).
Anche la Bibbia cita quest'albero quando racconta la storia del patriarca
Giacobbe, costretto a fuggire nell'Alta Mesopotamia e a mettersi al servizio
dello zio Labano perchè il fratello Esaù lo cercava per ucciderlo, dopo avergli
soffiato la primogenitura con uno stratagemma. Labano cercò di trattenerlo al
proprio servizio prima dandogli in sposa le due figlie Lia e Rachele, e poi
promettendogli di regalargli tutti i capi di bestiame nati pezzati o
punteggiati. Giacobbe ricorse allora ad un altro artificio: « Giacobbe prese
rami freschi di pioppo, di mandorlo e di platano, ne intagliò la corteccia a
strisce bianche, mettendo a nudo il bianco dei rami. Mise i rami così
scortecciati nei canaletti agli abbeveratoi dell'acqua, dove veniva a bere il
bestiame, bene in vista per le bestie che andavano in calore quando venivano a
bere. Così le bestie andarono in calore di fronte ai rami e le capre figliarono
capretti striati, punteggiati e chiazzati. » (Gen 30,37-39) Questo racconto
mitologico nasce dall'antica convinzione secondo cui il colore del manto dei
nascituri fosse influenzato da ciò che le loro madri vedevano durante la
gestazione, ed è usato per mettere in evidenza il favore di Dio di cui godeva
Giacobbe/Israele, patriarca eponimo del popolo ebraico. Nella Bibbia trovano
posto anche le radici eccezionalmente estese dei pioppi: « Io sarò come rugiada
per Israele; / esso fiorirà come un giglio, / metterà
radici come un pioppo, / si spanderanno i suoi germogli… » (Osea 14,6-7)

Tre pioppi fotografati dall'autore di questo sito nel suo paese natale
Le
spine da cui stilla il miele
L'acacia
è un genere di arbusti e alberi della sottofamiglia Mimosoidee della famiglia
delle Fabacee. Inizialmente comprendeva un gruppo di specie vegetali originarie
dell'Africa e dell'Australasia. Il nome generico è mutuato dal greco ἀκακία (akakia),
termine usato da Dioscoride per un preparato estratto dalle foglie e dai
baccelli dei frutti di Vachellia nilotica, il tipo originario del genere.
Secondo i linguisti, tale nome dal greco deriva ἄκις, "spina" per mezzo del raddoppiamento della radice ak-, che
significa "penetrare" (da cui anche "ago", ma anche "acanto" e "acero") per via
delle spine di cui è irta.
Il genere fu così nominato per la prima volta nel 1754 da Philip Miller
(1691-1771). Nel 1913 Nathaniel Lord Britton (1859-1934) e Addison Brown
(1830-1913) scelsero Acacia nilotica di origine africana, come la specie tipo.
Il genere Acacia nel 1986 conteneva 1352 specie. Alla fine del XX secolo però,
grazie alle ricerche genetiche, si scoprì che il genere acacia non era
monofiletico, e che diversi lignaggi divergenti dovevano essere collocati in
generi separati. Si è scoperto in particolare che un lignaggio comprendente
oltre 900 specie originarie principalmente dell'Australia, della Nuova Guinea e
dell'Indonesia non era strettamente imparentato con il gruppo molto più piccolo
del lignaggio africano che conteneva Acacia nilotica, la specie tipo. Ciò
significava che il lignaggio australasiatico, di gran lunga il più numeroso
quanto a specie, avrebbe dovuto essere rinominato. Proprio nel 1986 il botanico
Leslie Pedley (1930-2018) propose di rinominare questo gruppo Racosperma, un
termine che però ha ricevuto pochi consensi nella comunità botanica. Nel 2003 i
botanici australiani Anthony Orchard (1946-) e Bruce Maslin (1946-) hanno
proposto una soluzione meno dirompente impostando una specie di tipo diverso per
Acacia (Acacia penninervis) e consentendo a un gran numero di specie australiane
di rimanere sotto il genere Acacia, mentre i due lignaggi tropicali sono stati
rinominati Vachellia e Senegalia e i due lignaggi endemici americani sono stati
rinominati Acaciella e Mariosousa. Sebbene molti botanici fossero ancora in
disaccordo circa la necessità di tale suddivisione, questa soluzione è stata
infine adottata ufficialmente al Congresso Botanico Internazionale di Melbourne
nel 2011. Comunque "acacia" rimane un nome comune ampiamente utilizzato per
tutti i generi. Diverse specie sono state introdotte in varie parti del mondo e
sono stati creati due milioni di ettari di piantagioni commerciali. Il gruppo è
così eterogeneo che comprende sia bassi arbusti che alberi d'alto fusto. Pare
che le giraffe siano ghiottissime di foglie di acacia.
Nell'antico Egitto, un unguento ricavato dalle foglie macinate di un'acacia (si
discute di quale specie) veniva usato per curare le emorroidi.
Alcune specie di acacia poi contengono alcaloidi psicoattivi e talune contengono fluoroacetato
di potassio, un veleno per roditori.
Un acacia fossile di 14 centimetri è
stata ritrovata nel bacino di Parigi e risale all'Eocene. Alcuni baccelli
fossili di un vegetale battezzato Leguminocarpon e molto simili a quelli
dell'acacia sono riemersi dai depositi del
tardo Oligocene in diversi siti in Ungheria. Fossili di baccelli di Acacia parschlugiana e Acacia cyclosperma,
entrambe estinte, sono noti da depositi terziari in
Svizzera. Estinta è anche l'Acacia colchica, descritta da fossili del Miocene
provenienti dalla Georgia
occidentale. Polline fossile di Acacia scoperto in Australiaè vecchio almeno di
25 milioni di anni.
Vediamo alcune delle specie più famose. L'Acacia nilotica, oggi rinominata
Vachellia nilotica come spiegato sopra (anche se in Africa è ancora chiamata
acacia, trattandosi di un iconico simbolo tradizionale), è conosciuta anche come
albero della gomma arabica o come mimosa spinosa. Come dice il nome, è
originaria dell'Egitto, ma attraverso il Maghreb e il Sahel ha raggiunto il
Sudafrica e ad est attraverso la penisola arabica si è spinta fino al
subcontinente indiano e alla Birmania. Il governo federale degli Stati Uniti la
considera una pianta nociva per i motivi sopra spiegati. La specie tipo del
genere Acacia è un albero alto da 5 a 20 metri con una densa chioma sferica,
steli e rami generalmente di colore da scuro a nero, corteccia fessurata
grigio-rosata, che trasuda una gomma rossastra di bassa qualità. L'albero ha
spine sottili, diritte, chiare e grigie in coppie ascellari, lunghe da 5 a 7,5
cm negli alberi giovani, mentre gli alberi maturi comunemente sono senza spine.
Le foglie sono bipennate, con 3-6 paia di pinnule e 10-30 paia di foglioline
ciascuna, con una ghiandola alla base dell'ultimo paio di pinnule. I fiori sono
capolini globosi di 1,2-1,5 cm di diametro di colore giallo dorato brillante,
disposti su peduncoli. I baccelli sono fortemente ristretti, pelosi,
bianco-grigi. I suoi semi sono piccoli, ce ne vogliono circa 8000 per arrivare a
un chilo. Se ne consumano i baccelli e le foglie, ma è anche molto usata come
foraggio per i bovini. I baccelli sono usati come supplemento alle razioni per
il pollame in India, e i baccelli secchi sono particolarmente ricercati dagli
animali nei pascoli. In Africa occidentale si ritiene che i baccelli e le foglie
abbiano proprietà antiparassitarie sui piccoli ruminanti, e ciò è stato
confermato da esperimenti in vitro sui nematodi. I Masai mangiano sia la
corteccia interna che la polpa del frutto bollita in acqua, e la usano nella
medicina tradizionale per curare mal di gola, tosse e dolori al petto. Il tenero
ramoscello di questa pianta viene utilizzato come spazzolino da denti
nell'Africa sud-orientale e nel subcontinente indiano. Gli aborigeni australiani
hanno tradizionalmente raccolto i semi di alcune specie di acaia per macinarli
in farina e mangiarli come una pasta o cotti in una torta. A Kano, in Nigeria, i
baccelli di acacia sono stati tradizionalmente usati per tingere la pelle di una
sfumatura rossastra. La gomma essudata di questo albero è nota come gomma
arabica ed è stata raccolta fin dai tempi dei Faraoni per la fabbricazione di
medicinali, coloranti e vernici. La gomma di Vachellia nilotica in India è anche
chiamata gomma Amaravati. Il legno dell'albero è molto resistente se stagionato
in acqua, e i suoi usi includono manici di utensili e legname per barche.
L'Acacia dealbata è invece comunemente conosciuta come mimosa (dal latino mimus,
"attore", per i movimenti con cui le foglie reagiscono a qualsiasi contatto). È
una tipica pianta pioniera, molto utilizzata come pianta ornamentale grazie alla
sua profumata fioritura con fiori gialli molto delicati. È una pianta originaria
della Tasmania, e per le sue meravigliose caratteristiche come pianta
ornamentale ha avuto una notevole diffusione in Europa a partire dal XIX secolo.
In Italia è molto diffusa lungo la Riviera ligure, in Toscana, in Sicilia, e in
tutto il meridione, ma anche sulle coste dei laghi del nord. È una pianta molto
delicata che preferisce terreni freschi, ben drenati, tendenzialmente acidi
soprattutto per una buona fioritura. Cresce preferibilmente in aree con clima
temperato e teme inverni molto rigidi. Dal 1946, per iniziativa della
parlamentare comunista Teresa Mattei (1921-2013), in Italia il ramo fiorito di
mimosa viene offerto alle donne il giorno dell'8 marzo per la Giornata
Internazionale della Donna. La Mattei la scelse perché era uno dei primi fiori a
sbocciare a inizio marzo e aveva il vantaggio di essere poco costosa: «
Scegliamo un fiore povero, facile da trovare nelle campagne. »
L'Acacia farnesiana è comunemente nota come gaggia
(forse deformazione del fancese "acacie" o "cassie"). Questa pianta è un arbusto
deciduo con fusto alto fino a 6-7 metri e con diametro di 20 cm, con rami
pendenti. Originaria della zona tropicale del Nuovo Mondo, è stata introdotta
con successo e si è naturalizzata in molti paesi della fascia tropicale e
subtropicale di Africa, Asia e Australia. In Europa è diffusa in Spagna, Francia
e Italia. Le foglie sono bipennate, provviste di stipole spinose, lunghe da 1,5
a 5 cm, formate da 4-10 paia di pinne composte da numerose piccole foglioline,
lunghe 2–4 mm. Ha infiorescenze globose, di colore giallo-dorato, solitarie o in
piccoli gruppi, riunite all'ascella delle foglie, particolarmente profumate. Il
frutto è un legume cilindrico contenente da 2 a 10 semi, ricoperti da un
tegumento di colore bruno. Il fogliame è una fonte di foraggio con un tenore di
proteine di circa il 18%. I fiori sono distillati per produrre un profumo
chiamato Cassie. È ampiamente usato nell'industria dei profumi in Europa.
L'unguento profumato di Cassie è realizzato in particolar modo in India.
La Vachellia erioloba o spina della giraffa (Kameeldoring
in afrikaans) è invece un albero dell'Africa meridionale che ama i terreni
sabbiosi profondi e asciutti in alcune parti del Sudafrica, del Botswana, dello
Zimbabwe e della Namibia. Questo maestoso albero fu descritto per la prima volta
da Ernst Heinrich Friedrich Meyer e Johann Franz Drège nel 1836. Può crescere
fino a 20 metri di altezza, ma è a crescita lenta, molto resistente alla siccità
e abbastanza resistente al gelo. Le spine di colore grigio chiaro riflettono la
luce solare e le foglie bipennate si chiudono quando fa caldo. Il legno è di
colore bruno-rossastro scuro ed estremamente denso e forte. Produce baccelli a
forma di orecchio, molto amati dagli erbivori africani, tra cui le giraffe. I
semi possono essere tostati e usati come sostituto dei chicchi di caffè. Il nome
"spina della giraffa" si riferisce al fatto che la giraffa (kameelperd in
afrikaans) si nutre comunemente delle sue foglie con la lingua e le labbra
appositamente adattate, che riescono ad evitare le spine; il nome "erioloba"
significa invece "lobo lanoso", un riferimento ai baccelli a forma di orecchio.
Il celebre ed apprezzato "miele di acacia" invece non viene invece raccolto
dalle piante della famiglia delle acacie, ma piuttosto dalla
Robinia
pseudoacacia, originaria del Nord America ma naturalizzatasi in Europa. Vi fu
importata dall'America del Nord nel 1601 da Jean Robin (1550-1628), farmacista e
botanico del re di Francia Enrico IV. L'introduzione avvenne attraverso semi
provenienti dagli Appalachi in Virginia, regalati a Robin dal botanico
inglese John Tradescant il Vecchio (1570-1638). Nel 1601 Jean Robin piantò un esemplare di
acacia a Parigi, in Place René Viviani, sulla Rive Gauche, nei pressi della
chiesa di Saint-Julien-le-Pauvre; esso è ancora esistente, anche se danneggiato
dai bombardamenti della Prima Guerra Mondiale, che rovinarono la parte più alta
della chioma, e successivamente anche da un fulmine che ne ha colpito il tronco.
Per questo motivo è stato necessario sostenerlo con tre pilastri in cemento.
Ciononostante è vigoroso continua a fiorire ogni primavera da oltre quattrocento
anni. Dei più di 370.000 alberi dei viali e parchi parigini quest'esemplare è
comunemente considerato il più antico, oltre ad essere l'acacia più longeva
d'Europa (di solito invece la robinia è poco longeva fuori del suo areale
originario). In Italia la robinia è stata introdotta nel 1662 nell'Orto botanico
di Padova. La rapida diffusione di questa specie è stata favorita dall'uomo, che
la apprezza non solo per il legno, ma anche come pianta mellifera e come specie
ornamentale a motivo delle sue numerose qualità: la resistenza a condizioni
avverse, l'abbondante e profumata fioritura e la velocità di crescita (si pensi
che la robinia è stata scelta come Albero dell'Anno del 2020 in Germania, pur
non essendo nativa di questo paese). Per la sua capacità di prosperare anche in
condizioni che sarebbero avverse per altri alberi, la robinia viene utilizzata
per la lotta alla desertificazione.
E ora, alcuni riferimenti culturali. L'acacia è menzionata in un antico
proverbio egiziano attribuito al Faraone Amenhotep II (1424-1398 a.C.), della
XVIII Dinastia:
« Se ti manca un'ascia da battaglia d'oro intarsiata di bronzo, una pesante
mazza di legno di acacia andrà benissimo » (saggezza valida in ogni tempo)
Considerata sacra presso gli Egizi e le popolazioni della penisola arabica,
simboleggiava la speranza indistruttibile della rinascita a nuova vita dopo la
morte. Secondo una nota leggenda, infatti, Osiride fu ucciso e fatto a
pezzi dal fratello Seth per invidia, ma la sua sposa e sorella Iside, disperata,
cercò le membra disperse, le ritrovò tutte tranne il pene (che fu sostituito con
una protesi) e ricompose il corpo dell'amato e all'interno di un sarcofago di
legno d'acacia per farlo ritornare in vita e regnare per sempre. Questa
simbologia è arrivata fino agli Ebrei, i quali da sempre considerano questo
legno sacro e incorruttibile, tanto che la si trova citata più volte nel Libro
dell'Esodo, dove è indicata per la costruzione:
> dell'Arca dell'Alleanza, realizzata in legno di acacia rivestito d'oro: «
Besalèl fece l'arca di legno di acacia: aveva due cubiti e mezzo di lunghezza,
un cubito e mezzo di larghezza, un cubito e mezzo di altezza [...] Fece stanghe
di legno di acacia e le rivestì d'oro. » (Es 37,1.4);
> dell'altare dei profumi: « Fece l'altare per bruciare l'incenso, in legno di
acacia » (Es 37,25);
> dell'altare dei sacrifici: « Fece l'altare per gli olocausti di legno di
acacia » (Es 38,1).
Forse l'acacia citata nella Torah è la Vachellia tortilis (precedentemente nota come Acacia raddiana).
Comunque sia, questo legno era talmente connesso alla sfera del Divino da essere
considerato l'' che poteva contenere le Tavole della Legge, il patto ("Berit")
tra Dio e l'uomo. Secondo una leggenda posteriore alla distruzione del Secondo
Tempio, anche il roveto ardente attraverso il quale Dio si manifestò a Mosè
sarebbe stato un'acacia (per il Corano invece era l'albero delle more
selvatiche). Inoltre i suoi fiori bianchi sono simbolo di amore platonico,
mentre il suo legno porta il valore dell'amicizia. La sua foglia fu scelta come
simbolo di rinascita anche dalla Massoneria, per via delle caratteristiche della
pianta che, forte e delicata, non subisce i mutamenti stagionali ma si rinnova
continuamente. Pare che Giuseppe Garibaldi (noto esponente della Massoneria
ottocentesca) avesse espresso la volontà di essere cremato su una pira di legno
di acacia, ma il suo desiderio non venne accolto dal governo che lo seppellì
nella sua Caprera, e questo avvenimento scatenò le proteste di un altro celebre
massone, Giosuè Carducci. In America latina tuttora è tradizione che venga
regalato un rametto di acacia bianca in occasione delle feste di fidanzamento.
La mimosa invece nel linguaggio dei fiori indica il pudore; i Nativi Americani
regalavano un mazzo di mimose quando decidevano di dichiarare il proprio amore.
Infine, l'acacia è anche uno degli alberi che si incontrano nel popolare videogioco Minecraft.
In esso gli alberi sono modellati su due diverse specie: l'Acacia koa,
originaria delle Hawaii, e la Vachellia erioloba, originaria dell'Africa
meridionale. E scusate se è poco!

Notevole esemplare di Vachellia erioloba dello Zimbabwe (dall'Enciclopedia Britannica)
Gli
alberi di Salomone
Anzitutto, una precisazione. Il nome cedro
si riferisce al genere Cedrus, una conifera appartenente alla famiglia delle
Pinacee, e non ha niente a che vedere con l'omonimo agrume, il cui nome
scientifico è Citrus medica, della famiglia delle Rutacee, che non ha alcun
rapporto di somiglianza né di parentela con il nostro albero. La parola latina
cedrus deriva dal greco κέδρος, che alcuni fanno venire dal verbo ebraico Hadar,
"essere scuro" per il colore verde cupo del suo fogliame, e altri dal verbo
greco Keo, "colare", per via della sua resina; è stato anche suggerito che la
parola potrebbe essere stata originariamente applicata alle piante di ginepro, e
successivamente adottata per le specie ora classificate nei generi Cedrus e
Citrus, a causa della somiglianza dei loro legni aromatici. I cedri sono alberi
sempreverdi di dimensioni maestose, alti fino a 50 metri, con un legno dalla
resina aromatica, un tronco massiccio e possente e rami larghi, orizzontali nel
Cedrus libani, penduli in altre specie e sottospecie; il loro accrescimento è
piuttosto rapido. Sono nativi dell'Himalaya occidentale (nel caso di Cedrus
deodara) e del bacino del Mediterraneo (nel caso di Cedrus atlantica, Cedrus
libani e relative sottospecie). In natura si trovano ad altezze di 1500-3200 m
sull'Himalaya e 1000-2200 m sulle montagne a sud del Mediterraneo Sopportano
geli fino a circa -25 °C. Le foglie sono corte e leggermente pungenti,e disposte
in gruppi di 20-40 e variano dal verde brillante a un verde bluastro, a seconda
della specie e della quantità di cera bianca che protegge le foglie
dall'essiccazione. Le pigne, il cui nome scientifico è "strobili" hanno forma di
barile, sono lunghi da 6 a 12 cm e si disarticolano una volta maturi per
liberare i semi alati, che sono triangolari, lunghi 10-15 mm con alette di 20-30
mm. I semi hanno due o tre capsule, contenenti una resina dall'odore disgustoso
come difesa contro gli scoiattoli. La maturazione dello strobilo dura un anno,
con l'impollinazione in settembre-ottobre e la maturazione che avviene l'anno
seguente nello stesso periodo. Sono stati introdotti in Europa come alberi
ornamentali e sono molto diffusi nei parchi pubblici e nei giardini, ma sono
coltivati anche per il loro legno aromatico e resistente. Nel corso dei secoli
si è purtroppo verificata una vasta deforestazione, e solo piccoli resti delle
foreste originarie sopravvivono al giorno d'oggi. La deforestazione è stata
particolarmente grave in Libano e a Cipro. Vari tentativi sono stati fatti nel
corso della storia per conservare i cedri del Libano: il primo lo dobbiamo
dall'imperatore romano Adriano (117-138 d.C.), il quale creò una foresta
imperiale contrassegnata da cippi di confine invalicabili, due dei quali oggi si
trovano nel museo dell'Università di Beirut.
La simbologia relativa al cedro è
imponente quanto la sua statura: è l'emblema nazionale del Libano e compare
sulla sua bandiera e sul suo stemma, ma anche nel logo della Middle East
Airlines, la compagnia aerea di bandiera del Libano. Fu pure il simbolo
principale della cosiddetta "rivoluzione dei cedri" del 2005, innescata
dall'assassinio dell'ex primo ministro libanese Rafik Hariri. il Libano stesso è
talvolta indicato metonimicamente come la Terra dei Cedri. Anche grazie alla
presenza dei cedri, i Fenici sono diventati grandi commercianti e navigatori,
perché con i loro tronchi venivano realizzate le loro forti navi! Nell'arcieria
tradizionale il legno di cedro viene usato per la costruzione delle frecce, ed è
anche il legno più diffuso per la realizzazione delle scatole di sigari. Le
notizie scritte sui cedri sono antichissime. Nell'epopea di Gilgamesh l'eroe
sumero e il suo amico Enkidu si recano nella leggendaria foresta di cedri (e
quindi in Libano) per uccidere il suo mostruoso guardiano Humbaba e
impossessarsi dei suoi alberi (nell'antichità i mostri custodi di un luogo
prezioso erano la personificazione della difficoltà da superare per
conquistarlo). Il cedro era sacro a Enlil, il « Signore che determina il destino
». Il dio Tammuz sarebbe nato sotto un cedro. Il cedro e il cipresso, in quanto
sempreverdi, divennero un riferimento simbolico a una vita perenne (il suo legno
era considerato imputrescibile). Il cedro del Libano è menzionato più volte
nella Bibbia. Ai sacerdoti ebrei fu ordinato da Mosè di usare la corteccia del
cedro del Libano nel trattamento della lebbra. Il veggente Balaam loda le dimore
di Israele: « Come sono belle le tue tende, Giacobbe... come aloe, che il
Signore ha piantato, come cedri lungo le acque » (Num 24,5). Com'è noto,
Salomone si procurò anche legname di cedro per costruire il tempio di
Gerusalemme. Il profeta Isaia usò il cedro del Libano (insieme a "querce di
Basan", "tutti gli alti monti" e "ogni alta torre") come esempi di altezza e
come metafora dell'orgoglio del mondo. Estesi boschi di cedri formavano « la
gloria del Libano », che Isaia 35,2 considera simbolo del regno di Dio. Il
tenero ramoscello che il Signore pianta "sul monte alto d'Israele" e che
«metterà rami e farà frutti, diventerà infine "un cedro magnifico" (Ez 17,22).
Ad Ezechiele (31,3) il Signore parla del Faraone come di « un cedro del Libano,
bello nella sua altezza e nell'ampiezza dei suoi rami », ma poiché « aveva messo
la cima fra le nubi e il suo cuore si era inorgoglito per la sua grandezza, io
lo diedi in balia di un principe di popoli, lo rigettai a causa della sua
empietà » (Ez 31,10). Nel giorno del giudizio il Signore degli eserciti
giudicherà « tutti i cedri del Libano alti ed elevati » (Is 2,13). Nel Salmo
92,12 si dice: « Il giusto fiorirà come la palma e crescerà come un cedro del
Libano ». La Sapienza Divina è cresciuta "come un cedro sul Libano" (Sir 24,13),
ma anche il giusto viene paragonato a un cedro del Libano in fioritura (Sal
92,13). Nel Cantico dei Cantici troviamo di nuovo associati il Libano e il
cedro, quando viene elogiata la bella e nobile figura dello sposo (Ct 5,15).
Nella preparazione dell'acqua per la lustratio, che serviva alla purificazione
dopo il contatto con un cadavere, aveva una sua funzione il legno di cedro (Num
19,6), e questo era certamente in rapporto con l'idea della sua imputrescibilità.
Secondo Cirillo di Alessandria, il legno di cedro era simbolo della carne
incorruttibile di Cristo. Dato che l'interno del tempio di Salomone era tutto
rivestito con legno di cedro (l Re 6,18), e quindi questo legno racchiudeva
anche il Sancta Sanctorum con l'Arca dell'Alleanza, in antichi inni la Vergine
Maria era definita il Cedro, essendo stata prescelta per portare Cristo, il
Santissimo!

Il
guscio che racchiude Dio
Tra gli alberi ampiamente
citati nella Bibbia non può mancare il
mandorlo (Prunus amygdalus), un albero della
famiglia delle Rosacee che cresce nel Mediterraneo orientale; si pensa che i
mandorli siano stati coltivati intenzionalmente per la prima volta proprio in
questa regione. Si tratta di un albero alto fino a sette metri, ha crescita
lenta ed è molto longevo, può diventare plurisecolare. Presenta un fusto
dapprima diritto e liscio e di colore grigio, successivamente contorto,
screpolato e scuro; le foglie, lunghe fino a 12 cm, sono lanceolate; i fiori
sono bianchi o leggermente rosati, con un diametro fino a 5 cm,; sbocciano
all'inizio della primavera, e dove il clima è mite, anche tra gennaio e
febbraio e quindi il mandorlo è tra le fioriture più precoci! Tecnicamente il
frutto è una drupa, contenente la mandorla, cioè il seme con guscio legnoso
ricoperto da un mallo verde. Le mandorle si raccolgono in settembre-agosto a
seconda delle cultivar. I principali produttori al mondo sono Stati Uniti,
Spagna e Australia. Le mandorle sono per lo più dolci, ma esiste una parte di
coltivazione di mandorle amare: questi semi sono considerati tossici perché
contengono amigdalina, che può causare avvelenamento da cianuro di potassio; se
ingerite in quantità possono provocare cefalee, vomito e nei casi più gravi la
morte, soprattutto nei bambini. Tutti ricordiamo che nei romanzi di Agatha
Christie l'odore di mandorle amare è associato proprio alle vittime avvelenate
con il cianuro; tuttavia in quantità adeguate (e spesso in associazione con le
mandorle dolci) le mandorle amare vengono impiegate in preparazioni per
l'alimentazione come i celeberrimi amaretti, a cui danno un gusto particolare e
inconfondibile; si usano anche per produrre liquori, estratti per dolci e
insaporire alimenti tradizionali. Dal frutto del mandorlo si estrae, tramite
spremitura a freddo, un olio limpido e inodore che si usa come emolliente per le
pelli secche e sensibili. L'olio di mandorle dolci è di facile assorbibilità,
ricco in vitamina E, B e minerali, e come olio da massaggio venne introdotto in
Sicilia dai Fenici.
Nell'antichità, i frutti dal guscio duro e legnoso furono contraddistinti dallo
stesso nome: i Romani lo chiamavano "noce greca". In seguito si diffuse in
Francia, Spagna e quasi tutti i paesi del Mediterraneo. Il frutto del mandorlo
selvatico contiene l'amigdalina, che si trasforma nel mortale acido cianidrico
in seguito a danni al seme. Dopo la domesticazione, le mandorle divennero
commestibili: senza dubbio in origine venivano arrostite per eliminarne la
tossicità. Invece le mandorle domestiche non sono tossiche; il noto biologo
Jared Diamond (1937-) ritiene che una mutazione genetica abbia determinato la
casuale scomparsa dell' amigdalina in alcuni esemplari mutanti, che poi sono
stati coltivati e propagati dagli antichissimi agricoltori. Secondo alcuni
storici dell'agricoltura, le mandorle furono uno dei primi alberi da frutto ad
essere coltivati grazie all'abilità dei frutticoltori a selezionarne i frutti.
Così, a dispetto del fatto che questa pianta non si presta alla propagazione
tramite pollone o tramite talea, esso doveva essere stato addomesticato perfino
prima dell'invenzione dell'innesto! I mandorli domestici appaiono
all'inizio dell'Età del bronzo (3000-2000 a.C.): alcune mandorle
commestibili sono state trovate nella tomba di Tutankhamon, probabilmente
importate dal Levante. Oggi la produzione di mandorli nel Salento è purtroppo
messa a rischio da parecchi parassiti, come Xylella fastidiosa o l'insetto Arge
scita, contro cui gli agricoltori hanno scatenato una lotta senza quartiere.
Nell'area mediterranea la fioritura del mandorlo inizia già a gennaio, perciò
quest'albero è divenuto simbolo di vigilanza. Secondo certe tradizioni
dell'antico Oriente, il mondo ha avuto origine da un frutto primordiale
dal guscio duro; e infatti alcuni circoli esoterici nell'ambito del culto di
Cibele vedevano il Padre universale nella figura di una mandorla. Il mandorlo è
venerato in molte culture ed è citato dieci volte nella Bibbia, a cominciare da
Genesi 43,11, dove le mandorle sono menzionate come uno dei "prodotti più scelti
del paese" di Canaan. Il suo nome ebraico, shaqed, letteralmente significa
"agitato", "scosso", per via del fatto che per raccogliere le mandorle se ne
scuotevano i rami; e siccome chi è scosso nel sonno non può dormire, la stessa
parola venne anche a significare "vigilante", e ciò anche perchè che il mandorlo
è uno dei primi alberi a fiorire in Israele, di solito all'inizio di febbraio,
in coincidenza con il Tu BiShvat (ט״ו בשבט), una festività ebraica
chiamata anche "Capodanno degli alberi". Al mandorlo come l'« albero che vigila
» si fa riferimento nel libro di Geremia quando il profeta di Anatoth
riconosce un ramo di mandorlo, e il Signore gli dice: « Hai visto bene, poiché
io vigilo sulla mia parola per realizzarla » (Ger 1,11). Anzi, addirittura Dio
stesso è 1'« albero che vigila », cioè il mandorlo! Quando nel deserto la
comunità israelitica mormorava contro i privilegi sacerdotali di Aronne e della
sua tribù, il Signore ordinò di prendere un bastone per ognuna delle dodici
tribù e di contrassegnarlo con il nome dei capiclan. il mattino successivo Mosè
entrò nella tenda del convegno, ed « ecco, il bastone di Aronne era
fiorito; aveva prodotto germogli, aveva fatto sbocciare fiori e maturato
mandorle » (Numeri 17,17-23). La tribù di Levi dunque doveva essere la prima sia
per il servizio prestato a Dio che per la dignità sacerdotale, così come il
mandorlo è il primo di tutti gli alberi a fiorire! Anche per i Padri della
Chiesa il ramo di mandorlo e il suo frutto erano simbolo del sacerdozio: la
condotta del sacerdote deve essere temperante e riservata verso l'esterno, come
dentro un guscio, mentre il suo intimo si nutrirò della fede quale alimento
invisibile. « Il ramo di mandorlo è Cristo », scriveva Paolino di Noia
(355-431). II dolce frutto nel duro guscio è diventato anche simbolo
dell'incarnazione di Cristo, e per questo nelle icone dell'oriente cristiano
Egli è sempre racchiuso dentro una « mandorla », l'aureola di forma ovale che si
incontra frequentemente nella rappresentazione di Cristo glorioso. Se è Maria ad
apparire nella mandorla, questo allude al fatto che Cristo fu generato in Maria,
come il nocciolo della mandorla si forma nel guscio che rimane intatto!

L'albero
che stermina i vampiri
Veniamo al
frassino. Fraxinus è un genere della famiglia
delle Oleacee, cui appartengono l'ulivo e il lillà, Oleaceae, che comprende
45-65 specie, di solito alberi di dimensioni medio-grandi, per lo più decidui,
anche se alcune specie subtropicali sono alberi sempreverdi; può arrivare fino a
40 m di altezza. Il genere è diffuso in gran parte dell'Europa, dell'Asia e del
Nord America. Le specie di questo gruppo hanno una crescita rapida, riescono a
sopravvivere in condizioni ambientali difficili come zone inquinate, con
salsedine o forti venti, e resistono bene anche alle basse temperature. In
genere il loro habitat si trova nelle regioni temperate e subtropicali
dell'emisfero settentrionale, ma anche in zone tropicali come il Messico, Cuba,
Giava e le Filippine. Le specie più diffuse in Italia sono il Fraxinus excelsior
o frassino maggiore, il Fraxinus ornus noto come
orno, utilizzato per la produzione della manna e
chiamato comunemente anche albero della manna, e il Fraxinus angustifolia o
frassino meridionale. Tutte e tre le specie
spontanee della flora italiana vivono sull'arco alpino.
Le foglie sono disposte in modo opposto, sono decidue (raramente sempreverdi),
sono picciolate e prive di stipole. La lamina è a forma pennata, raramente è
semplice. Le infiorescenze sono di tipo sia ascellare che terminale. Sono
presenti delle brattee da lineari a lanceolate. I fiori sono ermafroditi e
tetraciclici, ossia formati da 4 verticilli: calice, corolla, androceo e
gineceo. In questi fiori a volte il calice o la corolla possono mancare: ssono
allora fiori "nudi". Il frutto è una samara appiattita con un'unica ala
terminale e contenente un seme a forma oblunga. L'endosperma è carnoso.
La riproduzione avviene per impollinazione tramite insetti (entomogama) oppure
tramite il vento (anemogama). I semi caduti a terra dopo aver percorso alcuni
metri a causa del vento (dispersione anemocora) sono dispersi soprattutto da
insetti come le formiche (disseminazione mirmecoria). Il frassino gradisce
generalmente un'esposizione in pieno sole o mezz'ombra, si adatta a qualunque
tipo di terreno purché profondo e fresco, sopporta bene i terreni umidi e con
scarso drenaggio; per le specie coltivate come piante ornamentali occorre
prevedere un buon apporto idrico nella stagione secca e la lotta contro i
frequenti parassiti.
E' però un albero afflitto dai parassiti. Le foglie possono subire attacchi da
parte di insetti adulti e da larve di coleotteri e lepidotteri; la corteccia può
subire notevoli danni per le gallerie scavate dai coleotteri del genere
Lepersinus; le foglie e i rametti vengono facilmente attaccati dall'oidio; e il
legno può subire attacchi molto gravi dai funghi della Carie del Legno che
distruggono la lignina con enormi danni economici.
Il nome Fraxinus risale al latino classico usato già da Virgilio e poi dal
botanico francese Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708); secondo Guido Borghi
dell'Università di Genova, esso continua un antecedente indoeuropeo *bʱr̥h₁g̑s-ĕnŏ-s
o *bʱr̥h₁g̑s-ĭnŏ-s, derivato di *bʱĕrh₁g̑-ōs- "betulla", dalla radice √*bʱrĕh₁g̑-
"splendere", per il colore bianco della corteccia della betulla. Il nome inglese "ash" non ha niente a
vedere con il sinonimo "cenere": risale all'antico inglese "æsc", e questo al
nome proto-indoeuropeo *h₂eHs. Questo sembra provenire dalla radice *h₂eh₁- da
cui il proto-celtico *ā-tis ("forno") e il proto-indoeuropeo *h₂éh₁-tēr
("fuoco"), visto che ai boschi di frassino veniva frequentemente dato fuoco per
liberare spazio per l'agricoltura.
Il legno di frassino è largamente utilizzato perché è robusto e nello stesso
tempo leggero e flessibile. In passato era impiegato per la realizzazione dei
raggi delle ruote dei carri agricoli a trazione animale e per la realizzazione
di archi, racchette da tennis e da neve. La facilità nella sagomatura lo portò a
essere un legno particolarmente utilizzato durante la rivoluzione industriale
per la creazione di parti di oggetti comuni, come i manici degli ombrelli o
delle pentole. Nel Novecento fu usato da architetti e deisgner di tutto il
mondo, e proprio in frassino è realizzata la celeberrima sedia Superleggera di
Giò Ponti, presentata nel 1955, prodotta da Cassina a partire dal 1957 ed
esposta nei più importanti musei di design del mondo. Oggi con il legno di
frassino si fabbricano sci, eliche per aeroplani, utensili per giardinaggio,
manici per martelli e strumenti musicali. Il legno di frassino è anche un ottimo
combustibile, e i tronchi di questa pianta possono ardere bene anche quando sono
ancora freschi, perché contengono una sostanza infiammabile.
I frutti, le foglie, le radici e la corteccia di frassino hanno proprietà
leggermente lassative, diuretiche, antinfiammatorie, antireumatiche,
antiartritiche. L'analisi chimica giustifica queste proprietà con la presenza di
cumarine (fraxina, fraxetina, frassinolo, esculetina) e di flavonoidi (quercetina,
rutina, idrossiframoside), che inibiscono la produzione di mediatori
infiammatori endogeni come le prostaglandine. Dalla linfa che sgorga dal tronco
di alcune specie, come il Fraxinus excelsior e il Fraxinus ornus, si estrae una
sostanza chiamata manna, sostanza solida bianca-giallastra ricavata dal succo
zuccherino che si rapprende rapidamente a contatto dell'aria. Raccolta in
estate, è un blando purgante, ha proprietà anticatarrali, può essere usata come
collirio nelle congestioni oculari; pezzetti di manna sciolti in bocca
lentamente hanno proprietà espettoranti.
Il frassino viene citato nell'Iliade: l'asta di Achille sarebbe stata costruita
con un Frassino del monte Pelio. Il frassino era sacro al dio del mare Poseidone,
e al suo interno si credeva che dimorassero le ninfe Melíadi, dette appunto le
"ninfe del frassino". Quest'albero assunse però un ruolo centrale nella
mitologia norrena dove è noto come Yggdrasil, l'albero cosmico. Il suo nome
significa "cavallo di Yggr", dove "cavallo" è metafora per "patibolo", mentre
Yggr è uno dei tanti nomi di Odino, con riferimento al mito secondo cui Odino,
alla ricerca della sapienza suprema, rimase appeso per nove giorni e nove notti
all'albero cosmico, sacrificando così "sé stesso a sé stesso". Il frassino
Yggdrasill sorregge con i suoi rami i nove mondi, nati dal sacrificio di Ymir,
il gigante primordiale ucciso dai figli di Borr. Questi mondi sono Ásaheimr, il
mondo degli Asi (gli dèi); Álfheimr, il mondo degli elfi; Miðgarðr o "Terra di
Mezzo", il mondo degli uomini (nome reso celeberrimo dall'opera di Tolkien);
Jǫtunheimr, il mondo dei giganti (gli Jǫtunn); Vanaheimr, il mondo dei Vani, una
stirpe divina che aveva combattuto contro gli Asi; Niflheimr, il mondo del gelo
e della nebbia; Múspellsheimr, il mondo del fuoco; Svartálfaheimr, il mondo
degli elfi oscuri e dei nani; ed Helheimr, il mondo dei morti. Questi nove mondi
costituiscono l'intero universo. Immenso, Yggdrasill sprofonda sin nel regno
infero, mentre i suoi rami sostengono l'intera volta celeste. Esso poggia su tre
radici, da una delle quali nasce la fonte detta Hvergelmir ("Pozzo risonante"),
da cui si dipartono tutti i fiumi del mondo. Le tre Norme, che nella mitologia
norrena incarnano la saggezza, abitano alla base del Frassino Yggdrasil, sono
poste a sua protezione e lo innaffiano ogni giorno, perchè possa continuare a
crescere. Sulla sommita di Yggdrasil vive Víðópnir, gallo dorato il cui canto
annuncerà il Ragnarǫk, la fine del mondo. Secondo l'"Edda" del poeta islandese
Snorri Sturluson (1179-1241) l primo essere vivente di sesso maschile, Askr,
prese vita da un tronco di frassino.
Anche per i Celti il frassino era carico di significati. Simbolo di rinascita,
trasformazione ed iniziazione, era usato dai druidi in varie cerimonie rituali.
Esso era associato ai giovani guerrieri ai quali veniva consegnata una lancia
con cui il giovane avrebbe superato una serie di prove. Era apprezzato per le
sue qualità magiche e miracolose, quindi aveva valenza apotropaica: era
considerato un rimedio contro il malocchio scagliato dalle donne contro gli
uomini, e un amuleto per i pastori al fine di allontanare i serpenti dalle
greggi. In Irlanda la leggenda vuole che Fintan Mac Bochra, il primo druido che
giunse nell'isola dopo essere stato l'' a sopravvivere al Diluvio Universale
trasformandosi in salmone, piantò cinque alberi magici che avevano il compito di
segnare i confini delle province irlandesi (Leinster, Munster, Connaught, Ulster
e Meath), e tre di essi erano frassini. Per i guerrieri celti il frassino era il
pilastro del cielo al centro dell'Irlanda.
Gli Slavi credevano invece che il suo legno fosse l'' in grado di uccidere
un vampiro: per riuscirci bisognava piantargli nel cuore un paletto acuminato di
frassino mentre dormiva nella sua bara, per il colore bianco del legno di
frassino, segno di purezza angelica in contrapposizione ai demoni succhiasangue
della Transilvania. Questo mito è stato fatto conoscere in tutto il mondo da
centinaia di romanzi, fumetti, film e telefilm horror, a partire dal Conte
Dracula, il più noto tra i "non morti", creato nel 1897 dallo scrittore
irlandese Bram Stoker (1847-1912) ispirandosi alle leggende intorno al principe
di Valacchia Vlad III l'Impalatore (1431-1477), e dal primo film di vampiri, "Nosferatu,
il Principe della Notte" (1922), diretto da Friedrich Wilhelm Murnau (in rumeno
"Nosferatu" significa "Non spirato"), fino al parodistico "Dracula Morto e
Contento" (1995) di Mel Brooks con Leslie Nielsen e al simpatico "Vampiretto"
d'animazione (2017) di Richard Claus e Karsten Kiilerich.
In araldica, infine, il frassino è simbolo di padronanza assoluta per la sua
capacità, si dice, di elevarsi potente sino a sacrificare tutti gli alberi che
gli stanno intorno, con la sola eccezione dell'olmo. Con questo significato lo
ritroviamo ancor oggi nello stemma del comune italiano di Frassinoro, in
provincia di Modena, del quale è riconosciuto come simbolo fin dal XVI secolo.
E' proprio il caso di dire: nomen omen!

La
conifera della vita eterna
É venuto il turno del
cipresso. Cupressus è un genere di
conifere della famiglia delle Cupressaceae comprendente alberi anche di notevoli
dimensioni, alti fino a 50 metri, con chioma affusolata, molto ramificata e
rametti cilindrici con numerosissime piccole foglie ridotte a squame,
strettamente addossate le une alle altre o divaricate all'apice, secondo le
specie. In alcune specie, le foglie schiacciate rilasciano un caratteristico
odore. Il colore delle foglie è molto scuro nel cipresso diffuso in Italia (Cupressus
sempervirens), ma in altre specie è più chiaro (Cupressus macrocarpa), e persino
verdazzurro (Cupressus arizonica). I coni, detti galbuli, sono legnosi e
tondeggianti. Nessuna sua parte è commestibile dall'uomo, ma in fitoterapia
l'estratto delle sue gemme viene utilizzato come tonificante dell'apparato
vascolare. Il genere Cupressus è diffuso in tutte le regioni a clima caldo,
temperato e persino arido dell'emisfero settentrionale: America settentrionale e
centrale, Europa meridionale, Africa settentrionale, Asia dal Vicino Oriente
fino alla Cina e al Vietnam. Stenterete a crederlo, ma esistono cipressi persino
nel cuore del deserto del Sahara! Più di metà delle specie comunque sono
originarie del triangolo formato da California, Arizona e Messico. Alcune specie
di cipressi hanno avuto grande successo a scopo ornamentale e sono state
piantate nelle regioni a clima caldo o temperato di quasi tutto il mondo: tra
queste troviamo il cipresso toscano, Cupressus arizonica e Cupressus macrocarpa,
specie endemica di una ristretta zona della California attorno a Monterey. Dalle
nostre parti il più diffuso è il cipresso mediterraneo (Cupressus sempervivens)
dalla chioma particolarmente sottile e slanciata, che a volte arriva sino a
terra. Predilige aree a clima caldo, con estati secche, e soffre i freddi
prolungati, ma la sua riproduzione spontanea e l'adattabilità a tutti i tipi di
terreno lo ha portato a vegetare un po' ovunque, anche fino a 700 metri di quota
e su terreni aridi, così da essere usato anche come albero da rimboschimento
oppure come da frangivento, oltre ovviamente al suo uso prominente come pianta
ornamentale del giardino e del paesaggio. Le sue origini sono dibattute, ma si
pensa provenga dall'Iran e dal Mediterraneo orientale; sarebbe stato importato
nel Mediterraneo occidentale dai Fenici e dagli Etruschi per motivi ornamentali,
dal momento che la forma piramidale di alcune sue varietà è da sempre molto
apprezzata. Oggi comunque rappresenta una delle specie più caratteristiche della
flora della penisola italiana: affusolati e robusti insieme, con la loro
accentuata verticalità e il colore scuro, risaltano con grande incisività
rispetto all'orizzontalità di prati e campagne, più chiari, dal verde brillante
all'ocra. Secondo alcuni si tratta di un fossile vivente,
rappresentante della flora europea prima delle glaciazioni.
Tra i cipressi di particolare rilevanza nell'ambito del paesaggio italiano, va
ricordato il cosiddetto "Cipresso di San Francesco" a Verucchio (RN), monumento
vegetale di oltre 700 anni situato nel chiostro di un monastero francescano.
Secondo la tradizione, mentre il Santo di Assisi attraversava la Romagna, un
ramo di cipresso si impigliò nel suo saio. Egli lo prese e lo gettò nel fuoco,
ma esso non bruciava. "Se non vuoi bruciare, cresci!" gli ingiunse il Santo, e
lo piantò. Nonostante sia stato parzialmente danneggiato dai bombardamenti della
Seconda Guerra Mondiale, è ancora un albero monumentale di grande rilevanza
storica e spirituale. Vi sono poi il cosiddetto Cipresso di Michelangelo,
conservato forse fin dalla costruzione della Certosa delle Terme nel chiostro
dell'edificio, situato di fronte alla Stazione Termini in Roma (oggi inglobato
nel Museo Nazionale Romano), e il Viale dei Cipressi immortalato dal poeta
Giosuè Carducci nell'opera Davanti San Guido, che, con uno sviluppo rettilineo
di quasi 4 chilometri collega Bolgheri all'oratorio di San Guido, ed oggi
è soggetto a tutela nell'ambito del patrimonio storico nazionale. Impossibile
non citare il "Sarv-e Abarkuh", nella provincia di Yazd (Iran),
considerato monumento nazionale iraniano: ha una circonferenza di 18 metri e
un'età stimata di 4.000 anni, che lo rende il cipresso vivente più vecchio al
mondo!
E ora, immancabilmente, la sua simbologia. Associato al culto dei morti fin
dall'antichità, il cipresso era simbolo di vita eterna in Persia, dove
attecchì la religione di Zarathustra, e come tale appare anche in alcuni sigilli
a cilindro dell'antica Mesopotamia. Gli antichi Greci raccontavano il mito di
Ciparisso, un giovane che per errore uccise il suo cervo molto amato e che per
questo morì di dolore; Apollo, mossosi a pietà, lo trasformò in un cipresso. Fin
da quei tempi dunque l'albero era legato al dolore che si prova a causa della
morte di qualcuno particolarmente amato. I Romani e gli Etruschi ripresero
l'eredità greca del cipresso come albero sacro, legato al lutto e al funerale,
tanto che in ambito cristiano fu ritenuto uno dei quattro legni con cui fu
costruita la croce di Gesù, insieme alla palma, al cedro e all'ulivo (abbiamo
già parlato di tutti e tre). Ancor oggi il cipresso è l'albero tipico dei
cimiteri, perchè essendo sempreverde è un riferimento simbolico a una vita senza
fine, sia perché le sue radici, scendendo a fuso nella terra in profondità
invece che svilupparsi in orizzontale (come fanno le querce e gli altri alberi a
chioma larga), non rischiano di distruggere le sepolture circostanti. A questo
proposito non può non venire in mente l'incipit dei celeberrimi "Sepolcri"
(1807) di
Ugo Foscolo, scritti come reazione al napoleonico Editto di Saint Cloud, il
quale imponeva che le tombe dovevano essere poste al di fuori delle mura
cittadine, in luoghi soleggiati e arieggiati, e che fossero tutte uguali e senza
iscrizioni: « All'ombra dei cipressi e dentro l'urne / confortate di pianto, è
forse il sonno / della morte men duro? »
Nel campo delle arti figurative, oltre al fatto che il cipresso era uno degli
alberi preferiti da Vincent Van Gogh (1853-1890), non si può non citare "L'isola dei morti" ("Die Toteninsel"),
titolo di ben cinque dipinti del pittore svizzero Arnold Böcklin (1827-1901),
realizzati tra il 1880 e il 1886 e conservati a Basilea, New York, Berlino e
Lipsia (la quinta versione andò distrutta durante i bombardamenti della Seconda
Guerra Mondiale). Al centro di tutte le versioni si vede un isolotto
roccioso con pareti scoscese, leoni di pietra, bianchi templi e misteriose
camere sepolcrali, il tutto immerso in un fitto bosco di cipressi verdi scuro
che appaiono lugubri e altissimi. L'impressione complessiva è quella di uno
spettacolo di desolazione immerso in un'atmosfera misteriosa e ipnotica. Lo
specchio d'acqua che circonda l'isola è innaturalmente immobile, a tal punto da
sembrare quasi una pietra tombale, e su di essa scivola una piccola
imbarcazione, a poppa della quale vi è il nocchiero, chiara evocazione del
Caronte di dantesca memoria, mentre a prua si trova una misteriosa figura
ammantata completamente di bianco (forse un'anima) e un feretro ornato di
festoni. Secondo Giovanna Pimpinella l'isola dei morti non è che « un cimitero
mistico, nascosto all'uomo comune, fatto per ospitare le spoglie di persone
eccezionali e costruito come una casa ultraterrena », mentre per Pierluigi
Tombetti si tratta di « una sorta di palcoscenico dell'inconscio, un anfiteatro
naturale in grado di mostrare l'identità oscura della morte e dell'individuo che
[...] sospira una verità che non si può dire ad alta
voce ». Non sappiamo nulla dello spunto che spinse Böcklin a dare vita a questa
inquietante composizione, che potrebbe aver preso le mosse da una visione
onirica o da un'immagine reale (ad esempio l'isola di San Giorgio, presso le
bocche di Cattaro) poi rielaborata dal genio artistico e dall'inconscio del
pittore, che vide morire sei suoi figli. Di sicuro lo stesso autore afferma
di aver dato vita ad « un'immagine onirica che deve produrre un tale silenzio
che il bussare alla porta dovrebbe fare paura »; e deve esserci riuscito, se
Adolf Hitler volle una delle versioni del dipinto esposta nel suo studio nella
Cancelleria del Reich!
Nella Bibbia il cipresso è citato molte volte: nella nuova Gerusalemme crescerà
la gloria del Libano (cioè il cedro) e olmo e cipresso orneranno la sacra dimora
di Dio (ls 60,13). Nel giardino di Dio, oltre a cedri e platani, crescono anche
cipressi (Ez 31,8). Nel libro del profeta Osea 14,9 il Signore arriva a dire di
se stesso: « Io sono come un cipresso sempreverde »! Nell'arredare il tempio,
Salomone rivestì il vano più grande « con legno di cipresso » (2Cr 3,5). L'alto
cipresso rappresenta la sublimità della sapienza in Sir 24,13. Ma soprattutto,
secondo un'antica tradizione, l'arca di Noè sarebbe stata costruita in legno di
cipresso, in accordo con il significato simbolico di quest'albero quale
portatore di vita e di speranza nella sopravvivenza. In realtà, tra gli esegeti
la questione è controversa. Gen 6, 14 afferma letteralmente che l'arca
fu realizzata in « legno di gopher » (in ebraico גפר), termine in passato
tradotto con "legno di cipresso" (dopotutto anche il Tempio di Salomone era
stato costruito con questo legno!), ma oggi ciò non appare più convincente,
perchè la parola ebraica comunemente usata nella Bibbia per indicare il cipresso
è "erez". La Jewish Encyclopedia ipotizza che "legno di gopher" sia una
traduzione del babilonese "gushure iş erini", cioè "travi di cedro"; altre
traduzioni moderne parlano di "legno resinoso" sulla base della parola "kopher",
"resina"; le Bibbie della Riforma di solito si limitano a riportare il termine
originale senza tradurlo. Naturalmente, dato che il legno di cipresso era
servito per la decorazione dell'interno del tempio, quest'albero è divenuto ben
presto uno dei simboli di Maria, il cui corpo, analogamente alle pareti del
tempio, custodì il Santissimo per eccellenza, cioè il Cristo. Una visione
decisamente più rassicurante di quella di Arnold Böcklin!

L'iraniano "Sarv-e Abarkuh", il cipresso più vecchio del mondo
I
colossi della California
Imparentata con il cipresso è
la sequoia. Sequoia sempervirens è l'unica specie
vivente del genere Sequoia, che appartiene alla famiglia delle Cupressacee. È un
albero sempreverde, che vive dai 1.200 ai 2.200 anni o più. Questa specie
comprende gli alberi viventi più alti della Terra, che superano i 110 m di
altezza. Prima che il disboscamento iniziasse nel 1850, questo enorme albero si
trovava naturalmente in una striscia lunga 750 km e ampia circa 800.000 ettari
lungo gran parte della California costiera. La gamma fossile preistorica del
genere era notevolmente maggiore, con una distribuzione che include Europa e
Asia fino a circa 5 milioni di anni fa. Durante l'ultima era glaciale, forse non
più di 10.000 anni fa, le sequoie crescevano fino all'area di Los Angeles, come
dimostra una corteccia di sequoia costiera trovata negli scavi della
metropolitana.
Il primo a descrivere la sequoia fu il botanico scozzese David Don (1799-1841)
che nel 1824 la chiamò Taxodium sempervirens. Il botanico austriaco Stephan
Endlicher (1804-1849) ribattezzò il genere Sequoia nella sua opera del 1847 "Synopsis
coniferarum". Endlicher derivò il nome" Sequoia" da quello dello studioso di
etnia Cherokee Sequoyah (1770-1843), noto ai bianchi anche come George Gist, che
ideò il sillabario Cherokee ancora oggi usato (85 simboli alfabetici). In lingua
Cherokee, "Sequoyah" significa "passero". La sequoia costiera più antica
conosciuta ha circa 2.200 anni; molti altri esemplari in natura superano i 600
anni, mentre le numerose affermazioni su sequoie risalenti addirittura alla
Preistoria sono da considerarsi delle fake news, comunque esse sono diventate
simbolo di longevità se non addirittura di immortalità; in latino, "sempervirens"
significa "sempre verde" e quindi "eterno".
La sequoia ha una chioma conica, con rami orizzontali o leggermente ricadenti;
il tronco è straordinariamente dritto. La corteccia può essere molto spessa,
fino a 30 cm, e abbastanza morbida e fibrosa, con un colore rosso-marrone
brillante quando è appena esposta, ma con l'invecchiamento diventa più scura.
L'apparato radicale è composto da radici laterali poco profonde e ad ampia
diffusione. Le foglie sono lunghe 15–25 mm, squamose, di colore verde scuro
sopra e con due bande stomatiche bianche sulla faccia inferiore. La disposizione
delle foglie è a spirale, ma le foglie più grandi sono attorcigliate alla base
per la massima cattura della luce. La specie è monoica, con polline e pigne
sulla stessa pianta. I coni del seme sono ovoidali, di 15–32 mm di lunghezza,
con 15-25 squame disposte a spirale; l'impollinazione avviene a fine inverno con
maturazione circa 8-9 mesi dopo. I semi vengono rilasciati quando il cono si
secca e si apre a maturità.
L'intervallo di elevazione prevalente è di 30–750 m sul livello del mare,
occasionalmente fino a circa 900 m. Di solito crescono sulle montagne dove sono
maggiori le precipitazioni dovute all'umidità proveniente dall'oceano. Gli
alberi più alti e più vecchi si trovano nelle valli profonde e nei calanchi,
dove possono scorrere ruscelli tutto l'anno e la nebbia ristagna regolarmente.
Infatti l'altezza delle sequoie è strettamente legata alla disponibilità di
nebbia; man mano che l'altezza di Sequoia sempervirens aumenta, infatti, il
trasporto dell'acqua attraverso il tronco diventa sempre più difficile a causa
della gravità. Si ritiene che l'altezza potenziale massima teorica delle sequoie
costiere sia compresa tra 122 e 130 m, poiché la traspirazione rende
insufficiente il trasportare di acqua alle foglie oltre questo intervallo. Per
integrare il loro fabbisogno idrico, le sequoie utilizzano i frequenti eventi di
nebbia estiva, la cui acqua viene assorbita direttamente dalle foglie attraverso
il tessuto epidermico. La nebbia può anche raccogliersi sulle foglie di sequoia,
gocciolare sul suolo della foresta ed essere assorbita dalle radici dell'albero.
La nebbia può costituire il 30% dell'acqua totale utilizzata da un albero in un
anno! Senza la nebbia, le sequoie non potrebbero raggiungere dimensioni
gigantesche, e infatti gli alberi sopra lo strato di nebbia (circa 700 m) sono
più corti e più piccoli a causa delle condizioni più secche, ventose e fredde.
Poche sequoie crescono vicino all'oceano, a causa dell'intensa nebbia salina,
della sabbia e del vento. La coalescenza della nebbia costiera rappresenta una
parte considerevole del fabbisogno idrico degli alberi. La nebbia nel XXI secolo
è, tuttavia, ridotta rispetto a quella del secolo precedente, a causa del
cambiamento climatico. Le popolazioni più numerose e più alte si trovano nei
parchi nazionali di Redwood in California (contee di Del Norte e Humboldt) e
nell'Humboldt Redwoods State Park. Le sequoie costiere sono resistenti agli
attacchi di insetti, alle infezioni fungine e al marciume. Queste proprietà sono
conferite dalle concentrazioni di terpenoidi e acido tannico nelle foglie, nelle
radici, nella corteccia e nel legno della sequoia. Pare che gli orsi neri
consumino la corteccia interna di piccole sequoie e si sa che i cervi dalla coda
nera mangiano i germogli di sequoia. La corteccia spessa e fibrosa delle sequoie
costiere è estremamente resistente al fuoco; inoltre, le sequoie contengono poca
pece o resina infiammabile. Se danneggiata dal fuoco, una sequoia germoglia
prontamente nuovi rami o addirittura una corona completamente nuova, e se
l'albero genitore muore, nuovi germogli spuntano dalla sua base. Addirittura,
gli incendi sembrano avvantaggiare le sequoie, causando una sostanziale
mortalità nelle specie concorrenti, avendo solo effetti minori sulla sequoia, e
le aree bruciate sono favorevoli alla germinazione riuscita dei semi di sequoia.
Il maggior pericolo invece viene dal fatto che le sequoie crescono spesso in
aree soggette a inondazioni: il terreno instabile nelle aree allagate spesso fa
inclinare gli alberi su un lato, aumentando il rischio che il vento li faccia
cadere.
La sequoia è una delle specie più pregiate nell'industria del legname. La
Pacific Lumber Company (1863-2008) della contea di Humboldt, in California,
possedeva e gestiva oltre 810 km quadrati di foreste di sequoie. Il legname di
sequoia costiera è molto apprezzato per la sua bellezza, leggerezza e resistenza
alla decomposizione; la sua mancanza di resina gli fa assorbire l'acqua e
resistere al fuoco. Nel grande incendio di San Francisco, iniziato il 18 aprile
1906, i vigili del fuoco riuscirono finalmente a fermarlo in quasi tutte le
direzioni dove la finitura esterna di questi edifici era di legno di sequoia
legname. A causa della sua impressionante resistenza alla decomposizione, la
sequoia è stata ampiamente utilizzata per le traversine ferroviarie in tutta la
California. La sequoia costiera è stata trapiantata in Nuova Zelanda più di
cento anni fa, in particolare nella foresta di Whakarewarewa, e quelle piantate
in Nuova Zelanda hanno tassi di crescita più elevati rispetto a quelle della
California, principalmente a causa della distribuzione uniforme delle
precipitazioni durante l'anno. Le sequoie costiere sono state utilizzate in
un'esposizione al Rockefeller Center e poi date alla Longhouse Reserve a East
Hampton (Long Island, New York):vivono lì da oltre vent'anni e sono
sopravvissute a temperature di - 17 ° C.
Come si è detto, le sequoie sono gli alberi più alti del pianeta Terra. Nel 1893
una sequoia tagliata al fiume Eel in California settentrionale avrebbe misurato
130,1 m di altezza e 23,5 m di circonferenza, ma il record non è stato
confermato per l'assenza di solide prove storiche. Oggi sono comuni alberi
superiori ai 60 m, e molti superano i 90 m. L'albero più alto conosciuto è il
cosiddetto "Hyperion", che misura 115,61 m (o 379,3 piedi, come si ostinano a
dire in America). Esso è stato scoperto nel Redwood National Park nel 2006 da
Chris Atkins e Michael Taylor, e si pensa che sia l'organismo vivente più alto
del mondo; la sua esatta posizione è tenuta segreta per motivi di sicurezza.
Fino alla sua caduta nel marzo 1991, il detentore del record era il "Dyerville
Giant"; si trovava nell'Humboldt Redwoods State Park, era alto 113,4 m e si
stima che avesse 1.600 anni; questo gigante caduto è stato preservato
all'interno del parco. La sequoia più alta facilmente accessibile al pubblico è
il "National Geographic Tree", alto 112,71 metri, nel Redwood National Park.
Invece la più grande sequoia vivente conosciuta è il "Generale Sherman", situato
a un'altitudine di 2.109 m sul livello del mare nella Giant Forest of Sequoyah
National Park nella contea di Tulare: con un volume di 1487 metri cubi, è il più
grande albero vivente a stelo singolo conosciuto sulla Terra, e si stima che
abbia un'età compresa tra 2.200 e 2.700 anni. Questo albero prende il nome dal
generale della guerra civile americana William Tecumseh Sherman (1820-1891), uno
dei massimi geni militari dell'età moderna, che avrebbe potuto diventare il
primo Presidente USA di religione cattolica (il Partito Repubblicano gli chiese
di candidarsi, ma lui fu più furbo e rifiutò). Un racconto, forse apocrifo,
afferma che l'albero sia stato battezzato con il suo nome nel 1879 dal
naturalista James Wolverton, che aveva servito come tenente nella 9a cavalleria
dell'Indiana sotto Sherman. Nel 1886 l'attuale territorio del parco passò sotto
il controllo della colonia di Kaweah, una comunità socialista utopica la cui
economia era basata sul disboscamento. Avendo in odio il ruolo che Sherman aveva
svolto nelle guerre indiane e nel trasferimento forzato di alcune tribù native
americane dentro le riserve, i suoi abitanti ribattezzarono l'albero in onore di
Karl Marx. La comunità fu sciolta nel 1892, principalmente in seguito
all'istituzione del Sequoyah National Park, e l'albero tornò al suo nome
precedente. Sebbene il "Generale Sherman" sia il più grande albero attualmente
vivente, non è il più grande albero registrato storicamente: il "Lindsey Creek
Tree" aveva un volume di più di 2.500 metri cubi, quasi il doppio del "Generale
Sherman", fu abbattuto da una tempesta nel 1905. Uno dei più grandi ceppi di
sequoia mai trovati, che misura 9,4 m di diametro, si trova a Oakland, sulle
Berkeley Hills, naturalmente in California.
Infine, avete mai sentito parlare degli « alberi di navigazione Blossom Rock »?
Erano due sequoie particolarmente alte situate nelle Berkeley Hills, utilizzate
come ausilio alla navigazione dai marinai per evitare l'infido scoglio Blossom
Rock, che si trovava a un metro e mezzo di profondità vicino all'isola di Yerba
Buena, nella Baia di San Francisco, ed essendo invisibile era un pericolo per i
naviganti. L'osservazione delle due sequoie aiutava le navi ad evitare la
roccia. Il disboscamento iniziato intorno al 1840 tuttavia non le risparmiò, e
nel 1860 praticamente nessuna delle vecchie sequoie era rimasta visibile dalla
baia, eliminando il principale mezzo per avvertire le navi della posizione di
Blossom Rock. La marina americana ha provato più volte a posizionare boe attorno
allo scoglio, ma ogni volta il mare agitato nella baia ha spazzato via le boe.
La perdita delle sequoie ha creato un tale problema di navigazione che i
migliori ingegneri degli Stati Uniti sono stati incaricati di rimuovere
fisicamente l'ostacolo; lo scoglio fu fatto brillare con potenti cariche di
esplosivo nel 1870. Siccome l'Homo sapiens ha la coscienza sporca, nel 1984 il
sito degli alberi di navigazione è stato nominato monumento storico dallo stato
della California; una targa indica il luogo dove sorgevano, e attualmente
nell'area ci sono sequoie in crescita che sono germogli spuntati dai ceppi degli
alberi originali. Per fortuna la Natura trova sempre il modo di rigenerarsi!

La monumentale sequoia "Generale Sherman", nel Sequoyah National Park
L'albero capovolto
In tema di alberi esotici,
oggi vi parlerò del baobab (Adansonia digitata).
Esso cresce tipicamente nelle savane secche e calde dell'Africa subsahariana,
dove dominano il paesaggio e rivelano da lontano la presenza di un corso
d'acqua. I baobab spesso crescono come individui solitari fino a 25 metri di
altezza. Il tronco è tipicamente largo e scanalato o cilindrico, spesso con una
base allargata. I tronchi possono raggiungere un diametro di 15 metri e possono
essere costituiti da più steli fusi attorno a un nucleo cavo. La corteccia è
grigia e generalmente liscia, i rami principali possono essere enormi. Tutti i
baobab sono decidui, perdono le foglie nella stagione secca e rimangono senza
foglie per circa otto mesi all'anno. Le foglie sono palmate e composte negli
alberi maturi, ma le piantine e i germogli possono avere foglie semplici: il
passaggio alle foglie composte arriva con l'età e può essere graduale. La
fioritura avviene sia nella stagione secca che in quella umida. I boccioli sono
arrotondati con una punta a forma di cono. I fiori sono appariscenti e
solitamente prodotti singolarmente all'estremità di un gambo pendente dai 15 ai
90 centimetri di lunghezza. I petali sono bianchi e sono accartocciati in
boccio. I fiori si aprono nel tardo pomeriggio, restando aperti e fertili solo
per una notte; hanno un profumo dolce, ma dopo circa 24 ore iniziano a diventare
marroni ed emettono un odore di carogna! I granelli di polline sono sferici con
punte sulla superficie, tipici della famiglia delle Malvacee. L'impollinazione
nel baobab africano è compiuta principalmente dai pipistrelli della frutta.
Tutti gli Adansonia sviluppano grandi frutti arrotondati indeiscenti che possono
essere lunghi fino a 25 cm, con un guscio esterno legnoso. I frutti del baobab
africano hanno una forma abbastanza variabile, da rotonda a cilindrica. Il
guscio ha uno spessore di 6-10 millimetri, e all'interno è presente una polpa
carnosa di colore beige chiaro. Mentre si asciuga, la polpa si indurisce in una
polvere friabile. I semi sono duri e a forma di rene; restano dormienti a lungo,
e con il loro rivestimento duro possono resistere all'essiccazione e rimanere
vitali per lunghi periodi. I frutti vengono mangiati da molte specie e il
potenziale di germinazione è migliorato quando i semi sono passati attraverso il
tratto digestivo di un animale o sono stati sottoposti al fuoco. Si pensa che
ciò sia dovuto al fatto che il rivestimento del seme deve essere rotto o
assottigliato per consentire all'acqua di penetrare prima che il seme possa
germogliare. Elefanti e babbuini sono i principali agenti di dispersione e i
semi possono potenzialmente essere dispersi su lunghe distanze. I frutti
galleggiano ei semi sono impermeabili, quindi anche i baobab africani possono
essere diffusi dall'acqua. Alcuni aspetti della biologia riproduttiva del baobab
non sono ancora stati compresi, ma si pensa che per sviluppare un seme fertile
sia necessario il polline di un altro albero. Alberi isolati senza una fonte di
polline da un altro albero formano dunque frutti, ma solo per abortirli in una
fase successiva. L'esistenza di alcuni alberi molto isolati può quindi essere
dovuta alla loro capacità di disperdere i semi su lunghe distanze.
Gli alberi di baobab sono ricercatissimi perchè hanno la simpatica
caratteristica di immagazzinare l'acqua nei loro tronchi e rami su base
stagionale poiché vivono in aree di siccità prolungata e scarsa accessibilità
all'acqua. Il materiale spugnoso della corteccia consente all'acqua di essere
assorbita più in profondità nel tessuto, poiché durante la stagione delle piogge
raramente c'è abbastanza pioggia da penetrare nel suolo. I rami a forma di U
consentono all'acqua di gocciolare verso il basso, permettendo il massimo
assorbimento per un lungo periodo di tempo anche dopo che la pioggia si è
fermata. L'acqua viene assorbita nel tessuto vascolare dell'albero, dove può
essere spostata nelle cellule del parenchima dell'albero (i parenchimi sono
cellule di tessuto vegetale molle che vengono comunemente utilizzate per la
conservazione dell'acqua in altre specie resistenti alla siccità come cactus e
piante grasse) per la conservazione a lungo termine: un grande baobab può
immagazzinare fino a 136.000 litri d'acqua!
Durante la stagione secca, gli alberi eliminano tutte le foglie, la
circonferenza del tronco si riduve di circa 2-3 cm e il contenuto di acqua dello
stelo diminuisce di circa il 10%. La caduta delle foglie durante la stagione
secca è necessaria per prevenire la perdita d'acqua attraverso la traspirazione,
che farebbe scendere troppo i potenziali idrici nel tessuto vascolare e farebbe
uscire l'acqua dai vacuoli nelle cellule del parenchima, uccidendo l'albero. Gli
alberi di baobab hanno un contenuto di acqua e parenchima molto più elevato
rispetto alla maggior parte degli alberi, e questo consente loro di crescere
molto grandi con un minore dispendio energetico.
Il tasso di crescita degli alberi di baobab è determinato dalle falde acquifere
o dalle precipitazioni. Gli alberi producono deboli anelli di crescita, ma il
conteggio di tali anelli non è un modo affidabile per stimare l'età dei baobab
perché in certi anni un albero forma più anelli, e in altri anni nessuno. La
datazione al radiocarbonio invece ha fornito dati su alcuni notevoli esemplari
di Adamsonia digitata. Il baobab Panke nello Zimbabwe aveva circa 2.450 anni
quando morì nel 2011, e questo fa di lui la angiosperma più antica mai
documentata; si stima che altri due alberi, Dorslandboom in Namibia e Glencoe in
Sud Africa, avessero circa 2.000 anni. I baobab possono essere così longevi
anche grazie alla loro capacità di germogliare periodicamente nuovi steli.
E ora, la consueta etimologia. Il nome comune viene dal francese "baobab",
attestato anche nel latino medievale intorno al 1590 come "bahobab", a sua volta
di origine africana. L'etimo esatto non è noto, ma potrebbe derivare dall'arabo
بو حباب "būħibāb", cioè "padre di molti semi". Il nome scientifico Adansonia è
un omaggio all'esploratore e botanico francese Michel Adanson (1727–1806),
autore nel 1749 della prima descrizione botanica dell'intera pianta di Adansonia
digitata sull'isola di Sor, in Senegal. "Digitata" si riferisce alle dita della
mano, poiché il baobab ha foglie composte con normalmente cinque (ma talvolta
fino a sette) foglioline, simili a una mano. Alcune popolazioni di baobab
africano presentano differenze genetiche significative, ed è stato suggerito che
il taxon contenga più di una specie. Ad esempio, la forma del frutto varia
notevolmente da regione a regione: in Angola i frutti sono allungati, piuttosto
che rotondi. Una nuova specie proposta (Adansonia kilima) è stata descritta nel
2012, trovata in siti ad alta quota nell'Africa orientale e meridionale, ma non
è stata riconosciuta come specie distinta. Alcuni alberi ad alta quota in
Tanzania mostrano genetica e morfologia diverse, ma sono necessari ulteriori
studi per determinare se debbano essere considerati una specie separata.
Veniamo alla storia. Non abbiamo prove che i Greci e i Romani lo conoscessero,
anche se la cosa non può essere esclusa perchè essi avevano rapporti commerciali
con i Garamanti del deserto libico, e alcuni arditi esploratori romani si
spinsero fino al lago Ciad. I primi rapporti scritti sul baobab africano
provengono dal diario di viaggio del XIV di secolo del marocchino Abd Allāh ibn
Muḥammad Ibn Baṭṭūṭa (1304-1369), da alcuni considerato il più grande
viaggiatore del Medioevo. La prima descrizione in Europa la si deve al medico
vicentino Prospero Alpini (1553-1616) nel 1592, che ne studiò i frutti da lui
scoperti in Egitto; fu lui, pare, a chiamarlo per primo Bahobab. Altri nomi
comuni includono: albero del pane delle scimmie (il frutto morbido e secco è
commestibile), albero capovolto (i rami radi assomigliano a radici) e albero del
cremor tartaro, a causa della polpa polverosa del frutto.
Originario dell'Africa continentale (si discute se nello Yemen e nell'Oman sia
stato introdotto dall'uomo o se vi fosse nativo), il limite settentrionale della
sua distribuzione in Africa è associato all'andamento delle precipitazioni; solo
sulla costa atlantica e nella savana sudanese la sua presenza si avventura
naturalmente nel Sahel. La sua presenza è molto limitata nell'Africa centrale e
si trova solo nell'estremo nord del Sudafrica. In Angola e Namibia i baobab
crescono nei boschi e nelle regioni costiere, oltre che nelle savane. I
commercianti arabi lo introdussero nel Madagascar nordoccidentale, dove gli
alberi di baobab venivano spesso piantati al centro dei villaggi. Il baobab è
l'albero nazionale del Madagascar e del Senegal. È stato
introdotto anche a Giava, Nepal, Sri Lanka, Filippine, Giamaica, Porto Rico,
Haiti, Repubblica Dominicana, Venezuela, Seychelles, India e Yunnan (Cina
meridionale). All'interno del forte di Golconda a Hyderabad, in India, c'è un
baobab che si stima abbia 430 anni: è il baobab più grande al di fuori
dell'Africa. Il baobab è un albero protetto in Sud Africa, dove è minacciato da
attività minerarie e agricole. Nel Sahel gli effetti della siccità, della
desertificazione e dell'uso eccessivo del frutto sono motivi di preoccupazione
per la conservazione della specie, visto che vi sono prove che le popolazioni
siano in declino. Molti dei più grandi e antichi baobab africani sono morti
negli ultimi anni, naturalmente a causa dei soliti fattori: gas serra,
cambiamenti climatici e riscaldamento. Ormai lo sappiamo: nella cristalleria c'è
un elefante, noi ne vediamo solo la coda e per lo più neghiamo l'evidenza e
sosteniamo che quella non sia una coda e che non ci sia nessun elefante, ma
presto o tardi esso si scuoterà, combinerà un patatrac e l'intero Antropocene
potrebbe andare verso il collasso.
Eppure i frutti, la corteccia, le radici e le foglie di baobab sono una fonte di
cibo fondamentale per molti animali, e gli alberi stessi sono un'importante
fonte di ombra e riparo. Le popolazioni africane hanno tradizionalmente
apprezzato gli alberi come fonti di cibo, acqua, rimedi per la salute o luoghi
di riparo. Il baobab infatti è una pianta alimentare tradizionale in Africa,
anche se è poco conosciuta altrove per questo scopo; anzi, lo stesso Adanson ha
concluso che il baobab, di tutti gli alberi africani da lui studiati, "è
probabilmente l'albero più utile di tutti": come scrisse nel suo diario, mentre
era in Africa egli consumava succo di baobab due volte al giorno, ed era
convinto che mantenesse in buona salute. Di sicuto quel succo può aiutare a
curare la diarrea. Le radici e i frutti sono commestibili; è stato suggerito che
il frutto abbia il potenziale per migliorare la nutrizione, aumentare la
sicurezza alimentare, favorire lo sviluppo rurale e sostenere la cura
sostenibile del territorio. n Sudan, dove l'albero è chiamato tebeldi (تبلدي),
le persone preparano il succo di baobab immergendo e sciogliendo la polpa secca
del frutto in acqua estratta dallo stesso tronco. Le foglie di baobab sono
ricche di sostanze fitochimiche e minerali e possono essere mangiate come
condimento: le giovani foglie fresche vengono cotte in una salsa e talvolta
vengono essiccate e polverizzate; tale polvere in Mali si chiama "lalo" e viene
venduta in molti mercati di villaggio dell'Africa occidentale; oppure sono
utilizzate nella preparazione di una zuppa che nel nord della Nigeria è chiamata
"miyan kuka". Dai semi triturati si ricava una farina o un olio per cucinare. Le
foglie di baobab sono utilizzate anche come foraggio per i ruminanti nella
stagione secca. La farina d'olio, che è un sottoprodotto dell'estrazione
dell'olio, può essere utilizzata anche come mangime per animali. In tempi di
siccità, gli elefanti consumano il succoso legno sotto la corteccia del baobab.
La fibra della corteccia poi può essere utilizzata per realizzare tessuti.
Nel 2008 l' Unione Europea ha approvato l'uso e il consumo del frutto del
baobab, comunemente usato come ingrediente in frullati e barrette di cereali.
Nel 2009 anche la Food and Drug Administration degli Stati Uniti d'America ha
riconosciuto come ingrediente alimentare sicuro la polpa di frutta secca di
baobab.
Chiudiamo come sempre con i riferimenti culturali. Lungo lo Zambesi, le tribù
aborigene credevano che i baobab fossero creature troppo orgogliose; gli dèi si
adirarono, li sradicarono e li gettarono di nuovo nel terreno a testa in giù;
oggi gli spiriti maligni causano sfortuna a chiunque ne raccolga i dolci fiori
bianchi. Si tratta di un evidente mito eziologico per spiegare il loro aspetto
di "alberi capovolti". Anche Dante parla di un albero capovolto nella V Cornice
del Purgatorio, quella dei Golosi (« e come abete in alto si digrada / di ramo
in ramo, così quello in giuso, / cred'io, perché persona sù non vada. » Purg,
XXII,133-135), ma ovviamente non vi è alcuna relazione tra esso e i baobab.
Nel Kafue National Park, uno dei più grandi baobab è conosciuto come "Kondanamwali"
o "l'albero che mangia le fanciulle". Secondo la leggenda locale, l'albero si
innamorò di quattro bellissime ragazze; quando raggiunsero la pubertà, resero
geloso l'albero sposandosi. Così una notte, durante un temporale, l'albero aprì
il suo tronco e chiuse dentro di esso le fanciulle; nelle notti di tempesta si
sentirebbe ancora il pianto delle fanciulle imprigionate. Alcune tribù africane
credono che le donne che vivono nei kraal dove abbondano i baobab avranno più
figli. Ciò è scientificamente plausibile, in quanto quelle donne avranno un
migliore accesso alle foglie e ai frutti ricchi di vitamine dell'albero per
integrare una dieta di solito carente di vitamine.
Il nostro albero ha anche un ruolo nel celeberrimo romanzo per bambini "Il
piccolo principe" di Antoine De Saint-Exupéry (1900-1944): in esso i baobab sono
descritti come piante pericolose che devono essere eliminate dalle piante buone,
per non superare in grandezza il piccolo pianeta su cui crescono e rischiare
così di farlo a pezzi. Il mandrillo sciamano Rafiki, personaggio centrale del
film di animazione Disney "Il Re Leone" (1994), ha la sua casa dentro un baobab. Ma la più notevole citazione letteraria del baobab è
senz'altro quella contenuta nel poema epico Mandinka « Son-Jara », il primo
capolavoro della letteratura africana, prima tramandato oralmente e più tardi
messo per iscritto in caratteri arabi. Eccone in succinto la trama. Siamo in
Africa Occidentale, nel XIII secolo, più o meno all'epoca di Francesco d'Assisi
e di Federico II di Svevia. Naré Maghann Konaté, re dei Mandinka, popolo della
vallata del Niger, si sente profetizzare da una strega che, se sposerà una donna
bruttissima, da lui nascerà un figlio potentissimo. Nonostante sia già sposato
con la bellissima Sassouma Berté, da cui ha avuto un figlio altrettanto bello,
Dankaran Toumani Keita, accetta così di sposare una donna bruttissima dell'etnia
Do, Sogolon, che in lingua locale significa "la donna bufalo" per la sua
bruttezza. Da questa ha un figlio, altrettanto brutto, che chiama Sundiata Keita,
incapace di camminare e di parlare. La prima moglie lo convince a scacciare
Sogolon e suo figlio Sundiata, e a nominare erede Dankaran Toumani. Sogolon, che
ha avuto altri due figli (di cui una con la vocazione di maga) e ne ha adottato
un quarto dalla terza moglie di Naré Maghann Konaté, Namandjé, va in esilio nel
vicino regno Mena, dove morirà qualche anno dopo.
Quando re Naré Maghann Konaté muore, gli succede il figlio di primo letto
Dankaran Toumani Keita, bellissimo ma politicamente e militarmente inetto. Ma
ecco che Soumaoro Kante, crudele re dei Sosso e conquistatore dell'intera
vallata del Niger, attacca il regno Mandinka: Dankaran Toumani pensa bene di
fuggire a gambe levate, abbandonando il regno a sé stesso. Allora i sacerdoti
dei Mandinka si ricordano della profezia fatta a Naré Maghann Konaté, e decidono
di inviare ambasciatori a Mena per richiamare Sundiata. Quest'ultimo, a dispetto
della malformazione alla nascita, si è fatto intanto un giovane forte e
invincibile in battaglia: la leggenda racconta che, appena ha imparato a
camminare, ha sradicato per l'appunto un gigantesco baobab dalla piazza centrale
di Mena e lo ha trapiantato davanti alla capanna di sua madre. Egli accetta
l'invito di tornare presso i Mandinka per difenderli da Soumaoro Kante, ma il re
di Mena non vuole privarsi di lui e vuole dargli in sposa sua figlia. Durante la
notte, sempre secondo la leggenda, il re è destato dal fantasma furioso di un
bufalo: è Sogolon, che non vuole che suo figlio sia privato del proprio destino
di gloria. Così Sundiata Keita torna presso i Mandinka e si oppone a Soumaoro
grazie all'aiuto della sorella, divenuta una potente maga, e di un guerriero di
proporzioni gigantesche, incontrato durante l'avventuroso ritorno in patria.
Lo stregone Soumaoro tuttavia usa la magia in battaglia, impedendo a Sundiata di
prevalere: in particolare, nessun tipo di freccia, anche trafiggendolo, riesce
ad ucciderlo. Allora la sorella di Sundiata, che è maga pure lei, si presenta
con un carro di ossa animali alla residenza fortificata di Soumaoro, protetta da
un branco di iene affamate, e si fa portare dal re-stregone, che nella sua sala
del trono tiene le teste di dodici re uccisi. Soumaoro resta stregato dalla sua
bellezza, la vuole in sposa e tenta di farla ubriacare, ma ella è una maga e ad
ubriacarsi è Soumaoro che, prima di stramazzare al suolo, le rivela scioccamente
il suo segreto: può essere ucciso solo da una freccia fatta con uno sperone di
gallo. Le iene impediscono a chiunque di uscire, ma la maga rovescia il carro di
ossa, le iene si accaniscono a divorarle ed ella si defila, rivelando al
fratello quanto ha scoperto. Quando Soumaoro si desta non ricorda di aver
rivelato il proprio prezioso segreto, ma le teste dei dodici nemici riprendono
vita e gli predicono la morte per mano di Sundiata. Per cercare di stornare da
sé questo destino il re dei Sosso ingaggia subito battaglia con i Mandinka, ma
vede Sundiata puntare su di lui una freccia fatta con uno sperone di gallo.
Tenta una fuga disperata, ma è bloccato dal nero uccello della sconfitta,
inviato dalla sorella di Sundiata. Appena la freccia lo coglie, il suo corpo si
dissolve in sabbia e, dove cadono i suoi bracciali, nasce una pianta mostruosa.
Sundiata ha vinto: si proclama Mansa, "Re dei Re", e fonda l'Impero del Mali. I
dodici nemici uccisi da Soumaoro sono riportati in vita da sua sorella e
diventano i suoi dodici vassalli, i feudatari dei dodici reami in cui divide il
suo impero: Djebeda, Tabon, Negueboria, Kankigne, Togom, Sili, Krina, Koulikoro,
Diaghan, Kita, Ka-Ba e Wagadou. Anni dopo, Sundiata Keita scomparirà
attraversando il fiume Sankarini, ed al suo posto riemergerà un ippopotamo
(secondo alcuni in lingua locale Mali significa proprio "ippopotamo"). Ogni
grande impero ha alla sua origine un supereroe fondativo, da Sargon di Akkad
fino a George Washington, ma certo nessuna epopea è più affascinante di quella,
affatto sconosciuta in Europa, di un bambino nato deforme che rivelò la sua
missione di origine divina trapiantando un baobab con le proprie mani!

Due giganti della savana: un elefante africano e un imponente baobab del Parco Nazionale del Ruaha in Tanzania
I
ramoscelli tanto cari a Panoramix
Il vischio (Viscum album) è
una pianta cespugliosa della famiglia delle Santalacee.
È una sempreverde parassita di numerosi alberi ospiti, in
particolare conifere e alcune latifoglie come pioppi, salici, aceri, betulle.
Invece non cresce mai su faggi, platani e noci. Fagus, Se ne può notare la
presenza specialmente nei boschi in inverno, quando i suoi cespugli
cresciuti sui tronchi e sui rami sono più evidenti grazie all'assenza di foglie
della pianta ospite.
Il vischio ha fusti lunghi da 30 a 100 centimetri, le
foglie sono oblunghe e coriacee, lunghe da 2 ad 8 centimetri, larghe 0,8–2,5 centimetri, di colore
verde-giallastro.
La foglia verde del vischio indica la presenza di clorofilla, quindi questa
pianta è in grado di compiere la fotosintesi; tuttavia, pur essendo in grado di farlo,
sottrae acqua, sali minerali e azoto dalla pianta ospite. Alla base del fusto
principale sono prodotti cordoni verdi che penetrano all’interno della corteccia
dell’ospite e generano delle propaggini, le quali si allungano fino al tessuto
conduttore. Il vischio ha fiori unisessuali poco appariscenti, riuniti in glomeruli; i fiori maschili
sono privi di calice, quelli femminili hanno sia calice che corolla. La specie è dioica,
e i fiori sono impollinati dagli insetti.
I frutti sono bacche sferiche o ovoidali, bianche o giallastre translucide,
contenenti semi di 5–6 mm, appiattiti sui lati e immersi in una polpa gelatinosa
e vischiosa.
Le bacche, trasportate e disperse dagli uccelli che se ne cibano in inverno, si
infilano nelle intercapedini di un ramo di una pianta ospite, e i semi ivi
contenuti iniziano a germinare. Attraverso un cono di penetrazione ha inizio la
formazione di un piccolo tronco e lo sviluppo della pianta.
Non ci crederete, ma il vischio può venire coltivato.
La coltivazione del vischio si pratica per fini ornamentali e per
l'erboristeria, recidendo in primavera una parte di ramo da una pianta ospite e
innestando, schiacciandola, una bacca di vischio matura. Dopo un lento sviluppo,
che può durare anche un paio di anni, inizia la crescita spontanea. Di solito la
pianta ospite non subisce danni, a patto che non ci siano troppi polloni di
vischio: in tal caso per liberarsene si dovrà recidere il ramo. Il succo delle
bacche veniva usato per preparare colle usate per catturare uccelli, per via del
suo aspetto colloso. Per questo oggi si dice "vischiosa" una sostanza
attaccaticcia, una persona particolarmente noiosa o una situazione in cui è
meglio non rimanere intrappolati (o, per l'appunto, « invischiati »). Infatti la
parola "vischio" deriverebbe da una radice indoeuropea che significa "molle",
"appiccicoso", da cui anche la parola "viscere". In Fisica si dice "attrito
viscoso" quello avvertito dai corpi dentro una sostanza fluida, ad esempio un
paracadutista che scende nell'atmosfera. L'attrito viscoso è assai minore di
quello radente (per strisciamento) o volvente (per rotolamento), e da qui deriva
la lubrificazione degli ingranaggi con olio.
Ma attenzione: i frutti del vischio sono velenose, e ci si può ammalare gravemente mangiandone le bacche.
Gli estratti concentrati possono causare un'intossicazione importante, che può
manifestarsi con diplopia, ipotensione, confusione mentale,
allucinazioni, convulsioni. Dal vischio è stata isolata la lectina tossica
viscumina, una proteina
inattivante ribosoma (RIP, per ironia dellla sorte significa anche Riposi In
Pace!) che si lega ai
residui di galattosio delle glicoproteine sulla superficie cellulare e può
essere assorbita dall'endocitosi. La viscumina inibisce fortemente la
sintesi proteica con conseguenze che, ad alte dosi, possono anche essere letali.
Nonostante questo, il vischio viene impiegato nella medicina tradizionale sotto forma di tinture o
infusi, come antipertensivo e anti-arteriosclerotico. Nel Nepal diversi tipi di
vischio sono usati per una varietà di scopi medici, in particolare per il
trattamento delle fratture ossee (naturalmente non vi sono
al momento studi clinici che confermino tali effetti). Per queste sue proprietà
curative era utilizzato già dai popoli scandinavi in epoca precedente alla
conversione al cristianesimo; però, come ha scritto Wilhelm Pelikan,
« il vischio, che per lungo tempo non ha giocato alcun ruolo speciale come pianta
medicinale, ed era stato pressoché dimenticato dalla medicina moderna, è stato
messo, da qualche decennio a questa parte, al centro di una nuova corrente della
medicina; questo dopo che Rudolf Steiner l'ha indicato come base di un
medicamento che combatte il carcinoma nelle sue differenti forme. »
Il vischio è una delle sostanze più
studiate nella cosiddetta medicina alternativa e complementare per la lotta al cancro:
sbene non esistano prove a sostegno dell'idea
che la stimolazione del sistema immunitario da parte del vischio porti a una
migliore capacità di combattere il tumore, la ricerca di base con estratti di
vischio ha fornito spunti per ulteriori indagini sul possibile uso del vischio
come prodotto di supporto nell'intero trattamento oncologico. Gli estratti di
vischio sono stati valutati in numerosi studi clinici, e spesso sono stati
segnalati miglioramenti della qualità e aspettativa di vita. Tuttavia, secondo
alcuni critici, la maggior parte degli studi clinici condotti fino ad oggi hanno
avuto uno o più importanti punti deboli che hanno sollevato dubbi
sull'affidabilità dei risultati. Inoltre, la possibilità di condurre studi di
controllo randomizzati in doppio cieco con estratti di vischio è limitata a
causa di reazioni allergiche osservati sulla pelle dopo le iniezioni
sottocutanee. In secondo luogo, tichiedono grandi investimenti senza poter avere
alcuna esclusiva commerciale sul prodotto derivato. In altre parole, come per
altre piante definite "miracolose" dai soliti guru di Internet, tipo aloe vera e
bacche di goji, queste conclusioni vanno prese assolutamente con le pinze!
Poteri terapeutici o no, il vischio comunque è stato ed è rilevante per diverse culture. Le
bacche bianche erano considerate simbolo della fertilità maschile, con i semi
che assomigliavano allo sperma. I Celti credevano addirittura che il vischio fosse germinato
dalo sperma del dio
Taranis (l'equivalente del norreno Thor), ed anche gli antichi greci si
riferivano al vischio come "sperma di quercia". Gli storici ritengono che il vischio
probabilmente svolse un ruolo importante nella mitologia druidica, e così lo
ritroviamo nei fumetti di Asterix, ambientati in un immaginario villaggio
gallico senza nome dell'Armorica: per preparare la celeberrima pozione magica,
con cui gli abitanti del villaggio riescono a resistere vittoriosamente agli
invasori Romani, l'ingrediente fondamentale è proprio il vischio, da raccogliere
tassativamente con un falcetto d'oro (da cui il titolo della seconda avventura
di Asterix e Obelix). In realtà però l'unico scrittore antico a
menzionare l'uso del vischio nelle loro cerimonie è Plinio il Vecchio (23-79
d.C.), e le
prove tratte dai corpi rinvenuti quasi intatti nelle paludi fanno supporre l'uso del vischio
presso i Celti a scopo medicinale piuttosto che rituale. Originariamente
potrebbe essere stato collegato ai sacrifici umani, e associato a rituali meno
cruenti solo
dopo che i Romani vietarono i sacrifici umani. Proprio i Romani associavano il vischio alla pace, all'amore e alla comprensione,
e lo appendevano sopra le porte per proteggere le case. A sorpresa, ritroviamo il vischio anche nell'"Eneide"
di Virgilio (libro VI, 133-141): durante la discesa di Enea nell'oltretomba, la
Sibilla cumana gli ordina di trovare un "ramo d'oro" (cioè di vischio) che sarà
necessario per placare le divinità infere durante la sua ricerca dell'ombra del
padre Anchise, che gli profetizzerà la futura grandezza di Roma. L'antropologo
britannico James Frazer (1854-1941) ha dedicato a questo mito una ponderosa
ricerca in un volume intitolato appunto "Il ramo d'oro" (1925).
Dopo l'affermazione del Cristianesimo, nel mondo occidentale si continuò ad usare il vischio
come protezione da streghe e demoni: esso fu associato alla fertilità e
alla vitalità per tutto il Medioevo, e in molti paesi è tuttora simbolo di buon augurio
durante il periodo natalizio: è diffusa l'usanza di origine scandinava
di salutare l'arrivo del nuovo anno baciandosi sotto uno dei suoi rami, usanza
rapidamente diffusasi nei paesi Anglosassoni e specialmente in America, e giunta
infine anche da noi. In pratica, ad un uomo era permesso di baciare qualsiasi
donna in piedi sotto il vischio, e la donna che avesse rifiutato il bacio
sarebbe stata colpita dalla sfortuna. Secondo una versione di questa tradizione, ad ogni bacio si doveva
togliere una bacca, e il rituale del bacio doveva cessare dopo che tutte le
bacche erano state rimosse.
Al vischio tuttavia è in special modo legato il mito norreno di Baldr (in islandese
moderno Baldur, in alto tedesco Phol, in antico anglosassone Bealdor, forse
significa "signore"), sfortunato secondogenito di Odino e Frigg, considerato il
dio del bene, anche se in origine doveva rappresentare una divinità solare,
essendo descritto come il più bello degli Asi (gli dèi della mitologia norrena),
che splende di luce propria e i cui capelli sono candidi come la neve. La sua
dimora si chiamava Breiðablik, che significa "ampio splendore", e Nanna è la sua
sposa. Nell'"Edda in prosa" di Snorri Sturluson (1179-1241), e in particolare
nella sezione intitolata "Gylfaginning", cioè "L'Inganno di Gylfi", si racconta
come il dio Baldr sia perseguitato da incubi che ne annunciano la morte; nella
mitologia norrena infatti, pur non invecchiando e non ammalandosi, gli Asi
possono morire uccisi o suicidi. Saputolo, suo padre Odino si reca ad Helheim,
il regno dei morti, dove purtroppo scopre che è già tutto pronto per accogliere
Baldr, ma non si sa in quale occasione il dio morirà e come. Nel tentativo di
scongiurare un destino che sembra ineluttabile, la madre Frigg, dea della
Natura, raduna ogni essere vivente imponendo a tutti di giurare che nulla dovrà
mai arrecare danno a Baldr. Da allora gli dei cominciano un gioco che ripetono
ogni giorno: formano un cerchio intorno a Baldr lanciandogli contro qualunque
oggetto, perché nulla poteva più nuocergli. Loki, il tenebroso dio del disordine
e del male, si rende conto che il punto debole di Baldr è proprio il vischio:
essendo parassita, non è dotato di vita propria e non aveva potuto giurare. Loki
ne raccoglie quindi una piantina, con essa forgia una lancia e si avvicina a
Hǫðr, fratello di Baldr: essendo cieco, Hǫðr non può partecipare al gioco e
Loki, dicendo di volerlo aiutare perché possa divertirsi come tutti e far così
piacere a suo fratello, gli mette in mano il vischio e lo guida nel lancio. La
lancia di vischio trafigge Baldr uccidendolo, davanti agli altri dèi atterriti.
Sua moglie Nanna muore immediatamente di dolore. Al funerale di Baldr
partecipano tutte le creature del mondo, a testimonianza di quanto il dio fosse
amato. Odino depose sulla pira funebre Draupnir, magico anello in grado di
generare otto sue copie ogni nove notti, mentre Hermóðr, figlio di Odino, si
mette disperatamente in viaggio verso Helheim nella speranza di restituire al
mondo Baldr. La regina degli inferi Hel, tuttavia, pone una condizione: tutti
gli esseri della terra, vivi o morti, dovranno piangere, dimostrando così il
dolore universale per la morte di Baldr. Gli Asi inviano dunque messaggeri in
ogni dove ottenendo che ogni essere del creato pianga per Baldr; la condizione
sembra essere soddisfatta finché in una caverna viene trovata la gigantessa
Þǫkk, che si rifiuta di prendere parte al cordoglio cosmico, condannando per
sempre il dio a restare preda della morte. Secondo alcuni, Þǫkk altri non era
che il solito Loki sotto mentite spoglie. Ma non è finita qui: dopo il Ragnarǫk
("Destino degli Déi"), la grande battaglia escatologica finale in cui gli déi
buoni e quelli malvagi si uccideranno tutti a vicenda e il vecchio mondo dal
fuoco, Baldr tornerà da Hel insieme alla moglie Nanna per geberare una nuova
stirpe divina e per creare un nuovo mondo senza ingiustizie né guerre nè
falsità.
Il mito di Baldr è stato variamente interpretato. C'è chi lo ha visto come un
mito legato al ciclo annuale del tempo, che fa riferimento all'accorciarsi delle
giornate d'inverno e al ritorno della primavera; in tal senso la morte di Baldr
troverebbe analoghi in area mediterranea e mesopotamica, nelle figure di Attis,
Tammuz, Adone, Osiride, Orfeo. Questa teoria ha però un punto debole: Baldr non
presenta i tratti precisi di un dio della fertilità e, inoltre, non è previsto
per lui un ritorno stagionale dal regno dei morti se non successivamente al
Ragnarök, cioè alla fine di questo mondo. Delle precise analogie sono state
invece trovate con il dio finlandese Lemminkäinen, ucciso da un mandriano cieco
armato di una semplice canna, arma all'apparenza inoffensiva come il vischio di
Höðr. C'è inoltre chi ha visto la morte di Baldr come un tipico sacrificio
odinico. Non era insolito infatti che Odino chiedesse di far uccidere tramite un
sacrificio rituale i guerrieri che desiderava avere con sé nel Valhalla, in
vista di suoi scopi futuri. Höðr allora non sarebbe altro se non una
manifestazione di Odino stesso, il quale è cieco da un occhio avendo dovuto
cederlo per bere alla fonte di Mimir ed ottenere la perfetta sapienza.
Alcuni hanno accostato la figura di Baldr anche a Gesù Cristo: entrambi muoiono
traditi dai loro amici e, come Bakdr, anche Gesù tornerà alla fine del mondo per
governare su un mondo rinnovato. Loki ovviamente farebbe la parte di Satana.
Purtroppo non è possibile ad oggi precisare se il mito di Baldr sia stato creato
in un'epoca, attorno al X secolo, in cui nella penisola scandinava convivevano
fianco a fianco l'antico politeismo e il nuovo monoteismo, o se si tratti di un
mito del tutto indipendente.
L'esoterista austriaco Rudolf Steiner (1861-1925) interpretava invece il mito
della morte di Baldr partendo dal principio che Baldr sarebbe una divinità che
agiva sulla terra, mentre Loki apparterrebbe alle entità lunari. Il vischio
sarebbe una pianta che pur vivendo sulla terra, mostrerebbe delle affinità
lunari come Loki; Baldr non verrebbe ferito dagli oggetti comuni perché
terrestri, mentre viene ferito da una pianta che appartiene a un’affinità
opposta. In questa leggenda quindi si nasconderebbe unntica sapienza legata a
culti astrologici, ma ovviamente è una teoria non suffragata da alcuna prova.
Alla natura parassita di questa pianta Giovanni Pascoli (1855-1912) dedicò una
poesia, intitolata appunto "Il vischio": « albero infermo della tua salute, /
albero che non hai gemme fiorite, / albero che non vedi ali cadute; / albero
morto, che non curi il mite / soffio che reca il polline, nè il fischio / del
nembo che flagella aspro la vite... / ah! sono in te le radiche del vischio! »
Il vischio è l'emblema floreale dello stato americano dell'Oklahoma e della
contea britannica di Herefordshire. Ogni anno la città britannica di Tenbury
Wells organizza un festival del vischio e incorona una "regina del vischio"...
sperando che nessuno ci rimanga invischiato!

La
prugna dei maiali
La
ximenia (Ximenia americana), è un
arbusto della famiglia delle Olacacee che può dar vita a un cespuglio o a un
piccolo albero fino a un'altezza compresa tra 2 e 7 metri. Cresce principalmente nei tropici:
Africa, India e sudest asiatico, Australia, Nuova Zelanda, Isole
del Pacifico, Caraibi e Sudamerica Centrale. È conosciuta con molti altri nomi:
"prugna dei maiali", "prugna gialla", "limone di mare", "falso legno di
sandalo", "noce di sego", "legno di sego ", "chabbuli" e "ysada" in Africa occidentale, "ghène", "n'ghani"
e "léaman" in Costa d'Avorio e "kleinsuurpruim", "inkoy", "mutente", "kol", "mulebe",
"mungomba ", "musongwasongwa", "mulutulwa", "museka", "ntogé", "nogbé", "séno",
"séné", "madarud" e "madarau" in altre regioni
dell'Africa, e "pi'ut" in lingua Chamorro (parlata sull'isola di Guam e nelle
isole Marianne). Non è mai stato domesticata, quindi
si trova solo allo stato selvatico.
Cresce in aree con più di 500 mm di precipitazioni medie annue e fino ad altezze
di 2000 m. Si trova comunemente in una varietà di habitat diversi,
prevalentemente in boscaglie semi-aride e in boschi secchi e umidi, boschi
aperti sabbiosi, aree collinari aride, boscaglie costiere, campagne, savane
arbustive, terreni forestali e lungo corsi d'acqua come argini di fiumi e pendii
rocciosi. Cresce su molti suoli argillosi, poveri e asciutti. Può anche
assorbire nutrienti e acqua da altre specie vegetali attraverso le sue radici,
tuttavia di solito non utilizza questo metodo come modalità di sopravvivenza.
Per questo può essere classificata come emiparassita facoltativo, in quanto può
crescere perfettamente senza un ospite, anche se cresce meglio nei terreni dove
può entrare in contatto con le radici di altre piante.
Un po' di storia. L'esploratore e botanico francese
Jean Baptiste Christophore Fusée Aublet (1720-1778) descrisse le nuove specie Heymassoli
inermis e Heymassoli spinosa nella sua "Histoire des Plantes de la Guiane Françoise"
del
1775; in seguito queste due specie furono identificate con Ximenia americana. Il
nome del genere Ximenia deriva
da quello del sacerdote spagnolo Francisco Ximénez (1666-1729), meglio noto per
aver curato la prima traduzione in spagnolo del noto testo Maya "Popol Vuh";
egli descrisse dettagliatamente una
collezione di piante da lui scoperte in Messico. Il cognome Ximénez o Jiménez a
sua volta è di origine basca ed è probabilmente legato alla radice "semen", in
basco "figlio".
Il tronco ha un diametro inferiore
a 10 cm; la corteccia ha un colore dal marrone scuro al grigio
chiaro. I rami formano un arco verso il basso e i rametti hanno spine
dritte e sottili lunghe 1 cm, di colore rosso porpora.
Le foglie sono semplici e alterne, di forma da
lanceolata a ellittica, e hanno una consistenza simile al cuoio. Esse crescono da
2,5 a 8 cm di lunghezza e da 1 a 4 cm di larghezza, hanno uno spessore che va da sottile a semisucculento
e hanno da 3 a 7 paia di nervature laterali difficili da osservare su entrambi i
lati della foglia.
Le foglie sono pelose quando iniziano a crescere, ma diventano lisce e lucide
man mano che maturano. I piccioli sono corti e sottili, fino a 3-6
mm di lunghezza, di colore
grigioverde o verde brillante; rilasciano un forte odore di mandorle quando
vengono schiacciati.
La fioritura avviene comunemente osservata durante le stagioni secche. I fiori
sono profumati, di colore bianco, giallo-verde o rosa e sono lunghi da
5 a 10 mm. Crescono su infiorescenze ramificate,
racemose o ombrelliformi, su peduncoli lunghi 3-7 mm. I frutti
sono di forma globosa o drupacea, crescono fino a 3 cm di lunghezza, hanno un
diametro di 2,5 cm e sono lisci.
Gli alberi producono frutti dopo circa 3 anni di crescita. I giovani frutti
sono verdi ma diventano giallo oro o rosso aranciato man
mano che maturano; le condizioni climatiche non ne
influenzano la maturazione. A maturità il frutto ha una polpa verde,
succosa e un grosso seme legnoso di colore giallo chiaro che cresce fino a 1,5 cm di
lunghezza e contiene circa il 60% di olio. Quando viene mangiato il frutto ha un
sapore di mandorla; i semi vengono dispersi dagli
animali che mangiano il frutto, attirati dai suoi colori vivaci.
Un'altra specie di questo genere è Ximenia caffra; è simile a Ximenia americana,
ma le foglie e i frutti sono più grandi di quelli di quest'ultima, il che rende facile distinguerle.
Inoltre Ximenia americana
porta diversi fiori su infiorescenze ramificate, mentre i fiori in Ximenia caffra
sono portati in ciuffi o singolarmente.
La ximenia è ricca di acidi grassi e di gliceridi, ma essa contiene anche
alcaloidi, flavonoidi, composti fenolici, saponine, tannini e terpenoidi. Alcune
foglie raccolte da Ximenia americana nel sud del Niger sono risultati ricchi
di calcio, ferro, magnesio e manganese, ma sono privi di proteine. Il frutto
contiene acido cianidrico ed alti livelli
di vitamina C; i frutti verdi hanno il 74% in più di
vitamina C rispetto a quelli gialli maturi. Il seme contiene derivati del
cianuro che contribuisce all'odore di mandorla; l'olio di semi contiene gli acidi ximenico, linoleico
e stearico. È resistente alla siccità, il che la rende una buona fonte di cibo
durante i periodi di siccità. È anche tollerante alle inondazioni lievi, che si
verificano durante le tempeste per brevi periodi di tempo, ed è persino
tollerante ai terreni salati, agli spruzzi di sale e ai venti.
Nelle savane la ximenia è una fonte alimentare vitale per gli animali che vi
vivono, vale a dire i mammiferi come le giraffe, che la apprezzano moltissimo.
Le foglie sono cibo anche per insetti, come le farfalle, e le loro larve.
La Ximenia americana può essere utilizzata come fonte alimentare anche dagli
uomini, principalmente per i suoi frutti, che possono essere consumati crudi o in salamoia, e possono
essere usati per sostituire il limone nelle ricette di pesce, per preparare succhi,
marmellate o bevande alcoliche; in Sud Africa dai frutti viene prodotta una
specie di birra. In Etiopia, paese notoriamente alla fame (anche per causa di
guerre endemiche e di dittature decennali) è uno dei frutti più utilizzati dai
pastori, dai bambini, dalle donne e dalle famiglie più povere; il frutto viene
venduto nei mercati e la foglia è molto importante come mangime per bovini,
capre e pecore. I ricercatori etiopi ritengono che essa potrebbe contribuire a
sconfiggere la malnutrizione in molte zone del paese, perchè è disponibile tutti
i mesi dell'anno in quanto non è decidua. La specie non è certamente in
pericolo, ma i botanici hanno notato che in Etiopia sta diventando rara
principalmente a causa dell'uso eccessivo della pianta e dei suoi componenti;
per questo sono in corso tentativi di domesticarla su larga scala. In Asia le
giovani foglie vengono cotte e consumate come verdura; tuttavia, contenendo del cianuro, devono essere ben cotte e non
dovrebbero essere consumate in grandi quantità. Anche i semi hanno un forte effetto purgante e non dovrebbero essere consumati
in quantità eccessive. Il nocciolo del frutto può essere trasformato in olio,
che viene utilizzato in cucina come sostituto del burro, ma anche per scopi
cosmetici come emollienti, balsami, ammorbidenti per la pelle, oli per il corpo
e per capelli, nonché ingredienti in saponi, rossetti e lubrificanti. L'olio di semi di Ximenia
americana può essere utilizzato persino come potenziale biocarburante se
miscelato con cherosene.
Il legno è usato come legna da ardere e per ottenere carbone. Ximenia viene utilizzata anche come
pianta da siepe per marcare i confini e a
scopo decorativo, in quanto ha fiori e fogliame attraenti.
La ximenia è molto utilizzata nella medicina tradizionale per trattare un gran numero di
malattie, tra cui morbillo, malaria, infezioni della pelle, malattie trasmesse
sessualmente, diarrea, crampi muscolari e ascessi polmonari. Le
foglie e i ramoscelli sono usati come trattamento per raffreddori e febbri, come
lassativi e lozioni per gli occhi e come collutorio per prevenire mal di denti e
infezioni alla gola. Tuttavia ai guaritori tradizionali era nota l'eccessiva
salivazione come segno della tossicità quando veniva usata per trattare le
malattie orali. La corteccia, solitamente usata in polvere o in
decotto, viene usata per curare le ulcere della pelle e posta nell'acqua del bagno per i bambini malati. Il frutto
viene consumato per curare vermi intestinali e stitichezza.
Xymelys 45 è un farmaco contenente estratto di corteccia di Ximenia americana
commercializzato come cosmetico per fornire protezione alla pelle
ultrasensibile, allo stress ossidativo e ai radicali liberi. Il tè di ximenia
è stato commercializzato in Brasile per curare ferite, ulcere, problemi cardiaci e renali. L'olio di semi è commercializzato come
trattamento per la pelle secca, in prodotti idratanti, emollienti, antietà e antiacne e come trattamento per capelli fragili e
danneggiati.

Le
patate pelose
Ora vi parlerò del kiwi, un frutto
che io adoro. Nonostante le apparenze, anch'esso è considerato una bacca, e
l'albero che la produce è classificato come... liana (sì, come quella di
Tarzan), del genere Actinidia. Non c'è solo il kiwi verde, c'è anche una meno
nota varietà di kiwi giallo o gold. La prima, la più diffusa, ha la buccia
pelosa marrone scuro con la polpa verde brillante e semi piccoli e neri disposti
a raggiera intorno al centro della bacca, che ha la forma di una piccola patata.
La varietà gold invece ha forma più allungata, la polpa gialla e non ha peli
sulla buccia. Esistono altre varietà poco diffuse dalle nostre parti, come il
kiwi con la polpa rossa e la buccia color mattone. Il kiwi ha un tipico sapore
acidulo, ma gustoso e rinfrescante; lo si mangia a fette, specie con la
macedonia o negli spiedini di frutta. Il nome scientifico della pianta di kiwi è
l'Actinidia deliciosa, ma è coltivata anche l'Actinidia arguta, il cosiddetto
"mini kiwi", caratterizzato da frutto piccolo e buccia liscia. Come quelle degli
asparagi, le piante sono dioiche, cioè vi sono esemplari maschio ed esemplari
femmina.
Il nome "kiwi" deriva dalla lingua dei Maori, popolo di probabile
origine polinesiana che intorno al 1300 sbarcò nell'attuale Nuova Zelanda e la
chiamò Aotearoa, cioè "la Grande Nuvola Bianca" (portò tra l'altro
all'estinzione la megafauna neozelandese i Diorniti o uccelli Moa, alcuni tra i
più grandi uccelli mai esistiti, alti fino a 3,60 m per 250 kg di peso). Tornando
al kiwi, il suo nome deriva da huakiwi, letteralmente "uovo di kiwi". Difatti, a
causa della peluria e del colore bruno, questo frutto ricorda un altro uccello
endemico della Nuova Zelanda, l'Apteryx australis, uccello non volatore con ali
piccolissime, becco lungo e piumaggio marrone, eletto animale simbolo della
Nuova Zelanda. Quando nel 1931 il famoso fisico Ernest Rutherford, lo scopritore
del nucleo atomico, fu nominato Lord, nello stemma che si scelse mise proprio un
kiwi, essendo nato a Brighwater in Nuova Zelanda, anche se studiò e lavorò a
Cambridge.
In realtà l'Actinidia deliciosa è originaria della Cina meridionale,
dove si coltiva da almeno 700 anni; il suo frutto era considerato una
prelibatezza dagli imperatori cinesi, e il suo uso era anche ornamentale.
All'inizio dell'Ottocento gli inglesi lo portarono prima in Inghilterra e poi in
Nuova Zelanda, dove ha trovato un ambiente abbastanza favorevole e si è diffuso
attraverso coltivazioni intensive. La grande fortuna del kiwi (del frutto, non
dell'uccello) iniziò dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando gli statunitensi lo
esportarono con successo in tutto il mondo con il nome di kiwifruit. Da notare
che questo è ancor oggi il nome del frutto in Australia e Nuova Zelanda, dove il
nome "kiwi" è riservato all'uccello. Peraltro, "kiwi" è anche il soprannome
degli abitanti della Nuova Zelanda, soprattutto in occasione di competizioni
sportive o eventi sociali (come "gli azzurri" è una metonimia comune per
designare gli italiani). Alla fine del Novecento si diffuse anche in Europa e
soprattutto in Italia, ben presto diventata il terzo produttore mondiale di
questo frutto, dopo Cina e Nuova Zelanda. La principale zona di produzione del
kiwi in Italia è il Lazio, particolarmente adatto alla coltivazione del frutto
per il suo clima caldo in estate, ma anch'io ho quattro piante di kiwi nel mio
giardino. Dalle nostre parti il kiwi viene raccolto tra settembre e ottobre, ed
è commerciato da novembre ad aprile. Per essere coltivato ha bisogno di
abbondante acqua, e questo è un problema, visto il periodo siccitoso che la
Penisola sta attraversando a causa dei cambiamenti climatici. Il frutto teme
l'umidità e le alte temperature, per cui deve essere conservato in luoghi
freschi e asciutti (io li tengo nel sottoscala della cantina). Se si vuole
accelerare la maturazione bisogna riporre i frutti di fianco a mele o banane. Il
kiwi è costituito da circa l'84% di acqua, ed è ricchissimo di vitamina C,
potassio, magnesio, vitamina E e ferro. L'alto contenuto di potassio e la
povertà di sodio rendono il frutto ideale per gli sportivi, poiché diminuisce il
rischio di crampi. È consigliato per chi ha problemi di digestione e aiuta il
lavoro dell'intestino come le verdure e le prugne. Purtroppo alcuni sono
allergici ai kiwi: tale forma di allergia è stata descritta per la prima volta
nel 1981. Infatti l'actinidina, un coadiuvante digestivo presente nei kiwi può
essere un allergene per alcuni, e provocare prurito, dolore alla bocca e respiro
sibilante. Per fortuna non è il mio caso, io ne vado pazzo!

La
bevanda degli imperatori
Riguardo al cacao, a differenza di
pomodori e patate, dal punto di vista botanico non è un ortaggio, ma un vero e
proprio albero, alto anche più di dieci metri! Io ne ho visto una pianta con i
miei occhi in un giardino in Israele, nonostante il riscaldamento globale alle
nostre latitudini non cresce (per fortuna). Manco a dirlo, il cacao più
apprezzato del mondo è quello dell'Ecuador, ma il primato di primo produttore al
mondo se lo giocano Costa d'Avorio e Nigeria. Di sicuro non è di origine
africana; pare che i primi a domesticarlo siano stati i popoli del Centroamerica,
secondo alcuni gli Olmechi, secondo gli altri i Maya. Una leggenda mesoamericana
dice che il cacao (era il dono che Quetzalcoatl, il dio supremo creatore del
mondo, fece agli uomini per rendere loro più piacevole la vita, altrimenti
faticosa e mortale. Chi la coltivò intensivamente furono gli Aztechi, per i
quali era una pianta sacra. Ovviamente non ne facevano tavolette come noi, ma
una bevanda (cacao deriva dal nahuatl "cacahuatl", dove "cacahu" ha significato
oscuro, mentre "atl" significa "acqua", e quindi bevanda) riservata all'alta
nobiltà e in particolare agli imperatori ("tialoque" in nahuatl) che, come tu
sai, erano ritenuti di discendenza divina. Per questo il cacao era considerata
la "bevanda degli déi" per eccellenza, ed infatti, quando Linneo dovette
scegliere un nome scientifico per la pianta, la chiamò Theobroma cacao, perchè "theobroma"
in greco significa proprio "la bevanda degli dèi"! Gli etnologi hanno
ricostruito il processo di lavorazione degli antichi Mexica (come gli Aztechi
chiamavano se stessi, per via di un mitico capo chiamato Mexi, da cui Messico):
le fave, estratte dalla bianca polpa interna al frutto, detto cabossa (di circa
10 x 30 cm), erano fatte fermentare, tostate e macinate, ottenendo così un
impasto umido che veniva disciolto in acqua insieme ad altri ingredienti; una
densa schiuma sulla superficie della bevanda veniva ottenuta versandola
ripetutamente da un vaso all'altro, e questa era la pregiata bevanda degli déi.
Per inciso, le fave di cacao erano addirittura usate dagli Aztechi come moneta!
Purtroppo il cacao contiene un alcaloide chiamato teobromina (dal suo nome
scientifico), non troppo dissimile dalla caffeina, che come quest'ultima e come
tutti gli alcaloidi dà forte dipendenza. Pare che Moctezuma II (in nahuatl
"colui che governa con faccia arcigna", a volte erroneamente chiamato Montezuma
per ragioni eufoniche), ultimo imperatore azteco ucciso dai suoi stessi sudditi
con una sassata perchè aveva cercato di convincerli a non combattere Cortés, da
lui creduto l'incarnazione di Quetzacoatl in persona, fosse del tutto drogato di
teobromina, tanto da bere fino a quaranta tazze al giorno di cacao!! Per questo
la dipendenza da cacao (ci sono statunitensi obesi che arrivano a mangiare 10 kg
di cioccolata al giorno) viene chiamato "la Vendetta di Moctezuma": gli Aztechi
furono sterminati dalle malattie come vaiolo, morbillo e rosolia portate dai
Conquistadores, contro cui essi non avevano alcuna difesa immunitaria, e loro
"ricambiarono il favore" con questa dannosa dipendenza che tanti guai provoca
alla nostra salute, essendo il cioccolato molto grasso, nonostante se ne
estragga buona parte del "burro di cacao". Per fortuna però il cacao è anche uno
dei migliori antiossidanti conosciuti, venti volte più antiossidante di una
mela. Occhio perchè per cani e gatti il cacao è velenosissimo: per intossicare a
morte un cagnolino di piccola taglia ne bastano 25 g! Il primo europeo a vedere
di persona il cacao potrebbe essere stato Cristoforo Colombo nel suo quarto
viaggio, ma il primo a portarlo in Europa fu il famigerato Hernàn Cortés,
secondo solo al Colonnello George Armstrong Custer nella fama di massacratore di
nativi americani. La parola cioccolato pare derivi da "xocoatl", uno dei tanti
nomi della bevanda, e il primo autore della letteratura italiana a nominarlo è
Giuseppe Parini nel "Giorno", dove scrive che il "giovin signore" si beava del "brun
cioccolatte", servito come in America dentro tazze (ma dal sapore assai diverso,
per l'aggiunta di latte, zucchero, cannella e vaniglia). In Italia però il
cioccolato era consumato già ai primi del '600. Il celeberrimo "cioccolato
svizzero", preso in giro dalle pubblicità nostrane ("Sfìzero?" "Nooo! Novi!"),
nacque grazie a Francois-Luis Cailler, che nel 1819 fondò la prima fabbrica
svizzera di cioccolato a Vevey. Nel 1878 lo svizzero Daniel Peter mescolò il
latte al cacao producendo il cioccolato al latte; nel 1879 a Berna il
famosissimo Rodolphe Lindt produsse per primo il cioccolato fondente; infine nel
1923 a Chicago Frank Mars inventò la barretta al cioccolato, e il suo nome è
rimasto a un popolare snack che si trova anche nei distributori alimentari del
mio Liceo (io credevo fosse un nome commerciale, e invece...) In Italia invece
abbiamo il gianduiotto, prodotto a Torino e lanciato in occasione del Carnevale
del 1865: non a caso ha il nome di Gianduia, la più popolare maschera torinese.

Il
vino d'Arabia
Non tutti lo sanno, ma la
pianta del caffé non è originaria del Sudamerica,
dove oggi viene coltivata su latifondi immensi, bensì dell'Etiopia, da dove gli
Arabi poi l'avrebbero trapiantata nella penisola arabica. Il suo nome
scientifico è infatti Coffea arabica. Secondo alcuni il suo nome deriverebbe da
Caffa, la regione dell'Etiopia dove ne furono scoperte le prime piante; secondo
altri invece deriva dall'arabo qahwa, "eccitante". Secondo una nota leggenda,
tutto sarebbe cominciato da un incendio che a Caffa incenerì alcune piante
di caffé: la popolazione dei villaggi vicini fu attirata dall'aroma che ne
scaturì e cominciò a tostarne i semi. Un'altra versione narra del pastore Kaldi,
un etiope che avrebbe notato che le sue capre, che brucavano le bacche di una
certa pianta, non si addormentavano e restavano sveglie e attive tutta la notte.
Una terza leggenda ha come protagonista il profeta Maometto il quale, sentendosi
male, ebbe la visione dell'Arcangelo Gabriele che gli offriva una pozione nera
come la Pietra Nera della Mecca, creata per lui da Allah, che gli permise di
riprendersi e tornare in forze. Siccome il Corano vieta di bere alcolici, gli
Arabi prima e i Turchi poi lo bevevano in grande abbondanza (da cui il nome di
"Vino d'Arabia"), e il Kahvecibaşı ("Capo caffettiere") era un incarico
importante alla corte del Sultano. Da Costantinopoli nel '500 cominciò a
diffondersi in tutta l'Europa, naturalmente attraverso Venezia, che commerciava
attivamente con gli Ottomani. Il caffè però fu introdotto in Europa per la prima
volta nell'isola di Malta, attraverso i prigionieri musuomani dopo il grande
assedio di Malta del 1565. Invece a Vienna il primo caffè fu aperto nel 1683,
subito dopo il fallito assedio da parte dei Turchi, secondo la tradizione usando
i sacchi di caffè abbandonati sul posto dai guerrieri ottomani (in quell'occasione
sarebbe stato inventato anche il cornetto, che avrebbe ripreso la forma a
mezzaluna sulla bandiera della Turchia). In Inghilterra ne parlò per primo il
filosofo Francesco Bacone. Inizialmente la Chiesa ne osteggiò la diffusione
perchè era la bevanda preferita degli odiati infedeli, perchè era nero "come il
peccato" e perchè molti lo credevano un afrodisiaco, ma l'elezione al papato di
Clemente VIII cambiò le carte in tavola: il Pontefice lo assaggiò, lo trovò
ottimo, ed usò un escamotage per renderne lecito il consumo: sostenne che il
caffé poteva aiutare i monaci a restare svegli la notte a pregare, come aiutava
noi a stare svegli a studiare la notte prima degli esami universitari. In realtà
non a tutti piaceva: il medico e letterato Francesco Redi nel suo "Bacco in
Toscana" scrisse: « Beverei prima il veleno / che un bicchier, che fosse pieno /
dell'amaro e reo caffè! » Intanto gli olandesi trapiantavano le piante di caffè
in Indonesia, i Francesi nei Caraibi e gli Spagnoli in Sudamerica.
Nel settecento ogni città d'Europa e del Nordamerica aveva almeno un caffè, dove
ci si riuniva per discutere di politica e di cultura, e "Il Caffè" era il titolo
del primo quotidiano di stampo illuminista pubblicato in Italia, ad opera dei
fratelli Alessandro e Pietro Verri, fondatori dell'Accademia dei Pugni (con
tutta probabilità Pietro Verri, amante di Giulia Beccaria, era il vero padre di
Alessandro Manzoni). A segnare il trionfo del caffè, ormai non più "amaro e
reo", fu l'invenzione della Moka, caffettiera ideata da Alfonso Bialetti nel
1933, vera icona del Made in Italy formata di soli quattro pezzi in acciaio, di
cui anch'io possiedo un esemplare; essa prende il nome da Mokha, città portuale
dello Yemen da dove secondo alcuni il caffè sarebbe stato esportato in tutto il
mondo. Ormai, come il pomodoro, il caffè era diventato uno dei simboli stessi
della napoletanità, tanto che Totò annoverava 60 sigarette e 40 tazzine di caffé
tra i suoi "vizi quotidiani" (che peraltro lo condussero a prematura morte a 69
anni).

La
camelia che si beve
Sul tè siamo tutti d'accordo: viene
dall'Estremo Oriente. Quasi nessuno sa però che è parente strettissimo delle
nostre fiorite camelie, ed in effetti il suo nome scientifico è Camellia
sinensis (Sina, da Ch'in, è il nome latino della Cina). La parola "tè" deriva
dalla pronuncia (tei) del carattere cinese 茶 nel dialetto min meridionale, e
tale parola è pressoché la stessa in moltissime lingue del mondo. Non però in
giapponese, dove il tè si chiama chá, dalla pronuncia dello stesso
ideogramma cinese nei dialetti settentrionali. Il tè contiene la teina, un
alcaloide stimolante del sistema nervoso centrale, che a fine ottocento è stata
dimostrata essere identica alla caffeina; contiene però anche la catechina, un
antiossidante presente soprattutto nel tè verde. Un'infusione breve (due-tre
minuti) estrae dalle foglie di tè soprattutto la teina/caffeina e ha proprietà
stimolanti; un'infusione più lunga (cinque-sette minuti) estrae anche acido
tannico che disattiva la caffeina perché si combina con essa, attenuando
l'effetto stimolante. Inoltre l'acido tannico rende amaro il sapore del tè.
Innumerevoli sono le varietà conosciute ed apprezzate. Nella lavorazione del
tè bianco le foglie subiscono una lunga fase di
appassimento che è causa anche di un leggero processo di ossidazione; il nome
bianco deriva dal colore delle gemme apicali, usate per produrre questo tè, che
sono ricoperte da una lanugine bianca particolarmente folta. Invece nella
preparazione del tè nero le foglie vengono fatte
appassire in modo da far perdere l'acqua in esse contenuta, renderle morbide e
poterle in seguito rullare, allo scopo di rompere le membrane cellulari e far
affiorare i succhi in superficie. Nella lavorazione del tè
verde poco dopo la raccolta le foglie vengono sottoposte a un trattamento
termico chiamato "stabilizzazione" (in inglese "fixation") che inibisce gli
enzimi responsabili dell'ossidazione e permette al tè di mantenere il proprio
colore verde. Il Bancha (in giapponese "tè
ordinario"), come mi ha spiegato l'amico
Perchè No?, che vive a Tokyo, è
un tè verde giapponese ricavato dall'ultimo raccolto dell'anno, che di solito ha
luogo in ottobre: è il tè verde comune per i giapponesi, ma è considerato la più
leggera tra tutte le qualità di tè verde. Il suo sapore è ', con un marcato
odore di paglia. Il Matcha (in giapponese
"sfregato") è un tè verde originario della Cina le cui foglie vengono prima
cotte al vapore, asciugate e ridotte in polvere finissima, usatissimo per la
cerimonia del tè. Mi dice l'amico
Perchè No? che c'è addirittura il tè blu o Oolong (dal cinese wūlóng, "drago
scuro"), un tipo di tè semiossidato prodotto in Cina e a Taiwan, a metà tra il
tè verde e il tè nero, perché ossidato solo parzialmente. Mi dicono che una
delle qualità di tè più pregiata in assoluto è il
Darjeeling, dal nome dell'omonima regione del Bengala, un tè nero indiano
soprannominato addirittura lo "champagne dei tè", coltivato in zone piovose e
dal tipico aroma di uva Moscato. Ma quello che io prediligo fra tutti è sempre
il buon vecchio Earl Grey, aromatizzato al
bergamotto, che prende il nome dal Conte Charles Grey, Primo Ministro del Regno
Unito dal 1830 al 1834, il quale guarda caso ricevette in dono un tè
aromatizzato con olio di bergamotto, e da allora ne fu pazzo. Ne vado matto
anch'io, ma non perchè è di moda. Le mode passano, l'Earl Grey è per sempre, se
è vero che anche nel 2350 dopo Cristo il Capitano Jean-Luc Picard concludeva
ogni sua giornata ordinando al replicatore un "tè Earl Grey, caldo, in tazza di
vetro"!! Il
maggior produttore di tè al mondo è ovviamente la Cina, seguita da India e
Giappone.
I primi riferimenti storici certi al consumo del tè in Cina risalgono
al III secolo dopo Cristo: i maggiori sponsor del tè furono i monaci buddisti,
che lo adottarono come bevanda rituale e come tonico. Durante l'epoca Tang il tè
si diffuse in tutto il paese cominciando a venire usato anche come moneta,
grazie anche al contributo del "Canone del tè" scritto da Lu Yu nel 760. In
Giappone nel XVI secolo venne codificata una particolare forma di preparazione
ritualizzata, il cosiddetto Cha no yu, per cui oggi esistono vere e proprie
scuole. In Europa il tè fu menzionato per la prima volta dal domenicano
portoghese Gaspar da Cruz, che nel 1560 parlò di « una specie di acqua che
chiamano "cha", rossiccia e molto terapeutica ». La prima importazione del tè in
Europa di cui si ha memoria la dobbiamo alla Compagnia Olandese delle Indie
orientali nel 1610. Oggi però se pensiamo al tè non pensiamo ai Paesi Bassi, ma
all'Inghilterra. Il merito di aver portato il tè in Inghilterra è attribuito a
Caterina di Braganza (1638-1705), consorte portoghese di re Carlo II. Il suo
consumo nelle case e nei giardini, dato che le donne nelle coffeehouse non erano
ammesse, si consolidò nel XVIII secolo, durante l'era georgiana, e ben presto il
suo successo fu eccezionale, presso tutte le classi sociali, facendone uno dei
protagonisti della storia economica dell'Impero Britannico. La crescente domanda
diede impulso alla marina e incoraggiò la coltivazione nelle colonie. Nel 1758
la potente Compagnia Britannica delle Indie Orientali ottenne dal Parlamento il
monopolio del commercio dell'oppio e la sua esportazione verso la Cina, in
cambio di tè, provocando le Guerre dell'Oppio e dando il colpo di grazia al già
traballante Impero Qing. All'inizio del XX secolo il consumo medio annuo inglese
pro capite raggiunse la sbalorditiva cifra di tre chilogrammi, e poiché
l'alcolismo si stava rivelando una piaga molto grave, il tè si rivelò anche uno
straordinario strumento di controllo sociale, sostituendo la birra come bevanda
nazionale e aiutando a combattere l'abuso di sostanze alcoliche. Ciò si rivelò
fondamentale anche sui campi di battaglia delle guerre moderne, dove anziché
caffè o gin ai soldati era distribuito proprio il tè caldo, che li manteneva
sobri e ne stimolava l'attenzione, migliorando il rendimento in battaglia.
Insomma, secondo l'antropologo Alan MacFarlane dell'Università di Cambridge,
senza il tè non ci sarebbero stati né l'Impero Britannico né la Rivoluzione
Industriale. Persino la Storia degli Stati Uniti d'America comincia con il
"Boston Tea Party" del 16 dicembre 1773. In quella tazzina galleggiano dunque
l'identità di un popolo e secoli di imperialismo e dominio sul mondo. Pensate dunque cosa sarebbe successo se Re Carlo II avesse sposato un'altra
principessa, o se Caterina di Braganza avesse preferito la cioccolata...

L'infuso rosso del Ventennio
Vorrei parlarvi adesso di qualcosa di "italiano", anche se in
realtà è nato molto lontano dall'Italia: il karkadè.
Si tratta di una notissima tisana ricavata mettendo in infusione i calici dei
fiori dell'Hibiscus sabdariffa, una pianta della famiglia delle Malvacee,
probabilmente originaria dell'Africa occidentale. È un arbusto a base legnosa,
che cresce fino a 2,5 m di altezza. Le foglie hanno dai tre ai cinque lobi, i
fiori hanno un diametro di 8-10 cm e vanno dal bianco al giallo pallido con una
macchia rosso scuro alla base di ogni petalo. Hanno un robusto calice carnoso
alla base, che diventa carnoso e rosso vivo mentre il frutto matura. La
maturazione impiega circa sei mesi. La parola karkadè deriva dal nome "karkadeb"
con cui la pianta è chiamata nel dialetto Tacruri, in Eritrea. Invece ibisco
deriva dal greco "ixos" (latino viscus), il nome ellenico del vischio, perchè
nelle radici contiene una sostanza mucillaginosa. Oggi i calici rossi della
pianta vengono esportati negli Stati Uniti e in Europa, in particolare in
Germania, dove vengono utilizzati come coloranti alimentari. Può essere trovato
nei mercati sotto forma di fiori o sciroppo in paesi, come la Francia, dove sono
presenti comunità di immigrati senegalesi. Le foglie verdi sono usate come una
versione speziata di spinaci. In India, invece, la pianta è principalmente
coltivata per la produzione di fibre di rafia utilizzate come cordame, ricavate
dal suo gambo, come sostituto della iuta. Nel Maharashtra (India centrale) l'Hibiscus
sabdariffa è chiamato ambadi; le foglie di ambadi sono mescolate con peperoncini
verdi, sale e aglio per preparare un chutney che viene servito con pane di sorgo
o miglio: esso viene mangiato dagli agricoltori come colazione per iniziare la
giornata. Nella cucina birmana l'Hibiscus sabdariffa, chiamato "chin baung ywet"
("foglia acida"), è uno degli ortaggi più popolari: le foglie sono fritte con
aglio, gamberi secchi o freschi e peperoncino verde o cotte con pesce, oppure
come zuppa a base di brodo di gamberi essiccati. In Vietnam le giovani foglie,
steli e frutti sono usati per cucinare zuppe con pesce o anguilla. In Mali le
foglie essiccate e macinate, dette anche djissima, sono comunemente utilizzate
nella cucina Songhay e sono l'ingrediente principale in almeno due piatti a base
di agnello, uno chiamato djissima-gounday, in cui il riso viene cotto in un
brodo contenente le foglie, e l'altro chiamato djissima-mafé, dove le foglie
vengono cotte in salsa di pomodoro e carne di agnello. In Congo e Gabon le
foglie vengono chiamate oseille e vengono utilizzate in purea o in salsa, spesso
con pesce o melanzane. Il karkadè sudanese è una bevanda fredda prodotta tenendo
immersi in acqua per una notte i calici essiccati in frigorifero con zucchero e
succo di limone o lime; viene quindi consumato dopo che i fiori sono stati
filtrati. In Libano vengono talvolta aggiunti pinoli tostati. Il karkadè viene
utilizzato in Nigeria per preparare una bevanda rinfrescante nota come Zobo e
vengono aggiunti succhi di frutta naturali di ananas e anguria; sempre in
Nigeria si prepara la marmellata di karkadè, simile nel sapore alla marmellata
di prugne, anche se più acida; si differenzia da altre marmellate in quanto la
pectina è ottenuta bollendo i boccioli interni dei fiori di Hibiscus sabdariffa. Nei
Caraibi, dove la pianta o il frutto si chiama sorrel, viene preparata una
bevanda bollendo sepali freschi, congelati o secchi, e talvolta i calici e i
semi del frutto in acqua per dieci minuti (o fino a quando l'acqua diventa
rossa), quindi aggiungendo zucchero. Nei ristoranti messicani negli Stati Uniti,
questa bevanda è talvolta conosciuta semplicemente come Giamaica. È molto
popolare a Trinidad e Tobago soprattutto come bevanda stagionale a Natale, con
cannella, chiodi di garofano e foglie di alloro. Il Carib Brewery, un birrificio
di Trinidad e Tobago, produce uno "Shandy Sorrel" in cui il tè è combinato con
la birra. I fiori di ibisco selvatici sciroppati sono considerati una leccornia
in Australia; vengono spesso riempiti con formaggio di capra, servendoli su
fette di baguette al forno, e mettendone uno con un po' di sciroppo in un flute
di champagne prima di aggiungere lo champagne, in quanto le bolle provocano
l'apertura del fiore. La marmellata di rosella viene prodotta nel Queensland, in
Australia, come un prodotto fatto in casa venduto in occasione di feste e
sagre. L'ibisco è anche usato nella medicina popolare come lassativo e diuretico
lieve. In Brasile si attribuiscono proprietà gastriche, emollienti e risolutive
alle radici amare.
Ok, e in tutto questo cosa c'entra l'Italia?
C'entra eccome, perchè un tempo il suo consumo era assai diffuso da noi, tanto
da venire chiamato il "tè degli italiani". Infatti, dopo aver lottato un secolo
e passa per costruirci un nostro stato nazionale, chissà perchè, verso la fine
dell'ottocento abbiamo deciso anche noi di prenderci il nostro posto al sole,
come tutte le grandi potenze. Ed essendoci mossi tardi, abbiamo dovuto
accontentarci delle briciole: Eritrea, Somalia, le coste della deserta Libia, in
cui si sapeva che c'era il petrolio, ma mancavano i mezzi per estrarlo. Eppure
il neonato regno aveva tutta una serie di problemi di natura economica, sociale,
politica, di stabilità ecc. e le perplessità per avventure oltremare furono
molto numerose. Alla fine vinse la politica del "dobbiamo avere le colonie
perchè tutte le Potenze le hanno e noi vogliamo essere una Potenza", con una
grande spintarella da parte delle industrie di armi pesanti. Le colonie però
furono in massima parte un incubo logistico da gestire, un continuo pozzo senza
fondo dove buttare uomini e mezzi senza alcun risultato, strisce di terra
poverissime di risorse e inadatte anche al popolamento, tanto che le ondate
migratorie si diressero verso Stati Uniti, Brasile e Argentina, non certo verso
di esse (almeno fino a Mussolini e ai suoi modi spicci). Poi ci si mise Benito
che, incurante del fatto che le colonie erano sempre state foriere per noi di
bilanci in rosso, continuò a perseguire il sogno di un impero coloniale italiano
ininterrotto da Tunisi al Corno d'Africa, aggredì l'Etiopia, fu colpito dalle
sanzioni internazionali da parte della Società delle Nazioni, e finì nel mortale
abbraccio con Hitler che lo condusse al disastro militare. E siccome le sanzioni
includevano anche il tè, amato da molti italiani (vista la politica di Splendido
Isolamento portata avanti dagli USA tra le due guerre, Società delle Nazioni
significava in pratica Francia e Regno Unito), Mussolini tentò di sostituirlo
con tisane "autoctone", cioè prodotte nelle colonie italiche. Il karkadé, bevuto
appunto a litri in Eritrea, fece breccia nei salotti italiani, sicché il regime
fascista, nel quadro della sua politica autarchica, lo promosse come sostituto
del britannico tè. Dopo la sconfitta (prevedibile, visto che Hitler e Mussolini
avevano dichiarato guerra praticamente a tutto il resto del mondo) le colonie
andarono perdute e l'Eritrea fu annessa all'Etiopia (divenuta indipendente nel
1993, oggi è considerata una delle peggiori dittature del pianeta), e il té
tornò sui mercati italiani, anche grazie agli aiuti del Piano Marshall. Ma il
karkadè, con il suo colore rosso vivo, non è mai stato messo definitivamente in
soffitta, a differenza di altri cimeli del Ventennio, e conserva un suo
pubblico di appassionati. Questa bevanda infatti, e non lo dice la propaganda
del Regime ma i moderni studi di scienza dell'alimentazione, è digestiva e
regolarizza la funzionalità epatica; è inoltre antinfiammatoria, lenitiva,
vitaminizzante, utile anche nel combattere la stipsi cronica. La presenza delle
antocianine la rende una pianta angioprotettiva. Si afferma anche che abbia
spiccate capacità regolatrici della pressione sanguigna. E quindi... buon
karkadè!

Il
regalo dell'ambasciatore
Un altro prodotto agricolo tipicamente americano è il
tabacco. Si tratta delle foglie essiccate e
arrotolate o sminuzzate di una pianta chiamata Nicotiana tabacum; il nome è un
omaggio a Jean Nicot, ambasciatore francese in Portogallo, che nel 1559 fece
pervenire un esemplare della pianta, considerata una medicina, alla corte di
Caterina de' Medici. Si ritiene che la parola spagnola "tabaco" derivi dalla
lingua Arawak, e in particolare dal dialetto caraibico Taino: secondo il famoso
Bartolomeo de Las Casas i Taino si riferivano con la parola "tabago" ad una
sorta di pipa a forma di Y, usata per aspirarne il fumo da ambe le narici. Altri
invece sostengono che il termine "tabaco" fosse presente nella lingua spagnola
per definire erbe officinali già a partire dal 1410, e fosse un adattamento
della parola araba "tabbaq", che fin dal IX secolo indicava erbe di vario tipo.
La parola potrebbe essere quindi stata originariamente europea, e
successivamente usata per questa pianta americana. Di sicuro i popoli originari
del continente americano erano abituati a fare uso di tabacco ben prima dello
sbarco dei Conquistadores, ma presto questi ultimi impararono a fumare ed
esportarono la pratica in Europa, dove divenne in breve tempo straordinariamente
popolare. Non ci sono solo pipe, sigari e sigarette: altre forme di consumo
comprendono il tabacco da masticare, il tabacco da fiuto o la vaporizzazione
attraverso dispositivi come le famose "sigarette elettroniche". In Scandinavia è
popolare l'uso dello snus svedese, polvere di tabacco umida che viene posta tra
il labbro e la gengiva superiore; siccome la nicotina in tal modo è assorbita e
non aspirata, la Svezia è il paese d'Europa con il più basso indice di tumori al
polmone.
Pochi lo sanno, ma già prima di Colombo di qua dall'Oceano Atlantico si
usava fumare altri prodotti vegetali, in particolare canapa, ginepri, erbe
aromatiche come ad esempio il farfaro, la lavanda, l'anice, ma anche funghi,
anche allucinogeni. Dato che, assunto in dosi molto elevate, anche il tabacco
provoca effetti di tipo allucinogeno, i nativi americani non lo usavano per puro
diletto, ma piuttosto per provocare stati di trance a scopo rituale e religioso:
fumare era perciò riservato a sciamani e uomini-medicina, che così facendo erano
convinti di entrare in contatto con gli spiriti dei defunti (il culto degli
antenati era già diffuso tra i cacciatori-raccoglitori del Paleolitico, e
storicamente precedette quello della Grande Madre, tipicamente neolitico). Oltre
a fumarlo, presso i nativi americani il tabacco veniva mangiato fresco appena
raccolto, oppure se ne otteneva un succo da consumare come bevanda. I primi
missionari cattolici condannarono con forza l'uso del tabacco, tanto che, man
mano che la loro opera di evangelizzazione si spingeva verso l'interno del
continente, il suo uso a scopi magico-rituali finì per venire meno, tuttavia
ancor oggi l'impiego di tabacco a scopi religiosi è diffuso tra le popolazioni
amazzoniche che vivono secondo i loro costumi tradizionali. Con l'arrivo degli
Europei, il tabacco divenne uno dei più importanti prodotti esportati dal Nuovo
Mondo, e fornì una forte spinta per la colonizzazione dell'America Meridionale;
la volontà di aumentarne la produzione provocò i primi conflitti con i nativi, e
divenne una delle principali motivazioni per lo sfruttamento del lavoro di
schiavi africani nelle piantagioni. Nel 1609, nella colonia di Jamestown in
Virginia, per primo fu il puritano John Rolfe a coltivare con successo il
tabacco per scopi commerciali in Nord America, ma era della specie Nicotiana
rustica, ed il suo sapore non era gradito dai consumatori europei; in seguito
Rolfe portò con sé dalle isole Bermude alcuni semi di Nicotiana tabacum. Poco
dopo il suo arrivo in Virginia, sua moglie morì ed egli sposò in seconde nozze
la famosissima Pocahontas, la figlia del capo indiano Powathan, cui la Disney ha
dedicato un famoso (e romanzato) cartone animato. Quando partì alla volta
dell'Inghilterra con Pocahontas, Rolfe era straricco, ma purtroppo la sua moglie
nativa morì in Europa, ed egli tornò in Virginia per migliorare la qualità del
tabacco. Già nel 1620 riusciva ad inviare in Inghilterra 18 tonnellate di
prodotto all'anno, e quando nel 1622 morì, Jamestown stava prosperando grazie
alla produzione di tabacco. Insomma, prima ancora dei Padri Pellegrini, gli
Stati Uniti d'America sono nati... grazie al tabacco! L'introduzione del tabacco
incontrò una certa resistenza: il re d'Inghilterra Giacomo I Stuart, figlio un
po' bacchettone della famosa e sfortunata Maria Stuarda, nel 1604 scrisse un
famoso libello intitolato "A Counterblast to Tobacco" ("Una forte opposizione al
tabacco"), in cui denunciava l'uso di tabacco come "un'abitudine spiacevole per
l'occhio, odiosa per il naso, nociva per il cervello, pericolosa per i polmoni,
e che per le sue nere e puzzolenti esalazioni ricorda l'orribile fumo che
proviene dal pozzo senza fondo dello Stige"!! Anche in altri paesi, come la
Russia, entrarono in vigore pesanti dazi doganali sull'importazione di tabacco,
ma essi venivano facilmente aggirati dai contrabbandieri. Nel 1650 papa
Innocenzo X comminò addirittura la scomunica contro chiunque usasse il tabacco
all'interno della basilica di San Pietro. Il tabacco continuò tuttavia a
rappresentare un'autentica miniera d'oro per le colonie americane (soprattutto
Virginia e Nord e Sud Carolina) Pensa che, fino al 1883, le accise sul commercio
del tabacco rappresentavano un terzo di tutte le tasse raccolte dal governo
degli Stati Uniti! Nel 1850 il conte belga Hippolyte Visart de Bocarmé avvelenò
il fratellastro con estratto di foglie di tabacco, al fine di ereditare i suoi
beni; questa è stata la prima prova esatta della presenza di alcaloidi in
medicina legale. Il noto chimico belga Jean Servais Stas dimostrò con un esame
tossicologico che l'estratto di tabacco era effettivamente velenoso, e per
questo ottenne fama mondiale, mentre il conte avvelenatore fu
giustiziato. Purtroppo la nicotina, isolata per la prima volta nel 1807 dal
cremonese Gaspare Cerioli, come tutti gli alcaloidi genera una forte dipendenza,
chiamata tabagismo, e per questo motivo Zeno Cosini, il protagonista de
"La Coscienza di Zeno" di Italo Svevo, tentò per una vita inutilmente di
smettere, continuando a scrivere sul suo diario "ultima sigaretta" in
corrispondenza di date curiose, tipo 1/1/1901, salvo poi tornare a fumarne
altre. L'uso di tabacco è praticato da almeno un terzo della popolazione
mondiale adulta, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che il
tabacco è la seconda causa di morte nel mondo dopo l'ipertensione, ma la prima
causa di morte evitabile, e si stima che provochi quasi 6 milioni di decessi
l'anno. Oltre al cancro, l'uso e l'abuso di tabacco provocano danni
cardiovascolari, potenziali danni al feto per le donne incinte e persino rischi
per la vista (il fumo è tra i fattori che favoriscono l'insorgenza di una
malattia della retina chiamata degenerazione maculare legata all'età, che può
provocare ipovisione e cecità centrale). Il 31 maggio di ogni anno a partire dal
1987 si celebra la Giornata Mondiale Senza Tabacco, evidenziando i rischi che
corre la salute umana a causa del fumo e sollecitando politiche per ridurne il
consumo, ma neppure la stampa sui pacchetti di sigarette di foto da incubo (es.
di cancri al polmone) si è rivelato un deterrente efficace, e il tabacco
continua a mietere morti, nonostante - a differenza del cacao - essi non siano
vittima di alcuna "Vendetta di Moctezuma". Per fortuna, il tabacco non ha avuto
solo conseguenze negative sulla storia dell'uomo. Il disastroso impatto
economico provocato dalla comparsa della "malattia del mosaico del tabacco" fu
la spinta che condusse all'isolamento del relativo virus, il primo virus in
assoluto ad essere identificato dalla scienza! Per fortuna si trattava di un
virus tra i più semplici, e così la scienza fu aiutata a fare rapidi progressi
nel campo della virologia. Nel 1946 il Premio Nobel per la chimica fu
assegnato a Wendell Meredith Stanley proprio per i suoi studi su questo virus!

La
spezia che i Romani cercavano in capo al mondo
Il pepe nero (Piper nigrum) è
una pianta rampicante della famiglia delle Piperaceae, coltivata per il suo
frutto (il pepe in grani), che viene solitamente essiccato e utilizzato come spezia e condimento. Il frutto è una drupa che ha un diametro di circa 5 mm,
rosso scuro, e contiene un nocciolo che racchiude un singolo seme di pepe. I
grani di pepe e il pepe macinato da essi derivato sono chiamati pepe nero
(frutti acerbi cotti ed essiccati) oppure pepe verde (frutti acerbi secchi) o
pepe bianco (semi di frutti maturi). La parola pepe deriva dal latino piper e
dal sanscrito pippali, che significa "grano di pepe", probabilmente passando
attraverso il persiano che non aveva la lettera L, e provocando la caduta
dell'ultima sillaba. Nel XVI secolo la parola "pepe" indicava anche il
peperoncino del Nuovo Mondo, del genere Capsicum. La pianta del pepe è una vite
legnosa perenne che cresce fino a 4 m di altezza su pali o tralicci. Si espande
e radica facilmente dove gli steli toccano il suolo. Le foglie sono alterne,
intere, lunghe da 5 a 10 cm e larghe da 3 a 6 cm. I fiori sono piccoli, prodotti
su punte pendule lunghe da 4 a 8 cm ai nodi delle foglie. Il pepe può essere
coltivato in terreni né troppo asciutti né soggetti a inondazioni, ben drenati e
ricchi di sostanza organica. Le viti vengono propagate per talea lunga circa
40-50 cm; su terreni asciutti, le giovani piante richiedono annaffiature a
giorni alterni durante la stagione secca per i primi tre anni. Le piante
fruttificano dal quarto o quinto anno, e poi tipicamente per sette anni. Un
singolo stelo porta da 20 a 30 spighe fruttifere. La raccolta inizia non appena
uno o due frutti alla base delle spighe cominciano a diventare rossi, e prima
che il frutto sia completamente maturo, quando è ancora duro; se lasciati
maturare completamente, i frutti perdono la piccantezza e alla fine cadono e
vanno perduti. Le spighe vengono raccolte e stese ad asciugare al sole, quindi i
grani di pepe vengono tolti dalle spighe. Primo produttore al mondo di pepe nero
nel 2020 è stato il Vietnam (con il 36% del totale mondiale), seguito da
Brasile, Indonesia, India, Sri Lanka, Cina e Malaysia. I grani di pepe sono tra
le spezie più commercializzate al mondo, rappresentando il 20% di tutte le
importazioni di spezie. Il pepe selvatico cresce nella regione indiana dei Ghati
occidentali. Nel XIX secolo le foreste contenevano estensioni di pepe selvatico,
come registrato dal medico e botanico scozzese Francis Buchanan nel suo "Un
viaggio da Madras attraverso i paesi di Mysore, Canara e Malabar". Ad oggi
purtroppo la deforestazione ha portato al declino del pepe selvatico; finora non
è stato ottenuto alcun innesto riuscito di pepe commerciale su pepe selvatico.
E ora, un po' di storia. Il pepe nero è originario dell'Asia meridionale e del
sud-est asiatico ed è noto alla cucina indiana almeno dal 2000 a.C. Il suo
esportatore più importante era l'India, in particolare la costa del Malabar, in
quello che oggi è lo stato del Kerala. L'antica città portuale di Muziris (oggi Kodungallur),
famosa per l'esportazione di pepe nero e di varie altre spezie, è citata in
molte fonti storiche classiche per il suo commercio con l'Impero Romano: la
troviamo in Plinio il Vecchio e Claudio Tolomeo. I grani di pepe erano un bene
commerciale molto apprezzato, spesso indicato come "oro nero" e usato persino
come denaro. I romani conoscevano bene il pepe, e la sua popolarità non declinò
fino alla scoperta del Nuovo Mondo e all'arrivo del peperoncino, più facile da
coltivare in luoghi più vicini all'Europa. Grani di pepe nero sono stati trovati
infilati nelle narici della mummia di Ramses II, essendo parte dei rituali di
mummificazione, ma poco si sa su come il pepe raggiungesse il Nilo dalla costa
del Malabar. Il pepe era conosciuto in Grecia almeno nel IV secolo a.C., sebbene
fosse probabilmente un oggetto raro e costoso che solo i più ricchi potevano
permettersi; Ippocrate lo consiglia contro i dolori mestruali. Dopo la conquista
dell'Egitto da parte di Roma nel 30 a.C., la traversata in mare aperto del Mar
Arabico diretta alla costa del Malabar governata dalla dinastia Chera era quasi
una routine. I dettagli di questo commercio attraverso l'Oceano Indiano sono
stati tramandati nel "Periplo del Mare Eritreo", un'opera geografica del I
secolo d.C. Secondo il geografo greco Strabone, l'impero romano inviava una
flotta di circa 120 navi in un viaggio annuale in India e ritorno, sfruttando i
prevedibili venti monsonici. Di ritorno dall'India, le navi risalivano il Mar
Rosso, da dove il carico veniva trasportato via terra fino al fiume Nilo,
imbarcato ad Alessandria e da lì spedito a Roma. L'itinerario di questa rotta
commerciale dominò il commercio del pepe in Europa per un millennio e mezzo.
Plinio il Vecchio si lamentava dei prezzi eccessivi: "Non c'è anno in cui
l'India non prosciughi l'Impero Romano di 50 milioni di sesterzi!" Il pepe nero
era un condimento noto e diffuso, anche se costoso, nell'impero romano: il "De
re coquinaria" di Apicio, un libro di cucina del III secolo, include il pepe
nella maggior parte delle sue ricette. Alarico, re dei Visigoti, incluse 3.000
libbre di pepe come parte del riscatto che chiese a Roma quando assediò la città
nel 410 d.C. (e ancor oggi a Roma è invalso il detto "caro come il pepe"!) Dopo
la caduta di Roma, prima i persiani e poi gli arabi ne presero il posto alla
guida del commercio delle spezie; il navigatore bizantino Cosma Indicopleuste,
che viaggiò nell'Oceano Indiano nel VI secolo, comprovò che il pepe veniva
ancora esportato dall'India alla sua epoca. Nell'Alto Medioevo il commercio
delle spezie era saldamente sotto il controllo islamico (dagli avventurosi
viaggi dei mercanti arabi nell'Oceano Indiano deriva il racconto di Simbad il
Marinaio); una volta nel Mediterraneo, il commercio era in gran parte
monopolizzato da Venezia e Genova. L'ascesa di queste repubbliche marinare fu
finanziata in gran parte dal commercio delle spezie. Un indovinello scritto da
Saint Aldhelm. vescovo di Sherborne del VII secolo, fa luce sul ruolo del pepe
nero in Inghilterra nell'Alto Medioevo: « Sono nero all'esterno, avvolto in una
coperta grinzosa, / eppure dentro porto un midollo ardente. / Condisco le
prelibatezze, i banchetti dei re e i lussi della tavola, / sia le salse che le
carni intenerite della cucina. / Ma non troverai in me alcuna qualità di valore,
/ a meno che le tue viscere non siano state scosse dal mio midollo luccicante! »
La convinzione che il pepe nel Medioevo fosse ampiamente utilizzato come
conservante delle carni è discutibile; è vero che la piperina, il composto che
conferisce al pepe la sua piccantezza, ha alcune proprietà antimicrobiche, ma
alle concentrazioni presenti quando il pepe viene usato come spezia, l'effetto è
minimo. Il sale è un conservante molto più efficace e le carni salate erano cibo
comune, soprattutto in inverno. Piuttosto, il pepe e altre spezie hanno
sicuramente avuto un ruolo nel migliorare il gusto delle carni a lunga
conservazione, e per questo era così ricercato. Del pepe parlarono i viaggiatori
tardomedioevali italiani Marco Polo e Niccolò dei Conti nei loro resoconti di
viaggio. Un riferimento al pepe si trova persino nella "Divina Commedia", perchè
nella settima bolgia (quella dei ladri) Dante vede « un serpentello acceso, /
livido e nero come gran di pepe » (Inf. XXV,83-84)!
È possibile che il pepe nero fosse conosciuto in Cina nel II secolo a.C., se
sono storici i resoconti poetici riguardanti un esploratore di nome Tang Meng. Inviato dall'imperatore Wu in quella che oggi è la Cina sud-occidentale,
si dice che Tang Meng si sia imbattuto in qualcosa chiamato jujiang; gli fu
detto che proveniva dai mercati di Shu, un'area in quella che oggi è la
provincia del Sichuan. L'opinione tradizionale tra gli storici è che egli si
riferisse al pepe. Nel III secolo d.C. il pepe nero fece la sua apparizione
definitiva nei testi cinesi, chiamato hujiao o "pepe straniero". Il pepe
compare nel testo buddista "Samaññaphala Sutta" come una delle poche medicine
che un monaco può portare con sé. Entro il XII secolo era diventato un
ingrediente popolare nella cucina dei ricchi cinesi, prendendo il posto del pepe
di Sichuan, originario della Cina (è il frutto essiccato di una pianta non
imparentata col pepe). Nel corso dei suoi viaggi all'inizio del XV secolo,
l'ammiraglio eunuco Zheng He e le sue imponenti flotte tornarono dall'India con
una quantità così grande di pepe nero, che il bene di lusso un tempo costoso
divenne un prodotto comune in Cina.
Il prezzo esorbitante del pepe e il monopolio sul commercio detenuto dall'Impero
Ottomano e dalle repubbliche marinare italiane fu uno degli incentivi che
spinsero i Portoghesi a cercare una rotta marittima alternativa verso l'India.
Proprio sulle tracce del prezioso pepe, il 20 maggio 1498 Vasco da Gama
(1469-1524) fu il primo europeo a raggiungere l'India navigando intorno
all'Africa. Quando gli abitanti di Calicut (oggi Kozhikode, non ha nulla a che
vedere con l'attuale Calcutta) gli chiesero perché fosse venuto fin lì, Vasco da
Gama rispose loro: "Cerchiamo cristiani e spezie". Il trattato di Tordesillas
del 1494 con gli spagnoli concessi al Portogallo i diritti esclusivi sulla metà
del mondo da cui ha avuto origine il pepe nero. Tuttavia, alla lunga, i
portoghesi si dimostrarono incapaci di monopolizzare il commercio delle spezie.
Le reti commerciali arabe e veneziane più antiche importavano con successo
enormi quantità di spezie e il pepe ancora una volta passava attraverso
Alessandria e l'Italia, e nel XVII secolo i portoghesi persero quasi tutto il
loro prezioso commercio nell'Oceano Indiano a favore degli olandesi e degli
inglesi che, approfittando del dominio spagnolo sul Portogallo durante l'Unione
con la Spagna (1580-1640), occuparono con la forza quasi tutte le stazioni
commerciali portoghesi nell'Indiano. Con l'aumento delle forniture di pepe in
Europa, il suo prezzo cominciò a diminuire, e così il pepe, che nell'alto
Medioevo era stato un alimento esclusivamente per ricchi, cominciò a diventare
un condimento sempre più quotidiano. Oggi il pepe rappresenta un quinto del
commercio mondiale di spezie; ed è sulle tracce dei suoi preziosi e profumati
chicchi, che i navigatori e conquistatori europei dell'Età Moderna mossero alla
conquista del mondo. Gli imperi coloniali dell'ottocento e i loro eredi
contemporanei poggiano dunque le loro basi su uno strato di pepe nero spesso
molti secoli.
Il pepe ottiene il suo sapore speziato principalmente dalla piperina derivata
sia dal frutto esterno che dal seme. Il pepe nero contiene tra il 4,6 e il 9,7%
di piperina in massa e il pepe bianco leggermente di più. La piperina raffinata,
in peso, è circa l'uno per cento più piccante della capsaicina che si trova nei
peperoncini. Lo strato esterno del frutto, lasciato sul pepe nero, contiene
anche terpeni che contribuiscono all'aroma e gli donano note agrumate. Questi
profumi sono per lo più assenti nel pepe bianco, poiché la fermentazione e altre
lavorazioni rimuovono lo strato di frutto che contiene anche parte della
piperina speziata. Un cucchiaio (6 grammi) di pepe nero macinato contiene
quantità moderate di vitamina K (13% del valore giornaliero), ferro e manganese,
con tracce di altri nutrienti essenziali, proteine e fibre alimentari. Come
molte spezie orientali, il pepe è stato storicamente sia un condimento che una
medicina tradizionale. Si credeva che il pepe nero curasse diverse malattie come
stitichezza, insonnia, ascessi orali, scottature solari e mal di denti. Diverse
fonti dal V secolo in poi raccomandavano il pepe per trattare problemi agli
occhi, spesso applicando unguenti o impacchi a base di pepe direttamente
sull'occhio. Pare che la piperina possa facilitare l'assorbimento di selenio
vitamina B12 e beta-carotene, ma le ricerche mediche non hanno ancora confermato
alcun beneficio terapeutico per l'uomo. Esiste anche l'olio di pepe, ma è usato
come olio da massaggio ayurvedico e in alcuni trattamenti estetici e di
bellezza.
Un luogo comune afferma che respirare del pepe causare starnuti. Alcuni
affermano che la piperina, sostanza presente nel pepe nero, irrita le narici,
provocando lo starnuto, ma pochi studi scientifici sono stati condotti per
rispondere a questa domanda. Per concludere, esiste anche il cosiddetto "falso
pepe nero", cioè Embelia ribes, una specie della famiglia delle primule che con
la spezia dell'India non ha nulla a che vedere. La corteccia di Drimys winteri
("corteccia d'inverno") è usata come sostituto del pepe nelle regioni fredde e
temperate del Cile e dell'Argentina, dove è facilmente reperibile. In Nuova
Zelanda, i semi di kawakawa (Piper excelsum), un parente del pepe nero, sono
talvolta usati per sostituirlo. Una persona di carattere molto vivace è definita
in italiano "un peperino", probabilmente per la piccantezza della nostra spezia.
Infine, il pepe era tra gli ingredienti del famoso "Caffè della Peppina"
nell'omonima canzone vincitrice dello Zecchino d'Oro 1971, che è stata una delle
colonne sonore della mia infanzia; ma quella bevanda fantasy vi sconsiglio
vivamente dal provare a prepararla!

Il
seme
di Carnevale
Il
coriandolo (Coriandrum sativum) è un'erba annuale della famiglia delle
Apiacee, originario delle regioni che vanno dall'Europa meridionale e
dall'Africa settentrionale fino all'Asia sudoccidentale. "Coriandrum" è una
parola latina citata da Plinio il Vecchio (Naturalis Historia, XX, 82), che ha
le sue radici nella parola greca corys o korios ("cimice dei letti") con il
suffisso -ander ("somigliante"), in riferimento alla supposta somiglianza
dell'odore emanato dai frutti acerbi (o sfregando le foglie) con quello del
suddetto insetto. È una pianta che cresce fino a 50 cm di altezza; le foglie
sono di forma variabile, lobate alla base della pianta, e sottili e piumose più
in alto sugli steli fioriferi. I fiori sono bianchi o rosa pallido, sono riuniti
in infiorescenze a ombrello, asimmetriche e con i petali rivolti lontano dal
centro dell'infiorescenza più lunghi di quelli rivolti verso di esso. Il frutto
è un achene globoso e secco di 3–5 mm di diametro. Tutte le parti della pianta
sono commestibili, ma le foglie fresche e i semi essiccati sono le parti più
tradizionalmente utilizzate in cucina. La maggior parte delle persone percepisce
il sapore del coriandolo come aspro, simile a quello del limone, ma per
alcuni le foglie sanno di sapone (la percezione di un gusto saponoso di alcune
aldeidi è legata a un gene specifico, OR6A2, deputato a codificare un recettore
altamente sensibile alle sostanze chimiche aldeidiche, e che non tutti
possiedono. Io, per esempio, non ce l'ho), e questo ne ha limitato l'uso in
Europa.
E ora, un po' di storia. Il coriandolo cresce spontaneamente in una vasta area
dell'Asia occidentale e dell'Europa meridionale, il che rende difficile definire
esattamente di dove questa pianta sia originaria e dove si sia stabilita solo di
recente. Studi recenti hanno suggerito che le specie di coriandolo trovate allo
stato selvatico in Israele e Portogallo potrebbero rappresentare l'antenato del
coriandolo oggi coltivato. Quindici semi essiccati sono stati trovati nel
livello B del neolitico pre-ceramico (da sei a ottomila anni fa) della grotta di
Nahal Hemar in Israele. Se questi reperti appartengono agli strati archeologici
in cui li abbiamo rinvenuti, rappresentano il più antico ritrovamento di
coriandolo al mondo. Alcuni semi di coriandolo sono stati recuperati dalla tomba
di Tutankhamon e, poiché questa pianta non cresce spontaneamente in Egitto,
questa scoperta è considerata la prova che il coriandolo fosse già coltivato
dagli antichi egizi. Il papiro Ebers, un testo egiziano datato intorno al 1550
a.C., menziona vari usi del coriandolo. Il coriandolo sembra essere stato
coltivato in Grecia almeno dal secondo millennio a.C. Una delle tavolette in
lineare B recuperate a Pilo si riferisce al coriandolo perché coltivato per la
fabbricazione di profumi; la parola in scrittura sillabica lineare B che lo
indica è "ko-ri-ja-da-na", curiosamente simile al nome della mitologica figlia
di Minosse, Arianna, di solito fatto derivare dal greco "ariadne" cioè "casta",
"pura". Le grandi quantità di coriandolo recuperate in uno strato della prima
età del bronzo a Sitagroi in Macedonia potrebbero indicare la sua coltivazione
della specie in quell'epoca. Successivamente il coriandolo fu menzionato da
Ippocrate (intorno al 400 a.C.) e da Dioscoride (65 d.C.). I Romani lo usarono
moltissimo e Apicio ne fa la base di un condimento chiamato "Coriandratum".
Secondo Plinio il Vecchio, mettendo alcuni semi di coriandolo sotto il cuscino
al levar del sole si poteva far sparire il mal di testa e prevenire la
febbre. Viene ricordato nella Bibbia nel seguente passo dell'Esodo: "E il popolo
d'Israele diede il nome di ‘Manna' a quel cibo che era bianco come il seme di
coriandolo; e il suo sapore era come di focaccia fatta col miele" (Es 16,31).
Per inciso, la biblica manna - il cui nome deriva da "Mân Hu" che significa
"cos'è?", espressione di stupore degli Ebrei nel veder piovere un cibo
sconosciuto dal cielo - è data dalla secrezione dei giovani rami, provocata
dalle punture di un insetto su varie piante del deserto (Anabasis articulata,
Haloxylon schweinfurthii e alcune specie di Tamarix e di Artemisia), ancor oggi
è usata come alimento dai beduini dell'Arabia e dei paesi vicini, e in effetti
niente ha in comune con il coriandolo, se non forse vagamente il sapore.
Attenzione all'equivoco: i frutti di coriandolo essiccati sono spesso chiamati
"semi di coriandolo" se usati come spezia. Il linalolo, un terpenoide,
contribuisce in modo determinante alla fragranza del coriandolo. I tipi a frutto
grosso sono coltivati principalmente nei paesi tropicali e subtropicali, ad
esempio Marocco, India e Australia, e contengono un basso contenuto di olio
volatile. Sono ampiamente utilizzati per la macinazione e la miscelazione nel
commercio delle spezie. I tipi con frutti più piccoli vengono prodotti nelle
regioni temperate e di solito hanno un contenuto maggiore di olio volatile e
quindi sono molto apprezzati come materia prima per la preparazione di olio
essenziale. La tostatura o il riscaldamento dei semi in una padella asciutta ne
esalta il sapore, l'aroma e la piccantezza. I semi di coriandolo macinati
perdono rapidamente sapore durante la conservazione, ed è meglio macinarli
freschi. Il seme di coriandolo è una spezia molto usata nei curry indiani, che
spesso impiegano i frutti macinati in quantità generose insieme al cumino. I
semi di coriandolo tostati vengono consumati come snack. Al di fuori dell'Asia,
i semi di coriandolo sono ampiamente usati per mettere in salamoia le verdure.
In Germania e Sudafrica i semi vengono utilizzati durante la preparazione delle
salsicce. I semi di coriandolo sono usati nella preparazione di alcuni tipi di
birra, in particolare alcune birre di frumento belghe, e per aromatizzare il
gin. Inoltre il coriandolo è elencato come uno degli ingredienti originali nella
formula segreta della Coca-Cola.
Le foglie fresche di coriandolo sono particolarmente utilizzate nei paesi
orientali, motivo per il quale esso viene chiamato anche "prezzemolo cinese": è
un ingrediente in molti cibi come chutney e insalate, e come guarnizione per
zuppe, pesce e carne. Poiché il calore diminuisce il loro sapore, le foglie di
coriandolo vengono spesso utilizzate crude o aggiunte al piatto immediatamente
prima di servire. Le radici di coriandolo invece hanno un sapore più intenso
rispetto alle foglie e sono utilizzate in una varietà di cucine asiatiche,
specialmente nei piatti tailandesi.Alcune persone sono allergiche alle foglie o
ai semi di coriandolo, con sintomi simili a quelli di altre allergie alimentari:
in uno studio che esaminava persone sospettate di allergie alimentari alle
spezie, il 32% dei test nei bambini e il 23% negli adulti erano positivi per il
coriandolo e altri membri della famiglia delle Apiacee, tra cui cumino,
finocchio e sedano. Per fortuna però ci sono anche molti aspetti positivi: il
coriandolo può essere usato come infuso contro i dolori di stomaco, è
consigliato anche per problemi di aerofagia e le emicranie, aiuta la digestione
e ha una funzione antidiarroica; contiene preziosi oli essenziali che forniscono
flavonoidi e steroli, importanti per il loro potere antiossidante e per la
capacità di ridurre il colesterolo cattivo nel sangue. Inoltre contiene vitamina
A, vitamine del gruppo B, vitamina C, E, K e sali minerali tra cui fosforo,
calcio, ferro, zinco e manganese. In Sri Lanka le popolazioni Tamil utilizzano i
frutti per la preparazione di un decotto che, dolcificato con il miele, è
assunto per alleviare la tosse. Ultima curiosità: dai semi rivestiti di
zucchero, lanciati addosso alle maschere durante il Rinascimento, prendono nome
i famosi coriandoli di Carnevale, in un secondo momento sostituiti da
pallottoline di gesso, e oggi da dischetti di carta multicolori!

La
bacca della Nuova Guinea
Può sembrare incredibile, ma dal punto di vista botanico anche la
banana è una bacca! La pianta del banano,
appartenente alla Famiglia delle Musacee, non è affatto africana o sudamericana,
è originaria dei paesi tropicali del Sud-Est Asiatico (Malesia, Indonesia e
Filippine). La pianta di banana è la più grande pianta erbacea dotata di fiore:
spesso è scambiate per un albero, ma il suoo fusto principale è in effetti uno
pseudofusto che cresce fino a 6 o 7 metri a partire da una specie di tubero:
dopo la fruttificazione lo pseudofusto muore, ma possono svilupparsi e crescere
dei polloni laterali. Il frutto si sviluppa in una serie di grappoli, i popolari
"caschi", che possono pesare anche 30–50 kg. Le banane pesano tipicamente uno o
due etti, ma circa il 20% del peso è da attribuire alla buccia. Sono costituite
da uno strato protettivo esterno, la buccia appunto, con numerosi fili lunghi e
sottili (il cosiddetto floema), che corrono lungo tutta la lunghezza tra la
buccia e la parte interna commestibile. Il sapore e la struttura di molti tipi
di banane sono influenzati dalla temperatura a cui maturano, e dal grado di
maturazione: i frutti fatti maturare per più tempo e a temperature maggiori
avranno minore consistenza e saranno più dolci rispetto a quelli più acerbi e
cresciuti in ambiente più rigido o ventilato, che saranno quindi più turgidi e
meno saporiti. Il colore della polpa evolve dal verde verso il giallo e, in
avanzato stato di maturazione, tende a mostrare tipiche chiazze marroni
corrispondenti ad accumuli di zuccheri. Il livello di maturazione è visibile
anche dal colore della buccia: tendente al verde nelle banane acerbe, al giallo
scuro con piccole chiazze marroni in quelle molto mature, al giallo acceso nelle
altre. Quasi tutte le moderne banane utilizzate a scopo alimentare provengono
dalle specie Musa acuminata e Musa balbisiana. Nella cultura popolare e nel
commercio con "banana" di solito ci si riferisce alle banane utilizzate come
frutta, ma esistono anche cultivar di Musa con frutti più duri e ricchi di
amido, inadatte ad essere consumate crude, e nei paesi di lingua spagnola
vengono chiamate "platani", anche se con il nostro omonimo albero d'alto fusto
non c'entrano un bel niente. Le banane maturano generalmente nella stagione
primaverile o estiva del luogo in cui si trovano, e manifestano la tendenza a
maturare anche dopo essere state colte dalla pianta: questo processo è dovuto
all'emissione di etilene da parte della banana stessa, e caratterizza in
generale tutti i cosiddetti frutti climaterici, anche se nel caso della banana
il fenomeno è particolarmente marcato. Il fenomeno è accelerato dalle
temperature elevate, che influiscono sulla maggiore produzione di etilene, dalla
ridotta ventilazione e dalla presenza di altri frutti climaterici nelle
vicinanze, come mele, pomodori o altre banane più mature. A sorpresa, oggigiorno
il primo produttore mondiale di banane non è una nazione sudamericana ma
l'India, seguita da Cina, Filippine e Brasile. A causa del riscaldamento
climatico, oggi si riesce a far fruttificare i banani persino in Italia, e in
particolare in Sicilia (dopotutto Ragusa è più a sud di Tunisi!)
L'etimologia
della parola banana è una delle più incerte, tra tutti gli ortaggi e i frutti di
cui vi ho parlato: i più la riconducono all'arabo banan, dito" (per la sua
forma), ma c'è chi ritiene più probabile che derivi da una lingua dell'Africa
occidentale subsahariana, rappresentando il plurale con prefisso ba- (come
inbaNtu o baLuba) del suo nome originario (ed inesplicato) "nana"; forse
indicava in origine una località oggi non più rintracciabile, poiché la banana
veniva chiamata "il fico di Banane". In ogni caso, il suo significato originario
si è perso lungo le rotte commerciali che per millenni hanno viaggiato
dall'Africa Occidentale fino alla remota Cina. Recenti prove archeologiche e
paleoambientali nelle paludi del Kuk, in Papua Nuova Guinea, suggeriscono che la
coltivazione della banana risalga almeno al 5000 a.C. e forse anche all'8000 a.C.:
se è vero, sarebbe nei lontanissimi e piovosi altopiani della Nuova Guinea che
il banano fu domesticato per la prima volta, ma è possibile che altre specie di
banani selvatici siano state domesticate successivamente in altre zone dell'Asia
sudorientale. La prima menzione scritta della banana si trova in testi buddisti
del 500 a.C. Alessandro Magno scoprì la banana nelle valli dell'India nel 327
a.C., primo europeo in assoluto (per quanto ne sappiamo) ad assaggiarla.
L'esistenza di una coltivazione organizzata di banane è stata dimostrata in Cina
almeno dal 200 d.C. Nel 650 d.C. i conquistatori islamici portarono la banana in
Egitto, e successivamente in quasi tutta l'Africa. Intorno al 1516 la pianta di
banana fu introdotta dai portoghesi nei Caraibi e in America Centrale. Tutti
conoscono le banane del marchio "Chiquita", ma pochi sanno che tali banane...
grondano di sangue innocente. La multinazionale nacque infatti nel 1899 con il
nome di United Fruit Company, dalla fusione tra la Boston Fruit Company e la
società ferroviaria Minor C. Keith, che aveva piantato banani lungo i suoi
binari. In poco tempo divenne così potente da influenzare la politica e persino
l'elezione dei capi di stato nei paesi latinoamericani! Il 5 dicembre 1928 in
Colombia i lavoratori, costretti a restare 15-18 ore al giorno nelle piantagioni
senza alcun diritto, entrarono in sciopero chiedendo contratti scritti, giornate
lavorative di otto ore, settimane di lavoro di sei giorni e l'eliminazione dei
buoni pasto. La United Fruit Company convinse il governo di Bogotà che si
trattava di una pericolosa insurrezione bolscevica, e il Presidente Miguel
Abadìa Méndez inviò un reggimento dell'esercito che aprì il fuoco su una folla
di operai e sulle loro famiglie, compresi i bambini, che si erano radunati dopo
la messa domenicale, compiendo una strage: si parla di oltre mille morti. Nel
1984 la United Fruit Company è stata rifondata e ribattezzata "Chiquita" nel
tentativo di cancellare gli orrori del passato, ha accettato le richieste
sindacali dei lavoratori e da allora ha rigato diritto, ma quella terribile
macchia nella sua storia rimane.
Oltre ai frutti, nella cucina del Bengala e del Kerala si usano i fiori del banano, crudi o cotti. Negli stessi paesi e in
Birmania si consuma pure il cuore tenero del tronco del banano. Le banane sono
consumate anche essiccate: hanno un colore marrone scuro e un sapore tipico e
intenso. In Ruanda, Burundi, Uganda, Tanzania e Repubblica Democratica del Congo
si usa far fermentare le banane per ottenere una bevanda alcolica, detta kasiksi.
Tuttavia, al contrario di altri frutti, sono state usate solo recentemente per
preparare succhi e spremute: malgrado l'85% di contenuto d'acqua, è stato
storicamente difficile estrarre il succo dal frutto perché, quando viene
pressata, una banana diventa semplicemente polpa. Nel 2004, però, gli scienziati
del "Bhabha Atomic Research Centre" in India, hanno brevettato una tecnica per
estrarre il succo trattando la polpa di banana in un recipiente con una reazione
che impiega da 4 a 24 ore. Le foglie di banana, grandi, flessibili e
impermeabili, lunghe fino a 2,7 metri per 60 centimetri di larghezza, sono usate
come ombrelli e per avvolgere cibi. Inoltre la buccia della banana veniva
utilizzata come medicinale per il trattamento della psoriasi. Pochi sanno che è
possibile utilizzare la buccia di banana come lucido per scarpe ecologico! Dato
che sono ingegnere nucleare, non posso fare a meno di far notare che le banane
sono naturalmente lievemente radioattive, più di ogni altro frutto, a causa del
loro alto contenuto di potassio, e di conseguenza della relativamente abbondante
percentuale di potassio-40, che fa parte della miscela naturale (ed è usato per radiodatazioni alternative al radiocarbonio). Pensa che a volte ci si riferisce
alla "dose equivalente a una banana di radiazione" per far comprendere i livelli
di rischio della radioattività!
E ora, alcune curiosità. In certe zone del
sudest asiatico, ad esempio a Singapore, "banana" è un termine dispregiativo per
una persona di origine asiatica che non conosce molto della cultura asiatica ma
vive all'europea e parla inglese correntemente, perchè di loro si dice: "giallo
fuori, bianco dentro". In Occidente, invece, quando pensiamo a "banana" ci viene
in mente una comica in cui un tizio scivola su una buccia di banana, un classico
della comicità senza tempo. Ma si tratta solo di una leggenda metropolitana; in
realtà la buccia di banana non è più sdrucciolevole di quella di altri frutti.
Il suo utilizzo nelle gag è stato introdotto semplicemente per sostituire... la
cacca, in realtà ben più scivolosa, come purtroppo tutti abbiamo verificato
prima o poi, mantenendone la comicità ma edulcorando la situazione, soprattutto
in culture bacchettone come quella di primo '900 in cui furono girate le prime
comiche mute. Alcuni film horror invece parlano di terribili tarantole che si
nascondono nei caschi di banane, pronte a tendere agguati a chi li
raccoglie o li consuma; un riferimento a tale mito è presente anche nella
canzone "Banana Boat Song", canto popolare giamaicano (« Hide the deadly black
tarantula »). In realtà le tarantole non si nascondono tra le banane, ma hanno
questa abitudine degli esemplari del genere Phoneutria; questi ragni autoctoni
delle zone dell'America Centrale e Meridionale sono in effetti molto velenosi e
altamente aggressivi. Un'altra nota leggenda metropolitana attribuisce proprietà
allucinogene alla buccia essiccata della banana, se fumata. Questa diceria, che
non ha trovato conferme scientifiche, risale a un articolo del marzo 1967 in un giornale
studentesco, il "Berkeley Barb", ispirato alla storia del cantante
Country Joe McDonald, e più tardi a una canzone degli anni ottanta di un gruppo
punk satirico, "The Dead Milkmen", che magnifica gli effetti della buccia di
banana da fumare: perfino la FDA aprì un'inchiesta, ma il fatto restò solo una
leggenda e niente più. Infine, non dimentichiamo il mitico capolavoro del grande
Bud Spencer:
Banana Joe!

La
pigna con il ciuffo
L'ananas è una pianta tropicale
perenne della famiglia delle Bromeliaceae, che cresce in media da un metro a un
metro e mezzo di altezza, ha un gambo corto e tozzo con foglie dure e cerose, ed
i singoli fiori della pianta non impollinata si fondono per formare un frutto
multiplo. In natura gli ananas vengono impollinati principalmente dai colibrì di
giorno e dai pipistrelli di notte. Il primo riferimento in inglese al frutto
dell'ananas fu la traduzione dal francese del 1568 di "The New Found World" di
André Thevet, dove si parla di una "Nana fatta alla maniera di una pigna",
usando una parola della lingua Tupinamba (una tribù del Brasile), "nanas", che
significa "frutto eccellente". Questo nome è stato adottato da molte lingue
europee e ha portato al nome scientifico della pianta, Ananas comosus, dove
comosus ("ciuffo"), si riferisce alla rosetta di brattee sopra ogni frutto.
La
prima registrazione della parola ananas da parte dell'Oxford English Dictionary
è del 1714. La pianta selvatica proviene dai dintorni del fiume Paraná, tra il
Brasile meridionale e il Paraguay. Poco si sa della sua domesticazione, ma si è
diffuso come coltura in tutto il Sudamerica. Prove archeologiche del suo uso
risalgono al 1200 a.C. in Perù e al 200 a.C. in Messico, ove era coltivato dai
Maya. Il primo europeo a incontrare l'ananas fu Colombo, il 4 novembre 1493, il
quale lo chiamò "piña de Indes", che significa "pino degli indiani". L'ananas è
stato documentato nelle "Decadi del Nuovo Mondo" di Pietro Martire (1516) e
nella Relazione del primo viaggio intorno al mondo di Antonio Pigafetta
(1524-1525); la prima illustrazione conosciuta si trova nella Historia General
de Las Indias di Oviedo (1535). Furono i portoghesi a prelevare l'arbusto dal
Brasile e ad introdurlo in India nel 1550, ma non fu coltivato con successo in
Europa fino a quando Pieter de la Court non sviluppò l'orticoltura in serra
vicino a Leida (Paesi Bassi) a partire dal 1658. A causa delle spese di
importazione e dell'enorme costo in attrezzature e manodopera necessari per
coltivarli in un clima temperato, nelle serre chiamate "pineries", l'ananas
divenne un simbolo di ricchezza: inizialmente i frutti erano usati
principalmente per decorare le tavole durante le cene, piuttosto che per essere
mangiati. Si cominciò a consumarlo solo ai primi dell'800, e la prima
piantagione commerciale nelle Hawaii fu fondata nel 1886. Oggi uno dei
principali produttori mondiali sono le Filippine, l'importazione in Europa è
gestita soprattutto dalla californiana Del Monte Foods Inc., protagonista negli
anni '80 e '90 di un celeberrimo spot pubblicitario italiano ("L'uomo Del Monte
ha detto sì!")
Purtroppo gli ananas esportati dal Sudamerica all'Europa sono
usati frequentemente come veicolo di copertura per il narcotraffico, per via
dell'odore dei frutti che tende a confondere i cani antidroga (per fortuna,
sempre meno spesso). La polpa e il succo dell'ananas sono utilizzati nelle
cucine di tutto il mondo; in molti paesi tropicali, l'ananas viene preparato e
venduto ai bordi delle strade come spuntino. Viene venduto intero o tagliato a
metà, con un bastoncino inserito. Le fette intere e private del torsolo con una
ciliegia nel mezzo sono una guarnizione comune del prosciutto; dadini di ananas
vengono utilizzati in macedonia, ma anche in alcuni piatti salati, e persino
come condimento per la pizza! Il succo dell'ananas viene servito come bevanda,
ed è anche l'ingrediente principale di cocktail come la piña colada. Ma non vi venga la tentazione di assaggiare il cilindro centrale
dell'ananas, perchè pizzica terribilmente la lingua: io l'ho provato, ed è vero!
Nel laboratorio di chimica del mio Liceo, invece, il succo d'ananas è usato
negli esperimenti per l'estrazione del DNA dalle cellule, perchè contiene la bromelina, potente antinfiammatorio ma anche sostanza capace di demolire le
membrane cellulari e quelle dei nuclei, rilasciando così il DNA. E per
finire, il succo di ananas assunto per via orale è utilizzato in radiologia come
mezzo di contrasto per gli esami di angiografia in risonanza magnetica al posto
di altre costose sostanze di sintesi.

Le
foglie dei martiri
Or vi delizierò con un altro albero ben noto alla Bibbia: Phoenix
dactylifera, cioè la ben nota palma da dattero,
della famiglia delle Arecacee (che comprende tutte le palme). Essa raggiunge
addirittura i 30 metri di altezza, crescendo singolarmente o formando un ciuffo
con diversi steli da un ' apparato radicale. A crescita lenta, può
raggiungere i 100 anni. Come gli altri membri della famiglia delle palme, le
palme da datteri non producono anelli nel tronco. Le foglie sono lunghe 4–6 m,
con spine sul picciolo, con circa 150 foglioline. L'intera ampiezza della corona
varia da 6 a 10 metri. I frutti sono ovali, lunghi da 3 a 7 centimetri e di
circa 2,5 cm di diametro, con colore che va dal marrone scuro al rosso vivo o al
giallo, a seconda della varietà. Contenendo il 60-68% di zucchero in massa una
volta essiccati, i datteri sono molto dolci e sono apprezzati come dessert.
I
datteri sono coltivati in Medio Oriente e nella Valle dell'Indo da migliaia di
anni. 'Intu', la radice proto-dravidica del termine "Hindu", e quindi
dell'"India", si riferiva in origine proprio alle palme da datteri che si
trovano nella regione della Valle dell'Indo! Il nome attuale del frutto deriva
dalla parola δάκτυλος, "dito", a causa della forma allungata del frutto (se
ricordate, era la stessa etimologia dall'arabo proposta per la banana); anche il
nome scientifico della specie, "dactylifera", deriva dalla stessa parola
greca. La palma da datteri è dioica, con piante maschili e femminili separate.
Possono essere facilmente coltivate piantandone il seme, ma solo il 50% delle
piantine sarà femmina e quindi fruttifero, e i datteri delle piantine sono
spesso più piccoli e di qualità inferiore. La maggior parte delle piantagioni
commerciali utilizza quindi talee di cultivar con raccolto molto più
consistente. Le piante cresciute da talee fruttificano 2-3 anni prima delle
piantine cresciute dal seme. Si diffonde così facilmente che in alcune zone
degli USA e dell'Australia è classificata come specie aliena invasiva. Le palme
da datteri mature possono produrre 70–140 chilogrammi di datteri per stagione
del raccolto; non maturano tutti contemporaneamente, quindi sono necessari
diversi raccolti. Per ottenere frutti di qualità commerciabile, i grappoli di
datteri devono essere diradati e insaccati o coperti prima della maturazione in
modo che i frutti rimanenti crescano più grandi e siano protetti dalle
intemperie e dagli uccelli. Un famoso proverbio arabo recita: « Quando è finita
la stagione dei datteri, tutti hanno da ridire della palma » (sante parole!)
Nel 2020, la produzione mondiale di datteri è stata di 9 milioni di tonnellate.
Anche se in Italia noi consumiamo soprattutto i datteri della Tunisia, il primo
produttore al mondo di datteri è l'Egitto, tallonato da Arabia Saudita, Iran e
Algeria; sono una coltura tradizionale in tutto il Medio Oriente e del Nord
Africa, ma vengono coltivati anche negli Stati Uniti sudoccidentali e in
Messico. Oggi si pensa che ne esistano 400 varietà, ma la maggior parte di esse
sono limitate a una particolare regione, e solo poche hanno raggiunto
un'importanza commerciale più ampia. Le cultivar più rinomate a livello mondiale
includono Deglet Noor, originaria dell'Algeria; Yahidi e Hallawi dell'Iraq;
Medjool del Marocco; e Mazafati dell'Iran. In passato, i datteri appiccicosi
venivano serviti usando piccole forchettine specializzate con due punte di
metallo. I semi di dattero vengono messi a bagno e macinati per l'alimentazione
animale; il loro olio è adatto per l'uso in cosmetica e per applicazioni
dermatologiche. In Nord Africa le foglie di palma da dattero sono comunemente
usate per costruire capanne. Le foglie mature vengono anche trasformate in
stuoie, cestini e ventagli. Le guaine di foglie sono apprezzate per il loro
profumo e la loro fibra viene utilizzata anche per corde, tessuti ruvidi e
grandi cappelli. Nel 2009 un team di ricercatori del Weill Cornell Medical
College in Qatar ha pubblicato una bozza del genoma della palma da datteri
(della varietà Khalas), ma la sequenza è stata migliorata nel 2019 con il
rilascio di una più completa utilizzando la tecnologia di sequenziamento in
tempo reale di piccole molecole da parte di un team del Centro per la genomica e
la biologia della New York University e del Khalifa Center for Genetic
Engineering and Biotechnology negli Emirati Arabi Uniti.
Il luogo di origine
della palma da datteri è incerto a causa della lunga storia di coltivazione che
la ha diffusa un po' dappertutto: secondo alcuni sarebbe originario della
regione della Mezzaluna Fertile a cavallo tra Egitto e Mesopotamia, mentre altri
affermano che siano originari della zona del Golfo Persico o addirittura
dell'India occidentale. I reperti fossili mostrano che la palma da datteri
esiste da almeno 50 milioni di anni. Esistono prove archeologiche della
coltivazione di datteri in Arabia dal VI millennio a.C. I datteri sono stati
coltivati in Medio Oriente e nella valle dell'Indo per migliaia di anni, e ci
sono prove archeologiche della coltivazione di datteri a Mehrgarh, una civiltà
neolitica nel Pakistan occidentale, intorno al 7000 a.C.! Gli antichi egizi
usavano i frutti per fare vino di datteri. Le prove della loro coltivazione si
trovano in tutte le civiltà della valle dell'Indo, incluso l'ancora oscuro
Periodo Harappa dal 2600 al 1900 a.C. Una palma da dattero della Giudea è
germogliato con successo dopo che il suo seme si era accidentalmente conservato
per 2000 anni! Uno studio genetico del Centro per la genomica e la biologia dei
sistemi della New York University ha mostrato che le varietà domestiche di palma
da dattero del Nord Africa, comprese varietà ben note come Medjool e Deglet Nour,
sono un ibrido tra le palme da datteri del Medio Oriente e la palma selvatica
cretese, Phoenix theophrasti. Le palme da dattero compaiono nella documentazione
archeologica in Nord Africa circa 2.800 anni fa, suggerendo che l'ibrido sia
stato diffuso dai minoici o dai fenici. Nell'Antica Roma le fronde di palma
utilizzate nei cortei trionfali per simboleggiare la vittoria erano molto
probabilmente quelle di Phoenix dactylifera. La palma da dattero era una pianta
da giardino popolare nei peristili delle case signorili romani, anche se non
avrebbe dato frutti nel clima temperato dell'Italia. È riconoscibile negli
affreschi di Pompei e altrove in Italia, inclusa una scena nel giardino della
Casa delle Nozze di Alessandro. In tempi successivi i commercianti diffusero i
datteri nel sudovest asiatico, nell'Africa settentrionale e in Spagna. Un saggio
sulla coltivazione della palma da dattero è contenuto nel "Libro
dell'Agricoltura" scritto da Ibn al-'Awwam nel XII secolo. I datteri furono
introdotti dagli spagnoli in Messico già nel XVI secolo e in California nel
1769.
E ora, due parole sulla sua simbologia, non meno complessa di quella di
altre piante di cui vi ho parlato. Le palme da datteri hanno un grande
significato nelle religioni abramitiche, e sono menzionate più di 50 volte nella
Bibbia e 20 volte nel Corano. Nell'antica Mesopotamia la palma da dattero era
considerata un albero sacro; alcune raffigurazioni assire mostrano sopra la sua
corona a ventaglio il dio del sole dentro il disco solare alato. In Egitto i
rami di palma divennero simbolo di lunga vita, e a volte di vita senza fine, ed
erano perciò portati nelle processioni funebri, e spesso posti sul feretro o sul
petto della mummia. L'antico simbolismo dell'albero della vita può riecheggiare
nelle palme che nel tempio di Salomone ornavano le pareti e i battenti dei Santo
dei Santi (1 Re 6,29-35). Quando sul rivestimento in legno di cipresso ricoperto
d'oro della grande aula del tempio vengono scolpite palme e catenelle (2 Cr
3,5), queste ultime simboleggiano il limite sacro che nessun impuro e nessun
empio può superare. Alcuni studiosi ebrei ritengono che il riferimento al
"miele" contenuto nel capitolo 3 dell'Esodo a "una terra dove scorre latte e
miele" (onde indicare la Terra Promessa) sia in realtà un riferimento alla
dolcezza dei datteri, e non al miele delle api. Nella Torah le palme sono citate
come simboli di prosperità e trionfo. La palma è una metafora di ciò che è
elevato e sublime; così della Sapienza divina si dice che essa è cresciuta come
una palma in Engaddi (Sir 24,14), località sulle rive del Mar Morto che io ho
avuto la fortuna di visitare di persona. « Il giusto fiorirà come palma » (Sal
92,13). Di chi si allontana da Dio Giobbe dice: « La sua fronda sarà tagliata
prima del tempo, e il suo ramo di palma non rinverdirà più » (Gb 15,32). I rami
di palma sono ancora oggi usati come ornamento in Israele durante la Festa dei
Tabernacoli. Quando il popolo seppe che Gesù veniva a Gerusalemme « prese dei
rami di palma e uscì incontro a lui gridando: "Osanna! Benedetto colui che viene
nel nome del Signore, il re d'Israele!"» (Gv 12,13). Nella visione apocalittica
i martiri sono avvolti in vesti candide in segno della loro purezza e costanza
nella fede, e le palme nelle loro mani significano che essi hanno superato ciò
che è terreno e hanno ormai ottenuto il premio eterno (Ap 7,9). Nell'arte
cristiana i rami di palma sono attributi dei martiri; una palma fra altri due
alberi è simbolo della croce di Cristo. A partire dal secolo VII secolo si
diffuse la processione della domenica delle Palme, legata alla benedizione di
rami di palma, in ricordo dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme. La credenza
popolare crede che piccoli cespi benedetti di agrifoglio, di ulivo, di
rosmarino, di ginepro o di altre piante aromatiche possano tenere lontane le
disgrazie, ma essi sono probabilmente un ricordo dei rami delle palme, divenuti
inaccessibili o quasi all'Europa medioevale dopo il prepotente Volkwanderung
arabo. Nel Corano, Allah istruisce Maryām (la Vergine Maria) a mangiare datteri
durante le doglie quando dà alla luce Isa (Gesù). Nella cultura islamica i
datteri e lo yogurt o il latte sono tradizionalmente i primi alimenti consumati
per Iftar dopo che il sole è tramontato durante il Ramadan. Nel mandeismo la
palma da datteri simboleggia l'albero cosmico: la palma da dattero, associata
alla mascolinità, e la fonte, associata alla femminilità, sono spesso menzionate
insieme come simboli celesti nei testi mandei. Infine, una palma da dattero
compare nell'odierno stemma dell'Arabia Saudita. E scusate se tutto questo è
poco!

Palme da datteri fotografate dall'autore di questo sito a Lanciano (CH)
Il
fiore della Vergine Maria
É arrivato il momento del
giglio. Lilium è un genere di piante
da fiore erbacee che crescono da bulbi, tutte con grandi fiori prominenti. La
maggior parte delle specie sono originarie dell'emisfero settentrionale dai
climi temperati a quelli subtropicali. Sono comunemente adattati agli habitat
boschivi, spesso montani, o agli habitat delle praterie; alcuni possono
sopravvivere perfino nelle paludi. In generale preferiscono terreni
moderatamente acidi o privi di calcare. I gigli variano in altezza 60 a 180 cm,
formano bulbi sotterranei squamosi e in alcune specie nordamericane la base del
bulbo si sviluppa in rizomi, sui quali si trovano numerosi piccoli bulbi. La
maggior parte dei bulbi è sepolta in profondità nel terreno, ma alcune specie
formano bulbi vicino alla superficie del suolo. Ogni anno il nuovo fusto emette
radici avventizie sopra il bulbo quando emerge dal suolo; queste radici si
aggiungono a quelle basali che si sviluppano alla base del bulbo. I fiori sono
grandi, spesso profumati e sono disponibili in un'ampia gamma di colori tra cui
bianchi, gialli, arancioni, rosa, rossi e viola, a volte screziati con macchie e
nere. Le piante sono a fioritura tardiva primaverile o estiva. I fiori sono
portati in racemi all'estremità dello stelo. Il frutto è una capsula
tricellulare, i semi maturano a fine estate. La maggior parte delle specie
temperate sono decidue e dormienti in inverno nel loro ambiente nativo, ma
alcune specie originarie di zone con estati calde e inverni miti (Lilium
candidum, Lilium catesbaei, Lilium longiflorum) perdono le foglie ed entrano in
un breve periodo di dormienza in estate o in autunno, germogliano in inverno
formando fusti nani portanti una rosetta basale di foglie, fino a quando lo
stelo inizia ad allungarsi con il caldo. Molte altre piante hanno "giglio" nei
loro nomi comuni, ma non appartengono allo stesso genere e quindi non sono veri
gigli. Tutte le traduzioni inglesi della Bibbia ad esempio rendono l'ebraico
shūshan come "giglio", ma il "giglio tra i rovi" del Cantico dei Cantici 2,2
potrebbe essere il caprifoglio.
Il nome latino Lilium deriva dalla parola greca λείριον (leírion), a sua volta
presa in prestito dal copto "hleri" attraverso il demotico hrry, a sua volta
dall'antico egiziano hrṛt, "fiore". Il linguista francese Antoine Meillet
(1866-1936) sosteneva che sia la parola egiziana che quella greca siano
possibili prestiti da una lingua estinta del Mediterraneo orientale.
Molte specie sono ampiamente coltivate in giardino nelle regioni temperate,
subtropicali e tropicali per la loro bellezza, e sono stati ottenuti numerosi
ibridi ornamentali. Sono utilizzati nelle aiuole erbacee, nelle piantagioni di
boschi e arbusti e come piante da cortile. Alcuni gigli, in particolare Lilium
longiflorum, formano importanti colture di fiori recisi o piante in vaso. I
bulbi dei gigli sono solitamente piantati nella stagione dormiente. È meglio
piantarli in una osizione esposta a sudleggermente in pendenza, al sole o in
ombra parziale, a una profondità pari a due o tre volte l'altezza del bulbo,
eccetto Lilium candidum che dovrebbe essere piantato in superficie. La maggior
parte cresce meglio in terreni ben drenati e le piante vengono annaffiate
durante la stagione di crescita. Alcune specie e cultivar hanno steli robusti,
ma quelli con capolini pesanti hanno bisogni di sostegni per stare in piedi.
Alcune specie di Lilium, ad esempio il Lilium longiflorum, sono tossiche per i
gatti. L'esatto meccanismo di tossicità è ignoto, ma si sa che può causare
insufficienza renale; va perciò chiamato con urgenza il veterinario, appena si
sospetta che il proprio gatto abbia mangiare qualsiasi parte di un giglio, o
anche solo abbia leccato il polline finito sul suo pelo. La proliferazione di
cervi (ad es. Odocoileus virginianus) in Nord America, dovuta principalmente a
fattori come la caccia spietata ai grandi predatori per garantire la sicurezza
ad uomini e greggi, è responsabile di un calo delle popolazioni di gigli in
natura e rappresenta una minaccia anche per i gigli da giardino.
I bulbi di giglio sono ricchi di amido e commestibili come ortaggi, anche se i
bulbi di alcune specie risultano troppo amari per essere mangiati. Lilium
brownii, noto come 百合 (pak hop, letteralmente "cento uniti"), è uno dei gigli
commestibili più importanti in Cina, e furono persino esportati e venduti nella
Chinatown di San Francisco nel XIX secolo, disponibili sia freschi che secchi. I
bulbi essiccati sono comunemente usati nel sud della Cina per insaporire la
zuppa; possono essere saltati in padella, grattugiati e usati per addensare la
zuppa o lavorati per estrarne l'amido. La loro consistenza e il gusto sono stati
paragonati a quelli della patata. I boccioli di fiori di "giglio" comunemente
commercializzati, chiamati 金针菜 (jīn zhēn cài, letteralmente "vegetale dell'ago
d'oro"), provengono in realtà da Hemerocallis citrina. I fiori e i bulbi del
giglio si consumano soprattutto in estate, per la loro asserita capacità di
abbattere il calore interno. Una fonte inglese del XIX secolo riferiva che "si
dice che i fiori di giglio siano anche efficaci nelle affezioni polmonari e che
abbiano proprietà toniche". Il bulbo di giglio o yuri-ne è talvolta usato anche
nella cucina giapponese. I boccioli dei fiori e le radici del Lilium canadense
sono tradizionalmente raccolti e mangiati dalle popolazioni native
nordamericane: la maggior parte dei popoli nativi dello Stato di Washington
cuociono a vapore, fanno bollire o cuociono in fosse i bulbi di Lilium
columbianum. Dal sapore amaro o piccante, sono usati soprattutto come
condimento, spesso nelle zuppe con carne o pesce.
Nel linguaggio tradizionale dei fiori, i gigli rappresentano l'amore, l'ardore e
l'affetto per i propri cari, mentre i gigli arancioni rappresentano la felicità,
l'amore e il calore. I gigli sono i fiori più comunemente usati ai funerali,
dove rappresentano simbolicamente il fatto che l'anima del defunto è stata
restituita allo stato primordiale di innocenza. Lilium formosanum, o giglio
taiwanese, è chiamato "il fiore della ciotola rotta" (in cinese :打碗花) dai membri
anziani del gruppo etnico Hakka. Poiché questo giglio cresce vicino a specchi
d'acqua pulita, essi credono che danneggiare il giglio potrebbe danneggiare
l'ambiente, proprio come rompere le ciotole di casa Pare che i genitori
convincano i bambini a non cogliere i gigli convincendoli che le ciotole della
loro cena potrebbero rompersi se distruggono questo fiore.
Al fiore del giglio vengono associate molte leggende: per gli antichi greci e
romani il giglio era associato ad Era-Giunone, dea del matrimonio e della
procreazione, che mentre allattava Ercole perse due gocce di latte. Da una di
queste si originò appunto il giglio a cui venne attribuito il significato di
amore, fedeltà e procreazione. Era però anche simbolo di fierezza e orgoglio:
questa simbologia deriva dal suo portamento eretto, e non a caso in passato lo
si regalava a membri dell'alta nobiltà. Nel VI canto dell'"Eneide" di Virgilio
l'ombra di Anchise pronuncia la celeberrima frase « Manibus date lilia plenis »
(« Spargete gigli a piene mani »), alla vista dell'ombra destinata a
reincarnarsi in Marcello, nipote dell'imperatore Ottaviano Augusto, già
destinato a morte precoce. Con una lieve variazione tal citazione è riproposta
da Dante nel canto XXX del Purgatorio, in omaggio proprio al personaggio di
Virgilio che lo ha appena lasciato poco prima dell'arrivo di Beatrice. Questo
verso è talvolta inciso sulle lapidi mortuarie di bambini o persone decedute
molto giovani, recisi nella primavera della vita, o talvolta sui monumenti ai
caduti, come sul monumento ai soldati morti nella prima guerra mondiale a Pieve
di Cento realizzato nel 1930, o sull'ara a Riva del Garda dedicata ai caduti
della Resistenza.
Come hanno scritto Maria Grilli Caiola, Paolo Maria Guarrera e Alessandro
Travaglini nel loro suggestivo saggio "Le piante nella Bibbia", pubblicato da
Gangemi editore, nella Bibbia il giglio è citato più volte come simbolo e
speranza di liberazione del popolo Israelita; il profeta Osea invita alla
conversione, profetizzando la salvezza di Israele da parte del suo Dio: "Sarò
come rugiada per Israele; fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero
del Libano. » (Os 14,6) Coltivato da tempi immemorabili in Persia, Siria e
Palestina, in Israele lo si trova ancora sul Monte Carmelo e in Galilea.
Dall'ebraico shūshan, "giglio" deriva il nome Susanna, protagonista di un
episodio del libro di Daniele considerato apocrifo dai protestanti e
deuterocanonico dai Cattolici; in esso Daniele si manifesta come giusto giudice
fin dall'infanzia, dimostrando la purezza e l'innocenza di una bellissima
giovane ingiustamente condannata a morte per non aversi voluta concedere a due
vecchi pervertiti. La bellezza del fiore ha colpito gli artisti che lo hanno
raffigurato nell'arte a cominciare dal Tempio di Salomone, dove decoravano i
capitelli in cima alle colonne (1Re 7,19), ed il mare di bronzo al centro di
esso aveva l'orlo a forma di giglio (1Re 7,26). I gigli sono citati otto volte
nel Cantico dei Cantici, ad esempio « Le sue guance sono come aiuole di balsamo
dove crescono piante aromatiche, le sue labbra sono gigli che stillano fluida
mirra » (Ct 5,13) I Salmi 45, 60 e 69 andavano intonati « Su "I gigli" dei figli
di Core », un'antichissima melodia che non ci è pervenuta. Il Siracide
ammonisce: « Come incenso spargete buon profumo, fate sbocciare fiori come il
giglio, alzate la voce e cantate insieme, benedite il Signore per tutte le sue
opere » (Sir 39,14) Famosissima è la metafora con cui Gesù invita a preoccuparsi
delle cose spirituali, e non di quelle materiali: « Guardate come crescono i
gigli: non faticano e non filano. Eppure io vi dico: neanche Salomone, con tutta
la sua gloria, vestiva come uno di loro » (Luca 12,27).
Nel cristianesimo occidentale, il giglio della Madonna (Lilium candidum) è stato
associato alla Vergine Maria almeno dall'era medievale, ed è simbolo di purezza,
santità e resurrezione. Le raffigurazioni medievali e rinascimentali della
Vergine Maria, specialmente al momento dell'Annunciazione, la mostrano spesso
con questi fiori in mano, alludendo alla purezza di Maria concepita senza
macchia. I gigli della Madonna sono comunemente inclusi anche nelle
raffigurazioni della risurrezione di Cristo. Lilium longiflorum, il cosiddetto
giglio pasquale, è un tradizionale simbolo della Pasqua. Nell'iconografia
cattolica il giglio è associato anche all'Arcangelo Gabriele, spesso raffigurato
nell'iconografia religiosa con un giglio in mano, simbolo di purezza e verità, e
a Sant'Antonio di Padova, al quale Gesù Bambino donò dei candidi gigli.
Il giglio è molto citato dai poeti simbolisti, decadenti e crepuscolari.
Giovanni Pascoli (1855-1912) scrisse una poesia della raccolta "Myricae" dove i
gigli, piantati dalla sua defunta madre nel giardino di una casa non più di
proprietà della famiglia, continuano a nascere e fiorire, finendo quindi
sull'altare della "Madonna dell'acqua". Presso quest'altare, alcune donne che
conoscono le sfortunate vicende della famiglia Pascoli, chiedono alla Madonna
che Giovanni sia riportato nella sua vecchia casa e qui vi muoia tornando infine
ad unirsi ai suoi cari già estinti. In "Canzone folle" di Federigo Tozzi
(1883-1920) una regina dona al poeta un giglio, sicché il suo spirito si incarni
in esso, facendo nascere in lui sentimenti contrastanti di paradisiaco piacere e
di religioso dolore. Ne "La notte dei gigli" di Diego Angeli (1869-1937), i
fiori muoiono durante una notte di passione amorosa tra un uomo ed una donna
vergine: la morte dei gigli, relazionata alla donna, rappresenta la fine della
purezza. Il ciclo del giglio di Gabriele D'Annunzio (1863-1938) è costituito da
un solo romanzo, "Le vergini delle rocce", in cui domina il tema della
purificazione dalle passioni. In "Sinfonia di gigli" di Vincenzo Fago
(1875-1940), i fiori parlano e si definiscono "anime buone disaparite", "calici
d'un divino amore", "speranze rifiorite sovra un puro orizzonte oltremarino",
"canzoni fresche udite al raggio della luna adamantino". Un altro poeta che cita
spesso i gigli nei suoi versi è Corrado Govoni (1884-1965), il quale li descrive
in modi assai diversi, a volte sorprendendo per associazioni di idee molto
lontane dai tradizionali valori a cui si associano questi fiori. Prettamente
religioso è il tema dei sonetti "Il giglio solitario" di Alessandro Giribaldi
(1874-1920) e "Il giglio del campo" di Luigi Fallacara (1890-1963): nel primo il
fiore incarna il Cristo agonizzante, nel secondo è Dio stesso.
Infine, il giglio stilizzato, utilizzato come emblema dalla famiglia Farnese, è
noto come giglio farnesiano; è utilizzato ancor oggi nello stemma di molti
comuni ed è usato come simbolo anche dallo scoutismo. Invece il cosiddetto
Giglio di Firenze, che è anche il simbolo della squadra di calcio della città,
la Fiorentina, è in realtà un iris, per la precisione Iris germanica var.
florentina.

L'erba
appesa sul corsetto di Giulietta
Salvia rosmarinus, comunemente
nota come rosmarino, è un arbusto originario della
regione mediterranea, ma è ragionevolmente resistente nei climi freddi: alcune
cultivar possono resistere a temperature invernali fino a circa -20 ° C. Può
resistere alla siccità, sopravvivendo a una grave mancanza d'acqua per lunghi
periodi, e in alcune parti del mondo è considerata una specie invasiva. Fino al
2017 era. È un membro, come la salvia, della famiglia delle Lamiacee, che
comprende molte altre erbe medicinali e culinarie. Pianta arbustiva sempreverde
che raggiunge altezze di 50–300 cm, con radici profonde, fibrose e resistenti,
ha fusti legnosi di colore marrone chiaro, molto ramificati; i giovani rami
pelosi di colore grigio-verde sono a sezione quadrangolare. Le foglie,
persistenti e coriacee, sono lunghe 2–3 cm e larghe 1–3 mm, lanceolate,
addensate numerosissime sui rametti, di colore verde cupo lucente sulla pagina
superiore e biancastre su quella inferiore per la presenza di peluria bianca e
sono ricche di ghiandole oleifere. I fiori ermafroditi sono sessili e piccoli,
bianchi, rosa, viola o blu, riuniti in brevi grappoli all'ascella di foglie
fiorifere sovrapposte, formanti lunghe spighe allungate, con fioritura da marzo
ad ottobre, nelle posizioni più riparate anche per tutto l'anno ad
intermittenza. L'impollinazione è entomofila, cioè è mediata dagli insetti
pronubi, tra cui l'ape domestica, che ne raccoglie il polline e l'abbondante
nettare, da cui si ricava un ottimo miele. I frutti sono tetracheni, con acheni
liberi, oblunghi e lisci, di colore brunastro.
Si può coltivare in vaso sui terrazzi, rinvasando ogni 2-3 anni, usando
terriccio universale miscelato a sabbia e concimazioni mensili. In primavera si
rinnova cimando i getti principali, per ottenere un aspetto cespuglioso, senza
dover ricorrere ad interventi di potatura. Si moltiplica facilmente per talea
apicale dei nuovi getti in primavera prelevate dai germogli basali e piantate
per almeno due terzi della loro lunghezza in un miscuglio di torba e sabbia,
oppure si semina in aprile-maggio, si trapianta in settembre o nella primavera
successiva, o ancora si moltiplica per divisione della pianta in primavera.
Per effetto dei meccanismi di difesa dal caldo e dall'aridità tipici della
macchia mediterranea, la pianta presenta il fenomeno della estivazione, cioè
arresta quasi completamente la vegetazione in estate, mentre ha il massimo
rigoglio di vegetazione e le fasi di fioritura in tardo autunno o in inverno, e
di fruttificazione in primavera. Solo in climi più freschi ed umidi, le fasi di
vegetazione possono essere spostate verso l'estate.
Salvia rosmarinus è oggi considerata una delle molte centinaia di specie del
genere Salvia, ma fino al 2017 era conosciuto con il nome scientifico Rosmarinus
officinalis e collocato in un genere molto più piccolo, Rosmarinus, che
conteneva solo quattro specie. Salvia jordanii, precedentemente Rosmarinus
eriocalyx, è una specie strettamente imparentata originaria della Spagna e del
Maghreb. La scrittrice e botanica Elizabeth Kent (1791-1861) scrisse nella sua
"Flora Domestica" (1823) che « il nome di questa pianta è composto da due parole
latine, ros marinus, che letteralmente significano "rugiada del mare"; e in
effetti il rosmarino prospera meglio in riva al mare. » Il latino "ros"
("rugiada") sarebbe collegato al sanscrito "vrasas", dalla radice di "varsa",
"pioggia". Il nome inglese, "Rosemary", è invece un calco su "rosmarinus" per
analogia con diffusi nomi femminili.
E ora, un po' di storia. La prima menzione del rosmarino si trova su tavolette
cuneiformi già nel 5000 a.C. Gli egiziani lo usavano nei loro rituali di
sepoltura, come attestato dalle mummie ritrovate intatte, ma non si fa più
menzione del rosmarino fino agli antichi Greci e Romani. Plinio il Vecchio
(23–79 d.C.) ne parlò nella sua "Naturalis Historia", e il greco Pedanio
Dioscoride (40-90 d.C.) descrisse l'utilità del rosmarino nel suo scritto più
famoso, "De Materia Medica", uno dei libri dedicati alle erbe più influenti
nella storia dell'uomo. Intanto, il rosmarino si diffuse a est verso la Cina e
vi fu naturalizzato già nel 220 d.C., durante la tarda dinastia Han. In
Inghilterra lo portarono probabilmente i romani durante la loro quadrisecolare
dominazione, ma non ci sono documenti sulla presenza del rosmarino nelle isole
britanniche fino all'VIII secolo d.C. Si pensa che ciò si avvenuto grazie a
Carlo Magno e al suo breve "Rinascimento Carolingio", che promosse l'uso delle
erbe e ordinò che il rosmarino venisse coltivato negli orti e nelle fattorie dei
monasteri. Si sa per certo che delle talee di rosmarino furono spedite alla
regina Filippa, influente moglie del re Edoardo III (1312-1377), da sua madre,
la contessa Giovanna di Hainault. Esse erano accompagnate da una lettera che
descriveva le virtù del rosmarino e di altre erbe donate con esso. Il
manoscritto originale si trova ora al British Museum, mentre le talee sono state
piantate nel giardino del vecchio Palazzo di Westminster. Successivamente il
rosmarino fu citato nella maggior parte dei testi erboristici inglesi e fu
ampiamente utilizzato per scopi medicinali e culinari. L'"acqua ungherese", che
risale al XIV secolo, fu uno dei primi profumi a base alcolica in Europa, ed era
composta principalmente da rosmarino distillato. Il rosmarino, insieme
all'agrifoglio e all'edera, era comunemente usato già nel XVII secolo per le
decorazioni natalizie. Naturalmente il rosmarino arrivò nelle Americhe con i
primi coloni europei all'inizio del XVII secolo, e da qui in tutto il pianeta.
Poiché è verdissimo e resistente alla siccità, il rosmarino è usato come pianta
ornamentale nei giardini. Le sue foglie sono utilizzate fresche o essiccate sono
utilizzate nella cucina tradizionale mediterranea, ad esempio come aromatizzante
negli arrosti di agnello, maiale, pollo e tacchino. Hanno un sapore amaro,
astringente e un aroma caratteristico che completa molti cibi cotti; quando
vengono arrostite con carni o verdure, le foglie conferiscono loro un aroma
simile alla senape con un'ulteriore fragranza di legno carbonizzato che si sposa
bene con i cibi alla brace. Dalle sue foglie si può preparare una buona tisana.
Nelle quantità tipicamente utilizzate per aromatizzare i cibi, come un
cucchiaino da tè (circa un grammo), il rosmarino non fornisce alcun valore
nutrizionale, ma è stato dimostrato che l'estratto di rosmarino migliora la
durata di conservazione e la stabilità al calore degli oli ricchi di omega-3 che
sono inclini all'irrancidimento. Il rosmarino poi è anche un'efficace erba
antimicrobica. In Europa settentrionale si usava per preparare la birra Gruit
con achillea millefoglie e mirto di palude.
L'olio di rosmarino viene utilizzato per profumare il corpo o per aromatizzare un
armadio o una stanza. Viene anche bruciato come incenso e utilizzato in shampoo
e prodotti per la pulizia. Il rosmarino contiene una serie di sostanze
fitochimiche, tra cui acido rosmarinico, canfora, acido caffeico, acido ursolico,
acido betulinico, acido carnosico e carnosolo. L'olio essenziale di rosmarino
contiene il 10-20% di canfora. L'estratto di rosmarino ricco di acido carnosico
e carnosolo, è approvato come conservante antiossidante alimentare in diversi
paesi con la sigla E392.
E veniamo al folclore. Il rosmarino era considerato sacro dagli antichi egizi e
poi dai greci. Da sempre è stato auspicio di buona salute e le sue foglie e il
suo olio sono stati usati nella medicina popolare nella convinzione che
donassero salute e felicità. Si pensava che le foglie di rosmarino poste sotto
il letto allontanassero gli incubi ed assicurassero una buona giornata
l'indomani. Non è un caso se nella parte prima, capitolo XVII del "Don
Chisciotte" di Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), l'antieroe protagonista
usa il rosmarino nella sua presunta ricetta del balsamo miracoloso di Fierabras,
nominato in alcune Chansons de Geste medioevali, che sarebbe stato usato per
ungere il corpo di Gesù deposto dalla croce, e sarebbe in grado di guarire
chiunque ne faccia uso.
La nostra erba è stata utilizzata per ricordare i caduti durante le
commemorazioni di guerra e i funerali dei soldati morti in combattimento, perchè
fin dall'antichità era lasciata cadere nelle fosse come simbolo del ricordo dei
morti. In Australia, i rametti di rosmarino vengono indossati durante il
Remembrance Day per onorare i caduti della Prima Guerra Mondiale, perchè cresce
spontaneamente nella penisola di Gallipoli, dove molti australiani morirono
durante il fallimentare tentativo alleato di conquistare gli Stretti, sconfitta
in conseguenza della quale l'allora Ministro della Guerra Winston Churchill fu
costretto a dimettersi. Anche diverse opere di William Shakespeare (1564-1616) fanno
riferimento all'uso del rosmarino nei riti funebri o commemorativi: nella Scena
13 dell'"Amleto", Ofelia dice: « Questo è il rosmarino, è per il ricordo. Ti
prego, amore, ricorda! » Appare anche nell'atto 4, scena 4 del "Racconto
d'inverno", dove Perdita parla di « rosmarino e ruta ». Nell'Atto 4, scena 5 di
"Romeo e Giulietta", Frate Lorenzo ammonisce la famiglia Capuleti di « attaccare
il tuo rosmarino su questo bel corsetto, e come è consuetudine, e nel suo
miglior abbigliamento, portala in chiesa ». Nella fiaba spagnola "Il rametto di
rosmarino", l'eroina tocca l'eroe con il rametto del titolo per ripristinare la
sua memoria magicamente perduta. Infine, "Il rosmarino non capisce l'inverno" è
un toccante romanzo di Matteo Bussola pubblicato nel 2022 che racconta,
attraverso tante voci femminili, le storie ordinarie ma eccezionali delle donne
di oggi.

La
delizia della montagna
L'origano (Origanum vulgare)
è uno degli ingredienti più tipici della cucina mediterranea. Infatti la famiglia cui appartiene, le lamiacee, molto
numerosa con circa 250 generi e quasi 7000 specie, ha il principale centro di
differenziazione proprio nel bacino del Mediterraneo, ma alcune specie sono
presenti anche in Asia, e prediligono habitat caldi. Circa il 60% delle specie
cresce in Anatolia, e questo potrebbe indicare tale area geografica come il
centro di origine delle specie di Origanum. Delle tre specie presenti sul
territorio italiano, due si trovano nell'arco alpino. Con le moderne tecniche di
analisi di tipo filogenetico del DNA la famiglia delle lamiacee è stata
suddivisa in sette sottofamiglie; il genere Origanum fa parte della tribù dekke
Mentheae, sottotribù Menthinae, sottofamiglia delle nepetoidee. Le specie del
genere Origanum nella flora spontanea italiana sono tradizionalmente suddivise
in due sezioni Euoriganum, in cui le brattee dell'infiorescenza sono quasi
glabre (di questa fa parte Origanum vulgare e Majorana, in cui le brattee sono
pelose (Origanum majorana).
Prima ancora di Linneo, fu il botanico francese Joseph Pitton de Tournefort
(1656–1708) a denominare questo genere, ma in realtà l'etimologia del nome si
può far risalire agli antichi greci, probabilmente a Teofrasto (371–287 a.C.),
discepolo di Aristotele, autore di due ampi trattati botanici che per primo ha
usato questo nome per un'erba aromatica. Origanum è formato dalle parole "òros"
("monte") e "ganào" ("io mi compiaccio"), che insieme possono significare
"delizia della montagna" perché cresce bene in montagna o nei piani alti delle
zone più assolate.
Le piante di Origanum vulgare arrivano a un'altezza massima di 70–80 cm, sono
piante erbacee, a ciclo biologico perenne, con gemme svernanti al livello del
suolo e protette dalla lettiera o dalla neve. Le porzioni erbacee seccano
annualmente e rimangono in vita soltanto le parti legnose; tutta la pianta è
aromatica. Le radici sono secondarie, generate da un fittone. I fittoni possono
essere obliqui e più o meno legnosi. La parte aerea del fusto è ascendente, di
colore rossastro e talvolta ramosa, ma i rami inferiori sono sterili; ha una
curiosa sezione quadrangolare a causa della presenza di fasci di collenchima
posti nei quattro vertici, mentre le quattro facce sono concave. Le foglie lungo
il fusto sono verdi, picciolate e di forma lanceolata oppure ovata, spesso
asimmetrica alla base; i bordi sono dentellati. L'infiorescenza è formata da
dense spighe peduncolate con forme più o meno ovate e 8 o 10 fiori ermafroditi.
Il colore è bianco o roseo. Il nettario è un disco più o meno simmetrico alla
base dell'ovario ed è ricco di nettare. Il frutto è uno schizocarpo secco e
marrone di forma è ovoidale con apice arrotondato e superficie glabra e liscia.
L'impollinazione avviene tramite insetti, in particolare ditteri e imenotteri. I
semi cadono a terra dopo essere stati trasportati per alcuni metri dal vento
(disseminazione anemocora) e sono successivamente dispersi soprattutto da
insetti come le formiche (disseminazione mirmecoria). I semi infatti hanno un'appendice ricca di grassi, proteine e zuccheri che attira le formiche durante i
loro spostamenti alla ricerca di cibo.
Come detto, l'origano è ampiamente utilizzato in cucina per il sapore delle sue
foglie, che possono essere più intense se essiccate che fresche. Ha un gusto
terroso, caldo e leggermente amaro, che può variare di intensità. L'origano di
buona qualità può essere abbastanza forte da far intorpidire la lingua, ma le
cultivar adattate ai climi più freddi possono avere un sapore meno intenso.
Fattori come il clima, la stagione e la composizione del suolo possono
influenzare gli oli aromatici presenti, e questo effetto può essere maggiore
delle differenze tra le varie specie di piante. Ovviamente l'origano è l'erba
base della cucina italiana, frequentemente utilizzata con verdure, carne e pesce
arrostiti, fritti o grigliati. L'origano si combina bene con cibi piccanti
popolari nel nostro Sud; è usato meno comunemente nel Nord, poiché in genere lì
si preferisce la maggiorana (che infatti era molto usata da mia mamma, in
giardino ne ho ancora alcune piante). La sua popolarità negli Stati Uniti iniziò
quando i soldati di ritorno dalla seconda guerra mondiale portarono con sé la
passione per la "pizza alle erbe", che era stata consumata nel sud Italia per
secoli. L'origano però è ampiamente utilizzato anche nelle cucine dell'America
Latina, in particolare nella cucina messicana e nella cucina argentina. Nella
cucina turca, l'origano è utilizzato principalmente per insaporire la carne, in
particolare il montone e l'agnello. Nei ristoranti di barbecue e kebab è usato
solitamente come condimento, insieme a paprika, sale e pepe. Durante l'estate,
in Portogallo, vengono spesso aggiunte generose quantità di origano essiccato
come condimento a un'insalata di pomodori e cetrioli, ma può essere utilizzato
anche per condire piatti di carne e pesce. Le foglie essiccate e macinate sono
spesso utilizzate in Grecia per insaporire l'insalata, e di solito vengono
aggiunte alla salsa di limone e olio d'oliva che accompagna grigliate di pesce o
carne e sformati. In Albania l'origano essiccato viene spesso utilizzato per
preparare tisane particolarmente apprezzate. Inoltre è una pianta mellifera, e
si può ottenere del miele in alcune zone dove l'origano è molto diffuso (vale
anche la maggiorana, anch'essa membro del genere Origanum, ma la pianta è più
piccola e meno diffusa dell'origano, e il miele di questa si trova solo
mescolato in altri). Una curiosità: in Turchia l'origano in polvere viene
adulterato con il sommacco per diminuirne il costo, e in Francia le ditte
commerciali di aromi si fanno concorrenza sul prezzo, diluendolo ulteriormente,
con foglie giovani di ulivo.
Esiste poi anche l'olio essenziale di origano, che è stato usato per secoli
nella medicina popolare e nell'aromaterapia. Viene estratto dalle foglie, e
sebbene possa essere usato come integratore alimentare, non ci sono prove
cliniche che indichino che abbia alcun effetto sulla salute umana. Nel 2014 la
Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha avvertito una società dello
Utah, la "Young Living", che i suoi prodotti erboristici, incluso l'olio
essenziale di origano, venivano pubblicizzati come cure per diverse malattie
millantando effetti mai scientificamente provati, e quindi sono stati sottoposti
a sanzioni federali.
L'origano non è importante solo per il suo utilizzo in cucina ma anche per le
sue numerose proprietà terapeutiche. I suoi principi attivi sono principalmente
i fenoli timolo e carvacrolo, che hanno numerose proprietà terapeutiche:
l'origano è antalgico, antisettico, analgesico, antispasmodico, espettorante,
stomachico e tonico. L'origano contiene polifenoli, tra cui numerosi flavoni. I
suoi infusi sono consigliati contro la tosse, le emicranie, i disturbi digestivi
e i dolori di natura reumatica, svolgendo una funzione antinfiammatoria. A
sorpresa, l'origano è anche un buon repellente per le formiche: basta spargerlo
nei luoghi da esso frequentati e ricordarsi di sostituirlo spesso, per tenerle
lontane.
Bisogna aggiungere che anche altre piante sono chiamate "origano", pur non
avendo nulla a che fare con Origanum vulgare. Ad esempio il cosidetto "origano
cubano" è in realtà
Coleus amboinicus, chiamato anche "orégano francés" o menta messicana. Anch'esso
fa parte della famiglia delle Lamiacee, ma ha foglie grandi e un po' succulente
ed è omune in tutti i tropici, dall'America Latina all'Africa al sud-est
asiatico, è probabilmente di origine dell'emisfero orientale. Il cosiddetto
"origano messicano", noto in spagnolo come "orégano cimarrón" ("origano
selvatico") è invece classificato come
Lippia graveolens, e non fa nemmeno parte della Lamiacee ma delle Verbenacee. Il
suo sapore ha una
componente salata più forte invece del sentore simile al
rosmarino nel vero origano, e ha un retrogusto di agrumi che lo rende ancora più
aromatico di esso.
A questo punto, non possiamo fare a meno di dire qualcosa sulla
pizza, di cui
l'origano (italiano, non cubano o messicano) è componente essenziale. Si tratta
indubbiamente di uno dei prodotti gastronomici salati più consumati al mondo,
oltre che più facili da preparare, consistendo in un impasto a base di
farina, acqua e lievito che viene spianato per essere farcito tipicamente con
pomodoro, mozzarella e altri ingredienti e poi cotto in un forno a legna. Tipica
della cucina napoletana, è oggi, insieme alla pasta, la pietanza italiana più
conosciuta al mondo. In realtà però con il nome pizza, praticamente ignoto al di
fuori di Napoli,
ancora nel XVIII secolo si indicavano delle torte dolci. Fu solo a
partire dagli inizi del XIX secolo che la pizza assunse, sempre a Napoli, la sua
attuale connotazione, ed il seguente successo planetario della pietanza (grazie
all'emigrazione italiana soprattutto verso USA, Brasile, Argentina e Australia)
ha portato, per estensione, a definire nello stesso modo qualsiasi preparazione
analoga.
L'etimologia del sostantivo pizza è dibattuta. Esistono varie ipotesi, tra cui una
derivazione dal germanico (longobardo) dell'alto tedesco d'Italia bĭzzo o pĭzzo, da cui anche il tedesco moderno
"Bissen", "boccone", "pezzo di pane". Questa tesi sarebbe confermata dall'area di
diffusione originaria della parola, che coinciderebbe con il regno e i ducati
longobardi di Benevento e Spoleto. Tuttavia la diffusa presenza, in area balcanica
della parola "pita" ha indotto alcuni studiosi a cercare nel greco πίτα,
"píta",
l'origine dell'italiano pita, da cui poi pizza per incrocio con "pezzo". Lo
storico Alessandro Barbero ha proposto una derivazione dal termine
"pita" attraverso la pronuncia dei Longobardi "pitza".
Franco Fanciullo e Pierpaolo Fornaro hanno suggerito invece che pizza possa
derivare dal greco antico ἀπίκια, apíkia (in latino *apīcia) "focaccia all'Apicio",
dal nome del più famoso buongustaio romano Marco Gavio Apicio, della cui vita
nulla di certo ci è stato tramandato. Altre etimologie più bizzarre
(dall'ebraico, ad esempio) sono probabilmente da scartare.
La pizza ha una storia lunga e poco nota. Di sicuro già nell'antichità focacce schiacciate,
lievitate e non, erano diffuse presso gli Egizi e i Romani (in latino tale
focaccia era chiamata "offa"). Nell'insula 10 della Regio IX a Pompei
è stato riportato alla luce un affresco che, accanto a un calice di vino posato
su un vassoio di argento, raffigura una focaccia piatta condita con frutti vari,
spezie e forse un tipo di pesto ("moretum" in latino), indicato da puntini color
ocra. Le prime
attestazioni scritte della parola "pizza" risalgono al latino volgare della
città di Gaeta nel 997. Un successivo documento, scritto su pergamena
d'agnello, di locazione di alcuni terreni e datato sul retro "31 gennaio 1201",
conservato presso la biblioteca della diocesi di Sulmona, riporta la parola
"pizzas" ripetuta due volte. Il film di animazione "Totò Sapore e la
magica storia della pizza", realizzato nel 2003 da Maurizio Forestieri, presenta
solo una versione fantasioso dell'origine di questo piatto tipico della cucina
napoletana. La pizza per antonomasia, e quella che io preferisco, è la
cosiddetta Pizza Margherita, la pizza tonda condita con pomodoro, mozzarella e
basilico (rosso, bianco e verde, i colori della bandiera italiana) creata dal
cuoco Raffaele Esposito della Pizzeria Brandi l'11 giugno 1889 per onorare la
Regina d'Italia, Margherita di Savoia, consorte di Umberto I, in visita alla
città di Napoli. Poi, come detto, la diaspora italiana la fece conoscere a tutto
il pianeta. In Francia ad esempio le prime pizzerie furono aperte all'inizio del
Novecento a Marsiglia in seguito alla forte immigrazione napoletana in quella
città.
Negli Stati Uniti d'America la pizza ha avuto una sua evoluzione particolare,
per adattarsi alla differenza o carenza di alcuni ingredienti e al diverso gusto
degli americani, fino alla pizza all'americana contraddistinta dalla morbidezza,
dallo spessore e dal condimento sempre abbondante. Spesso all'impasto
vengono aggiunti burro o margarina e zucchero. Dopo il riso, la pizza è
l'alimento più mangiato al mondo, seguito dalla pasta. Secondo il Corriere della
Sera, "pizza" è la parola italiana più famosa al mondo, prima di "ciao". Non è
certo un caso se nel 2017 l'UNESCO ha dichiarato l'arte del pizzaiolo napoletano
come patrimonio immateriale dell'umanità!
La Pizza Margherita, contiene molte sostanze
nutrienti: i carboidrati sotto forma di amido nella farina, i lipidi vegetali
dell'olio extravergine d'oliva e quelli animali della mozzarella. Però non
dobbiamo dimenticare che la pizza non è un
alimento ipocalorico adatto a qualunque regime dietetico: una Margherita da 300 g dà un apporto di oltre 800 calorie, molto sbilanciate a
favore dei carboidrati (circa il 75%).
Una curiosità: la pizza più lunga al mondo, ben 1,93 chilometri, è stata realizzata il 10 giugno
2017 a Fontana, in California. Secondo il "Guinness Book of Records" per
ottenerla sono state
utilizzate 8,85 tonnellate di farina, 2,5 tonnellate di salsa di pomodoro, e 2
tonnellate di mozzarella, ed è stata cucinata in 54 ore (40 ore per preparare
fogli di impasto già pronti e stesi, più 14 ore per cuocerli a più riprese) da
un team di oltre 100 cuochi. Il precedente record era stato stabilito il 9
maggio 2016 sul lungomare di Napoli, con una lunghezza di 1.853,88 metri in un
totale di 9 ore. Invece, secondo la stessa fonte, la più distante consegna di
pizza spetta a Lucy Clough di una pizzeria di Feltham, sobborgo di Londra: una
pizza da lei cotta il 17 novembre 2004 ha percorso una distanza di 16.949 km per
essere consegnata a Melbourne, in Australia, il 19 novembre successivo!
Quando si dice un alimento giramondo!

L'albero del corno di montone
Il
carrubo (Ceratonia siliqua) è un albero o arbusto sempreverde della
famiglia delle Fabacee, quella delle leguminose. Cresce molto lentamente fino a
15 metri di altezza e può raggiungere i 500 anni di età; la chioma è ampia e
semisferica, sostenuta da un grosso tronco dalla corteccia bruna ruvida e da
rami robusti. Le sue foglie sono lunghe da 10 a 20 centimetri, sono pennate e
possono avere un fogliolina terminale. È resistente al gelo fino a circa -7 °
C. La maggior parte dei carrubi sono dioici, solo raramente sono ermafroditi.
Quando gli alberi sbocciano in autunno, i fiori sono piccoli e numerosi,
disposti a spirale lungo l'asse dell'infiorescenza e anche sul tronco ("caulifloria");
sono impollinati sia dal vento che dagli insetti. Curiosamente, i fiori maschili
odorano di sperma umano, un odore causato in parte dalle ammine in essi
contenute. Il frutto è un legume (noto anche come baccello) allungato, può
essere diritto o ricurvo e ispessito in corrispondenza delle suture. I baccelli
impiegano un anno intero per svilupparsi e maturare. Quando i baccelli dolci e
maturi alla fine cadono a terra, vengono mangiati da vari mammiferi, come i
maiali, disperdendo così il duro seme interno attraverso gli escrementi. Cresce
bene nelle zone temperate calde e subtropicali e tollera le zone costiere calde
e umide. In quanto xerofita (specie resistente alla siccità), il carrubo si
adatta bene alle condizioni della regione mediterranea con solo da 250 a 500
millimetri di pioggia all'anno. I carrubi possono sopravvivere a lunghi periodi
di siccità, preferiscono argille sabbiose ben drenate e sono intolleranti al
ristagno idrico, ma i sistemi di radici profonde possono adattarsi a un'ampia
varietà di condizioni del suolo e sono abbastanza tolleranti al sale (fino al 3%
nel suolo).
La parola "carruba" deriva dal francese antico carobe, che l'ha presa in
prestito dall'arabo خَرُّوبٌ (kharrūb, "baccello di carrube"). Può darsi che a
sua volta questo termine venga dalla parola accadica harūb- o dall'aramaico
חרובא ḥarrūḇā, con il medesimo significato. Ceratonia siliqua, il nome
scientifico del carrubo, deriva dal greco kerátiοn κεράτιον "frutto della
carruba" (da keras κέρας "corno", per la sua forma), e dal latino siliqua
"baccello". In yiddish è chiamato באקסער bokser, derivato dall'antico tedesco "bokshornboum",
"albero del corno di montone", sempre in riferimento alla forma della carruba.
Sebbene coltivato estensivamente, il carrubo può ancora essere trovato allo
stato selvatico nelle regioni del Mediterraneo orientale e si è naturalizzato in
occidente. L'albero è tipico della regione meridionale portoghese dell'Algarve,
dove l'albero è chiamato alfarrobeira e il frutto alfarroba. Si trova anche
nella Spagna meridionale e orientale, dove è chiamato algarroba), a Malta (in
maltese ħarruba), in Sicilia (in siciliano carrua), nel sud della Croazia (in
croato rogač), nella Bulgaria orientale (in bulgaro рожков), e nel sud della
Grecia (in greco ξυλοκερατιά, ksilokeratia, che significa "corno di legno"), a
Cipro, in Turchia (in turco keçiboynuzu, "corno di capra") e in Israele (in
ebraico moderno חרוב, charuv). Invece gli alberi conosciuti come algarrobo in
America Latina appartengono a una diversa sottofamiglia delle Fabacee, le
Mimosoidee; i primi coloni spagnoli li chiamarono algarrobos perché anch'essi,
come il carrubo, producono baccelli con la polpa dolce.
Non tutte le specie di leguminose possono sviluppare una relazione simbiotica
con la rizobia per utilizzare l'azoto atmosferico. Non è chiaro se il carrubo
abbia questa capacità: alcuni risultati suggerivano che non sia in grado di
formare noduli radicali con rizobia, mentre in un altro studio più recente sono
stati identificati alberi con noduli contenenti batteri che si ritiene
appartengano al genere Rhizobium. Tuttavia uno studio che misura il tasso di
assorbimento dell'isotopo radioattivo N-15 da parte dei tessuti del carrubo non
ha supportato la teoria che i carrubi utilizzino naturalmente l'azoto
atmosferico.
La coltivazione del carrubo ha una lunga storia, tanto che si sono ritrovate
testimonianze risalenti agli antichi Egizi sul suo uso come dolcificante. Una
leggenda popolare afferma che le carrube siano state il cibo che alimentò San
Giovanni Battista quando da giovane crebbe nel deserto, tanto da essere chiamato
anche Pane di San Giovanni. Le carrube sono citate anche nella Bibbia, come
esempio di mangime animale, nella famosa parabola del Figliuol Prodigo o, come
si dice oggi, del Padre Misericordioso, visto che è il padre il vero
protagonista del commovente apologo. Lo sventato secondogenito infatti, dopo
aver scialacquato tutta la sua parte di eredità con una vita da bohemién,
all'arrivo di una brutta carestia per sopravvivere è costretto ad accettare un
degradante lavoro come guardiano di porci (impurissimi per gli Ebrei), e «
avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno
gli dava nulla » (Lc 15,16) Il teologo luterano Helmut Gollwitzer (1908-1993) ha
intitolato questo piccolo capolavoro "La gioia di Dio", ed in effetti essa
esprime compiutamente la teologia di Luca dell'amore e della misericordia di
Dio. Il perdono del figlio minore non è la risposta del padre ai suoi propositi
di rifarsi da capo una vita migliore: il padre infatti lo accoglie ancor prima
che egli abbia la possibilità di parlare e di esprimere il proprio pentimento. E
come il padre è uscito incontro a lui che ritornava, così esce a supplicare il
figlio maggiore che giudica inopportuna la benevolenza del padre verso il
fratello. La parabola suggerisce che vi possono essere due differenti immagini
di Dio: quella corretta è quella di un Padre che, pur rispettando la libertà del
figlio minore che se ne va, non cessa nel suo cuore di attenderne il ritorno, e
gioisce quando questo avviene; il figlio maggiore non riesce a concepire tutt
questo: per lui Dio è uno con cui avere una relazione di dare/avere, uno a cui
reclamare di non avergli dato abbastanza, e per questo è immagine dei Farisei e
di tutti i loro moderni epigoni. La parabola termina in maniera aperta: non si
dice se il figlio maggiore ha accettato o meno l'invito accorato del padre. In
questa maniera Gesù suggerisce che anche per i Farisei, ai quali è rivolta la
parabola, c'è ancora tempo per la conversione.
Tornando alla coltivazione delle carrube, i loro semi sono comunemente usati
come mezzo di propagazione. I carrubi entrano lentamente nella fase produttiva:
in aree con condizioni di crescita favorevoli, il raccolto inizia 3-4 anni dopo
il germogliamento. La piena produzione degli alberi avviene principalmente a
un'età di 20-25 anni, quando la resa si stabilizza. E' molto diffusa la
consociazione con altre specie arboree. Sono necessarie solo potature leggere e
dissodamenti occasionali per ridurre le erbe infestanti. La fase più laboriosa
della coltivazione del carrubo è la raccolta, che viene effettuata abbattendo i
frutti con un lungo bastone e raccogliendoli con l'ausilio di reti stese al di
sotto. Questo è un compito delicato, perché gli alberi fioriscono tutti
contemporaneamente, e bisogna fare attenzione a non danneggiare i fiori e il
raccolto dell'anno successivo. Oggi infatti si prediligono cultivar che possono
essere raccolte meccanicamente tramite scuotimento. Dopo la raccolta, i baccelli
di carruba hanno un contenuto di umidità del 10-20% e devono essere asciugati
fino a un contenuto di umidità dell'8%, in modo che non marciscano. La
lavorazione della polpa comprende la macinazione per la produzione di alimenti
per animali o la tostatura e la macinazione per l'industria alimentare umana.
Sono noti pochi parassiti in grado di causare gravi danni nelle piantagioni di
carrube, quindi tradizionalmente non sono trattati con pesticidi; solo alcune
cultivar sono fortemente suscettibili alla peronospora. Un parassita
direttamente associato alla carruba è la larva della falena della carruba (Myelois
ceratoniae), che può causare ingenti danni al raccolto. Primo produttore al
mondo è il Portogallo con circa il 30% del totale mondiale, seguito nell'ordine
da Italia, Marocco, Turchia, Grecia e Cipro.
I prodotti a base di carruba consumati dall'uomo provengono dal baccello
essiccato, a volte tostato, che ha due parti principali: la polpa, che ha un
sapore dolciastro, pastoso e zuccherino, rappresenta il 90% e i semi il 10% in
peso. I baccelli di carruba sono leggermente dolci per natura, quindi sono usati
in polvere, scaglie o sciroppo come ingredienti in torte e biscotti, a volte
come sostituto del cioccolato in ricette a causa del colore, della consistenza e
del gusto della carruba. A Malta, un dolce tradizionale chiamato "karamelli
tal-harrub", consumato durante le festività della Quaresima e del Venerdì Santo,
è fatto con i baccelli di carruba. Sempre a Malta, dai baccelli si ricava uno
sciroppo di carruba detto "ġulepp tal-ħarrub"). A Cipro i baccelli di carruba
essiccati e macinati vengono lasciati in ammollo in acqua, il succo viene quindi
bollito mescolando continuamente ottenendo uno sciroppo denso noto come
haroupomelo. In Palestina i baccelli schiacciati vengono riscaldati per
caramellarne lo zucchero, quindi si aggiunge acqua e si fa bollire per qualche
tempo. Il risultato è una bevanda fredda, chiamata anche kharrub, che viene
venduta dai venditori ambulanti, soprattutto in estate. Il frutto essiccato
della carruba è tradizionalmente consumato durante la festa ebraica di Tu
Bishvat. In Libano i baccelli dorati vengono bolliti fino a produrre un liquido
nero, ridotto sino ad ottenere una melassa densa e nera chiamata "debs el
kharrub", dalsapore dolce, simile al cioccolato. Invece la farina di semi di
carruba viene utilizzata come agente addensante e stabilizzante per sostituire
il grasso nei prodotti ipocalorici o come sostituto del glutine, essendo ricca
di galattomannani (88% della massa secca), che sono idrofili e si gonfiano in
acqua. Se i galattomannani vengono miscelati con altre sostanze gelificanti,
come la carragenina, possono essere utilizzati per addensare efficacemente la
parte liquida del cibo. Questo gelificante, noto come E410, ha notevoli capacità
di assorbire acqua, oltre 50 volte il suo peso, e lo si utilizza ampiamente nel
cibo in scatola per animali per ottenere una consistenza gelatinosa. Facendo
parte della famiglia dei legumi, la carruba è fonte di aminoacidi essenziali e
di fibre che la rendono ideale per trattare vari disturbi intestinali e favorire
la digestione. Mentre il cioccolato contiene teobromina a livelli tossici per
alcuni mammiferi, la carruba non ne contiene affatto e non ha nemmeno caffeina,
quindi a volte viene usata per preparare dolcetti simili al cioccolato per i
cani o per chi è intollerante a quelle sostanze. La farina di baccelli di
carruba è usata anche come mangime ricco di calorie per il bestiame, in
particolare per i ruminanti, sebbene il suo alto contenuto di tannini possa
limitare questo uso. Nella penisola iberica i baccelli di carruba venivano
storicamente dati in pasto agli asini, e in Medio Oriente ai maiali.
Interessante è anche la produzione di miele di carrubo e l'uso di estratti di
carruba per la cura della raucedine. In fitoterapia l'estratto secco dellla
carruba è utilizzabile, anche assieme allo zenzero, per trattare il colon
irritabile. Invece il cosiddetto "sciroppo di carruba" prodotto in Perù è in
realtà ottenuto dal frutto dell'albero Prosopis nigra.
Il carrubo è ampiamente coltivato nel settore orticolo vivaistico come pianta
ornamentale per i climi mediterranei e altre regioni temperate del mondo: oggi è
particolarmente popolare in California e nelle Hawaii, perchè la pianta sviluppa
un tronco che sembra scolpito. A Creta il legno di carrubo è spesso usato come
legna da ardere. Poiché il gambo molto scanalato di solito tende a marcire, il
legno di carrubo è usato raramente per le costruzioni, tuttavia, a volte è
ricercato per il design di mobili, poiché la venatura estremamente ondulata del
legno conferisce al carrubo un'eccezionale resistenza alla spaccatura. Ecco
perchè le sezioni di tronco di carruba sono adatte per farne manici di scuri e
ceppi per spaccare la legna.
i baccelli di carruba erano spesso usati come mangime per animali e in tempi di
carestia, come "l'ultima fonte di cibo [umano] nei momenti difficili".
Ultima curiosità: i semi del carrubo vengono chiamati anche carati: dal nome
greco delle carrube (kerátion) deriva il "carato", l'unità di misura per la
massa di materiali preziosi. Questo uso storico dei semi di carrubo è legato
all'antica credenza (in seguito dimostrata falsa) nella loro sorprendente
uniformità in peso: secondo la convinzione popolare ognuno di essi avrebbe
pesato esattamente un quinto di grammo, e sin dall'antichità ciò li ha resi i
contrappesi ideali per le bilance utilizzate per pesare l'oro e oggetti di
valore. Allora è vero che il carrubo è un albero molto prezioso!!

Le
foglie amare dello Yemen
L'aloe
(Aloe vera), uno dei vegetali che oggi vanno più di moda, è una pianta
succulenta della famiglia delle Asfodelacee. Ha un'ampia distribuzione ed è
considerata una specie invasiva in molte parti del mondo. Si tratta di una
pianta senza gambo o con gambo molto corto che cresce fino a 60-100 centimetri
di altezza. Le foglie sono spesse e carnose, color verde o grigio-verde, con
alcune varietà che mostrano macchie bianche sulla superficie superiore e
inferiore del gambo. Il margine della foglia è seghettato e presenta piccoli
dentelli bianchi. I fiori sono prodotti in estate su una spiga alta fino a 90
cm; ogni fiore è pendulo, con una corolla tubolare gialla di 2-3 cm di
lunghezza. L'Aloe vera forma la mycorrhiza arbuscolare, una simbiosi in cui il
fungo simbionte penetra nelle cellule corticali delle radici di una pianta
vascolare formando arbuscoli. Ciò consente alla pianta un migliore accesso ai
nutrienti minerali nel terreno.
Il nome del genere Aloe deriva dalla parola araba alloeh, che significa
"sostanza amara" o dall'ebraico אוהלים "ahalim", plurale di אוהל "ahal", con lo
stesso significato, oppure ancora dal greco "alos", "sale", a motivo del suo
succo amarognola che ricorda il sapore dell'acqua di mare.
L'aloe vera è considerata originaria del sud-est della penisola arabica, e
precisamente delle montagne Al Hajar nell'Oman nordorientale, tuttavia è ormai
ampiamente coltivata in tutto il mondo e si è naturalizzata in Nord Africa, in
Sudan, nella regione portoghese dell'Algarve, nelle aree selvagge della Spagna
meridionale, nelle Isole Canarie, a Capo Verde e e Madeira. Le odierne tecniche
basate sull'analisi del DNA suggeriscono che l'Aloe vera è imparentata con
l'Aloe perryi, una specie endemica dello Yemen. L'aloe vera è da sempre usata
nella medicina tradizionale come trattamento per la pelle, da cui il suo largo
uso nel campo dei cosmetici: i primi documenti del suo utilizzo in questo secolo
risalgono addirittura al IV millennio a.C. L'uso dell'aloe è testimoniato da
alcune tavolette cuneiformi ritrovate sul finire dell'Ottocento da un gruppo di
archeologi nella città mesopotamica di Nippur, nei pressi di Bagdad, databili
attorno al 2000 a.C.: « le foglie assomigliano a foderi di coltelli ». L'aloe
era nota e utilizzata anche presso gli egizi, ed è citata nel "Papiro Ebers" del
1550 a.C. tra i preparati per l'imbalsamazione (da qui il nome "pianta
dell'immortalità") o per la cura e l'igiene del corpo o come cicatrizzante. Per
il suo uso come unguento prima della sepoltura è citato anche nel Vangelo di
Giovanni: « Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, portò
circa cento libbre di una mistura di mirra e di aloe » (Gv 19,39) e in seguito
nel Codex Juliana Anicia del 512 d.C. (Juliana Anicia era la figlia di Anicio
Olibrio, uno degli ultimi Imperatori Romani d'Occidente). La specie è stata
introdotta in Cina e in varie parti dell'Europa meridionale nel XVII secolo. La
specie fu descritta per la prima volta da Carlo Linneo nel 1753 come Aloe
perfoliata, e poi nuovamente nel 1768 dal botanico olandese Nicolaas Laurens
Burman (1734-1793) come Aloe vera. Precedentemente alla classificazione binomia
introdotta da Linneo, la specie era chiamata con vari termini; il nome "vera"
sta a spiegare che la pianta analizzata da Burman è stata considerata dal popolo
l'unica vera aloe. Lo studio sistematico di questa pianta ebbe inizio solo nel
1959 grazie al farmacista texano Bill Coats, che mise a punto un processo per
stabilizzare la polpa aprendo la strada alla sua commercializzazione dell'aloe
senza più problemi di ossidazione e fermentazione. In seguito il governo USA
dichiarò ufficialmente le proprietà curative di questa pianta per il trattamento
delle ustioni.
L'Aloe vera è ampiamente coltivata come pianta ornamentale. La specie è
apprezzata dai giardinieri moderni come pianta medicinale per i suoi fiori, la
sua forma e la sua succulenza. Questa succulenza consente alla specie di
sopravvivere in aree con scarse precipitazioni naturali, rendendola ideale per
giardini rocciosi e in generale per giardini a basso consumo idrico. La specie è
resistente nelle zone desertiche ed è intollerante al gelo intenso e alla neve.
Inoltre è relativamente resistente alla maggior parte dei parassiti degli
insetti, sebbene gli acari, le cocciniglie e alcune specie di afidi possano
causare un declino della salute delle piante. In vaso, la specie richiede
terriccio sabbioso ben drenato e condizioni ambientali luminose e ben
soleggiate. Le piante di aloe possono diventare rosse a causa delle scottature
sotto il sole diretto, anche se l'acclimatazione graduale può aiutarle. I vasi
di terracotta sono preferibili in quanto sono porosi; le piante in vaso
dovrebbero essere lasciate asciugare completamente prima di annaffiarle
nuovamente. Quando sono in vaso, le aloe possono affollarli di polloni che
crescono dai lati della "pianta madre"; allora possono essere divise e rinvasate
per lasciare spazio a un'ulteriore crescita. Durante l'inverno può diventare
dormiente, e durante tale periodo è richiesta poca umidità, ma va conservata al
chiuso o in serre riscaldate, analogamente ad altre piante d'appartamento come
haworthia e agave. Esiste una produzione agricola su larga scala di aloe vera in
Australia, Cuba, Repubblica Dominicana, Cina, Messico, India, Giamaica, Kenya,
Tanzania, Sud Africa, Spagna e Stati Uniti, gran parte della cui produzione è
destinata all'industria cosmetica. Viene coltivata anche in varie zone d'Italia.
Due sostanze dell'Aloe vera, il gel trasparente di aloe (la parte interna) e il
suo lattice giallo, vengono utilizzate per fabbricare prodotti in commercio. Il
gel di aloe viene tipicamente utilizzato per preparare farmaci per i danni della
pelle, come ustioni, ferite, congelamento, eruzioni cutanee psoriasi,
herpes labiale o pelle secca. Il lattice di aloe può essere ottenuto in forma
essiccata chiamata resina, o come "succo essiccato di aloe", e viene ingerito
per alleviare la stitichezza. Negli ultimi anni l'aloe vera, come le bacche di
Goji e altri prodotti del nostro orto, è entrata a far parte dell'esclusivo club
delle "piante miracolose" in grado di curare un po' tutto, dal mal di gola ai
calli, ma il mondo scientifico ha ampiamente smontato queste voci come fake news
messe in giro per i social dagli stessi produttori di integratori alimentari,
saponi e cosmetici per incrementare le vendite: per dirne una, esistono prove
contrastanti sull'efficacia dell'aloe vera come trattamento per ferite o
ustioni. Vi sono alcune evidenze che l'uso di prodotti a base di aloe potrebbe
alleviare i sintomi di psoriasi ed acne, ma vi è dissenso sulla sua reale
efficacia, e per di più l'applicazione frequente in alcune persone può causare
una fastidiosa reazione allergica, con conseguente dermatite da contatto con
lieve arrossamento e prurito, difficoltà respiratorie o gonfiore del viso, delle
labbra, della lingua o della gola. Il gel di aloe vera viene addirittura usato
come ingrediente di yogurt, bevande e dessert, ma attenzione! Prima di mettervi
a preparare una crostata di aloe, ricordate che a dosi elevate o prolungate
l'ingestione di lattice di aloe o dell'estratto di foglie intere può essere
tossica. L'aloina, un composto che si trova nel lattice semiliquido di alcune
specie di aloe, era l'ingrediente comune nei prodotti lassativi da banco negli
Stati Uniti fino al 2002, quando la Food and Drug Administration lo ha vietato
perché i produttori non hanno fornito i dati di sicurezza necessari.
L'ingestione cronica di un grammo di succo di aloe al giorno può causare effetti
avversi, tra cui ematuria, perdita di peso e disturbi cardiaci o renali. È
particolarmente pericoloso per le donne in gravidanza. I prodotti di aloe
ingeriti possono avere interazioni avverse con i farmaci, come quelli usati per
trattare coaguli di sangue, diabete, malattie cardiache e diuretici.
Di conseguenza, l'8 aprile 2021 è entrato in vigore il divieto di
commercializzare in Unione Europea alimenti e integratori alimentari contenenti
una famiglia di molecole chiamate idrossiantraceni, presenti anche nell'aloe, a
causa dei gravi effetti nocivi per la salute (anche cancerogeni). Queste
sostanze si concentrano nella parte più esterna lasciando abbastanza pulita la
parte interna gelatinosa con cui si fanno le bevande, i cosmetici e il grosso
delle preparazioni non purganti. Il gel di aloe, se prodotto come si deve,
non contiene queste sostanze se non in tracce. E, ovviamente, l'aloe non cura
affatto il cancro, nonostante i tanti articoli pubblicati su riviste di ogni
genere. Come scriveva La biotecnologa Beatrice Mautino aveva già da tempo
denunciato la pericolosità degli idrossiantraceni, e parlando del lungo processo
che dura da una decina di anni e che si basa sulle prove raccolte man mano dalla
comunità scientifica sulla pericolosità di queste sostanze, su "Le Scienze" del
giugno 2021 ha scritto: « niente di strano per il mondo alimentare e cosmetico.
Siamo abituati ai regolamenti restrittivi nei confronti delle sostanze. Ma
quando queste cose succedono a quei prodotti che abbiamo sempre percepito come
"naturali, quindi innocui", ecco che ci crolla il mondo addosso. Per evitare che
succeda di nuovo, dovremmo imparare a guardare alla natura attraverso gli
occhiali della chimica e vedere le sostanze per quello che sono, a prescindere
dalla loro origine! » Come darle torto?

L'erba
velenosa delle streghe
La
mandragora o mandragola (Mandragora
officinarum) è una pianta appartenente alla famiglia delle Solanacee ma, a
differenza di patate e pomodori, è originaria del bacino del Mediterraneo
(Portogallo, Grecia, Medio Oriente). Si tratta di una pianta perenne senza
fusto, che forma rosette di foglie dentellate e ruvide, le quali assumono una
colorazione verde scuro quando la pianta è matura. Predilige i terreni calcarei
soleggiati. I fiori hanno una forma a campanella con petali biancazzurri che
sbocciano durante la primavera per poi originare in estate dei frutti
tondeggianti di color giallo. Se masticati, questi frutti danno una sorta di
ebbrezza, e se consumati in quantità sono velenosi. Le dimensioni della pianta
sono molto ridotte, tanto da non superare i 5-6 cm. di altezza; durante il
periodo invernale, la pianta entra in riposo vegetativo perdendo la parte aerea.
La mandragora autunnale (Mandragora autumnalis) presenta un grado maggiore di
tossicità rispetto alle altre mandragore.
Veniamo alla sua etimologia: il nome greco μανδραγόρας, assegnatole da Ippocrate
di Coo, si rifarebbe alla radice sanscrita "mad" con il significato di
"inebriante" (da cui il sanscrito "madhira", "bevanda inebriante", ma anche la
nostra parola "matto") e "gar", "consumare" (da cui il sanscrito "gara",
"malattia"). Deve essere invece considerata una paraetimologia rinascimentale
quella che la riconduce al greco "mandra", "gregge", e "agayra", "pericoloso",
cioè "pericolosa per le greggi".
La mandragora probabilmente fu il più antico dei nostri anestetici ed uno dei
primi afrodisiaci conosciuti. Compare come pianta capace di favorire l'amore e
la fecondità già nel Papiro Ebers (circa 1550 a.C.); alla dea Afrodite fu dato
l'appellativo di "Mandragoritis". Nella medicina ippocratica era considerata
un'erba medicinale, utilizzata soprattutto per le sue proprietà antidepressive.
Per la sua efficacia nel favorire il concepimento, compare anche nella Bibbia
con il nome di "duda'im" (plurale, il singolare è דודא, "duda"), che
letteralmente significa "piante dell'amore". Infatti Rachele, la seconda ed
amatissima moglie del patriarca Giacobbe, colpita da sterilità, un'infamia per
le donne di quel tempo, voleva farne uso per cercare di concepire dei figli: «
Al tempo della mietitura del grano, Ruben uscì e trovò delle mandragore, che
portò alla madre Lia. Rachele disse a Lia: "Dammi un po' delle mandragore di tuo
figlio". Ma Lia rispose: "Ti sembra poco avermi portato via il marito, perché
ora tu voglia portare via anche le mandragore di mio figlio?" Riprese Rachele:
"Ebbene, Giacobbe si corichi pure con te questa notte, ma dammi in cambio le
mandragore di tuo figlio." La sera, quando Giacobbe arrivò dalla campagna, Lia
gli uscì incontro e gli disse: "Devi venire da me, perché io ho pagato il
diritto di averti con le mandragore di mio figlio." Così egli si coricò con lei
quella notte.» (Gen 30,14-16) Grazie a questo afrodisiaco, Lia concepì il suo
quinto figlio, Issacar. Non poteva mancare anche una citazione nel Cantico dei
Cantici: « Le mandragore mandano profumo; / alle nostre porte c'è ogni specie di
frutti squisiti, / freschi e secchi: / amato mio, li ho conservati per te! » (Ct
7,14)
La mandragora possiede un grosso rizoma e possenti radici; nel suo insieme,
l'apparato radicale presenta una classica biforcazione e una serie di
protuberanze che le fanno assumere un aspetto vagamente simile a quello del
corpo umano. Proprio da questa curiosa pareidolia derivano leggende,
superstizioni e riti magici vecchie forse quanto l'uomo stesso. Gli antichi
sciamani ne consumavano le radici, e i suoi poteri inebrianti li facevano cadere
in trance, fase durante la quale erano convinti di entrare in contatto con gli
spiriti degli antenati o con il Grande Spirito. La pareidolia della strana
radice i poteri allucinogeni convinsero gli uomini primitivi che la Mandragora officinarum avesse poteri magici sul corpo umano. Con l'avanzare della civiltà,
gli antichi sciamani lasciarono il posto alle donne esperte di medicina,
facilmente scambiate per streghe che trescavano con il diavolo (e come tali
duramente punite). Nel Medioevo si diceva che le streghe avessero ideato un
complesso cerimoniale per estirpare la grossa radice, poiché si diceva nel
momento in cui questa veniva estirpata, emanava grida sovrumane in grado di far
impazzire o uccidere colui che l'aveva estirpata. Il rituale consisteva nel
proteggersi le orecchie con della cera, tracciare un cerchio magico attorno alla
pianta e legare la stessa con una grossa fune ad un cane nero che correndo,
smuoveva ed estirpava la pianta prima di morire; questa leggenda è riportata
anche da Machiavelli nella sua commedia "La mandragola". L'estirpazione doveva
necessariamente avvenire nella notte tra il venerdì ed il sabato, mentre
venivano recitate lunghe formule magiche. Forse nelle favole delle streghe che
volano a cavalcioni delle loro scope (e anche della Befana, loro versione
odierna e più rassicurante) c'è un fondo di verità: per via dei suoi poteri
allucinogeni, le donne medievali esperte di medicina e divinazioni, dopo aver
bevuto pozioni a base di radice polverizzata di mandragora, ninfea e papavero
sciolti nel vino, avevano terribili allucinazioni e sostenevano di aver davvero
volato sulle loro scope.
Per tutti questi motivi, la mandragora costituì uno degli ingredienti principali
per la maggior parte delle pozioni mitologiche e leggendarie. È raffigurata in
alcuni testi di alchimia con le sembianze di un uomo o un bambino, il che ne
faceva una creatura a metà tra il regno vegetale e animale (come il meno noto
agnello vegetale della Tartaria, che secondo i bestiari medioevali sarebbe nato
dai frutti di una pianta esotica). In un trattato sulla licantropia pubblicato
nel 1615, si parlava dell'uso di un magico unguento a base di mandragora che
permetteva la trasformazione in animali, e quindi anche in uomini-lupo; in
effetti, l'azione allucinogena dei fittoni poteva portare un uomo ad emettere
versi animaleschi e ad un'andatura quadrupede. Secondo una macabracredenza
popolare, le mandragore nascevano dallo sperma lasciato cadere dagli impiccati
in punto di morte. È considerata una pianta magica anche dalla moderna Wicca (un
famoso culto neopagano), in particolare nelle notti di plenilunio, guarda caso
quelle in cui apparirebbero i licantropi...
Col tempo e con lo studio scientifico delle sue reali proprietà, la mandragora
ha perso il suo prestigio magico. Oggi le si riconoscono in effetti proprietà
narcotiche, ed è considerata molto tossica. Le sue radici contengono infatti un
gruppo di alcaloidi, la cui azione è simile a quella dell'atropina che si estrae
dalla belladonna: a basse dosi è uno spasmolitico, ma in dosi superiori a 3 mg è
un veleno che provoca la paralisi letale del sistema nervoso centrale. Tra gli
effetti che l'atropina produce nel cervello vi sono visione offuscata,
dilatazione delle pupille, secchezza della bocca, difficoltà di minzione,
vertigini, mal di testa, vomito, arrossamento e tachicardia, oltre ai già ben
noti effetti allucinogeni.
La mandragola è al centro dell'omonima rappresentazione teatrale di Niccolò
Machiavelli (1469-1527), scritta tra il 1514 e il 1515, e considerata il
capolavoro del teatro italiano del Cinquecento, oltre che un classico della
drammaturgia italiana. Composta da un prologo e cinque atti, è una potente
satira sulla corruzione della società italiana dell'epoca. La storia si svolge a
Firenze nel 1504: Callimaco è innamorato di Lucrezia, moglie dello sciocco
dottore in legge messer Nicia, che si lamenta per la mancanza di figli. Con
l'aiuto dell'astuto amico Ligurio, Callimaco, travestito da famoso medico,
riesce a convincere messer Nicia che l'' modo per avere figli sia di
somministrare a sua moglie una pozione di mandragola (da qui il titolo della
commedia), ma il primo che avrà rapporti con lei morirà. Ligurio quindi propone
a Nicia una geniale soluzione, cioè che a morire sia un semplice garzone: Nicia
rimane perplesso, visto che qualcuno dovrà giacere con sua moglie, la quale però
è l'unica a farsi scrupoli (non se li fanno né sua madre Sostrata né fra'
Timoteo). Naturalmente Ligurio ha pensato all'amico Callimaco, che si
travestirà da garzone e giacerà con Lucrezia. In una scena famosa e molto
divertente, il falso garzone (Callimaco) viene colpito in testa e portato a casa di
Nicia, e poi infilato nel letto insieme a Lucrezia. Questa, che nel frattempo è
stata convinta a consumare il rapporto adulterino da fra' Timoteo, accetta, e
nel momento in cui scopre la vera identità di Callimaco, passa con lui una
piacevolissima notte e decide di diventare sua amante. Dopo la notte degli
inganni, assunte nuovamente le sembianze del medico, Callimaco ottiene
dall'ingenuo Nicia, contento della futura paternità, il permesso di abitare in
casa sua e quindi di godere, non visto, delle grazie di Lucrezia. Nel corso
della storia, "la Mandragola" ebbe talmente successo che Voltaire espresse
l'opinione che questa da sola valesse più di tutte le commedie di Aristofane, e
nelle sue memorie Carlo Goldoni raccontava che, a diciassette anni, aveva
divorato la commedia, di nascosto, leggendola dieci volte. L'opera di Machiavelli ha avuto nel 1965 una versione cinematografica diretta da Alberto
Lattuada e interpretata da Philippe Leroy nel ruolo di Callimaco, Rosanna
Schiaffino nel ruolo di Lucrezia, Romolo Valli nel ruolo del notaio Nicia, Nilla
Pizzi nel ruolo di Sostrata e Totò nella parte di frate Timoteo.
La mandragola è citata anche in "Antonio e Cleopatra" di Shakespeare (1607). Nel
romanzo "Il mandragolo" (1979) di Luigi Santucci (1918-1999) il protagonista
Demo, un essere deforme, ma dotato di straordinari poteri medianici, viene
paragonato alla pianta magica. La mandragora si trova anche citata tra le piante
magiche del bestseller "Harry Potter e la camera dei segreti" (1998) e
dell'omonimo film da esso tratto (2002), nel film "Shakespeare in Love" (1998),
nel nome di due personaggi dell'anime e manga cult "I Cavalieri dello Zodiaco",
nonché nel film di Stefano Bessoni "Krokodyle", dove una mandragola viene
utilizzata nel processo di fabbricazione di un homunculus (un essere vivente
artificiale), e nella famosa serie di videogiochi fantasy "Castlevania". Nel
film di animazione di Iginio Straffi "Winx Club - Il segreto del regno perduto"
(2007) uno dei personaggi ostili alle fate si chiama Mandragola.
Infine, Mandragora in inglese si traduce con "mandrake", e Mandrake è il nome di
un personaggio dei fumetti creato nel 1934 da Lee Falk (1911-1999), dotato di
superpoteri basati sull'illusionismo; è divenuto famoso in tutto il mondo e
particolarmente in Italia, dove nacque il modo di dire "Non sono mica Mandrake!"
per indicare l'impossibilità di fare qualcosa. Falk, negli anni trenta ancora
giovane pubblicitario, affascinato dagli spettacoli di illusionismo, pensò di
realizzare un fumetto incentrato sulla figura di un mago il cui nome richiamava
la mandragora, e vestito con frac, cilindro e mantello, tipico abito dei
prestigiatori. Pochi sanno che Mandrake è ispirato a un mago realmente esistito,
tale Leon Mandrake, che si accordò con Falk affinché questi non rivelasse mai la
sua fonte di ispirazione, per consentire all'amico mago di sfruttare la
popolarità del personaggio. Pare che Federico Fellini volesse girare un film
incentrato sul personaggio, che sarebbe stato interpretato dal suo attore
feticcio Marcello Mastroianni, mentre il ruolo di Lothar, il forzuto servo nero
di Mandrake, sarebbe andato addirittura ad un giovane Cassius Clay; ma purtroppo
non fu mai realizzato. Cara mandragora, anche al giorno d'oggi, lasciatelo dire: più magica di così!

Le
bacche rosse di Natale
L'agrifoglio
(Ilex aquifolium), detto anche aquifoglio o alloro spinoso, è una pianta
appartenente alla famiglia delle Aquifoliacee. E' un albero sempreverde dioico
alto fino a 10 metri, con la chioma piramidale, corteccia liscia grigia e rami
verdastri. L'agrifoglio conta circa quattrocento specie tra arbusti ed alberi.
Oggi l'agrifoglio si trova in Asia occidentale e in Europa, in particolare nel
sottobosco di querce e faggete. Lungo la costa occidentale degli Stati Uniti e
del Canada, dalla California alla Columbia Britannica, l'agrifoglio inglese non
nativo si è dimostrato molto invasivo, diffondendosi rapidamente nell'habitat
della foresta nativa, dove prospera all'ombra e spazza via le specie autoctone.
Cresce spontaneo in Italia, con fogliame che a prima vista sembra sempreverde:
in realtà le foglie vivono per un anno, e poi cadono, ma non si rinnovano tutte
contemporaneamente. Le foglie sono di colore verde scuro lucente, molto
decorative, con varietà variegate di bianco, crema o giallo. I fiori sono
piccoli e riuniti in fascetti ascellari, unisessuali, con quattro petali di
colore bianco o rosato; durante l'inverno danno vita a drupe sferiche di colore
rosso vivo lucente, contenenti da due a quattro semi triangolari. I frutti fanno
forte contrasto con il colore delle foglie, che sono ovali, coriacee, con
margine spinoso. Quando le foglie dell'agrifoglio vengono danneggiate o
rosicchiate, la pianta attiva i geni per renderle spinose nella ricrescita, e
proteggerle da ulteriori attacchi; per questo sugli alberi di agrifoglio più
alti, le foglie superiori (che sono fuori portata) hanno i bordi lisci, mentre
le foglie inferiori sono spinose; da qui viene il nome della pianta, dal latino
"acrifolium", "pianta dalle foglie aguzze". L'agrifoglio è una robusta specie
pioniera che resiste al caldo e non teme le temperature rigide, sebbene alcune
varietà come l'Ilex cornuta mostrino una maggior sensibilità al gelo. Per
questo, dove gli inverni sono più rigidi, bisogna provvedere alla pacciamatura
(cioè alla ricopertura del terreno superficiale con paglia, foglie secche o
letame. Gradisce posizioni ombreggiate o di sottobosco, terreno acido o
semi-acido, fertile e ricco di humus. La moltiplicazione avviene con la semina
dei semi freschi, per mezzo di talea, per margotta o anche per innesto. Ilex
aquifolium è ampiamente coltivato in parchi e giardini nelle regioni temperate,
ed è spesso usato per le siepi, poiché le foglie spinose le rendono difficili da
penetrare, e si prestano bene alla potatura e alla sagomatura. Il legno di Ilex
aquifolium era una volta uno dei legni tradizionali per realizzare le cornamuse
scozzesi.
Durante il Cenozoico la regione mediterranea, l'Europa e l'Africa nordoccidentale avevano un clima più umido ed erano in gran parte ricoperte da
foreste di alloro; l'agrifoglio era una tipica specie rappresentativa di questo
bioma, insieme a molte specie attuali del genere Ilex. Con l' inaridimento del
bacino del Mediterraneo durante il Pliocene, le foreste di alloro si ritirarono
gradualmente, sostituite da comunità vegetali più resistenti alla siccità. Ancor
oggi a Piano Pomo, sul versante nordorientale del Massiccio del Carbonara nelle
Madonie (in provincia di Palermo) cresce una cinquantina di grandi piante di
agrifoglio, che in una valle dal suolo siliceo e profondo a 1400 metri di
altitudine hanno trovato il loro optimum climatico, raggiungendo dimensioni
ragguardevoli: la pianta più vecchia ha almeno 900 anni.
Nonostante nel linguaggio corrente siano considerati sinonimi, agrifoglio e
pungitopo non sono la stessa pianta: il secondo appartiene alla specie Ruscus
aculeatus. Agrifoglio e pungitopo differiscono tra loro nelle foglie (quelle
dell'agrifoglio sono verde scuro) e nei fiori che hanno colori diversi. Entrambe
le piante venivano usate nelle dispense intorno a salumi e formaggi per tenere
lontani i topi: da qui il nome volgare di "pungitopo"!
L'alto contenuto di ilicina come meccanismo di difesa da parte della pianta
contribuisce a rendere l'agrifoglio tossico per gli esseri umani poiché irrita
lo stomaco e l'intestino, e altri componenti lo rendono dannoso per il sistema
nervoso e per il cuore. L'ingestione di appena venti bacche può essere mortale
per un adulto. Tuttavia, alle giuste dosi, l'agrifoglio è molto usato nella
medicina popolare. Il decotto delle giovani radici raccolte in autunno è
diuretico, mentre il decotto della corteccia raccolta in qualunque periodo
dell'anno vanta proprietà febbrifughe. L'infuso delle foglie raccolte prima
della fioritura e fatte essiccare all'ombra ha proprietà calmanti, febbrifughe e
curative dell'itterizia, grazie alla ilicina in esso contenuta. Invece i frutti
raccolti a maturazione da ottobre a dicembre e fatti essiccare al calore hanno
azione purgativa. Un tempo le foglie non spinose erano anche usate come foraggio
per gli animali.
Per via delle sue spettacolari bacche rosse come sangue, l'agrifoglio è una
pianta considerata magica fin da prima dell'avvento del cristianesimo: si dice
che proteggesse dai demoni e portasse fortuna. I suoi primi utilizzi risalgono
all'Irlanda, dove anche le famiglie più povere potevano permettersi di
utilizzarlo per realizzare corone con cui decorare le proprie abitazioni. I
popoli germanici celebravano la rinascita del sole al solstizio d'inverno nella
festa di Yule (analoga alla nascita del Sol Invictus presso i Romani): la
rinnovata ascesa del sole in cielo che iniziava al solstizio era simbolicamente
inscenata come una battaglia tra la quercia estiva e l'agrifoglio invernale.
Inoltre le rosse bacche dell'agrifoglio rappresentavano la fertilità durante la
profonda oscurità invernale, una promessa di ritorno di luce e calore. Secondo
una nota leggenda, Baldur ("Signore"), il dio norreno del bene, ucciso a
tradimento dal suo malvagio fratello Loki con una freccia fatta di vischio,
cadde sopra una pianta di agrifoglio, e per aver accolto il corpo del figlio
venne benedetta da Odino: il sangue di Baldur fu trasformato appunto nelle
bacche rosse che da allora lo decorano.
Successivamente i Cristiani, che hanno sempre soppiantato le festività pagane
sovrapponendo ad esse dei nuovi significati, decisero di porre la data del
Natale proprio il 25 dicembre, perchè Cristo è il vero Sole Invincibile
dell'universo. Ovviamente molti simboli della tradizione precedente, come
l'agrifoglio, persistettero alla ridefinizione operata dai primi cristiani, e
per questo l'agrifoglio divenne una delle piante simbolo del Natale. Infatti,
secondo i nostri teologi la struttura della foglia ricorda la corona di spine di
Gesù Cristo e i frutti rossi il suo sangue, semplicemente sostituendo il
sacrificio di Cristo alla morte di Baldur, con la differenza che il primo ha
offerto la salvezza a tutta l'umanità. Inoltre i boccioli bianchi sarebbero
immagine della purezza della Madonna. Dopo la conversione dei popoli nordici al
cristianesimo, nacque la leggenda secondo cui le bacche dell'agrifoglio
derivassero dal sangue coagulato di un pastore che nel recare doni a Gesù si era
ferito con le foglie pungenti della pianta (ennesima versione del ferimento a
morte di Baldur). Una leggenda natalizia racconta che un bambino molto povero
era insieme ai pastori nel momento in cui gli angeli annunciarono loro la
nascita di Gesù. Egli si mise in cammino verso Betlemme con tutti gli altri,
e come regalo al Re dei Giudei portò una corona intrecciata con dei rami dalle
foglie spinose. Quando si trovò davanti alla grotta, tuttavia, si vergognò per
il suo dono così misero, tanto da mettersi a piangere. Le lacrime si posarono
sulla corona al cospetto del Bambinello, ed ecco che le foglie cominciarono a
brillare di un verde intenso, e le lacrime si trasformarono in bacche rosse, in
questo caso originate non dal sangue di un Dio ucciso, ma dall'amore di un Dio
neonato. Le proprietà magiche dell'agrifoglio fanno sì che esso sia uno dei
componenti della bacchetta magica acquistata da Harry Potter prima di essere
ammesso nella scuola di magia di Hogwarts. Caro agrifoglio, non sarai
magico quanto la mandragora, però ti difendi bene!

Primo piano dell'agrifoglio che cresce nel giardino dell'autore di questo sito
La
pera alligatore
Una volta, quindici anni fa, io e mia mamma abbiamo comprato un
avocado e abbiamo cercato di mangiarlo come se
fosse una pera, con il risultato che ci ha stomacato e non ne abbiamo preso più
per molto tempo; solo in seguito abbiamo scoperto che non è un frutto bensì una
verdura, e va consumato in insalata o come contorno di secondi piatti (sarebbe
stato come se avessimo cercato di sbucciare un platano e di mangiarlo in
macedonia... bleah!) Da allora, l'avocado compare spesso sulla mia tavola. Anche
se forse non ci crederete, l'albero di avocado (nome scientifico Persea
americana) è un albero sempreverde di medie dimensioni della famiglia
dell'alloro (le Lauracee). Si tratta di un albero che cresce fino a venti
metri, con un diametro del tronco compreso tra 0,3 e 0,6 m. È originario
anch'esso delle Americhe ed è stato domesticato per la prima volta dalle tribù
mesoamericane più di 5.000 anni fa. Allora come oggi era apprezzato per i suoi
frutti grandi e insolitamente oleosi.
Probabilmente ha avuto origine nella valle
di Tehuacan, nello stato messicano di Puebla, sebbene le prove fossili
suggeriscano tre possibili domesticazioni separate dell'avocado, che hanno dato
vita alle varietà autoctone attualmente riconosciute in Messico (aoacatl), in
Guatemala (quilaoacatl) e nell'India occidentale tlacacolaocatl). Le varietà
autoctone messicane e guatemalteche hanno avuto origine negli altopiani di quei
paesi, mentre la varietà autoctona dell'India occidentale è stata ivi
trapiantata dal Sudamerica. È molto probabile che le tre razze autoctone
separate si fossero già mescolate nell'America precolombiana, e sono descritte
nel cosiddetto Codice Fiorentino, scritto nel 1577 dal missionario fra
Bernardino de Sahagún. I primi abitanti della costa settentrionale del Perù
vivevano in accampamenti temporanei in una zona umida e mangiavano avocado,
insieme a peperoncini, molluschi, squali, uccelli e leoni marini. La scoperta
più antica di un nocciolo di avocado proviene dalla grotta di Coxcatlan,
risalente a circa 9.000 anni fa! Anche altre grotte nella valle di Tehuacan
risalenti all'incirca allo stesso periodo mostrano le prime prove della presenza
e del consumo di avocado. Esistono prove del consumo dell'avocado nei siti della
civiltà Norte Chico in Perù di almeno 3.200 anni fa e a Caballo Muerto in Perù
di circa 3.800 anni fa! Nella città preincaica di Chan Chan è stato scoperto un
vaso a forma di avocado, risalente al 900 d.C. La varietà selvatica e non
domesticata è nota come crioll, è piccola con buccia nera e un grande seme. Nel
1982 il biologo evoluzionista Daniel H. Janzen suggerì che l'avocado sia un
esempio di "anacronismo evolutivo", cioè di un frutto evolutosi per via della
relazione con la megafauna sudamericana ormai estinta (come i bradipi terrestri
giganti o i gonfoterii), perchè la maggior parte dei grandi frutti carnosi serve
alla funzione di dispersione dei semi, compiuta dal loro consumo da parte di
animali di grossa taglia. Ci sono alcune ragioni per pensare che il frutto, con
il suo nocciolo leggermente tossico, sia stata concepito per per essere
inghiottito intero dalla megafauna del Pleistocene ed espulso nello sterco,
pronto a germogliare: infatti nessun animale oggi ancora esistente è abbastanza
grande da disperdere efficacemente i semi di avocado in questo modo.
Il primo
resoconto scritto conosciuto dell'avocado in Europa è quello di Martín Fernández
de Enciso (1470–1528) nel suo libro del 1518 "Suma De Geographia Que Trata De
Todas Las Partidas Y Provincias Del Mundo". La parola avocado deriva dallo
spagnolo aguacate, che a sua volta viene dalla parola nahuatl "āhuacatl";
secondo la cultura popolare questa parola significherebbe "testicolo" per la sua
forma, ma si tratta di una paraetimologia; al contrario, è probabile che la
parola che designava l'avocado sia stata usata in Nahuatl come un eufemismo per
indicare il testicolo. La vera etimologia è sconosciuta. La pianta fu introdotta
in Spagna nel 1601, in Indonesia intorno al 1750, a Mauritius nel 1780, in
Brasile nel 1809, negli Stati Uniti nel 1825, in Sudafrica e Australia alla fine
del XIX secolo. Prima del 1915, l'avocado era comunemente indicato in California
come ahuacate e in Florida come pera alligatore (corruzione dell'antico spagnolo
"avogato"). In Argentina, Cile, Perù e Uruguay si usa inveceuna parola derivata
dal quechua, "palta". È invece noto come "frutto del burro" in alcune parti
dell'India e a Hong Kong. Botanicamente parlando, anche l'avocado è una bacca,
che contiene un ' grande seme. L'albero si ricopre di migliaia di fiori ogni
anno, che spuntano dai racemi vicino all'ascella delle foglie; sono piccoli e
poco appariscenti. Gli alberi di avocado sono in parte autoimpollinanti e spesso
vengono propagati tramite innesto, per mantenere una produzione di frutta
costante. Oggi l'avocado è coltivato in quasi tutti i paesi dal clima tropicale
e mediterraneo. Il Messico è il principale produttore mondiale di avocado, dato
che ha fornito quasi il 30% del raccolto globale del 2020; seguono a ruota
Repubblica Dominicana, Perù e Indonesia. I frutti delle varietà domestiche hanno
polpa liscia, burrosa, verde-dorata; a seconda della cultivar, gli avocado hanno
buccia verde, marrone, violacea o nera e possono essere a forma di pera, a forma
di uovo o sferica. Per scopi commerciali anche questi frutti vengono raccolti
acerbi e maturati dopo la raccolta.
Nelle principali regioni di produzione
come il Messico, il Cile e la California, il fabbisogno idrico degli allevamenti
di avocado mette a dura prova gli agricoltori locali: secondo le informazioni
pubblicate dal Water Footprint Network, per far crescere un avocado occorrono in
media circa 70 litri d'acqua per chilo di avocado prodotto! Il fabbisogno idrico
per la coltivazione degli avocado è tre volte superiore a quello delle mele e 18
volte superiore a quello dei pomodori. E così, si prevede che il riscaldamento
globale comporterà cambiamenti significativi nelle zone di coltivazione adatte
per gli avocado e metterà ulteriori pressioni sui luoghi in cui vengono prodotti
a causa delle ondate di calore e siccità. La coltivazione di avocado è inoltre
accusata di favorire la deforestazione e crea preoccupazioni per i diritti
umani, visto che buona parte del controllo della loro produzione in Messico è in
mano alla criminalità organizzata, che tratta i lavoratori come veri e propri
schiavi (ricordate le banane Chiquita?) Il frutto delle cultivar orticole ha un
contenuto di grassi notevolmente più elevato rispetto alla maggior parte degli
altri frutti, per lo più grassi monoinsaturi, e come tale funge da alimento base
importante nella dieta dei consumatori che hanno un accesso limitato ad altri
alimenti grassi (carne e pesce, latticini). Avendo un alto punto di fumo,
l'olio di avocado è costoso rispetto ai comuni oli per insalata e da cucina, ed
è usato principalmente per insalate o salse. Un avocado maturo cede a una
leggera pressione quando viene tenuto nel palmo della mano e schiacciato. La
polpa tende all'imbrunimento enzimatico, come mele e pere, diventando
rapidamente marrone per esposizione all'aria; per evitare ciò, è possibile
aggiungere succo di lime o limone agli avocado dopo averli sbucciati. L'avocado
è comune nella cucina vegetariana come sostituto della carne nei panini e nelle
insalate a causa del suo alto contenuto di grassi. Generalmente viene servito
crudo, anche se alcune cultivar, inclusa la comune "Hass", possono essere cotte
per un breve periodo senza diventare amare. È usato come base per la salsa
messicana nota come guacamole, da spalmare su tortillas di mais o pane tostato,
servito con spezie. Nel 2022 uno studio che ha seguito 110.487 persone per 30
anni ha scoperto che mangiare due porzioni di avocado a settimana riduce il
rischio di sviluppare malattie cardiovascolari del 20%. Alcuni lavori
s.cientifici indicano che l'avocado è un frutto ipocolesterolemizzante; inoltre
fa bene alla gola, perché le sue proprietà grasse sciolgono le placche. Contiene
poi beta-carotene, vitamine C, E, e K, glutatione, folati, e potassio in
concentrazione maggiore rispetto alle banane. L'avocado è anche un cosmetico
naturale: può essere utilizzato per creare maschere idratanti per la pelle ed è
un alleato per contrastare l'invecchiamento della pelle. Alcune persone però
hanno reazioni allergiche all'avocado, soffrendo di orticaria, dolori addominali
e vomito. È inoltre documentato che le foglie, la corteccia, la pelle o il
nocciolo di avocado sono velenosi per cani, gatti, bovini, capre, conigli e
cavalli: le foglie di avocado contengono infatti un componente tossico, la persina.
L'albero di avocado può essere coltivato anche come
pianta decorativa d'appartamento. Il nocciolo germina in condizioni normali
parzialmente sommerso in un piccolo bicchiere d'acqua.La pianta normalmente
cresce abbastanza alta da poter essere potata; non porta frutti a meno che non
goda di una forte luce solare. In Italia si è cominciato a coltivarlo in alcune
zone della Sicilia, della Calabria e della Sardegna, e pare che i frutti
ottenuti siano particolarmente apprezzati. Quella dell'avocado oggi è
un'avanzata inarrestabile che prosegue da anni, spalleggiata anche dalla
propaganda social di molti influencer che, esaltandone gusto e consistenza,
hanno acceso i riflettori sulle proprietà benefiche di questo alimento e lo
hanno reso popolarissimo tra i Millenials. Ah, ricordatatevi che il 31 luglio è
la Giornata Mondiale dell'Avocado!

Il
frutto giallo di Mao
Ora parliamo del mango, ovviamente
non del cantante nativo di Lagonegro, provincia di Potenza (Giuseppe Mango è
proprio il suo cognome, non è un nome d'arte!) Il nome botanico Mangifera indica
caratterizza un frutto diffuso nei paesi con clima tropicale, che appartiene
alla famiglia delle Anacardiaceae. Originario dell'India, del Pakistan e della
Birmania, dove cresce ancora spontaneamente, è noto da tempi immemorabili per le
sue proprietà e, soprattutto, per la sua polpa gialla e dolce con un retrogusto
acidulo, in alcune varietà leggermente piccante, con un retrogusto di pera e
anice.
Coltivato da oltre 4.000 anni, oggi il mango è il frutto nazionale di
India, Pakistan e Filippine ed è l' albero nazionale del Bangladesh. In un suo
editto l'imperatore indiano Maurya Ashoka, vissuto poco dopo Alessandro Magno,
scrisse: « Sulle strade ho fatto piantare alberi di banani, in modo che
potessero offrire ombra al bestiame e agli uomini, e dei boschetti di mango ».
Il poeta sanscrito classico Kālidāsa ha cantato le lodi dei mango, e nell'India
medievale il poeta indo-persiano Amir Khusrow definì il mango « il frutto più
bello dell'Hindustan ». Il fondatore dell'Impero Moghul, Babur, ne amava
particolarmente i frutti, e il suo successore Akbar (1556-1605) pare abbia
piantato un frutteto di oltre 100.000 alberi di mango vicino a Lahore!
Dall'India si diffuse rapidamente in tutto il mondo: già nel XVI secolo gli
arabi lo introdussero in Africa e i portoghesi lo stabilirono in America
Centrale e Meridionale. L'incontro con la civiltà europea risale proprio ai
tempi dei primi colonizzatori portoghesi, che all'inizio del sedicesimo secolo
fecero propria la parola Tamil "maangai", che potrebbe significare "sotto
salamoia". Oggi il primo produttore mondiale è l'India, seguita da Indonesia,
Cina e Messico; come altri frutti esotici, viene raccolto prima della completa
maturazione e continua a maturare nei cesti di frutta. Sono note diverse
centinaia di specie, ma solo alcune vengono commercializzate. La varietà "Tommy
Atkins", la più venduta con l'80% del mercato viene dalla Florida, resiste bene
ai trasporti, è ricca di fibra e dura a lungo, ma è anche meno succosa. La "Keitt"
è una varietà tardiva piuttosto grande, la polpa è dolce e succosa, ma dalla
consistenza fibrosa. Conosciuto da molto tempo nel Regno Unito attraverso piatti
di ispirazione indiana, apparve solo in ritardo sulle nostre tavole italiane,
dove rimase per lungo tempo confinato ai pasti delle feste per le famiglie
facoltose: era ancora considerato un cibo di lusso negli anni '70.
Il mango è un
frutto carnoso, più o meno ovale, che misura in media 10 cm. La sua pelle
verdastra è screziata di rosso e giallo, mentre la polpa giallo-arancione è
attaccata a un grosso nocciolo appiattito. Il contenuto di zucchero e quindi il
valore calorico variano a seconda del grado di maturazione: più è maturo, più è
dolce. Composto per oltre l'80% da acqua e per circa il 15% da carboidrati,
cento grammi di frutto assicurano in media 56,7 kcal, vitamina B3 e C, potassio,
fosforo, magnesio e di carotenoidi, tra cui il betacarotene, oltre ad una
significativa presenza di importanti aminoacidi come lisina, arginina, acido
aspartico, leucina e serina. Questo frutto tropicale è anche molto ricco di
sostanze antiossidanti come i polifenoli, in particolare l'acido gallico. Oltre
ad essere un ottimo dissetante con il suo gusto dolce, è un vero toccasana per
il nostro benessere, essendo una buona fonte di fibre solubili; come altri
frutti tropicali svolge una decisa azione antiossidante, ha un basso carico
glicemico ed è indicato per certe diete, dando una sensazione di sazietà. Alcuni
studi condotti sul mango hanno dimostrato che il suo succo ha un effetto
antitumorale sulle cellule in vitro, ma è ancora da dimostrare se queste
proprietà persistono dopo che il succo viene digerito o assorbito dal corpo
umano. Nel complesso, l'effetto antitumorale può essere spiegato dal suo
contenuto di polifenoli. Inoltre, sembra che le varietà Haden e Ataulfo abbiano
un'attività preventiva maggiore rispetto alle altre. La maggior parte della
fibra solubile del mango è pectina, in quantità paragonabili a quelle di mela e
banana. Controindicazioni? È moderatamente calorico, dolce e molto ricco di
valori nutrizionali, quindi l'elevata quantità di zuccheri presenti in questo
frutto lo sconsiglia per chi soffre di diabete. Inoltre la sua buccia è ricca di
sostanze irritanti come le oleoresine, che potrebbero causare
addirittura dermatiti da contatto; per questo, è fondamentale sbucciarlo prima
di mangiarlo ed evitare il contatto della buccia con le labbra. Oltre al consumo
crudo e in macedonia, il mango si presta ad un'ampia rosa di utilizzi in
cucina, ad esempio in quella sudamericana dove è un ingrediente di primi e
secondi piatti, come la cheviche. Si sposa infatti perfettamente con la carne e
il pesce. Il mango è usato per fare marmellate, il cosiddetto "amchur" (mango
acerbo essiccato e in polvere) e persino sottaceti. I mango maturi vengono
spesso tagliati in fette sottili ed essiccati, oppure usati per preparare
succhi, frullati, gelati e cocktail. È popolare su un bastoncino intinto in
polvere di peperoncino piccante e sale o come ingrediente principale in
combinazioni di frutta fresca. In America centrale, il mango viene consumato
verde, mescolato con sale, aceto, pepe nero e salsa piccante. Le consuete
curiosità per concludere. La dea giainista Ambika è tradizionalmente
rappresentata seduta sotto un albero di mango, e i fiori di mango sono usati
anche nel culto della dea Saraswati. Le foglie di mango decorano archi e porte
nelle case indiane durante matrimoni e celebrazioni; i motivi a forma di mango
sono ampiamente utilizzati in diversi stili di ricamo indiano e si trovano negli
scialli del Kashmir e nei sari di seta. Nel Tamil Nadu il mango è indicato come
uno dei tre frutti reali, insieme alla banana e al giaca; questa triade è nota
come ma-pala-vazhai. Infine, i mango sono stati oggetto di culto in Cina durante
la Rivoluzione Culturale come simboli del (presunto) amore di Mao Zedong per il
suo popolo, anche se per lui sarebbe stato meglio, anziché amare i manghi,
evitare la strage di tanti suoi connazionali!

La
palma della Caria (o no?)
E ora occupiamoci della papaia. La
Carica papaya è una delle 21 specie nel genere Carica della famiglia delle
Caricacee. Fu domesticata per la prima volta nell'odierno Messico meridionale e
nell'America centrale; nella Florida meridionale venne introdotta dagli antenati
dei Calusa non più tardi del 300 d.C. Gli spagnoli la introdussero nel Vecchio
Mondo fin dal XVI secolo. Il termine "Carica" deriva dal greco "Caria" usato da
Linneo per la somiglianza delle sue foglie con l'albero di Ficus carica, che
cresceva appunto nella regione anatolica della Caria, mentre "papaia" proviene
dal termine ispano-americano "papayo", derivato a sua volta dal termine Arawak "papaw", il
cui significato originario si è perso nella notte dei tempi. Prima dell'arrivo
degli europei, in Messico era chiamata Chichihualtzapotl, che in nahuatl
significa "frutto dolce da balia", ed era un frutto particolarmente connesso con
la fertilità.
La papaia è un albero piccolo, scarsamente ramificato, vagamente
simile alla palma, di solito con un ' fusto che cresce da 5 a 10 m di
altezza, con foglie disposte a spirale nella parte superiore del tronco. Le
foglie misurano 50-70 cm di diametro, lobate e palmate, con sette lobi, ricche
di lattice. Le piante di papaia crescono in tre sessi: maschio, femmina ed
ermafrodita. Il maschio produce solo polline, mai frutti; la femmina produce
piccoli frutti non commestibili, a meno che non vengano impollinati;
l'ermafrodita può autoimpollinarsi poiché i suoi fiori contengono sia stami
maschili che ovaie femminili; quasi tutti i frutteti commerciali di papaia
contengono solo piante ermafrodite. I fiori maschili e femminili compaiono
nell'ascella delle foglie, sono profumati, aperti di notte e impollinati dal
vento o dagli insetti. Il frutto è una grande bacca compresa tra 15 e 45 cm di
lunghezza e 10–30 cm di diametro; è maturo quando è morbido al tatto, la sua
buccia ha raggiunto una tonalità da ambra ad arancione e lungo le pareti della
grande cavità centrale sono fissati numerosi semi neri. La buccia, la polpa e i
semi della papaia contengono una varietà di sostanze fitochimiche, inclusi
carotenoidi e polifenoli. La coltivazione della papaia è oggi quasi pantropicale,
abbracciando le Hawaii, l'Africa centrale, l'India e l'Australia. Nelle
coltivazioni cresce rapidamente, fruttificando entro tre anni, ma è molto
sensibile al gelo, e quindi eventuali temperature sotto zero in Florida (a volte
capita) risultano fatali per le coltivazioni. Preferisce terreni sabbiosi e ben
drenati, poiché l'acqua stagnante può uccidere la pianta entro 24 ore. Vengono
comunemente coltivati due tipi di papaia: uno ha polpa dolce, rossa o arancione
e l'altro ha polpa gialla; entrambi i tipi, raccolti verdi, sono chiamati
"papaia verde". Primo produttore al mondo è l'India, seguito da Repubblica
Dominicana, Brasile, Messico e Indonesia. In Italia può essere coltivata sulle
coste siciliane e su quelle meridionali calabresi, tuttavia a causa delle basse
temperature invernali fruttifica solo da aprile a novembre, a differenza delle
regioni tropicali dove fruttifica tutto l'anno. Gli Stati Uniti invece sono il
più grande consumatore di papaia in tutto il mondo.
Carica papaya è stato
peraltro il primo albero da frutto transgenico il cui genoma è stato sequenziato!
In risposta all'epidemia del virus PRV (Papaya Ringspot Virus) che ha flagellato
le Hawaii nel 1998, è stata approvata e immessa sul mercato una papaia
geneticamente modificata, ottenuta da alcuni ricercatori filippini ibridando la
papaia con Vasconcellea quercifolia. La papaia quando non è matura rilascia un
lattice, causando probabilmente una reazione allergica in alcune persone, perché
l'enzima papaina agisce come un allergene in individui sensibili. Mangiata
fresca direttamente dalla buccia, spruzzata di succo di limone per esaltarne
ulteriormente il gusto, la papaia è una prelibatezza, ma si fa valere anche
nelle macedonie. Dato che nel gusto ricorda il melone, si sposa benissimo anche
con il prosciutto crudo e il salmone affumicato. Il frutto acerbo viene spesso
consumato cotto a causa del suo alto contenuto di lattice, ma viene comunemente
consumato crudo in Vietnam e Thailandia. Il frutto maturo della papaia viene
solitamente consumato crudo, senza buccia né semi; anche i semi neri però sono
commestibili e hanno un gusto piccante. La polpa di papaia cruda contiene l'88%
di acqua, l'11% di carboidrati e una quantità trascurabile di grassi e proteine;
100 g di papaia forniscono 43 chilocalorie e sono una fonte significativa di
vitamina C (il 75% del valore giornaliero. In alcune parti dell'Asia le foglie
giovani di papaia vengono cotte al vapore e mangiate come gli spinaci! La papaia
è entrata a far parte della cucina filippina dopo essere stata introdotta nelle
isole tramite i galeoni di Manila; le papaie acerbe o quasi mature (con polpa
arancione ma ancora dura e verde) sono messe in salamoia nell'atchara, che è
onnipresente nell'arcipelago come contorno ai piatti salati. Le papaie quasi
mature possono anche essere consumate fresche come insalata di papaia o tagliate
a cubetti e consumate intinte nell'aceto o nel sale. Nella cucina indonesiana,
invece, i frutti verdi acerbi e le foglie giovani vengono bolliti per essere
utilizzati come parte dell'insalata lalab, mentre i boccioli dei fiori vengono
saltati in padella con peperoncini e pomodori verdi. Sia il frutto della papaia
verde che il suo lattice sono ricchi di papaina, una proteasi utilizzata per
intenerire la carne e altre proteine, come fanno i nativi americani, i popoli
della regione caraibica e delle Filippine. La papaia invece non è adatta per
dessert a base di gelatina, perché le proprietà enzimatiche della papaina
impediscono alla gelatina di solidificarsi. I semi di papaia hanno un gusto
simile a quello del crescione; essiccati e macinati, si possono utilizzare al
posto del pepe. Invece, nella medicina tradizionale le foglie di papaia sono
utilizzate come trattamento per la malaria, come purgante o addirittura fumate
per alleviare l'asma. E' nota una citazione di Homer Simpson: « Assaggia le
papaie. Sono succose e piene di papaina! Rendono forti come Braccio di ferro!
Popeye-papaina! Popeye-papaina! Popeye-papaina! Capito? Stessa cosa! » Infine,
non dimentichiamo che "Papaya" è un album del 2008 di Cristiano Malgioglio!

Il
frutto con la corona di spine
Avete mai assaggiato il frutto della
passione? La pianta che lo produce (Passiflora edulis) appartiene
all'ordine delle passifloracee, ed è originaria del Brasile meridionale e
dell'Argentina settentrionale. Viene coltivato a scopi commerciali nelle aree
tropicali e subtropicali per il suo frutto dalla polpa dolce e morbidissima, che
è una bacca ovale, gialla o viola scuro quando è maturo, con un interno succoso
e pieno di numerosi semi. Il frutto viene consumato sia mangiandone la polpa con
un cucchiaino, come se fosse un barattolo di yogurt, che spremendolo, con il
succo spesso aggiunto ad altri succhi di frutta per migliorare l'aroma. Il
nome del frutto della passione (passiflora ne è la traduzione letterale in
latino, il nome originale brasiliano era "fiore delle cinque piaghe ") gli fu
dato intorno al 1700 dai missionari in Brasile per via della forma del fiore, i
cui elementi ricordano la Passione e la crocifissione di Gesù: la corolla,
infatti, richiama alla mente una corona di spine, mentre i pistilli ricordano i
chiodi della crocifissione, e i viticci sembrano rievocare la frusta della
flagellazione. Tale frutto dunque poteva servire come aiuto didattico per
convertire i nativi al cristianesimo, come il trifoglio fu usato da San Patrizio
per illustrare la Santissima Trinità ai suoi compatrioti irlandesi. In Brasile
invece è noto come Mararacuyá o Maracujá, da una parola guaranì che significa
"vivaio per le mosche". Nella Repubblica Dominicana il frutto prende il nome di
chinola, che deriva probabilmente dalla parola Cina, per similitudine
all'arancia, che avuto origine in quel Paese.
La Passiflora edulis è un albero
perenne; come la vite, è dotata di viticci portati nelle ascelle delle foglie
che hanno una tonalità rossa o viola quando sono giovani. Di solito la pianta
produce un ' fiore largo 5-7,5 cm ad ogni nodo; il fiore ha 5 sepali
oblunghi verdi e 5 petali bianchi. Il frutto ha un diametro di 4–7,5 cm; i
frutti viola sono più piccoli, pesano circa 35 grammi, mentre i frutti gialli
pesano circa 80 grammi. La buccia liscia e coriacea ha uno spessore di 9-13 mm,
compreso uno spesso strato di midollo. All'interno della bacca ci sono
tipicamente 250 semi marroni, ciascuno lungo due o tre millimetri. Ogni seme è
circondato da un sacco membranoso pieno di succo polposo. Il sapore del succo è
leggermente acido e muschiato, La varietà giallo brillante può crescere fino
alle dimensioni di un pompelmo, ha una buccia liscia, lucida e leggera; la
varietà viola scuro è più piccola di un limone, sebbene sia meno acida del
frutto della passione giallo e ha un aroma e un sapore più ricco. La buccia non
è commestibile. A volte il dragon fruit è confuso con il frutto della passione,
ma il loro sapore e la loro composizione hanno molte differenze: la polpa del
frutto della passione è più vischiosa e cremosa, mentre quella del dragon fruit
risulta essere più consistente; i semi del frutto della passione sono più grandi
e croccanti, nel dragon fruit invece sono molto piccoli e simili ai semi di
papavero. Principali produttori al mondo sono Brasile, Perù, Sudafrica, India,
Indonesia e Nuova Zelanda. Il frutto della passione crudo contiene il 73% di
acqua, il 22% di carboidrati, il 2% di proteine e lo 0,7% di grassi; 100 grammi
di polpa di frutto della passione crudo forniscono 97 calorie ed è una ricca
fonte di vitamina C; inoltre è un concentrato di preziosi nutrienti che gli
conferiscono numerose proprietà benefiche. L'elevato contenuto di molecole
antiossidanti come vitamina C, betacarotene e polifenoli, lo rendono utile nel
prevenire malattie croniche come tumori, diabete di tipo 2 e malattie
neurodegenerative. Siccome è ricco di antiossidanti esercita un elevato potere
antinfiammatorio, utile nel contrastare disturbi e malattie legate
all'infiammazione, come l'osteoartrite; promuove la salute intestinale: ricco di
fibre, favorisce il transito intestinale e la funzionalità del microbiota. Controlla
infine i livelli di zuccheri e colesterolo nel sangue: grazie alla presenza di
fibre solubili, è in grado di ridurre la velocità di assorbimento di zuccheri e
grassi. Il frutto della passione non presenta particolari controindicazioni, ma
il suo consumo è sconsigliato a chi soffre di allergia al lattice; è
consigliabile non assumerlo in quantità eccessive, perché potrebbe avere un
effetto lassativo. Il frutto della passione è ampiamente coltivato nelle regioni
tropicali e semitropicali del mondo; negli Stati Uniti è coltivato in Florida,
Hawaii e California. In genere deve essere protetto dal gelo, anche se alcune
cultivar sono sopravvissute a gelate leggere. Il fiore del frutto della passione
è il fiore nazionale del Paraguay. Infine, nel 2006 la cantautrice Paula Fuga ha
pubblicato la popolare canzone "Lilikoi", la parola in lingua hawaiana che
indica il frutto della passione, e l'artista hip-hop Drake nel 2017 ha
pubblicato la canzone di successo "Passionfruit"!

Il
ciliegio cinese
E' venuto il turno del litchi, nome
scientifico Litchi chinensis. È un albero tropicale originario della Cina
meridionale, della famiglia delle Sapindacee, detto anche "il ciliegio
cinese". È stato descritto e così denominato dal naturalista francese Pierre
Sonnerat (1748-1814) nel suo "Voyage aux Indes Orientales et à la Chine, fait
depuis 1774 jusqu'à 1781", pubblicato nel 1782. Il termine Litchi è la
latinizzazione del nome cinese lì zhì o lì zhì (荔枝). La coltivazione del litchi
iniziò nella regione della Cina meridionale, in Malesia e nel nord del Vietnam.
Documenti cinesi fanno riferimento al litchi fin dal 2000 a.C. Nel I secolo d.C.,
durante la dinastia Han, i litchi freschi erano un popolare oggetto di tributo,
ed erano così richiesti alla corte imperiale che uno speciale servizio di
corrieri con cavalli veloci portava la frutta fresca dal Guangdong fino alla
capitale. C'era una grande richiesta di litchi durante la dinastia Song
(960-1279), come narra Cai Xiang nel suo trattato "Li chi pu" ("Trattato sui
litchi"). Fin da subito il litchi attirò l'attenzione dei viaggiatori europei,
come il vescovo, esploratore e sinologo spagnolo Juan González de Mendoza, nella
sua "Storia del grande e potente regno di Cina" (1585), basata sui rapporti di
frati spagnoli che avevano visitato la Cina nel 1570. Il litchi fu introdotto in
Occidente nel 1656 da Michal Boym, un missionario gesuita polacco; venne
invece introdotto nella pianura pakistana nel 1932 e rimase una pianta esotica
fino agli anni '60, quando iniziò la produzione commerciale. Studi genomici
indicano che il litchi odierno è il risultato di un doppio addomesticamento
mediante coltivazione indipendente in due diverse regioni dell'antica Cina.
Ne
esistono tre sottospecie, che differiscono per la disposizione dei fiori, lo
spessore del ramoscello e i tipi di frutto. Il Litchi chinensis sperò è l''
commercializzato. Cresce spontaneamente nel sud della Cina, nel nord del
Vietnam, in Cambogia e nelle Filippine. Il Litchi chinensis è un albero
sempreverde alto fino a 15 m e con foglie ellittico-oblunghe o lanceolate. La
corteccia è grigio-nera, i rami rosso bruno. Ricordano nel fogliame la famiglia
delle Lauracee, probabilmente a causa di convergenza evolutiva. I fiori crescono
su un'infiorescenza terminale con molte pannocchie che crescono in grappoli di
dieci o più, raggiungendo da 10 a 40 cm, e portando centinaia di piccoli fiori
bianchi, gialli o verdi molto profumati. I frutti sono carnosi e maturano in
80-120 giorni a seconda del clima, della posizione e della cultivar. La forma
dei frutti varia da rotonda a ovoidale a forma di cuore, fino a 5 cm di
lunghezza e 4 cm di larghezza, con unl peso di circa 20 g. La buccia sottile e
durissima è verde quando è acerbo, maturando diventa rossa o rosata, ed è liscia
o ricoperta da piccole protuberanze appuntite molto ruvide. La crosta non è
commestibile, ma può essere facilmente rimossa per esporre uno strato di
polpa carnosa bianco-traslucida dal sapore dolcissimo. La polpa carnosa e
commestibile circonda un seme non commestibile marrone scuro lungo da 1 a 3,3 cm
e largo da 0,6 a 1,2 cm. Alcune cultivar producono un'alta percentuale di frutti
con semi avvizziti noti come "lingue di pollo", ed hanno in genere un prezzo più
alto, a causa della polpa più commestibile. Poiché il sapore floreale si perde
nel processo di inscatolamento, il frutto viene solitamente consumato fresco. La
Cina è il primo produttore mondiale di litchi, seguita da Vietnam e India, ma
tali alberi sono ampiamente coltivati anche a Taiwan, nel sudest asiatico, in
Sudafrica e nel Madagascar. Richiedono un clima tropicale, precipitazioni e
umidità elevate, e crescono in modo ottimale su terreni ben drenati, leggermente
acidi, ricchi di materia organica. Alcune cultivar sono piantate anche come
albero ornamentale, oltre che per i loro frutti. Il modo più comune di far
figliare il litchi è attraverso la margotta (si taglia un ramo di un albero
maturo, si copre il taglio con torba o muschio e lo si avvolge con polietilene
per permettere al taglio di fareradici. Una volta che si è verificato un
radicamento significativo, la margotta viene tagliata dal ramo e messa in vaso.
100 g di frutti maturi danno ben 66kcal, 15,43 g di carboidrati, 15,23 g di
zuccheri e 1,3 g d fibre. La polpa cruda è ricca di vitamina C: ne contiene 72
mg ogni 100 grammi, una quantità che rappresenta l'86% del
fabbisogno giornaliero, ma non contiene altri micronutrienti in
quantità significative. I litchi contengono invece quantità moderate di
polifenoli.
Purtroppo però non sono tutte rose e fiori. Nel 1962 si scoprì che i
semi di litchi contengono metilenciclopropilglicina (MCPG), che causa
ipoglicemia negli studi sugli animali. Dalla fine degli anni '90 si sono
verificate epidemie inspiegabili di encefalopatia, che sembravano colpire solo i
bambini in India e nel nord del Vietnam (dove è stata chiamata encefalite di Ac
Mong, dal nome della parola vietnamita che significa incubo!) durante la
stagione del raccolto del litchi da maggio a giugno. Un'indagine del 2013 dei
Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC)
ha dimostrato che i casi erano collegati al consumo di litchi. All'inizio si
pensò erroneamente che la trasmissione della malattia potesse avvenire per
contatto diretto con i litchi contaminati da saliva di pipistrello, invece le
successive indagini hanno collegato la malattia all'ipoglicina A. alla tossicità
dell'MCPG e ai bambini malnutriti che mangiavano litchi (in particolare quelli
acerbi) a stomaco vuoto. Poveri bimbi, vittime del nostro opulento
menefreghismo...

Il
padre del muschio
Adesso voglio portarvi in Africa, e parlarvi di un ortaggio poco
noto, di cui forse avete sentito parlare raramente: il
gombo, per i botanici Abelmoschus esculentus (dall'arabo ʾabū l-misk,
"padre del muschio"). Vi dice niente? Si tratta di una pianta della famiglia
delle Malvacee, imparentata quindi con il cotone, il cacao e l'ibisco, coltivata
sia in zone tropicali che subtropicali; esso fornisce frutti che sono consumati
in Africa ma anche in India. È conosciuto anche come okra (dalla parola Igbo
okuru), gnaouia (ڤناوية) in Tunisia e bāmiyā in Egitto ed in Etiopia. Nei paesi
di lingua portoghese è nota con il nome di quiabo. Viene coltivato anche in
Italia, per lo più ovviamente in Sicilia.
L'origine geografica del gombo è
controversa: si discute se sia originario del sud-est asiatico, dell'Asia
meridionale, dell'Etiopia o dell'Africa occidentale. Gli Egiziani del XII e XIII
secolo usavano il nome arabo "bamya", suggerendo che fosse arrivato in Egitto
dall'Arabia, ma prima probabilmente era stata portata in Arabia dall'Etiopia,
come il caffè. Potrebbe essere passata nell'Asia sud-occidentale attraverso il
Mar Rosso o lo stretto di Bab-el-Mandeb, piuttosto che a nord attraverso il
Sahara, o dall'India. Uno dei primi resoconti europei è quello di un arabo
spagnolo che visitò l'Egitto nel 1216 e descrisse la pianta coltivata dalla
gente del posto che ne mangiava i teneri e giovani baccelli impanati.
Dall'Arabia la pianta si diffuse lungo le coste del Mar Mediterraneo e verso
est. La pianta fu introdotta nelle Americhe (purtroppo) dalle navi che
effettuavano la tratta degli schiavi nell'Atlantico nel 1658, quando fu
registrata la sua presenza in Brasile. Il primo uso della parola okra nella
colonia della Virginia apparve nel 1679, mentre la parola "gumbo" fu usata per
la prima volta nello slang americano intorno al 1805, derivando dal creolo della
Louisiana; probabilmente viene dalla parola Kimbundu "ki-ngombo". Thomas
Jefferson notò che era una coltura comune in tutti gli Stati Uniti meridionali
nel 1800.
Quella del gombo è una pianta perenne, che cresce fino a circa due
metri. Le foglie sono lunghe e larghe 10-20 centimetri, i fiori hanno cinque
petali da bianchi a gialli, spesso con una macchia rossa o viola alla base. Il
frutto è un baccello lungo fino a 18 centimetri con sezione pentagonale,
contenente numerosi semi rotondi e bianchi. È tra le specie vegetali più
resistenti al calore e alla siccità, e tollera terreni con argilla pesante e
umidità intermittente. I baccelli diventano rapidamente fibrosi e legnosi e, per
essere commestibili, devono essere raccolti quando sono acerbi, di solito entro
una settimana dall'impollinazione. I baccelli della pianta sono mucillaginosi,
dando luogo al caratteristico "goo" ("bava") quando vengono cotti; la
mucillagine contiene fibra solubile. Un modo per rimuovere la bava è cuocerlo
con un alimento acido come i pomodori. I baccelli sono cotti, serviti in
salamoia o consumati crudi nelle insalate. Oggi il frutto del gombo è di moda
perchè è molto usato nella cucina indiana, ma lo si ritrova anche nella cucina
turca, tunisina, persiana, greca, albanese e brasiliana, oltre che in quella
dell'Africa subsahariana. Il gombo è uno dei tre addensanti che possono essere
utilizzati nella "zuppa della Louisiana"; a Cuba e Portorico è usato in piatti
come il "quimbombo guisado". Nell'Asia meridionale i baccelli sono utilizzati in
molte preparazioni piccanti e cucinati con carne di manzo, montone, agnello e
pollo. I semi di gombo possono essere tostati e macinati per formare un
sostituto del caffè privo di caffeina: quando nel 1861 l'importazione di caffè
fu interrotta dalla guerra civile americana, un politico dichiarò: « Un acro di
gombo produrrà semi sufficienti per fornire una piantagione di caffè in ogni
modo uguale a quello importato da Rio! » Dai semi di gombo viene spremuto un
olio commestibile giallo-verdastro ricco di grassi insaturi come l'acido oleico
e l'acido linoleico. Il gombo crudo contiene il 90% di acqua, il 2% di proteine
e il 7% di carboidrati, ed è una fonte importante di fibre alimentari, vitamina
C e vitamina K; per questo è un benemerito, venendo efficacemente utilizzato nei
paesi in via di sviluppo per mitigare la malnutrizione. Il principale produttore
mondiale è l'India, seguito da Nigeria, Mali, Sudan e Pakistan. Nel 2021, la
produzione mondiale di gombo è stata di oltre 10,8 milioni di tonnellate. I
fusti del gombo, come quelli di molte malvacee, sono macerati e lavorati per
fornire una fibra tessile nota come fibra di gombo. Avendo una composizione
simile a una spessa pellicola di polisaccaride, la mucillagine del gombo è in
fase di sperimentazione come imballaggio alimentare biodegradabile; infine, uno
studio del 2009 ha rilevato che l'olio di gombo è adatto per l'uso come
biocarburante, anche se questo sarebbe negativo, perchè sottrarrebbe milioni di
ettari alla coltivazione a scopo alimentare, per combattere la fame nel Terzo e
Quarto Mondo.

I semi del Subcomandante
La Chia è una pianta erbacea della famiglia delle Lamiacee, nativa
del Guatemala e del Messico centrale e meridionale, che può raggiungere
l'altezza di un metro e ha fiori viola o bianchi, in realtà infiorescenze
composte. La parola chia deriva dal nahuatl "chian", che significa "oleoso"; tra
l'altro, è la stessa etimologia del nome dello stato messicano del Chiapas,
quello del famoso Subcomandante Marcos, epigono di Che Guevara. Come risulta dal
Codice Mendoza, un manoscritto mesoamericano del XVI secolo, la pianta di Chia
era coltivata dagli Aztechi in epoca precolombiana, e secondo alcuni storici
l'importanza della chia in campo agroalimentare era paragonabile all'epoca a
quella del mais. Viene ancora coltivata in Messico e Guatemala, per la
produzione sia di sfarinati sia di semi interi ad uso alimentare; ma è coltivata
anche in Bolivia, Ecuador, Colombia, Nicaragua, Argentina nordoccidentale,
Australia e Stati Uniti sudoccidentali. I semi, a quanto pare, sono ricchissimi
di omega-3, paragonabili dal punto di vista nutrizionale a quelli del lino e del
sesamo; tipicamente sono piccoli e ovali con un diametro di circa 1 mm, di
colore screziato, marrone, grigio, nero e bianco. Questi semi sono idrofili, al
punto che possono assorbire fino a 12 volte il loro peso quando sono messi a
mollo. Durante l'ammollo, i semi sviluppano un rivestimento mucillaginoso che
conferisce alle bevande a base di chia una caratteristica consistenza
gelatinosa. Le linee guida raccomandano di assumere almeno 25 grammi di fibre al
giorno, e con una porzione di 30 grammi di semi di chia noi soddisferemmo un
terzo del nostro fabbisogno! Inoltre i semi di chia sono ricchi di proteine di
alta qualità, che apportano tutte e nove gli amminoacidi essenziali. I semi di
chia sono ricchi anche di minerali: manganese, calcio, fosforo, rame, ferro,
selenio e magnesio. Sempre secondo i nutrizionisti, i semi di chia contrastano
l'infiammazione, migliorano l'attività del sistema nervoso centrale e la salute
cardiovascolare, promuovono la salute dell'intestino, regolano i livelli di
zucchero nel sangue e migliorano l'insulinoresistenza. Il gel ottenuto
mettendo in ammollo un cucchiaio di semi di chia in mezzo bicchiere di acqua per
almeno trenta minuti può essere utile anche in casi di irregolarità
intestinale. Controindicazioni? Solo il fatto che un consumo eccessivo potrebbe
provocare disturbi gastrointestinali, per il loro elevato contenuto di
fibre.
Questi semi sono quasi privi di sapore, e possono essere aggiunti a
qualsiasi pietanza o alimento, senza alterarne il gusto: ad esempio, si possono
aggiungere all'impasto dei lievitati, come focacce, pizza o pane integrale,
all'interno di zuppe di cereali e legumi oppure nell'impasto di biscotti, per
conferire maggiore croccantezza. Si può preparare in casa anche un burro di semi
di chia aggiungendo 100 grammi di gel di semi a un burro vegetale nella medesima
quantità: il composto, frullato, si può conservare in frigorifero come un
normale burro. Tra le ricette più semplici e comuni con essi c'è il budino di
semi di chia: per prepararlo è sufficiente lasciare in ammollo 30 grammi di semi
di chia in 200 ml di latte vaccino o latte di mandorle o latte di soia per tutta
la notte in frigorifero, all'interno di una ciotola. Al mattino, i semi di chia
hanno assorbito i liquidi e il composto ha la consistenza simile a quella di un
budino, che si può guarnire con yogurt, frutta fresca e cacao amaro. Un fatto
importantissimo è questo: che io ne sappia, nessun parassita o malattia grave
colpisce la produzione di chia. Gli oli essenziali nelle foglie di chia hanno
proprietà repellenti contro gli insetti, rendendolo adatto alla coltivazione
biologica; possono verificarsi solo infezioni da virus. Invece le erbacce
possono rappresentare un problema nello sviluppo iniziale del raccolto di chia,
ma poiché è molto sensibile agli erbicidi più comunemente usati, è preferibile
il controllo meccanico delle erbe infestanti. Una curiosità: durante gli anni
'80, negli Stati Uniti la prima consistente ondata di vendite di semi di chia fu
legata ai cosiddetti "Chia Pets", sculture in argilla che raffigurano animali
domestici, da usare come base per una pasta appiccicosa di semi di chia; le
statuine venivano innaffiate, ei semi germogliavano in una forma che suggeriva
una copertura di pelliccia per l'animaletto. Pensa che ancor oggi negli Stati
Uniti ogni anno vengono venduti almeno 500.000 Chia Pet come piante da
appartamento!

Il
pianto della Luna
Non tutti sanno cos'è lo
jicama (Pachyrhizus erosus): si
tratta di una pianta rampicante messicana della famiglia delle Fabacee (quella
dei piselli), conosciuta soprattutto per i suoi tuberi commestibili (gli jicama
propriamente sono questi ultimi). A questo genere appartengono altre due specie
coltivate, Pachyrhizus tuberosus e Pachyrhizus ahipa, ma quello che si trova in
commercio con il nome di jícama è prodotto solo da Pachyrhizus erosus. Viene
chiamata anche atata messicana, ahipa, patata
cinese e rapa dolce. In Ecuador e Perù, invece, il nome jícama è usato per lo yacón
o mela macinata peruviana, una pianta della famiglia dei girasoli i cui tuberi
sono commestibili.
La pianta di jícama, che ricorda vagamente la vite, può raggiungere un'altezza di 4-5 metri,
se sostenuta con un
supporto adeguato. La sua radice può raggiungere la lunghezza di due metri e pesare fino a 20 chilogrammi (la radice
di jícama più pesante
mai raccolta pesava 23 kg ed è stata trovata nel 2010 nelle Filippine). La Jícama è
sensibile al gelo, e richiede nove mesi senza gelate per un
buon raccolto di grandi tuberi da sfruttare commercialmente, ma può essere anche
coltivata in zone più fresche che hanno almeno cinque mesi senza gelate, poiché
produrrà comunque tuberi, anche se saranno più piccoli. Nelle aree calde e temperate
si può iniziare a seminarla da otto a dieci
settimane prima dell'ultimo gelo primaverile. I semi richiedono temperature
elevate per germogliare, quindi i vasi
dovranno essere tenuti in un luogo caldo e protetto. La jícama non è adatta per
le aree con una stagione di crescita breve, a meno che non venga coltivata in
serra, mentre i coltivatori delle zone tropicali possono seminarla in qualsiasi
momento dell'anno. Invece quelli nelle aree subtropicali dovrebbero seminarla
una volta che il terreno si è riscaldato in primavera.
La pianta adulta produce fiori, blu o bianchi, e da questi dei baccelli simili a
quelli dei piselli. Le due varietà coltivate di Pachyrhizus erosus sono "jícama de agua" e
"jícama de leche", entrambe
così denominate per la consistenza del loro succo. La forma leche ha una radice
allungata e un succo lattiginoso, mentre la forma agua ha una radice da apicale
a oblata e un succo più acquoso e traslucido, ed è la varietà preferita per il
mercato.
Lo jícama è originario del Messico e dell'America centrale; anche se in Italia è
del tutto sconosciuto, si tratta di una materia prima antica, con una lunga
storia nascosta tra la sua buccia e la polpa croccante. Era infatti ben nota
alle civiltà precolombiane: il nome jicama deriva dall'atzeco "xicamalt",
termine con cui si indicava il tubero nella Mesoamerica: ne sono stati trovati
esemplari in siti archeologici del Perù risalenti al 3000 a.C. Scoperta dai
Conquistadores, nel XVII secolo fu introdotto dagli spagnoli nelle Filippine,
dove è conosciuto come singkamas, e da qui si è diffuso in varie parti
dell'Asia, entrando a far parte della tradizione culinaria di questi paesi. In
Malesia è conosciuto come ubi sengkuang, e in Indonesia come bengkuang. Padang, capitale della provincia
indonesiana di Sumatra Occidentale, è soprannominata "la città del bengkuang".
Molti abitanti della regione pensano addirittura che il jícama sia un prodotto indigeno
dell'isola di Sumatra, tanto esso è diventato parte della loro cultura!
Lo jícama deve essere conservato asciutto, tra 12,5° e 15°C: in questo
intervallo di temperatura la
radice di jícama rimane fresca fino a 4 mesi. Lo jícama intero può anche essere conservato in frigorifero per
mantenerlo privo di umidità fino a tre settimane. La conservazione a temperature
più basse può scolorire e danneggiare la radice e degradarne la consistenza. La
radice si manterrà fresca per una settimana dopo essere stata affettata, e
dovrebbe essere avvolta e refrigerata per la conservazione in questo stato.
Il sapore dello jicama è dolce, con delicate note di frutta secca: a qualcuno
ricorda il sapore di una mela molto saporita. La consistenza della polpa invece
è più simile a quella di una patata cruda. Di solito questo tubero si mangia
crudo in insalata, ma occorre pulire bene la jicama dalla buccia esterna, scura
e spessa che contiene sostanze tossiche. Alcuni amano condirlo con succo di
lime, un pizzico di sale e uno di peperoncino. Viene consumato anche grattugiato
nelle salse, ad esempio in un delizioso condimento per tacos insieme a cipolla,
pomodori tagliati a dadini, fagioli neri, peperoncino, coriandolo e succo di
lime, oppure aggiunto alla classica guacamole, salsa messicana a base di
avocado, cipolla bianca e pomodoro. Il suo sapore dolce si presta
all'abbinamento con la frutta, come avocado, cocomero, mela, arancia, melograna.
Nella Penisola dello Yucatan (Messico meridionale) si prepara un piatto chiamato
Xec, un'insalata di frutta con spicchi di mandarini e arance, condita con succo
di agrumi (lime, pompelmo, arancia), coriandolo, sale e pepe. Quando lo jicama è
di stagione, la Xec è uno street food molto diffuso tra le strade e i mercati.
Nei ristoranti e nelle case, invece, può essere servito come salsa di
accompagnamento a piatti di pesce o di carne di maiale. Nelle Filippine viene
solitamente consumato fresco con condimenti come aceto di riso e cosparso di
sale o con bagoong (pasta di gamberi). Viene utilizzato
anche come estensore per le versioni filippine di siomai e polpette. Negli Stati
Uniti i cuochi amano invece aggiungerla alla classica insalata di cavoli e
maionese ("coleslaw").
Lo jicama però viene anche consumato cotto, come sostituto delle patate in
verdure saltate in padella, nelle zuppe, nelle torte salate oppure al forno. In
Vietnam lo jicama è inserito tra gli ingredienti del ripieno degli involtini
primavera, mentre in Cina in quello dei ravioli. In Malesia è apprezzato il Jiu
Hu Char, un piatto a base di jicama saltato in padella con verdure (cavolo,
funghi, cipolla, aglio, carote), salsa di soia e seppia. Dai tuberi si può anche
ricavare una farina affettandoli, essiccandoli e macinandoli.
Il successo di questo prodotto nei secoli e nei vari continenti non è solo
dovuto alla sua versatilità in cucina, ma anche ai suoi valori nutrizionali. Lo
jicama è infatti particolarmente ricco di potassio, vitamina C, fibre e acqua; è
invece basso il suo contenuto di proteine, grassi e sodio. Contiene inoltre
inulina, un oligosaccaride che non alza il livello della glicemia, per cui si
tratta di un tubero adatto ai diabetici. Cento grammi di jicama forniscono 38 kilocalorie,
8,82 g di carboidrati, 4,9 g di fibra,
0,09 g di grassi,
0,72 g di proteine e parecchie vitamine: tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina
(B3), acido pantotenico (B5), folato (B9) e il 24% della dose quotidiana
consigliata di Vitamina C! Lo jicama possiede proprietà antiossidanti, i suoi
amidi si possono adoperare come sostituti della farina e del glucosio, o anche
come sostituto del grasso nello yogurt. Inoltre gli amidi di jicama sono stati
studiati come risorsa per la produzione di biofilm commestibili, onde combattere
la malnutrizione in molte aree del mondo dove regna la miseria.
Ma attenzione: contrariamente alla radice, il resto della pianta è molto velenoso.
I semi
contengono la tossina rotenone, un insetticida e acaricida naturale, a largo
spettro d'azione, che blocca il complesso I della catena respiratoria nei
mitocondri. Sull'uomo l'avvelenamento da rotenone provoca generalmente vomito,
nausea, dolori addominali, tremori, convulsioni, irritazioni cutanee,
alterazioni del ritmo respiratorio e del battito cardiaco, ma per fortuna il
rischio di morte da avvelenamento da rotenone è basso perché l'assunzione delle
dosi letali provoca in genere il vomito, impedendone l'assorbimento.
Sul Jicama esiste una suggestiva leggenda che fa parte del corpus mitologico
della cultura Purépecha, che fiorì nell'attuale stato messicano di Michoacán
durante il periodo postclassico mesoamericano, cioè più o meno tra il IX secolo
della nostra era e l'arrivo degli Spagnoli. In esso si narra che Curicaueri, il
dio del Sole nella religione Purépecha, sposò Xaratanga, la dea della Luna.
Curicaueri aveva una passione smodata per l'oro e si adornava di diademi, anelli
e collane fatte di questo metallo, splendenti quanto lui. Invece Xaratamga amava
l'argento, simile ai suoi scintillii notturni, e aveva una collezione di
gioielli non inferiore a quella del marito. I due si amavano molto e volevano
sempre stare insieme: ecco perché a volte i giorni e le notti erano troppo
lunghi, e nel mondo cominciava a regnare un grande disordine. Gli uomini se ne
lagnarono con Nana Cuerapperi, personificazione di Madre Natura, la quale non
poteva permettere che le cose continuassero in questo modo, e ad allora chiamò a
sé i due déi per rimproverarli:
« Voi siete responsabili dell'ordine naturale, tu devi illuminare le giornate e
far germogliare e crescere le piante », ricordò al Sole. « Tutto rimane
nell'ombra perché le persone possano riposare », disse invece alla Luna « Ma non
avete rispettato le mie istruzioni, ed è per questo che dovrò separarvi. »
Xaratanga le chiese di avere pietà di loro, Curicaureri la implorò di non
separarli, ma Nana Cuerapperi fu inflessibile: « Capisco quanto vi amate, ma più
importante del vostro amore è la missione che vi affido e il rispetto che dovete
agli esseri viventi che dipendono da voi. » Detto ciò, la Grande Madre
primordiale ignorò le loro preghiere e li lasciò soli. Vedendo quanto fosse
triste sua moglie, Curicaureri le parlò teneramente:
« Il nostro amore non sarà mai in pericolo. Di giorno uscirò per illuminare le
foreste e i mari, e tu vedrai come brillano attraverso le finestre delle nostre
case. Quando tornerò a casa la sera e vedrò che non ci sei, mi sentirò felice di
sapere che stai viaggiando nei cieli circondata da stelle più belle e nobili dei
tuoi gioielli. »
Xaratanga gli replicò: « Hai ragione. Forse, se rispettiamo la nostra missione,
Madre Natura permetterà che, di tanto in tanto, tu brilli dietro di me e che io
appaia all'improvviso, in pieno giorno. » Commossa, Xaratanga abbracciò suo
marito e iniziò a piangere. Una delle sue lacrime attraversò lo spazio,
attraversò le nuvole, attraversò le cime degli alberi e piovve in una valle tra
le montagne del Messico. Lì, nel profondo, attecchì e divenne il primo jicama,
con polpa luminosa, profumata e dolce come il pianto della Luna.

Il
ravanello che si meritò un Premio IgNobel
Lo wasabi (Eutrema japonicum,
in giapponese 山葵), detto anche ravanello giapponese, è una pianta della famiglia delle Brassicacee,
la stessa del cavolo. La pianta è originaria del
Giappone e dell'Estremo Oriente russo, comprese l'isola di Sakhalin e la penisola
coreana. Cresce spontanea in vicinanza dei fiumi in zone fredde del Giappone,
come per esempio in montagna o nelle valli in quota, nei cosiddetti satoyama
(里山) è un termine giapponese applicato alla zona di confine o all'area tra le
pendici delle montagne e la pianura coltivabile. Letteralmente sato (里)
significa villaggio e yama (山) collina o montagna. I satoyama sono stati
sviluppati attraverso secoli di uso agricolo e forestale su piccola scala..
Viene coltivata per i suoi rizomi, che vengono macinati a formare una pasta
usata come
condimento piccate per sushi e altri cibi, però è simile nel gusto alla senape
piccante o al ravanello piuttosto che al peperoncino, in quanto stimola il naso
più della lingua. Le due principali cultivar sul mercato sono Eutrema japonicum
"Daruma" e "Mazuma", ma ce ne sono molte altre.
I primi riferimenti scritti relativi allo wasabi risalgono al 550 d.C. circa, nel
periodo "Asuka" (538-710): sono presenti su alcuni "mokkan" (木簡), tavolette di
legno di forma rettangolare rinvenute in molti siti archeologici del Giappone
con la funzione di promemoria, che contenevano dalle note spesa fino a brevi poesie.
Un'importante citazione alla pianta di wasabi si trova nell'"onzowamyo" (本草和名),
un'enciclopedia medica compilata tra il 901 ed il 923 (periodo "Heian") da Sukehito Fukane, medico di corte dell'imperatore Daigo,
che ne illustra le doti curative, e nell'"Engishiki", la più antica collezione
di leggi e usanze nipponiche, che testimonia come lo wasabi, considerato il suo
valore, potesse essere impiegato persino per pagare i tributi! A quell'epoca lo
wasabi non veniva coltivato, ma era raccolto lungo i ruscelli di montagna
dove cresceva allo stato selvatico, cosa che lo rendeva particolarmente raro e
prezioso.
Per assistere alla nascita delle prime piantagioni fu necessario attendere
l'inizio del periodo "Edo" (1603-1868).
Lo shogun Tokugawa Ieyasu (1543-1616), fondatore dello Shogunato
Tokugawa e iniziatore dell'epoca del "sakoku" (l'isolazionismo giapponese durato
due secoli e mezzo), era un grande amante dello wasabi, forse perchè le sue
foglie gli ricordavano quella della malvarosa (Alcea rosea) presente nello
stemma di famiglia. Fu lui ad imporre per
legge che le sue colture fossero limitate alla regione di Shizuoka.
Pare che l'uso dello wasabi per accompagnare il sushi risalga proprio alla fine
del periodo "Edo".
Il botanico e viaggiatore tedesco Philipp Franz Balthasar von Siebold
(1796-1866) fu uno dei primi europei ad incontrarla nel 1830 e la chiamò Cochlearia
wasabi, osservando il suo uso come condimento. La pianta dello wasabi fu però descritta per la prima volta
nel 1866 dal botanico olandese Friedrich Anton Wilhelm Miquel (1811-1871) come
Lunaria japonica. Nel 1899 il botanico giapponese Jinzō Matsumura (1856-1928)
battezzò il genere Wasabia, riconoscendo al suo interno le
specie Wasabia pungens e Wasabia hederaefolia, ma esse sono oggi considerate
sinonimi di Eutrema japonicum. Nel 1930 un altro giapponese, Gen-ichi Koidzumi
(1883-1953), trasferì la pianta dello wasabi nel genere Eutrema, il cui nome deriva
dal greco εὐ- (eu-) "pozzo" e τρῆμα (trêma) "buco" per via di un foro nel
setto del frutto.
Col passare degli anni il suo consumo crebbe progressivamente, fino al vero e
proprio boom commerciale degli anni ‘80 del XX secolo, quando la cucina
giapponese divenne di gran moda in Occidente. A volte il comune ravanello è
utilizzato in Occidente al posto di quello giapponese; questa versione in
Giappone è comunemente chiamata "wasabi occidentale" (西洋わさび).
La pianta di wasabi ha grandi foglie prodotte da steli lunghi e sottili, con
vene palmate.
I fiori di wasabi compaiono in grappoli da lunghi steli che fioriscono dalla
fine dell'inverno all'inizio della primavera. Lo Wasabi predilige condizioni di crescita che ne limitano la coltivazione: è abbastanza intollerante alla luce solare diretta, richiede una
temperatura dell'aria compresa tra 8° e 20°C e preferisce un'umidità elevata in
estate.
Pochi luoghi sono adatti per la coltivazione su larga scala dello wasabi, che è
difficile anche in condizioni ideali. In Giappone è coltivato principalmente
nella penisola di Izu, nella prefettura di Shizuoka (la coltivazione tradizionale dello wasabi a Shizuoka è un patrimonio agricolo importante
per i giapponesi) e nella prefettura di Nagano, dove sorge la Daio Wasabi Farm
di Azumino, una popolare
attrazione turistica che rappresenta la più grande fattoria commerciale di wasabi del mondo).
Poiché la domanda di wasabi è superiore a
quella che può essere prodotta in Giappone, il Giappone importa abbondanti
quantità di wasabi da Stati Uniti, Canada, Taiwan, Corea del Sud, Israele,
Thailandia e Nuova Zelanda. In Nord America Eutrema japonicum è
coltivata da una manciata di piccoli agricoltori e aziende nelle foreste
pluviali sulla costa del Canada occidentale, dell'Oregon e nelle
aree delle Blue Ridge Mountains in North Carolina e Tennessee. In Europa lo wasabi viene coltivato commercialmente in Islanda, Paesi Bassi,
Ungheria e Regno Unito.
Queste circostanze rendono lo wasabi piuttosto costoso, e così lo wasabi si
presta spesso a falsificazioni; in Giappone il vero wasabi è denominato
hon-wasabi (本山葵), termine che significa "wasabi originale". Spesso le confezioni sono
etichettate come "wasabi" anche se gli ingredienti non includono alcuna parte della
pianta con questo nome.
Un sostituto comune dello wasabi è una miscela di rapanello, senape, amido e
colorante alimentare verde come polvere di spinaci. La differenza principale è
il colore, con lo wasabi
che è naturalmente verde.
Dello wasabi viene generalmente venduto il rizoma, che deve essere
grattugiato molto finemente prima dell'uso, ma lo si trova come polvere
essiccata o come pasta pronta all'uso in tubetti simili a quelli del
dentifricio.
In alcuni ristoranti chic la pasta viene preparata su ordinazione del cliente e
viene realizzata utilizzando una grattugia di metallo, chiamata oroshigane, ma alcuni
preferiscono utilizzare uno strumento più tradizionale fatto di pelle di squalo
essiccata, sottile da un lato e ruvida dall'altro. Una volta preparata, la pasta perde
il proprio sapore in 15 minuti se lasciata scoperta.
La pasta wasabi viene spesso usata per accompagnare pesce crudo e, in
particolare, il sushi e il sashimi (un carpaccio di pesce). Nel sushi ne viene
spalmata una piccola quantità tra il pesce e il riso, perché coprire lo wasabi
fino a quando non viene servito ne preserva il sapore; nel sashimi si scioglie
nella salsa di soia, in cui viene poi intinto il pesce crudo.
I legumi (arachidi, soia o piselli) possono essere arrostiti o fritti e poi
ricoperti di polvere di wasabi mescolata con zucchero, sale o olio e consumati
come spuntino croccante. In Giappone questo snack viene chiamato wasabi-mame (わさび豆, "fagiolo
wasabi").
Le foglie fresche di wasabi possono essere consumate crude, avendo il sapore
speziato dei rizomi di wasabi, ma possono provocare diarrea; meglio utilizzarle
secche come aroma per insaporire insalate, formaggio o pane. Dalla stessa pianta
si ottengono anche un vino e un forte liquore venduti in Giappone dai negozi di
specialità locali.
Le molecole che conferiscono allo wasabi il suo inconfondibile aroma sono degli
isotiocianati, tra cui il 6-metiltioesil isotiocianato, il 7-metiltioeptil
isotiocianato e l'8-metiltiottil isotiocianato. Di queste sostanze è noto che
inibiscono la crescita microbica con evidente funzione battericida e digestiva,
il che renderebbe indispensabile lo wasabi quando si mangia il pesce crudo. Esse
sono prodotte dall'idrolisi dei tioglucosidi naturali, coniugati del glucosio dello zucchero e dei composti
organici contenenti zolfo; la reazione di idrolisi è catalizzata dalla mirosinasi e si verifica quando l'enzima viene rilasciato in caso di rottura
cellulare causata dalla macerazione della pianta, ad esempio per grattamento. Lo stesso composto è responsabile della piccantezza del ravanello
e della senape. Gli isotiocianati possono anche essere rilasciati quando le
piante di wasabi sono state danneggiate perché vengono utilizzati come meccanismo
di difesa. Il bersaglio neurale sensoriale di tali molecole è il
recettore chemosensoriale TRPA1, noto anche come recettore wasabi. Lo wasabi
contiene vitamina C e, in minore quantità, la A e la B. Sono presenti inolte
ferro, zinco, calcio e potassio. I principali costituenti della radice di wasabi
cruda sono carboidrati (23,5%), acqua (69,1%), grassi (0,63%) e proteine
(4,8%). Secondo uno studio della Facoltà di medicina dell'Università di
Firenze, pubblicato dalla rivista statunitense Proceedings of the National
Academy of Sciences (PNAS), il consumo regolare di wasabi sarebbe in grado di
alzare la soglia di percezione del dolore.
In Giappone lo wasabi è soprannominato "namida", ossia "lacrime", perché se
usato in quantità eccessiva può far lacrimare. Però a differenza del peperoncino, il
cui effetto agisce prevalentemente in bocca, lo wasabi stimola fortemente la
mucosa nasale, e un boccone in cui ci sia una dose eccessiva di wasabi può
provocare un dolore tale da portare alla lacrimazione. Il dolore è comunque di
breve durata e non persiste come quello del peperoncino. Si dice che abbia una
funzione antibatterica.
Inalare o annusare il vapore di wasabi ha un effetto simile all'odore dei sali,
una proprietà sfruttata dai ricercatori che tentano di creare un rilevatore di
fumo per i non udenti. Un soggetto sordo che ha partecipato a un test del
prototipo si è svegliato entro 10 secondi da quando il vapore di wasabi ha
iniziato ad essere spruzzato nella
sua camera da letto. Una curiosità: il famigerato "Premio IgNobel" 2011 per la Chimica è stato
assegnato ai ricercatori giapponesi Makoto Imai, Naoki Urushihata, Hideki
Tanemura, Yukinobu Tajima, Hideaki Goto, Koichiro Mizoguchi e Junichi Murakami per aver determinato la densità ideale di wasabi
nell'aria per svegliare le persone in caso di emergenza!
Una leggenda giapponese colloca l'inizio della coltivazione dello wasabi nella
cornice di un evento storicamente accertato: la sconfitta del clan Heike nella
guerra Dan-noura, dal terzo al quinto anno dell'imperatore Bunji (795-797). I
sopravvissuti fuggirono in diverse regioni remote dell'isola di Honshu, ed
alcuni di loro si stabilirono vicino al monte Bahun, situato nel distretto a
monte del fiume Nishiki. Qui cercarono un posto dove poter vivere in pace.
Alcuni diventarono artigiani, altri agricoltori. La tradizione vuole che lo
wasabi crescesse allo stato selvatico nelle valli del Monte Heike, del Monte
Mizuo e del Monte Bahun, nello spartiacque Kitani-Kyo. Si ritiene che i
sopravvissuti del clan Heike abbiano raccolto lo wasabi selvatico da usare come
condimento per fette di yamame crudo (una specie di trota) e carne di cervo
cruda. Molti di questi sopravvissuti erano in origine samurai di estrazione
nobile e conoscevano bene la vita e la cultura di Kyoto. Per questo mangiavano
verdure in salamoia a base di steli e foglie di wasabi insieme a molte altre
piante selvatiche commestibili, e furono loro a rendere lo wasabi il condimento
più popolare in Giappone.
Alcune curiosità per finire. "Wasabi" è un film del 2001 diretto da Gérard
Krawczyk, scritto e prodotto da Luc Besson con protagonisti Jean Reno e Ryōko
Hirosue. Esso prende il titolo da una scena in cui il protagonista mangia un
intero piatto di wasabi in un ristorante giapponese senza batter ciglio! Nel
film "Cars 2" (2011) della Pixar, lo wasabi viene scambiato per gelato al
pistacchio dal protagonista Cricchetto, con effetti immaginabili. Nell'universo
dei Pokémon, Wasabi è un capitano membro del Team Diamante, incaricato di
sorvegliare il Poképassaggio ai Ghiacci Candidi. Infine, in
"Una serie di sfortunati eventi", ciclo di romanzi per ragazzi scritto da Lemony
Snicket (pseudonimo di Daniel Handler) tra il 2000 e il 2006, lo wasabi è
l'antidoto contro il Mycelium medusoide.

Il
grano degli déi
L'amaranto è simile ai cereali ma è
dicotiledone, non monocotiledone come i cereali "veri"; originario del
Centroamerica, il genere Amaranthus comprende almeno 60 specie, ma non tutte
sono coltivate per l'alimentazione umana. Anch'esso, appena arrivato in Europa,
fu considerato unicamente una pianta ornamentale, tossica da mangiare. A
differenza di patate e pomodori, però, il grande pubblico scoprì i semi di
amaranto solo nel 1975, grazie a una serie di pubblicazioni ad opera della
National Academy of Sciences statunitense in cui venivano descritte le
caratteristiche nutritive di diverse piante da tempo dimenticate tra cui,
appunto, l'amaranto. Fin qui niente di strano. Peccato che l'amaranthus, sempre
a differenza di patate e pomodori, fosse... noto anche ai Greci e ai Romani.
Infatti nella mitologia greca le dee amavano essere festeggiate dagli uomini con
ghirlande di amaranto, e i Romani attribuivano all'amaranto il potere di tenere
lontana l'invidia e la sventura. Una pianta simile all'amaranto è stata
descritta da Plinio il Vecchio nella sua" Naturalis Historia", dove si dice che
il suo fiore aveva la peculiarità di "non morire mai": raccolto ed essiccato,
riprendeva vita appena a contatto dell'acqua, anche se ormai era tutto
appassito. Per questi motivi la pianta rappresentava la permanenza dei
sentimenti e dei ricordi nel tempo, ed era così usata per riti funebri o
propiziatori. Poiché nessun romano raggiunse mai il Messico (non è certo neppure
che conoscessero le Canarie e Madeira) se non nelle nostre ucronie, è assai
probabile che con la parola "amaranto" gli antichi Greci e Romani indicassero
una pianta simile al crisantemo, fiore che veniva usato nei riti funebri proprio
per attrarre la benevolenza degli dei sul defunto e per i vivi. Nei suoi
territori d'origine l'amaranto era definito dagli Aztechi "il grano degli dei",
così come il cacao era "la bevanda degli dei"; i semi erano conosciuti per le
alte qualità nutrizionali ed energetiche, e come in Grecia se ne faceva largo
uso nei rituali religiosi, dove veniva impastato con farina di mais e utilizzato
per forgiare delle figurine antropomorfe che rappresentavano gli idoli
celebrati; le figure erano poi consumate al termine del rito propiziatorio. Gli
Incas lo definivano "kiwicha", cioè "piccolo gigante", e ne apprezzavano
principalmente il suo potere curativo. E' privo di glutine, e in Asia è
coltivato e consumato come un vero e proprio cereale.

Le
bacche dei lupi, o forse no
E ora, due parole sulle
famose e pubblicizzate bacche di Goji (in cinese 枸杞, in inglese wolfberry). Esse
rappresentano i frutti del Lycium barbarum o del Lycium chinense, due specie di
bosso strettamente imparentate tra loro che fanno parte come patate, pomodori e
belladonna della famiglia delle Solanacee. I loro frutti sono simili tra loro,
ma possono essere distinti per differenze di gusto e contenuto di zucchero. Il
nome del genere Lycium deriva dalla parola greca λυκιον (lykion), usata da
Plinio il Vecchio (23–79 d.C.) e Dioscoride (40–90 d.C.) per indicare una pianta
nota come "spinoso del tintore", che era probabilmente un arbusto del genere
Rhamnus; la parola greca si riferisce all'antica regione della Licia (Λυκία) in
Anatolia, dove cresceva quella pianta, esattamente come il nome di Licia, la
cristiana protagonista del "Quo Vadis?" di Henryk Sienkiewicz (1846-1916),
nativa della medesima regione dell'Asia Minore. Il nome inglese comune,
wolfberry, è derivato dall'errata ipotesi che il nome latino Lycium fosse
derivato dal greco λύκος (lycos), cioè "lupo". La parola Goji invece è
stata coniata nel 1973 dall'etnobotanico nordamericano Bradley Dobos come approssimativa trascrizione della pronuncia
della parola cinese gǒuqǐ, "bacca",
che a sua volta potrebbe derivare dalla stessa radice della parola persiana gojeh
(گوجه), che significa anch'essa "bacca".
Il Lycium barbarum è un arbusto legnoso deciduo, alto fino a tre metri, con rami
arcuati deboli, foglie lanceolate, verdi e poco carnose, lunghe fino a 25 mm. I
fiori crescono in gruppi da uno a tre nell'ascella delle foglie, con peduncoli
lunghi 6-15 mm. Il calice, di solito rotto dalla bacca in crescita, è un tubo
biancastro coronato da cinque o sei sepali triangolari radiali, più corti del
tubo e fortemente ricurvi. Ogni fiore ha cinque stami, con steli più lunghi
delle antere. Le piante sono autoimpollinanti, ma possono essere impollinate in
modo incrociato dagli insetti. Il frutto di Lycium barbarum, la principale
varietà di bacche di goji, è una bacca ellissoidale rosso-arancio brillante di
1–2 cm di diametro. Il numero di semi in ciascuna bacca varia ampiamente in base
alla cultivar e alla dimensione del frutto, da 10 a 60. I semi sono lunghi circa
2 mm, larghi 1 mm, giallastri, con un embrione ricurvo. Nell'emisfero
settentrionale la fioritura avviene da giugno a settembre e la maturazione delle
bacche da agosto a ottobre, a seconda della latitudine, dell'altitudine e del
clima. Dove non si verificano gelate, la fruttificazione è continua e le piante
non perdono le foglie. La specie è propagata da uccelli e altri animali che ne
mangiano i frutti e ne disperdono i semi con le feci. Quando sono mature, le
bacche sono tenere e devono essere raccolte o scosse in vassoi per evitare che
si rovinino; i frutti si conservano essiccandoli in pieno sole su vassoi aperti
o mediante disidratazione meccanica, impiegando una serie di esposizioni al
calore progressivamente crescenti nell'arco di 48 ore.
Il Lycium barbarum è coltivato in Cina, nelle fertili pianure alluvionali del
Fiume Giallo e del Fiume Azzurro, da almeno 600 anni. È ancora ampiamente
coltivato nella regione di Ningxia Hui della Cina centrosettentrionale, per un
totale di 200.000 acri nel 2005. Dato che il Ningxia Hui è circondato da tre
deserti, Lycium barbarum viene piantato anche per controllare l'erosione del
terreno e recuperare i suoli irrigabili dalla desertificazione. Il Lycium
barbarum fu introdotto nel Regno Unito nel 1730 dal Duca di Argyll, ma la pianta
era usata principalmente per siepi e giardinaggio decorativo. Naturalmente sia
Lycium barbarum che chinense sono usate da secoli sia nella cucina asiatica che
nella medicina tradizionale cinese, coreana e giapponese. La Cina è ovviamente
il principale produttore di Goji nel mondo, ma a partire dal 2000 gli
agricoltori di Canada e Stati Uniti iniziarono a coltivare Goji su scala
commerciale per soddisfare i potenziali mercati di bacche fresche, succhi e
prodotti lavorati. A partire dall'inizio del XXI secolo, le bacche di goji
essiccate e fresche sono state pubblicizzate in tutto il mondo come alimento
particolarmente salutare, anche in assenza di solide ricerche scientifiche in
proposito, e sono state incluse in molti snack e integratori alimentari, come
gli yogurt e le barrette di cereali. Tra le tante astute strategie utilizzate
per commercializzare il prodotto, spesso indicato come un "superfrutto", c'è la
storia non supportata di un uomo cinese di nome Li Qing Yuen, che si diceva
avesse consumato quotidianamente bacche di Goji, vivendo fino all'età di 256
anni (1677–1933)! Questa affermazione ha avuto origine in un opuscolo del 2003
del nutrizionista americano Earl Mindell (1940-), noto per le sue affermazioni
antiscientifiche sull'omeopatia, il quale sosteneva che il Goji avesse anche proprietà antitumorali,
ma le ricerche hanno dimostrato che si tratta solo di una bufala orchestrata per
scopi pubblicitari. Tali affermazioni esagerate sui benefici per la salute delle
bacche di Goji e dei prodotti derivati hanno scatenato forti discussioni,
anche da parte delle agenzie di regolamentazione governative. Nel 2006 la Food
and Drug Administration (FDA) statunitense ha avvisato vari distributori di
succo di Goji che i benefici terapeutici da essi sbandierati non sono mai stati
dimostrati. Nel gennaio 2007 Earl Mindell, intervistato dalla rete televisiva
canadese CBC, affermò falsamente che il Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
di New York aveva completato studi clinici che mostravano che l'uso del succo di
Goji avrebbe prevenuto il 75% di casi di cancro al seno. Di conseguenza il 29
maggio 2009 è stata intentata un'azione legale collettiva contro l'azienda per
cui Mindell lavorava presso il tribunale distrettuale dell'Arizona, denunciando
false dichiarazioni, pubblicità ingannevole e altri problemi riguardanti i
prodotti della ditta suddetta, che ovviamente ha cercato di difendersi
commissionando studi scientifici a proprio favore. Uno studio cinese condotto
sui topi avrebbe riscontrato che le bacche di Goji potenziano la capacità
antiossidante dell'organismo, che sarebbe risultata comparabile addirittura a
quella della vitamina C. Come per molti altri nuovi alimenti e integratori
pubblicizzati come "miracolosi", la mancanza di prove cliniche e lo scarso
controllo di qualità nella produzione impediscono al Goji di essere clinicamente
raccomandato o applicato. La considerevole mole di ricerche avviate per studiare
le proprietà biologiche delle sostanze fitochimiche di questi frutti, e in
particolare l'analisi dei polisaccaridi contenuti nei frutti, semi, radici di
Goji, è ancora in corso, tuttavia fino ad oggi non sono è stata confermata
alcuna vera efficacia clinica del consumo del frutto stesso, del suo succo o
degli estratti. Anzi, i test in vitro suggeriscono che le sostanze fitochimiche
non identificate nel tè di goji possono inibire il metabolismo di alcuni farmaci
per il diabete, la tachicardia o l'ipertensione. Inoltre la Food and Drug
Administration ha individuato alti livelli di residui di insetticidi e di
fungicidi in alcuni prodotti importati a base di Goji di origine cinese, il che
ha portato al sequestro di questi prodotti, e di conseguenza alla solita guerra
commerciale. Concludendo: meglio non credere alle riviste che sbandierano un
nuovo prodotto come poco meno che "miracoloso", ed informarsi bene sulle sue
controindicazioni, prima di cominciare a farne delle scorpacciate!

La
resina che sale fino a Dio
La parola
incenso deriva dal latino "incendere", "bruciare",
mentre il suo nome ebraico "lebonah" deriva dalla parola che significa "bianco,
splendente", e si riferisce a tutte quelle sostanze di
origine vegetale (non solo resine ma anche radici, cortecce, bacche, fiori e
foglie) che, bruciate, producono una fragranza particolarmente gradite. Per antonomasia,
tuttavia, con il termine "incenso"
si indicano le resine secrete da piante arbustive del genere Boswellia che crescono nelle regioni meridionali della penisola arabica e nelle
antistanti coste dell'Africa orientale, delle quali la più ricercata è la
Boswellia sacra. Il nome del genere onora il botanico scozzese John Boswell
(1710–1780), e il nome della specie vi sarà chiaro tra poco. Il termine inglese
"frankincense" deriva invece dall'antico francese "franc encens" ("incenso di
alta qualità"). Boswellia sacra è un albero deciduo alto fino ad 8 metri, con
uno o più tronchi che si ramificano a breve altezza dal suolo, assumendo la
forma di un cono rovesciato; nelle piante molto vecchie i rami si allargano,
quasi adagiandosi al suolo, per cui la chioma assume una forma emisferica. La
corteccia presenta uno strato superficiale papiraceo che si desquama con
facilità, e può essere rimosso in sottili strisce. I fiori, riuniti in
infiorescenze, hanno 7–9 mm di diametro e una corolla di 5 petali liberi
bianchi; alla base dell'ovario è presente un disco nettarifero di colore giallo
nel fiore giovane, poi arancione e infine rosso scuro. Il frutto è una capsula
ovoidale costituita da 3-5 valve, ognuna contenente un seme. Dalla corteccia
stillano delle resine in grado di liberare
nell'aria un forte e penetrante profumo al momento della loro combustione.
Invece il Plectranthus coleidos è detto "pianta dell'incenso" a causa dell'aroma molto somigliante, ma non ha
nulla a che vedere con l'incenso utilizzato nelle chiese.
Fin
dall'antichità, la forte domanda dei vari tipi di incenso e la loro elevata
utilità determinarono il sorgere di un importantissimo circuito commerciale in
grado di determinare la nascita e il declino di numerose culture umane: la
cosiddetta "via dell'incenso" andava dall'Arabia meridionale, detta dai Romani
Arabia Felix, fino a Petra, la capitale dei Nabatei scavata nella roccia
nell'attuale Giordania, e ciò spiega il grande splendore di questa città intorno
all'epoca di Cristo,per proseguire poi ad Antiochia e da qui in tutto il bacino
del Mediterraneo. L'imperatore Traiano la conquistò nel 106 d.C. proprio per
controllare la parte finale della via dell'incenso. In precedenza, già
Alessandro Magno, di rientro dalla sua spedizione fino in India, aveva
progettato la conquista dello Yemen, che non fu mai realizzata perchè il
Macedone morì a Babilonia a soli 33 anni il 10 giugno del 323 a.C. Nel 25 a.C.
anche il prefetto romano d'Egitto Elio Gallo aveva tentato di conquistare
l'Arabia per impadronirsi delle piste carovaniere attraverso cui passava il
commercio dell'incenso, ma il re nabateo Oboda III finse di allearsi con lui,
fornì a Gallo mille soldati e una guida, un certo Syleo, il quale però dirottò
gli invasori romani nei deserti più aridi, li disorientò con giri viziosi e li
fiaccò con marce a tappe forzate sotto un sole cocente; quando le legioni
giunsero in terra sabea, erano così sfiancate che fecero retromarcia. Nella
gestione dei traffici dell'incenso si sono succedute dal II millennio a.C. in poi
diverse entità statali yemenite: i regni di Saba, dei Minei, del Qataban, di Awsan e
del Hadramawt. Spesso i regni etiopici, come quello di Axum, hanno
invaso le aree sud-arabiche proprio per controllare in prima persona questi
commerci e arricchirsi. Addirittura c'è chi pensa che l'ascesa economica e spirituale della cittadina
araba della
Mecca, patria del Profeta Maometto, sia legata proprio al traffico dell'incenso lungo la dorsale carovaniera araba che metteva in collegamento la regione yemenita di Najrān
con le coste del Mediterraneo!
L'uso dell'incenso è attestato fin dalle epoche più antiche per via della
credenza che agli dèi
potessero essere graditi gli aromi non solo degli olocausti prodotti dalle carni
delle vittime sacrificali, ma anche di prodotti vegetali.
Ancor oggi numerose religioni, tra cui quella cristiana, usano questo prodotto per
glorificare simbolicamente la Divinità, mentre nei Paesi arabi l'incenso
conserva un ben preciso posto nella farmacopea popolare, d esempio come
espettorante ed antisettico per mezzo di inalazioni sfruttanti la
gommoresina estratta dai rami e dalle foglie).
In Occidente viene utilizzato l'olio aromatico estratto dalla sua resina gommosa;
nell'aromaterapia gli vengono attribuite proprietà rilassanti per la mente e per
il corpo, oltre a quelle antisettiche, astringenti e antinfiammatorie.
Fin dai tempi più antichi l'affumicamento con incenso aveva un forte valore
catartico e apotropaico. Per gli antichi egizi l'incenso era addirittura un
fenomeno soprannaturale, ed essi lo definivano "il sudore degli dei che cade
sulla terra"; nel culto dei morti, il fumo che saliva verso l'alto era
considerato una guida verso l'aldilà. Da qui fu breve il passo affinché
l'incenso diventasse simbolo della preghiera che sale a Dio. L'incenso era parte della composizione aromatica sacra destinata soltanto a Dio
(Es 30,34). Il suo soave profumo doveva servire anche alla propiziazione di YHWH,
così che Egli non inviasse il suo castigo sul popolo infedele; Aronne « mise l'incenso nel braciere e fece il rito espiatorio per il
popolo » (Num
17,12). « Ascoltaterni, figli santi, come incenso spandete un buon
profumo », ammonisce Gesù Ben Sirach (Sir 39,14). Secondo il Salmo 141 l'offerta dell'incenso e
la preghiera hanno pari
valore e sono interscambiabili, infatti sono entrambi sacrifici presentati a Dio
(Sal 141,2). Acquisterà una reinterpretazione messianica la parola del profeta
Isaia secondo la quale i cammelli verranno da Saba, « portando oro e incenso e
proclamando le glorie del Signore » (Is 60,6). Nel Vangelo secondo Matteo
l'incenso fu uno dei doni portati dai Magi al Bambino Gesù (Mt 2,11), e secondo
la tradizione simboleggia la divinità di Cristo, mentre l'oro simboleggia la Sua
regalità e la mirra il Suo futuro sacrificio sul Calvario. Nell'Apocalisse all'angelo che si ferma davanti all'altare reggendo un incensiere d'oro vengono
dati molti prof-mi, « perché li offrisse insieme con le preghiere di tutti i
santi » (Ap 8,3). In epoca paleocristiana, l'incenso dei culti pagani
aveva determinato in un primo momento un'avversione contro il suo uso
liturgico, ma in seguito prevalse la sacralità universale del suo profumo: a partire dal IV
secolo vennero sistemati dei turiboli dapprima
nella chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme, poi anche nelle grandi
basiliche dell'occidente, davanti agli altari e ai sepolcri dei martiri. L'incensazione dell'altare all'inizio delle funzioni sacre è menzionata per
la prima
volta dallo Pseudo-Dionigi l'Areopagita nel VI secolo. Tutto questo venne
poi sviluppato nell'arte medievale cristiana. Incenso, turibolo e aspersori
vennero introdotti nella liturgia cristiana quali oggetti sacri nelle varie
funzioni che a tutt'oggi vengono celebrate.

L'arbusto che purifica
L'issopo
(Hyssopus officinalis) è un arbusto della famiglia delle Labiate (come la menta
e la maggiorana), originaria dell'Europa meridionale, del Medio Oriente e della
regione che circonda il Mar Caspio. La sua altezza varia da 30 a 60 cm, il fusto
è legnoso alla base e da esso si sviluppano numerosi rami eretti. Le sue foglie
sono lanceolate, verde scuro e lunghe da 2 a 2,5 cm. Durante l'estate l'issopo
produce fiori profumati rosa, azzurri o più raramente bianchi. L'issopo è
resistente alla siccità e tollera i terreni calcarei e sabbiosi. Prospera in
pieno sole e in climi caldi. In condizioni climatiche ottimali, l'issopo viene
raccolto due volte all'anno, una alla fine della primavera e un'altra all'inizio
dell'autunno. Le piante vengono preferibilmente raccolte durante la fioritura.
Una volta tagliati i gambi, vengono raccolti ed essiccati. Il processo di
essiccazione vero e proprio dura sei giorni ed avviene in un ambiente fresco,
asciutto e ben ventilato, dove i fiori vengono miscelati più volte per garantire
un'asciugatura uniforme. Le erbe essiccate vengono protette dall'esposizione al
sole per prevenire lo scolorimento e l'ossidazione. Una volta essiccate, le
foglie vengono rimosse e i fiori vengono tritati finemente; il prodotto
essiccato può essere conservato fino a 18 mesi. Le foglie hanno un sapore
leggermente amaro dovuto ai suoi tannini e un intenso aroma di menta.
L'erba fresca invece è comunemente usata in cucina. Za'atar è una famosa miscela
di erbe mediorientali, alcune versioni della quale includono foglie di issopo.
La pianta è comunemente utilizzata dagli apicoltori per produrre il nettare dal
quale le api mellifere ricavano un miele ricco e aromatico. È anche un
ingrediente chiave in molte formulazioni di assenzio, dove è la principale fonte
del colore verde. In erboristeria si ritiene che l'issopo abbia proprietà
lenitive, espettoranti e sedative della tosse; esso è stato usato per secoli
nella medicina tradizionale per migliorare la circolazione e per trattare tosse
e mal di gola. L'olio essenziale contiene fenoli che gli conferiscono proprietà
antisettiche, ma le sue alte concentrazioni di sostanze chimiche che stimolano
il sistema nervoso centrale possono provocare reazioni epilettiche e
convulsioni, per cui va usato con attenzione.
Una pianta chiamata issopo è stata utilizzata fin dall'antichità classica. Il
suo nome è un adattamento diretto dal greco ὕσσωπος (hyssopos), che secondo
alcuni deriva dal greco "yssos", "freccia", e "ops", genitivo "opos", cioè
"aspetto", con evidente riferimento alla forma della foglia. Altri invece fanno
derivare il suo nome dalla parola ebraica אזוב (ezov o esob), usato nella
Scrittura, che è stata messa in relazione con l'arabo "sufa", "origano". Il nome
ezov è reso con issopo nelle moderne traduzioni della Bibbia, in particolare
nella toccante preghiera penitenziale del Salmo 51,7: « Purificami con issopo, e
sarò puro; lavami, e sarò più bianco della neve »; ma li esegetri hanno messo in
dubbio il fatto che i testi biblici si riferiscano alla pianta attualmente nota
come issopo, ma piuttosto ad altre erbe officinali, tra cui l'origano siriano. 1
Re 4,33 afferma che "ezov" era una piccola pianta che cresce sui muri, ben
diversa dall'issopo odierno. Per identificarla sono stati proposti il muschio,
la felce o erbe aromatiche ampiamente utilizzate come il timo, il rosmarino o la
maggiorana. Un altro suggerimento è la pianta del cappero, che è nota per
crescere nei terreni rocciosi della regione e lungo i muri.
L'issopo veniva utilizzato anche come purga per la purificazione rituale in
Egitto, dove, secondo il filosofo stoico Cheremone di Alessandria (10-80 d.C.),
i sacerdoti erano soliti mangiarlo con il pane per purificare questo tipo di
alimento e renderlo adatto alla loro dieta austera. Nella Bibbia viene citato
per la prima volta in rapporto all'esodo dall'Egitto: « Prenderete un fascio di
issopo, lo intingerete nel sangue che sarà nel catino e ne spruzzerete
l'architrave e gli stipiti » (Es 12,22), dice Mosè per salvare i primogeniti
degli Ebrei dalla strage di quelli degli Egiziani. Questa erba era usata nel
rito di purificazione col sangue degli animali sacrificali: così il sacerdote
asperge sette volte un lebbroso con un ramo di issopo immerso nel sangue di un
uccello (Lv 16,6), e la casa di un lebbroso viene purificata allo stesso modo (Lv
14,49). La forza purificatrice e in un certo senso risanatrice dell'issopo si
manifesta anche nel complicato rituale della giovenca rossa: « Il sacerdote
prenderà legno di cedro, issopo, colore scarlatto, e getterà tutto nel fuoco che
consuma la giovenca »; la cenere serviva a preparare un'acqua santa di
purificazione (Nm 19,6-9). Nella lettera agli Ebrei viene ricordato il rito
mosaico dell'aspersione col sangue associato all'issopo, a scopo di
purificazione (Eb 9,19). Questa pianta, usata da sempre con finalità cultuali,
interviene anche nel racconto della crocifissione, ad indicare che Gesù è il
vero agnello sacrificale: « C'era lì un vaso pieno d'aceto; posta dunque una
spugna imbevuta d'aceto in cima a un ramo d'issopo, l'accostarono alla sua bocca
» (Gv 19,29). Nel suo commento al salmo 51,9, Agostino scrive: « Lasciati
aspergere con issopo, l'umiltà di Cristo ti purificherà ». Nel Liber Floridus di
Lamberto di St. Omer (secolo XII), la Chiesa è presentata come "arbor bona"; la
virtù della carità è incorniciata da rami di issopo.

La
tintura che sedusse Shiva
L'henné
è una tintura cosmetica tratta da una pianta, Lawsonia inermis, un arbusto
spinoso appartenente alla famiglia delle Litracee, che rappresenta l'unica
specie inclusa nel genere Lawsonia. Originaria di Asia minore, Nordafrica, Iran
ed India occidentale, la specie è stata coltivata in tutto il bacino del
Mediterraneo orientale. Oggi è molto diffusa nei Paesi arabi. É alto da due a
sette metri, le foglie sono glabre, acuminate, ellittiche e lanceolate di 1,5–5
cm per 0,5–2 cm). I fiori bianchi o rosa, molto profumati, hanno quattro sepali
saldati in un tubulo, stami bianchi o rossi posti in coppia sul bordo del
tubulo, petali ovati; fioriscono da maggio a luglio. I frutti sono piccole
capsule brunastre, di 4-8 mm di diametro, con da 30 a 50 semi per frutto che si
aprono in quattro valve.
Henné è la versione francese del nome arabo della pianta, al-hinna, di origine
persiana, citato già da Avicenna (980-1037); il nome è entrato nella lingua
italiana già nel XVI secolo. La stessa sostanza in India viene indicata con il
nome di mehndi, dalla parola sanscrita mendhikā, che significa "tatuaggio".
Invece il nome scientifico deriva da quello dal medico scozzese Isaac Lawson
(1704-1747), amico di Linneo morto combattendo nella Guerra di Successione
Austriaca.
La pianta è conosciuta sin dall'antichità, soprattutto nella sua zona d'origine,
Mesopotamia e antico Egitto. In Nordafrica e India viene usata per tatuaggi
temporanei su mani e piedi nei matrimoni e altri riti religiosi,o per la tintura
dei capelli. La conoscenza delle proprietà coloranti e antisettiche risale a
tempi antichissimi, tanto che se ne trovano tracce fin nelle mummie egiziane.
Anche in India è usato da tempi immemorabili.
Dalle foglie essiccate e macinate si ricava una polvere giallo-verdastra
utilizzata come colorante su tessuti e pelle animale. La molecola colorante
dell'henné è il lawsone (C10H6O3), conosciuto
anche come acido hennotannico, una sostanza di colore rosso arancione presente
nelle foglie di questa pianta, ma anche nei fiori del giacinto d'acqua. La
tonalità rosso-bruna varia in funzione della composizione nei rami (dove è più
rosso) e foglie (dove è più marrone). Le foglie intere dell'henné non colorano
la pelle, perchè il lawsone è trattenuta all'interno delle cellule delle foglie
e deve essere liberata triturandole. Le foglie vengono raccolte, essiccate,
polverizzate e setacciate per ottenere la famosa polvere colorante. La polvere
secca viene miscelata con un liquido (acqua, succo di limone, tè forte e altri
ingredienti, a seconda della tradizione). Il lawsone migra gradualmente dalla
polvere o pasta di henné nello strato esterno della pelle o capelli, dove si
legherà alle proteine in essa contenute, creando una colorazione visibile. Molti
estetisti usano miele, zucchero o melassa nella pasta di henné per migliorarne
la consistenza e l'adesione alla pelle. La miscela di henné deve riposare fino a
48 ore prima dell'uso per liberare il lawsone delle foglie. L'hennè è di colore
arancione appena rimossa la pasta, ma si scurisce nei tre giorni successivi a
causa dell'ossidazione. Oli essenziali con alti livelli di alcoli monoterpenici,
come il tea tree, la melaleuca o la lavanda, migliorano le caratteristiche della
colorazione; altri oli essenziali, come l'eucalipto e il chiodo di garofano,
sarebbero altrettanto utili ma sono troppo irritanti e non dovrebbero essere
usati sulla pelle. Spesso l'henné viene mescolato con l'indaco per dare vita ad
una gamma maggiore di colori scuri.
Di henné ne esiste uno solo; quando sentiamo parlare di henné nero, si tratta in
realtà dell'Indigo, una polvere ottenuta dalla fermentazione ed essiccazione
delle foglie dell'Indigofera tinctoria. L'Indigo conferisce ai capelli un colore
nero corvino e può essere miscelato assieme all'henné puro per mitigarne i
riflessi ramati ed ottenere tonalità più scure. Usato puro su capelli di
tonalità scura, conferisce dei riflessi bluastri. Esiste anche l'henné neutro,
ottenuto dalle foglie della Cassia obovata. Questa polvere non ha proprietà
coloranti ma utilizzata come impacco nutre, ristruttura e lucida i capelli e non
modifica assolutamente il colore originario. Altre diciture tipo henné castano
ed henné biondo si riferiscono a miscele di Lawsonia con altre piante come mallo
di noce, Katam o Indigo per il castano e camomilla o rabarbaro per le tonalità
di biondo.
L'hennè viene comunemente usato anche per tingere la pelle, ottenendo dei
tatuaggi estemporanei. In tal caso bisogna miscelare la polvere setacciata (onde
evitare che si formino grumi) con succo di limone fino ad ottenere una miscela
della consistenza del puré di patate, e lasciare riposare il composto per 24
ore; il colorante forma uno strato di colore sul fluido mentre si ossida. Si
rimuove lo strato di colore con un cucchiaio, si aggiunge altro succo di limone
finchè non raggiunge la consistenza dello yogurt, e lo si mette in un apposito
cono con il quale lo si applica sulla pelle, accuratamente pulita con alcool. L'hennè
non deve essere troppo umido o unto, altrimenti inizia a creparsi. Lo si asciuga
con un phon, si applica un fissatore (di solito un gel spray) e si benda per 12
ore la zona decorata. Bisogna stare attenti perché l'henné macchia pelle,
vestiti e qualsiasi superficie porosa; le eventuali macchie di henné sui vestiti
vanno tolte con la candeggina. Di solito la colorazione dura dai 7 ai 12 giorni.
Un affascinante mito legato a questo uso dell'henné ha per protagonista Shiva,
il Distruttore della Trimurti indù, che si innamorò di Parvati, sua moglie, dopo
che lei, per riuscirgli gradita, aveva decorato il suo corpo con l'henné.
Tuttora in alcune zone dell'India le decorazioni simboleggiano la seduzione, ma
hanno anche un significato di buon auspicio per i riti nuziali, in cui è
usatissimo per abbellire le mani ed i piedi degli sposi, ed è considerato anche
come simbolo di iniziazione per la donna che si dovrà sposare, assumendo quindi
una nuova identità. Anche la "Salomé" dipinta in più versioni da Gustave Moreau
(1826-1898) ha il corpo fittamente ricoperto di disegni all'henné, anche se
nella Bibbia non se ne fa mai cenno.
Un uso particolare dell'hennè è quello per colorare le sopracciglia: sulla
pelle, sotto le sopracciglia, dura qualche giorno, mentre sui peli arriva fino a
due settimane. Alcuni musulmani lo usano persino per tingersi la barba.
L'henné si presta a diversi usi, non solo come cosmetico ma anche per scopi
terapeutici: secondo le analisi di laboratorio, l'henné possiede virtù
antimicotiche e astringenti, e combatte la dermatite e la seborrea. Sembra avere
inoltre un effetto deodorante e rinfrescante. L'henné è anche utilizzato per
tingere stoffe e unghie. La polvere di hennè invecchiando tende a perdere la sua
capacità tintoria, per cui ne è molto importante la corretta conservazione, che
deve avvenire al riparo dall'aria e dalla luce. Ma attenzione: l'henné è
pericoloso per le persone con carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi.
Neonati e bambini di particolari gruppi etnici, principalmente dal Medio Oriente
e dal Nord Africa, sono particolarmente vulnerabili per questo motivo. Inoltre
le paste di henné premiscelate per body art commerciali possono includere
ingredienti aggiuntivi per fortificare o modificare il colore finale, ed alcune
di queste sostanze possono causare rischi significativi per la salute. Negli USA
la Food and Drug Administration considera queste aggiunte come adulteranti e
quindi illegali per l'uso sulla pelle. Uno studio del 2006 ha rilevato nell'henné
messo in commercio sostanze come p-fenilendiammina, picramato di sodio, il
colorante amaranto (colorante rosso n. 2 vietato negli Stati Uniti nel 1976),
nitrato d'argento, carminio, pirogallolo, colorante arancione disperso e
addirittura cromo.

La
proteina cruda
Invece il seitan non è una pianta, ma
un alimento a base di glutine. La parola è di origine giapponese ed è stata
coniata nel 1961 da George Ohsawa, un sostenitore della dieta macrobiotica, per
riferirsi a un prodotto a base di glutine di grano ideato dal suo studente
Kiyoshi Mokutani, poi importato in Occidente nel 1969 dalla società americana
Erewhon. L'etimologia del seitan è incerta, ma si ritiene derivi dalla
combinazione dei caratteri 生 (sei, "fresco, crudo") e 蛋 (tan, da 蛋白 tanpaku,
"proteina"). Lo si ottiene lavando l'impasto di farina di frumento con acqua
fino a rimuovere tutti i granuli di amido, lasciando dietro di sé il glutine
appiccicoso e insolubile come una massa elastica, che viene poi cotta prima di
essere mangiata. Il glutine di frumento (ovviamente per i non celiaci) è
un'alternativa per i vegani agli alimenti a base di soia come il tofu (alcuni
tipi di glutine di frumento hanno una consistenza gommosa o fibrosa che ricorda
la carne più di altri sostituti), ed infatti il glutine di frumento è spesso
usato al posto della carne nelle cucine asiatica, in particolare buddista. L'uso
del glutine di frumento è stato documentato in Cina sin dal VI secolo: il
riferimento più antico al glutine di frumento appare nel Qimin Yaoshu,
un'enciclopedia agricola cinese scritta da Jia Sixie nel 535 d.C. L'enciclopedia
menziona polpettine preparate con glutine di frumento chiamati bótuō (馎饦). Il
glutine di frumento arrivò in Occidente nel XVIII secolo. "De Frumento", un
trattato sul grano scritto in latino da Bartolomeo Beccari nel 1728 e pubblicato
a Bologna nel 1745, descrive il processo di lavaggio della pasta di farina di
grano per estrarne il glutine. John Imison scrisse una definizione in lingua
inglese del glutine di frumento nel suo "Elements of Science and Art" pubblicato
nel 1803. Negli Stati Uniti, invece, i fedeli delle chiese Avventiste del
Settimo Giorno hanno promosso il consumo di glutine di frumento a partire dal
1882; oggi il seitan lo si trova in tutti i buoni supermercati. Ma attenzione!
Non è tutto oro quel che luccica. Pur essendo un alimento ricco di proteine,
povero di grassi e di colesterolo, il seitan non è in realtà l'alimento perfetto
che può sembrare. A parte la proibizione per chi è intollerante al glutine,
anche se è facilmente digeribile, non ha gli amminoacidi essenziali contenuti
nella carne. Per questo i vegani dovrebbero integrarne l'assunzione con il
consumo di legumi e di integratori di vitamina B12. Il seitan è sconsigliato
anche per chi soffre di diabete, dato che i carboidrati contenuti in questo
alimento provocano un innalzamento della glicemia.

Il
fermento di fagioli
Anche il tofu, come il seitan, non è
un vegetale ma un alimento preparato coagulando il latte di soia e pressando la
cagliata risultante in blocchi solidi bianchi di varia morbidezza: setoso,
morbido, sodo, extrasodo, o supersodo. Ha un sapore delicato, quindi può
essere utilizzato in piatti salati e dolci. Viene spesso condito o marinato e,
grazie alla sua consistenza spugnosa, assorbe bene i sapori. È un componente
tradizionale delle cucine dell'Asia orientale e del sud-est asiatico, e viene
consumato in Cina da oltre 2000 anni. Nella moderna cucina occidentale, invece,
come il seitan viene spesso trattato come un sostituto della carne. Dal punto di
vista nutrizionale, il tofu ha poche calorie, pur contenendo una quantità
relativamente elevata di proteine. È ricco di ferro e può avere un alto
contenuto di calcio o magnesio a seconda dei coagulanti utilizzati nella
produzione (cloruro di calcio, solfato di calcio, solfato di magnesio). La
parola "tofu" deriva dal giapponese tōfu (豆腐) a sua volta un prestito del cinese
豆腐(dòufǔ), cioè "fermento di fagioli". La prima documentazione della parola in
Occidente è towfu, in una lettera del 1770 del commerciante inglese James Flint
nientemeno che a Benjamin Franklin. La produzione del tofu è stata documentata
per la prima volta durante la dinastia Han circa 2000 anni fa; la leggenda
cinese attribuisce la sua invenzione al principe cinese Liu An (179–122 a.C.),
anche se gli storici della gastronomia nutrono dei dubbi in proposito, giacché
la scarsità di fonti affidabili per quel periodo rende difficile determinarlo in
modo definitivo, ed inoltre era normale, nella storia cinese, attribuire in modo
pseudoepigrafico importanti invenzioni a famosi leader dell'epoca. Nel 1960, un
murale in pietra portato alla luce da una tomba della dinastia Han orientale ha
dato supporto alla teoria dell'origine Han del tofu, tuttavia alcuni storici
sostengono che il tofu durante la dinastia Han fosse rudimentale e mancasse
della compattezza e del gusto per essere considerato davvero tofu. Un'altra
teoria suggerisce che il metodo di produzione del tofu sia stato scoperto
accidentalmente quando un impasto di semi di soia bolliti e macinati è stato
mescolato con sale marino impuro. Questo sale marino probabilmente conteneva
sali di calcio e magnesio, i quali hanno permesso alla miscela di soia di
cagliare e di produrre un gel simile al tofu. Una terza ipotesi invece sostiene
che gli antichi cinesi abbiano appreso il metodo per cagliare il latte di soia
emulando le tecniche di cagliatura del latte dei mongoli, e come prova portano
la somiglianza etimologica tra "tofu" e il termine cinese rǔfǔ (乳腐), che
letteralmente significa "latte cagliato", usato durante la dinastia Sui (581-618
d.C.), per piatti con consistenza simili a quella dello yogurt o formaggio
morbido. Sebbene intrigante e non impossibile, non ci sono prove a sostegno di
questa teoria al di là della speculazione accademica. Comunque siano andate le
cose, di sicuro il tofu e la sua tecnica di produzione furono introdotti in
Giappone durante il periodo Nara (710–794). Alcuni studiosi ritengono che il
tofu sia arrivato in Vietnam nell'XI secolo, per poi diffondersi anche in altre
parti del sud-est asiatico. Questa diffusione probabilmente coincise con quella
del Buddismo, poiché il tofu è un'importante fonte di proteine nella dieta
vegetariana del buddismo dell'Asia orientale. Il tofu può essere anche
fermentato, affumicato e addirittura congelato; esistono poi pure un tofu di
ceci e un tofu di mandorle, un tofu di arachidi e addirittura un tofu all'uovo,
anche se ovviamente quest'ultimo non è più vegetariano. Comunque molti piatti
cinesi di tofu possono includere carne. Per farti un esempio, in Giappone un
piatto comune nei mesi estivi è l'hiyayakko (冷奴), un tofu sodo servito con
zenzero appena grattugiato, cipolle verdi e salsa di soia. In inverno il tofu
viene spesso consumato come yudofu, che viene cotto a fuoco lento in una
pentola di terracotta con verdure come cavolo cinese o cipolla verde. Ma se
dovessi elencarvi tutte le ricette a base di tofu, finirei per diventare un
secondo Pellegrino Artusi!

La
gelatina di alghe
Chiudiamo questa lunghissima
carrellata con l'agar-agar, un polimero detto
poligalattoside perché costituito principalmente da unità di D-galattosio. Viene
usato come gelificante naturale e ricavato da alghe rosse appartenenti a diversi
generi (tra i quali Gelidiella, Gelidium, Gracilaria, Pterocladia, Sphaerococcus).
Il suo nome deriva dalla parola "agar", che in lingua malese indica le alghe
rosse del genere Gracilaria. In giapponese è noto anche come Kanten (寒天), dalla
frase "kan -zarashi tokoro ten" (寒曬心太) o "agar a cielo freddo" (cioè "agar
esposto al freddo"), ma viene chiamato anche erba cinese, muschio di Sri Lanka o
muschio Jaffna.
Usualmente si ritiene che l'uso dell'agar-agar come additivo alimentare sia
stato introdotto in Giappone nel 1658 da Mino Tarōzaemon, un locandiere di
Fushimi, rione di Kyoto, che secondo la leggenda avrebbe lasciato sulla finestra
la zuppa di alghe (Tokoroten) avanzata e più tardi avrebbe notato che si era
gelificata dopo il congelamento durante una fredda notte invernale. Nei secoli
successivi l'agar-agar divenne un agente gelificante comune in diverse cucine
asiatiche. Le alghe gelatinose sono state raccolte per secoli dalle comunità
malesi che vivevano sulle coste di Singapore. L'agar-agar fu sottoposto per la
prima volta ad analisi chimiche nel 1859 dal chimico francese Anselme Payen
(1795-1871), che lo aveva ottenuto dall'alga marina Gelidium corneum. Grazie al
suo utilizzo in microbiologia, di cui parleremo nel seguito, la produzione di
agar-agar aumentò rapidamente. La produzione era incentrata sul Giappone, che
esportò la maggior parte dell'agar-agar mondiale fino alla seconda guerra
mondiale. Con lo scoppio del conflitto, molte nazioni furono costrette ad
impiantare industrie proprie per la produzione di agar-agar onde continuare la
ricerca microbiologica. A quell'epoca venivano prodotte circa 2.500 tonnellate
di agar-agar all'anno, ma entro la metà degli anni '70 la produzione mondiale
era aumentata fino a circa 10.000 tonnellate all'anno. Da allora, la produzione
di questo gel ha oscillato a causa di popolazioni di alghe instabili e talvolta
sovrasfruttate.
L'agar-agar è usato come addensante nell'industria farmaceutica e dolciaria. Il
suo potere addensante varia a seconda dell'alcalinità o dell'acidità dei cibi
con cui è mescolato: gli alimenti acidi ne richiedono una maggior quantità di
quelli alcalini. Catalogato tra gli additivi alimentari codificati dall'UE col
numero E406, in cucina è un sostituto vegetariano per la colla di pesce. Ha un
alto contenuto (65%) di mucillagini e di carragenina, una sostanza gelatinosa
nota in farmacopea come alginato. La gelatina prodotta dall'agar-agar è ricca di
minerali ed ha un sapore delicato; viene impiegata nella preparazione di
gelatine per carni e per dessert, come il famoso pollo in aspic, perché ha la
proprietà di non alterarne il sapore naturale. Viene assorbita in minima parte
dall'organismo, quindi non fornisce alcun apporto calorico. L'agar-agar produce
una gelatina più solida di quella commerciale, non si scioglie facilmente ed è
completamente vegetale; non necessitando di zuccheri per gelificare, è adatta
per la produzione di confetture a basso tenore di zucchero. Usata per
preparazioni salate non è necessario usarne grandi quantità, mentre per
addensare dolci ne occorrono quantità maggiori. La sua preparazione è facile e
veloce e richiede solo una breve cottura; il tempo maggiore è richiesto per la
sua solidificazione, per cui occorre un'ora a temperatura ambiente.
L'alga da cui si ricava l'agar-agar ha pareti cellulari ricche di amidi e di
polisaccaridi complessi simili alla cellulosa, e soprattutto ha un sapore molto
forte e intenso per cui è necessario trattarla per ammorbidire le fibre e per
neutralizzarne il sapore. Per ottenere questo obiettivo vengono utilizzati due
metodi. Quello tradizionale prevede che le alghe siano raccolte da pescatori in
apnea e fatte seccare sulla spiaggia; in inverno sono poi trasportate in
montagna e lì cotte in poco aceto asprigno per ammorbidirne le fibre più dure.
Questo composto è poi pressato e filtrato in sacchetti di tela, da cui esce un
liquido omogeneo che viene versato in grosse forme simili a vassoi, dove si
rapprende; questa gelatina è poi tagliata a strisce o barre, e messa all'aperto
su graticci di bambù perché prenda quanto più sole possibile; si ripete un ciclo
di congelamento notturno alle basse temperature e di scioglimento diurno
all'esposizione al sole, in modo che tutta l'umidità contenuta evapori e che le
barrette di amido rimangano così secche, fibrose e leggerissime; ora hanno un
colore grigio e un sapore neutro. Le barrette vengono successivamente
impacchettate o ridotte in fiocchi finissimi. Esiste naturalmente anche un
metodo industriale, ben diverso, che implica l'uso dell'acido solforico per
sciogliere gli amidi e di procedimenti di sbiancatura inorganica per
neutralizzare il colore e il sapore. Ovviamente purtroppo la maggior parte
dell'agar-agar in polvere o in barre oggi è preparata così.
L'agar-agar naturale è ricco di iodio e di oligoelementi. Il suo principale
utilizzo in fitoterapia è legato all'effetto calmante, dimagrante,
antinfiammatorio e protettivo che esso esercita a livello della mucosa gastrica
e dell'intestino poiché ricopre con un sottile strato le mucose e le protegge
dagli ulteriori danni dell'infiammazione. A dosaggi più elevati esso ha
proprietà lassative, che possono venire esaltate dall'aggiunta di succo di
zenzero fresco: per la proprietà di idratarsi, aumenta la massa intestinale e si
comporta da purgante meccanico, privo di effetti collaterali. L'agar-agar è
indicato pertanto in pediatria e in età avanzata.
Uno dei dolci più tipici della cucina giapponese moderna a base di agar-agar è
il mizu shingen mochi (水信玄餅), noto anche come "goccia di pioggia dolce" o "torta
d'acqua", inventato nel 2013 e lanciato l'anno seguente dall'azienda alimentare
Kinseiken Seika con sede nella Prefettura di Yamanashi, vicino a Tokyo. Te per
la sua quasi totale assenza di calorie. Il mizu shingen mochi guadagnò
attenzione internazionale anche grazie allo chef di New York Darren Wong che,
dopo averlo rinominato "torta goccia di pioggia" ("raindrop cake"), lo presentò
al mercato di Smorgasburg, presso Williamsburg, a Brooklyn, durante il mese di
aprile del 2016. Ben presto questo dolce divenne famoso in tutto il mondo grazie
ad Internet, e taluni volarono fino in Giappone per assaggiare l'insolito
budino. Esso è composto da acqua minerale (originariamente proveniente dal Monte
Kaikoma) e agar-agar; tale alimento si caratterizza per la sua colorazione
trasparente che lo rende simile a una goccia d'acqua, ha una consistenza
gelatinosa, è poco saporito, si scioglie rapidamente in bocca ed è pressoché
privo di calorie. Per prepararlo bisogna ottenrre un composto di acqua e
agar-agar che, dopo essere stato riscaldato e modellato a piacere, viene
lasciato raffreddare; il dessert va consumato entro trenta minuti per evitare
che si sciolga o evapori. Può essere condito con il kuromitsu, uno sciroppo
simile alla melassa, o con la farina di soia (kinako), e può essere decorato
all'interno con frutti e fiori commestibili.
L'anmitsu (あんみつ) invece è un dolce fatto di piccoli cubetti di gelatina di
agar-agar e servito in una ciotola con frutta o altri ingredienti. È anche
l'ingrediente principale del mizu yōkan (水羊羹), un altro popolare dolce
giapponese preparato con una gelatina a base di fagioli rossi, agar agar e
zucchero, e con una grande quantità di acqua ("mizu" significa proprio acqua) il
che lo rende adatto alle stagioni calde. Nella cucina filippina, l'agar-agar è
usata per realizzare le barrette di gelatina nei vari rinfreschi a base di
gelatina di cocktail di frutta. Nella cucina vietnamita, gelatine fatte di
strati aromatizzati di agar-agar, chiamate thach, sono un dolce popolare e sono
spesso realizzate in stampi decorati per occasioni speciali. Nella cucina
birmana una gelatina dolce nota come kyauk kyaw è a base di agar-agar. La
gelatina di agar è ampiamente usata nel "bubble tea" taiwanese, oggi molto
diffuso anche negli USA.
Ma non ci sono solo impieghi alimentari. L'agar-agar non può essere digerito
dagli enzimi presenti nella maggior parte degli organismi, batteri e miceti
compresi, e per questo motivo è utilizzato in microbiologia per solidificare i
terreni di coltura per tali microorganismi. Si ritiene che l'agar-agar sia stato
utilizzato per la prima volta per questo scopo nel 1882 dal microbiologo tedesco
Walther Hesse (1846-1911), che lavorava nel laboratorio del Premio Nobel Robert
Koch (1843-1910), su suggerimento di sua moglie Fanny Hesse (1850-1934), un
altro esempio di coppia nuziale che ha molto giovato alla storia della scienza.
L'agar-agar ha rapidamente soppiantato la gelatina animale come base dei terreni
microbiologici, a causa della sua temperatura di fusione più elevata, che
consente ai microbi di crescere a temperature più elevate senza che il terreno
di coltura si liquefi: l'agar-agar è liquido a 80° e solidifica a temperature
inferiori a 50°; in questo modo rimane nello stato di gel a temperature che sono
ottimali per la crescita batterica. La consistenza dell'agar permette ai batteri
di riprodursi per schizogonia (scissioni multiple), ma impedisce loro di
muoversi in modo tale da dar luogo alla formazione di colonie separate. Un
terreno di coltura agarizzato è composto dallo 0,5% di peptoni (sostanze
derivanti dalla degradazione di estratti di carne), dallo 0,2% di estratto di
carne, dall'1,5% di agar e per il resto da acqua.
L'agar-agar è usato anche nella preparazione di terreni di coltura per la
coltivazione di piante in vitro, e in particolare per la riproduzione mediante
semina delle orchidee. In tempi più recenti è stato adoperato per la
preparazione dei ponti salini caratteristici delle celle elettrolitiche. A tal
scopo viene miscelato a una quantità di sale circa 10 volte maggiore in peso e
fatto bollire in una quantità d'acqua circa 30 volte maggiore in peso. La
soluzione viene lasciata solidificare e il gel così ottenuto viene trasferito
nel tubo ad U tipico dei ponti salini. L'agar-agar viene anche utilizzato come
strumento di pulitura delle superfici nell'ambito del restauro delle policromie
lignee e delle tele. In passato veniva utilizzato in odontoiatria protesica per
la presa di impronte di precisione, date le caratteristiche di buona stabilità
dimensionale e idrofilia. Per questo utilizzo veniva anche denominato "idrocolloide
reversibile", per distinguerlo dagli alginati, non reversibili. L'introduzione
dei materiali da impronta siliconici e dei polieteri, di più agevole utilizzo,
conservazione e disinfezione, ne ha però decretato l'abbandono per scopi
odontoiatrici. Nel 2016 l'azienda giapponese AMAM ha sviluppato un prototipo per
un sistema di imballaggio commerciale basato su agar-agar chiamato "Agar
Plasticity", destinato a sostituire gli imballaggi in pericolosa plastica a base
di petrolio.

« Esiste qualcosa di più affascinante, complesso, armonico, degli alberi? Vivono per un tempo non classificabile in termini umani, si esprimono in un silenzio solenne eppure sono animati da migliaia di piccoli rumori, ne basta uno a caratterizzare intere porzioni di spazio senza mai risultare fuori posto, interagendo in maniera sempre diversa con tutte le gradazioni di luce e di ombra creano riflessi e tonalità che hanno ispirato scrittori e artisti. Insomma, con la loro presenza agiscono nel mezzo, in un territorio di confine tra noi e qualcosa di superiore o inferiore, cioè una dimensione opposta, inafferrabile. » (Mario Francesco Simeone)